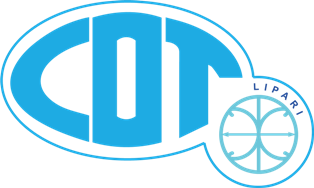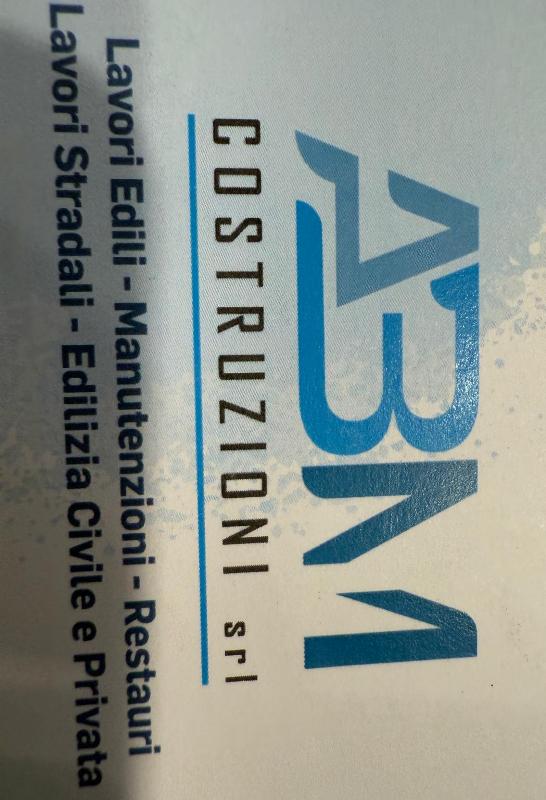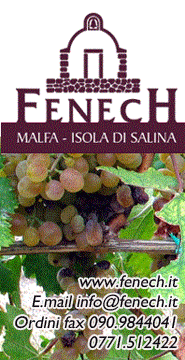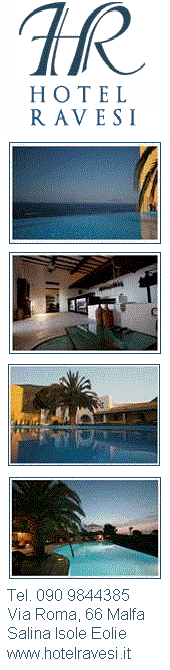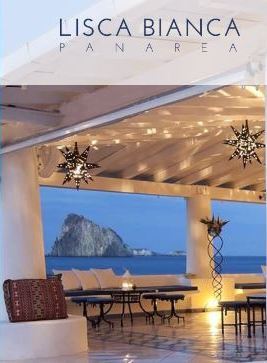di Dario Ferrara
Magistrati onorari, due soluzioni: stabilizzati per concorso o indennità a forfait sugli anni di servizio
Il Governo prepara un emendamento alla legge di bilancio dopo la procedura d’infrazione di Bruxelles: si lavora per arrivare al trattamento economico indicato dalla commissione ministeriale
Dal Governo arriva una schiarita per la magistratura onoraria dopo la procedura d’infrazione aperta contro l’Italia dalla Commissione europea sull’inquadramento dei non togati. Il ministero della Giustizia lavora a una soluzione da inserire come emendamento governativo alla manovra economica in modo da risolvere definitivamente i problemi della categoria entro il 31 dicembre; una svolta annunciata peraltro nei giorni scorsi da Cassazione.net in base alle novità emerse fra le pieghe della legge di bilancio 2021 (cfr. “Concorsi per Got. Pnnr: professionisti in sonno. Riforma Cpc in aula lunedì. Esami avvocato 21 febbraio”, pubblicato il 17 novembre; in allegato il ddl del provvedimento). È quanto emerge da un’incontro fra la guardasigilli Marta Cartabia e Stefania Cacciola, Monica Cavassa e Massimo Libri, già componenti per la magistratura onoraria della commissione ministeriale di riforma, presieduta da Claudio Castelli, presidente della Corte d’appello di Brescia.
“Esame” o liquidazione
Due le linee d’intervento che si stanno sviluppando. La prima ipotesi è stabilizzare nelle attuali funzioni tutta la magistratura onoraria in servizio, secondo un procedimento da completare nell’arco di tre anni, in base all’anzianità d’incarico. Che si svolgerà, come prescrive l’articolo 97 della Costituzione, attraverso una verifica: sono in corso di definizione le modalità delle prove, volte a valorizzare le esperienze compiute, tenendo conto delle procedure di conferma esistenti. La seconda possibilità offerta ai magistrati in servizio, in alternativa alla stabilizzazione, è un’indennità forfettaria ragguagliata agli anni di lavoro svolti. Sul trattamento economico, fanno sapere da Via Arenula, si lavora con il ministero dell’Economia per «arrivare, nel limite del possibile, ad un risultato corrispondente alle indicazioni fornite dalla commissione ministeriale».
di Antonella Bua
Bolletta acqua con conguagli tariffari? Per la Cassazione sono illegittimi
La Cassazione ha riconosciuto per la prima volta l'illegittimità delle partite pregresse, ossia dei conguagli tariffari nelle bollette
Cosa sono le partite pregresse
Le "partite pregresse" sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell'allora Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico - oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quel momento, sono comparse in bolletta le voci "partite pregresse", importi non elevati ma sgraditi agli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all'Autorità.
Conguaglio recupero tariffario in bolletta: la vicenda processuale
La pronuncia della Corte di Cassazione (sezione III, ordinanza n. 17959/2021), scaturisce dalla protesta di un utente che si è ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce "per conguagli recuperi tariffari 2009-2011". La società che gestisce il servizio idrico integrato giustificava l'operato in virtù della Delibera dell'allora Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico-AEEGSI 643/2013/R/idr. Il Giudice di Pace, accogliendo il ricorso del consumatore, ha interpretato il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali.
Anche in sede di appello, il Tribunale di La Spezia confermava le ragioni del consumatore ritenendo che la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014.
Il principio affermato dalla Cassazione
La società fornitrice ricorreva altresì all'ultimo grado di giudizio, ma anche la Corte di Cassazione ribadiva l'illegittimità dei conguagli regolatori ritenendo che, la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l'art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge. L'importanza della sentenza della Suprema Corte consta nel fatto che la decisione, pur riferendosi al suddetto caso, ha comunque una valenza nazionale, in quanto rileva che nessun atto amministrativo, nel caso in oggetto quello dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo, e di conseguenza qualsiasi richiesta nelle more, è da ritenersi illegittima.
di Debora Alberici
Cade la condanna ai sensi della “231” a carico della società che usa fatture false per incassare liquidità
Accolto il ricorso della srl: la frode fiscale esclude la truffa ai danni dello Stato
Cade la condanna ai sensi della “231” a carico dell’azienda che usa fatture false per incassare Iva che non spettante e, quindi, liquidità. La frode fiscale esclude la truffa ai danni dello Stato. La responsabilità dell’ente per i reati fiscali è stata introdotta solo dopo il 2009 ma la vicenda in esame è del 2008.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41582 del 16 novembre 2021, ha accolto il ricorso di una srl condannata per responsabilità amministrativa dell’ente.
I Supremi giudici hanno motivato la decisione spiegando che la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, a norma dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è costituita dalla condotta, di chi, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi».
A norma del comma 1, lett. a) del d.lgs. cit., «per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».
Gli Ermellini ricordano inoltre che nel caso in esame, non essendo configurabile il reato di tentata truffa, bensì quello di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deve escludersi che, nella specie, ricorra un reato idoneo, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto, ossia nel 2009, a costituire presupposto per la responsabilità amministrativa a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Invero, a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001, l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso.
di Vanessa Ranucci
Se l’utente contesta la bolletta è il gestore a dover provare che il contatore funziona
Il fruitore deve dimostrare che l'eccesso dei consumi è legato a fattori esterni al suo controllo e inevitabili anche con un'attenta custodia dell'impianto
Se l’utente contesta la bolletta è il gestore a dover provare che il contatore funziona. Il fruitore, al contrario, deve dimostrare che i consumi eccessivi sono legati a fattori esterni al suo controllo e, comunque, inevitabili anche con un'attenta custodia dell'impianto da parte sua. Così ha stabilito oggi la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 34701/21.
Una signora aveva citato in giudizio la compagnia elettrica per chiedere il rimborso del pagamento per un conguaglio nella fatturazione di consumi di energia. Secondo la ricorrente quella somma era stata pretesa dall’azienda dopo anni che non veniva effettuata la lettura del contatore e dopo che il dispositivo era stato sostituito. Inoltre, la donna ha evidenziato un'anomalia dei consumi rispetto a quelli precedenti e successivi il periodo di riferimento.
Il Tribunale, però, aveva respinto la domanda ritenendo che l'onere di provare il malfunzionamento del contatore spettasse al somministrato. Per questo, la donna è ricorsa in sede di legittimità affermando, invece, che doveva essere il somministrante a dimostrare che il contatore funzionava.
Piazza Cavour, discostandosi dalla decisione di merito, ha ricordato che “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo. Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite”.
Insomma, in caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccesso dei consumi è dovuto a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Pertanto, alla corte del rinvio il nuovo giudizio.
di Dario Ferrara
Licenziato il dirigente che non rispetta le procedure
Per la giustificatezza del recesso basta una ragione obiettiva e non pretestuosa. Addebiti fondati: il manager scavalca il superiore, rivolgendosi ai vertici, e attacca l’azienda prendendosela coi colleghi
Rischia grosso il dirigente che attacca l’azienda. Licenziato il manager che non rispetta le procedure interne, scavalca il superiore e crea un “caso” in ufficio, prendendosela con colleghi e collaboratori. A integrare la giustificatezza del provvedimento, d’altronde, basta una ragione obiettiva e non pretestuosa. È quanto emerge dall’ordinanza 34425/21, pubblicata il 15 novembre dalla sezione lavoro della Cassazione.
Legibus soluta
Diventa definitiva la condanna della dirigente a rimborsare alla spa quasi 160 mila euro a titolo d’indennità supplementare e circa 8 mila di spese legali. La Corte d’appello accoglie il gravame della società riformando la decisione del tribunale che l’aveva condannata a risarcire l’ex dipendente con dodici mensilità. E ciò perché risultano veri i fatti contestati alla lavoratrice, mentre i motivi del ricorso di legittimità sono in parte inammissibili e comunque infondati. La dirigente si sente sciolta da ogni tipo di regola: non spetta a lei, ma un’altra figura apicale, redigere la relazione annuale da inviare al responsabile internal audit. Eppure se ne arroga il diritto, mentre le è stato chiesto soltanto un report. Soprattutto manda il file al presidente della società, al collegio sindacale e perfino al responsabile audit della capogruppo. Insomma, se ne infischia «dei processi aziendali». Contro la società rivolge accuse gravi - «mille trappole e vigliaccherie» - con toni che il datore ritiene «a tratti diffamatori», invece che soltanto polemici. Parla di «dignità calpestata» e minaccia: o sarà «riabilitata in azienda» o si rivolgerà a un giudice. Intanto continua a lavorare anche in malattia trattando in modo aggressivo collaboratori e colleghi e preannunciando l’invio di una segnalazione all’organismo di vigilanza della società.
Condotta e funzione
Risultato: il licenziamento è legittimo perché le condotte contestate integrano la giustificatezza del recesso specie se si considera che devono essere rapportati al comportamento di un dirigente. E il giudice del merito ha la discrezionalità per valutare la proporzionalità fra gli addebiti, tutt’altro che generici, e il provvedimento espulsivo. L’incolpata, poi, ha potuto difendersi in modo adeguato.
SE FATE IL BOTTO CON UN CINGHIALE PAGA LA REGIONE
UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, SU UN CASO IN ABRUZZO, HA STABILITO CHE I DANNI ALL'AUTOMOBILE DOVUTI A UNA COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO LI DEVE RISARCIRE LA REGIONE, CHE È L’ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA:
MAGRA CONSOLAZIONE PER L'EX SINDACO VIRGINIA RAGGI CHE HA SEMPRE ACCUSATO ZINGARETTI PER GLI ASSEMBRAMENTI DI CINGHIALI A ROMA...
di Dario Ferrara
Non c’è obbligo di vaccinarsi contro il Sars-Cov-2 ed è il lavoratore che deve pagarsi il tampone Vincolo solo per il personale sanitario, mentre il docente no pass può presentare il test se vuole evitare la certificazione verde ma deve sobbarcarsi i costi. Esclusa la violazione della riserva di legge Continua la saga dei prof no pass. Ancora un no alla sospensiva degli atti che impongono la certificazione verde al personale della scuola e rifondono i costi del tampone soltanto ai lavoratori esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari. E ciò perché, a ben vedere, un obbligo di farsi inoculare la dose anti Covid-19 sussiste soltanto per il personale sanitario, mentre i dipendenti del ministero dell’Istruzione che non vogliono sottostare al Green pass possono comunque produrre un test molecolare o antigenico rapido per evitare le sanzioni: «non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa».
È quanto emerge dall’ordinanza 6154/21, pubblicata l’8 novembre dalla sezione terza bis del Tar Lazio. Sommaria delibazione Inutile adombrare questioni di legittimità costituzionale: non è violata la riserva assoluta di legge ex articolo 32, secondo comma, della Carta fondamentale, secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Allo stato il vaccino anti Sars-Cov-2 non è obbligatorio perché la legge consente l’alternativa fra il possesso del green pass e la produzione del tampone. Senza dimenticare che lo stesso personale sanitario può evitare la somministrazione se accetta di essere destinato a mansioni che non comportano il contatto con il pubblico. Insomma, a una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, appare legittimo che i costi del tampone siano a carico del docente, il quale non può essere destinato ad altri incarichi e svolge un servizio pubblico fondamentale: l’alternativa del tampone al Green pass è prevista proprio per tutelare il diritto del prof a non vaccinarsi. Dario Ferrara
di Giulia Provino
Rifiuti speciali non pericolosi assimilabili a quelli solidi urbani ma non esentasse
La delibera comunale che lo prevede deve contenere sia un criterio qualitativo che quantitativo
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che individua i criteri sia quantitativi che qualitativi di questi. Tuttavia lo smaltimento autonomo di questi, può giustificare una riduzione proporzionale dell’imposta dovuta, ma non una totale esenzione dal pagamento dello stesso. Con l’ordinanza 32603 del 9 novembre 2021, la Corte di cassazione accoglie il ricorso di una società che impugnava la decisione della Ctp di Milano. Quest’ultima aveva ritenuto che il regolamento comunale, seppur non indicando di fatto un limite quantitativo massimo di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, non fosse illegittimo. Tuttavia la Cassazione non è stata dello stesso parere.
Con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (TIA), ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera 9), del decreto legislativo 22/1997, (così come per la Tarsu), i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative dei rifiuti speciali. In tal caso al contribuente spetterà una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l’istante di avvalersene.
Qualora la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sia illegittima per violazione del criterio qualitativo o per l’omessa previsione del criterio quantitativo, questa va disapplicata. In questo caso i rifiuti non saranno esenti dalla tassa, ma ad essi si applicherà la disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 507/1993, che consente l’esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare.
di Debora Alberici
Abuso del processo quando i motivi di ricorso sono tutti inammissibili
In questi casi l’iniziativa giudiziaria è temeraria
Presentare un ricorso in Cassazione i cui motivi sono tutti palesemente inammissibili fa scattare l’abuso del processo a carico della parte che ha depositato l’atto al Palazzaccio.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 32031 del 5 novembre 2021, ha bocciato il gravame presentato da una srl.
La vicenda riguarda una società che aveva fatto emettere un decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente inadempiente.
Poi era stata presentata con successo opposizione. Quindi il ricorso in sede di legittimità.
E qui che il procedimento si è arrestato bruscamente per manifesta inammissibilità dei motivi. Non solo. L’ente è stato condannato dagli Ermellini per responsabilità processuale aggravata.
Infatti, ha sostenuto Piazza Cavour, la società ricorrente deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 96 comma 3, cod. proc. civ, in considerazione della temerarietà dell’iniziativa giudiziaria intentata, risultante dalla pretestuosità dei motivi, tutti inammissibili, di ricorso.
Ciò perché, si legge nel passaggio successivo delle motivazioni, in tema di responsabilità processuale aggravata, costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine alle ragioni già formulate nell’atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame.
di Remo Bresciani
Illegittima la tettoia sul balcone che impedisce al condomino sovrastante la veduta fino alla base dell’edificio
È irrilevante che il regolamento consenta la chiusura completa delle verande perché si tratta di strutture diverse non equiparabili
È illegittima la tettoia realizzata su un balcone che impedisce al condomino sovrastante la veduta fino alla base dell’edificio. È irrilevante, infatti, che il regolamento condominiale consenta la chiusura completa delle verande perché si tratta di strutture diverse non equiparabili e trattate in modo differente.
Lo ha ricordato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 31640/21 del 4 novembre che ha accolto il ricorso del proprietario di un appartamento che lamentava la violazione della normativa in tema di veduta. In particolare aveva sostenuto che l’inquilino sottostante aveva realizzato sul suo balcone una tettoia che lo aveva privato della veduta in appiombo, cioè fino alla base dell’edificio.
La corte d’appello aveva respinto la sua domanda rilevando che il regolamento di condominio, nel consentire la copertura delle verande, esonerava anche dall’osservanza delle norme sulle distanze e legittimava quindi la realizzazione di una tettoria sul balcone.
La controversia è così approdata in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che il collegio avrebbe dovuto verificare la natura dell’opera, l’impedimento della veduta in appiombo e conseguentemente applicare la disposizione prevista dall’articolo 907 del codice civile.
La Suprema corte, nel decidere la questione, ha ricordato che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e può opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi questo suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e di riservatezza del vicino, avendo operato già l'articolo 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e il valore sociale
espresso dal diritto di veduta, poiché luce e aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita. Nel caso in esame, quindi, la corte di merito è incorsa in errore di diritto laddove ha escluso l’applicabilità delle norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute nei rapporti tra condomini. Inoltre, ha concluso la Cassazione, il regolamento di condominio consentiva solo ai proprietari delle verande di realizzare tettoie di copertura mentre per quanto concerne i balconi si limitava ad ammettere l’installazione di tende da sole.
Inevitabile quindi l’accoglimento del ricorso e il rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello.
di Dario Ferrara
La scuola paritaria paga il danno morale alla prof discriminata perché gay
Anche il pregiudizio patrimoniale all’insegnante cui non è rinnovato il contratto a causa dell’orientamento sessuale. La libertà di organizzazione dell’istituto religioso non giustifica condotte lesive
La scuola cattolica paga il danno morale oltre che patrimoniale alla prof discriminata perché gay: alla docente non viene rinnovato il contratto a causa del suo orientamento sessuale; il tutto con un atto che è lesivo della «dignità umana» e «intrinsecamente umiliante» per la destinataria: la circostanza giustifica la liquidazione equitativa del risarcimento. Inutile per l’istituto religioso invocare la libertà di organizzazione: non spiega come i principi costituzionali invocati possano legittimare condotte apertamente discriminatorie come quelle accertate. È quanto emerge dall’ordinanza 31071/21, pubblicata il 2 novembre dalla sezione lavoro della Cassazione.
Diritti fondamentali
Bocciato il ricorso dell’ente religioso: diventa definitiva la decisione che riconosce all’insegnante 30 mila euro a titolo di danno morale e oltre 13 mila per il danno patrimoniale (più 10 mila euro ciascuna alla Cgil e all’associazione radicale Certi diritti nell’ambito dell’azione ex articolo 4 del decreto legislativo 216/03). La discriminazione avviene nel metodo di selezione degli insegnanti e non giova all’istituto invocare l’applicazione del contratto collettivo Agidae, associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica. Né dedurre che il diritto antidiscriminatorio dovrebbe declinarsi tenendo conto della necessità di assicurare la libertà di organizzazione dell’ente religioso, che certo non può giustificare la lesione di diritti fondamentali e inviolabili della persona. Legittima la liquidazione equitativa in ragione della gravità della discriminazione.
Il Comune risarcisce il centauro caduto sul tombino sconnesso Escluso il concorso di colpa del motociclista nella via buia e disseminata di brecciolino. L’ente locale non riesce ad addossare la responsabilità all’acquedotto, che sarebbe comunque solidale Scatta il risarcimento a carico del Comune per il centauro caduto sul tombino sconnesso. Decisivi i testimoni: il motociclista procede col faro acceso nella strada buia e disseminata di brecciolino, mentre l’ostacolo non risulta segnalato. L’ente locale è condannato a pagare anche se il chiusino appartiene all’impresa che gestisce il servizio idrico in città: l’eventuale responsabilità dell’acquedotto sarebbe solidale e non esclusiva laddove il cantiere stradale non risulta delimitato.
Nulla esclude che l’amministrazione locale possa agire in regresso contro il gestore, se sussistono i presupposti. È quanto emerge dall’ordinanza 32095/21, pubblicata il 5 novembre dalla sesta sezione civile della Cassazione. Fortuito escluso Bocciato il ricorso del Comune: diventa definitiva la condanna a pagare oltre 20 mila euro per il danno alla persona patito dal minorenne sul motorino del padre più 1.100 euro per i danni al veicolo. La Corte d’appello riforma la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto un concorso di colpa del 50 per cento a carico del minore.
E ciò sulla base delle prove testimoniali: il tombino si trova sopra una profonda buca sul manto d’asfalto, l’ostacolo non è segnalato mentre il ragazzo sullo scooter indossa il casco. Né l’ente locale adempie l’onere della prova del fortuito posto dalla legge a carico del custode ex articolo 2051 Cc: risulta insomma escluso che il giovane abbia in qualche modo concorso a determinare il sinistro. Litisconsorzio facoltativo È dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’amministrazione che eccepisce il difetto di legittimazione passiva sempre perché il tombino appartiene all’acquedotto. Il punto è che la responsabilità dell’appaltatore è esclusiva soltanto se il cantiere stradale risulta chiuso al traffico, mentre quando nell’area risulta consentito il passaggio dei veicoli la responsabilità è sia dell’impresa sia dell’ente titolare della strada.
Nella specie, dunque, la responsabilità dell’acquedotto sarebbe solidale. E la solidarietà passiva determina litisconsorzio facoltativo e non necessario: la Corte d’appello non poteva rilevare d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio. Il danneggiato aveva quindi facoltà di chiedere l’intero risarcimento al Comune. Che comunque può tentare di rivalersi sulla società.
Nell'ambito delle disposizioni che regolano il procedimento per Cassazione, gli artt. 383 e 384 c.p.c. prevedono la cassazione della sentenza con rinvio della causa ad altro giudice, di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, qualora siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e con enunciazione del principio di diritto cui quest'ultimo deve conformarsi.
Il Legislatore, in effetti, ha delineato un percorso del «giudizio di rinvio» obbligato, attribuendo – ratione materiae – una competenza funzionale inderogabile, non sucettibile di successive contestazioni nemmeno in relazione alla sopravvivenza di norme che modifichino i criteri di competenza.
Inoltre, stante il carattere «chiuso» della fase rescissoria, la sentenza della cassazione, nel disporre il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, bensì agli effetti della concreta decisione della lite, cosicché il “thema decidendum” rimane immutabilmente fissato dalla sentenza rescindente della corte e l'effetto di tale giudizio non può che essere limitato alla parte dell'originaria controversia cassata e rinviata alla C.T.R..
Ne restano estranei, quindi, tutti gli altri capi della sentenza di secondo grado che non siano stati cassati dal giudice di legittimità e che formano oggetto del giudicato implicito interno (da ultimo: Cass. Civ., n. 13825/2018).
L'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992 disciplina dettagliatamente il giudizio di rinvio, adeguando le disposizioni contenute negli artt. 392 e segg. del c.p.c. alle peculiarità del processo davanti alle Commissioni Tributarie.
Giova ricordare che, generalmente, mediante il giudizio di rinvio si tende a sostituire la sentenza cassata con una nuova decisione: invero, parte della dottrina suole distinguere il rinvio «prosecutorio o proprio» (cioè a seguito di accoglimento dei motivi di ricorso proposti ex art. 360 nn. 3 e 5) dal rinvio «restitutorio o improprio» (cioè a seguito di accoglimento dei ricorsi proposti ai sensi dell'art. 360 nn. 1, 2 e 4), con un riflesso pratico per la determinazione dei poteri del giudice del rinvio, ma soprattutto in punto di caducazione della sentenza di rinvio di primo grado.
Il distinguo, tuttavia, di fronte al tenore letterale dell'art. 393 c.p.c., non è accettato dalla dottrina dominante e così pure dalla giurisprudenza cosicché, quando la Cassazione annulla la sentenza impugnata, avendo riscontrato in essa vizi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., il giudizio di rinvio rappresenta una prosecuzione del giudizio di cassazione, che deve essere completato applicando al caso concreto il principio di diritto enunciato dalla Corte.
In questo caso, dunque, il rinvio non è una prosecuzione del precedente giudizio di secondo grado, ma una nuova e autonoma fase, con natura rescissoria funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce direttamene sulle domande proposte dalle parti.
Pertanto, il giudice dovrà soltanto uniformarsi, ex art. 384 – co. 1 – c.p.c. al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
L'art. 392 c.p.c. disciplina, poi, le modalità di riassunzione della causa davanti al nuovo giudice, che può essere fatta, ai sensi degli artt. 18, 20 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, con ricorso nei confronti di tutte le parti personalmente: ciò implica, da una parte, che l'atto di riassunzione, per quanto riguarda specificamente i contribuenti, va notificato non al domicilio eletto ai sensi dell'art. 17, bensì, in conformità a quanto previsto dall'art. 392 c.p.c., nel luogo di residenza o della sede degli stessi; dall'altra parte, che troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 331 e 333 c.p.c..
La corretta instaurazione del rapporto processuale, stante la stretta correlazione tra “iudicium rescindens e iudicium rescissorium”, non può prescindere dalla chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cd. litisconsorzio necessario processuale), configurandosi il ricorso in riassunzione propriamente come attività d'impulso processuale che coinvolge gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità.
Ne consegue che il giudizio di rinvio, pur risultando tempestivamente instaurato con la citazione di una sola (o di alcune soltanto) di dette parti, entro il termine di legge, non può legittimamente proseguire se il giudice adito, in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio necessario nella fase di gravame, non disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti cui non risulti notificato l'atto introduttivo del giudizio, mentre l'intero processo andrà ad estinguersi in caso di mancata ottemperanza a tale disposizione ordinatoria (Cass. Civ., n. 6829/1998).
Il ricorso dovrà avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nelle forme, rispettivamente, previste per i giudizi di primo e secondo grado; alla spedizione del ricorso, poi, dovrà seguire la costituzione in giudizio ex artt. 22 e 53 stesso decreto.
Il termine è rispettato con la notificazione del ricorso alla controparte e, in sede di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata.
Relativamente alla «alterità» del giudice, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, è stato affermato che “in ipotesi di cassazione con rinvio, il nuovo collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio, non determinando ciò alcuna compromissione dei requisiti di «imparzialità e terzietà» del giudice” (Cass. Civ., SS.UU. n. 24148/2013; Cass. n. 21835/2018).
di Emiliana Sabia
Condannati i dipendenti dello studio commerciale che indicano ai clienti come evadere le imposte
Gli imputati non si limitano a compilare le dichiarazioni con i documenti fittizi ma partecipano al sistema che con l’uso di fatture false consente ai contribuenti di denunciare il reddito prestabilito
Sono condannati per dichiarazione fraudolenta i dipendenti dello studio commerciale che danno indicazioni contabili ai clienti per evadere le imposte. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 38444/21, depositata oggi dalla terza sezione penale.
Sono inammissibili i ricorsi presentati da due imputati, dipendenti di uno studio commerciale, condannati in appello per dichiarazione fraudolenta. L’accusa contestava ai ricorrenti di aver fornito ai clienti dello studio delle indicazioni contabili per evadere le imposte avvalendosi di fatture false e gli ermellini confermano la condanna.
La Corte di appello ha dato conto del fatto che la ricorrente, così come il coimputato, «non si limitava a svolgere un’attività meramente esecutiva di compilazione delle dichiarazioni fiscali utilizzando i documenti, ancorché fittizi, che gli venivano consegnati dagli altri imputati, bensì, come confermato dalle persone sentite durante l’istruzione dibattimentale, partecipava attivamente al sistema organizzato da un altro coimputato, consistente nell’abbassare i redditi da dichiarare mediante l’utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti che venivano emesse per gli importi calcolati e indicati dai ricorrenti per ottenere la riduzione del carico fiscale già programmato».
La Corte di appello ha ritenuto correttamente sussistere la responsabilità di entrambi gli imputati sulla base di alcuni elementi fattuali, come ad esempio, il sistema utilizzato da entrambi nello stesso studio commerciale per calcolare «preventivamente gli importi che i clienti dovevano indicare nelle singole fatture in modo da raggiungere un reddito da dichiarare precedentemente stabilito».
di Remo Bresciani
Il notaio non risponde dell’imposta integrativa richiesta dal fisco dopo la registrazione dell’atto
Il professionista è responsabile in solido con la parte solo per quella principale autoliquidata in sede di presentazione del negozio o desumibile dal contratto
Il notaio non risponde dell’imposta integrativa richiesta dal fisco dopo la registrazione dell’atto da lui stipulato. Il professionista, infatti, è responsabile in solido con la parte solo per quella principale autoliquidata in sede di presentazione del negozio o desumibile dal contratto. Lo ha ricordato la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 30739/21 del 29 ottobre che ha accolto il ricorso di un notaio.
L’agenzia delle entrate gli aveva notificato un avviso di liquidazione per il pagamento, quale coobbligato solidale, della maggiore imposta di registro calcolata in misura proporzionale anziché fissa in relazione a un contratto di affitto di azienda. Il professionista si è opposto sostenendo di essere mero sostituto d’imposta e la ctp ha accolto l’impugnazione ritenendo che l’imposta facesse capo solo ai contraenti.
La commissione tributaria regionale ha però ribaltato la decisione dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione del fisco.
Di qui il ricorso in Cassazione dove il professionista ha sostenuto che la responsabilità solidale del notaio riguardava unicamente l'imposta principale, cioè quella assolta al momento della registrazione dell'atto e quella liquidata dall'ufficio, in sede di controllo della autoliquidazione, sulla base degli elementi risultanti dal negozio; per contro, la liquidazione di ogni altra imposta complementare e suppletiva poteva essere posta a carico esclusivamente delle parti stipulanti.
La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha ricordato che l'affermazione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, benché pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga tuttavia estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce un‘espressione di capacità contributiva, sicché deve ritenersi che contribuente in senso sostanziale non sia il notaio, ma la parte. Il professionista, in sostanza, non risponde per il pagamento delle imposte complementari o suppletive ma rimane obbligato solo per l’imposta principale, ossia quella applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica.
Nel caso in esame, però, l’imposta non aveva natura principale bensì complementare così da esulare in radice dalla responsabilità solidale del notaio. Non derivava infatti da "elementi desumibili dall'atto" e, in quanto tali, dotati di immediata evidenza ed univoca lettura, quanto piuttosto da una determinata valutazione giuridica di inquadramento dell'istituto della cessione di azienda. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che l'avviso di liquidazione integrativo risulta effettivamente illegittimo; e ciò per il solo fatto che esso mira a far valere un'ipotesi di responsabilità solidale del notaio al di fuori dei casi consentiti.
Non bastano 3 mila magistrati per 2 milioni di cause l’anno. Ufficio del processo: novità pericolose
Modificare il rito non serve a ridurre i tempi: va aumentato il numero di giudici e pm. La giustizia non può essere delegata a un team di giovani: dirompente che possano redigere bozze dei provvedimenti
C’è un aspetto che il ddl di riforma del processo civile non considera. Cioè «che circa solo 3 mila magistrati, e non di più» si occupano «per tutti i gradi di giudizio del contenzioso»: «non si vede proprio come i processi possano durare un tempo ragionevole, se 3 mila magistrati debbano far fronte ad un contenzioso di 2 milioni di cause ogni anno». A lanciare l’allarme in commissione Giustizia alla Camera è Giuliano Scarselli, professore ordinario di diritto processuale civile all’Università di Siena: «Se vogliamo ridurre i tempi del processo, solo un intervento va posto in essere, ed è quello di aumentare il numero dei magistrati» (riceviamo e volentieri pubblichiamo in allegato il testo dell’intervento tenuto in audizione a Montecitorio).
«Assai pericolose sono poi le novità in tema di Ufficio del processo», scrive l’accademico: «La giustizia è amministrata in nome del popolo, e quindi non può essere delegata ad un team di giovani, per quanto coordinati da un magistrato, appena usciti dalle università, assunti a tempo determinato e con compensi minimi; la giustizia deve essere resa personalmente dai magistrati, secondo scienza e coscienza, così come è sempre stato».
Nel mirino il compito di predisporre bozze di provvedimenti affidato agli addetti all’ufficio del processo: «Il rischio sarà quello che i giudici non scriveranno più i provvedimenti, ma solo correggeranno quelli scritti dai loro assistenti. Si tratterebbe di una novità dirompente - conclude il docente - poiché una cosa è studiare un fascicolo direttamente e redigere personalmente il consequenziale provvedimento, altra cosa farsi illustrare da un addetto i fatti di causa, lasciare a questi la redazione del provvedimento, e poi, se del caso, apporre delle correzioni».
di Emiliana Sabia
Il commercialista risarcisce il cliente se cumula i costi delle diverse attività d’impresa ma ne indica solo una nel modello Unico
L’imprenditore, destinatario dell’accertamento del fisco per la mancata inerenza delle spese, ottiene il risarcimento della somma dovuta a titolo di sanzioni e interessi
Il commercialista risarcisce il cliente se nel modello Unico cumula i costi inerenti alle attività d’impresa svolte dalla ditta individuale ma ne indica soltanto una. Ciò fa scattare inevitabilmente la contestazione del fisco sulla non inerenza dei costi e la rideterminazione della somma dovuta a titolo di maggiori imposte dovute oltre all’applicazione delle sanzioni.
Lo chiarisce il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 16760/21, pubblicata dalla tredicesima sezione, accoglie in parte la domanda di un imprenditore contro il commercialista incaricato di curare la contabilità della ditta individuale. Il cliente chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti perché il professionista non aveva provveduto a distinguere nel modello unico le due attività d’impresa svolte dalla ditta (consulenza nel settore tecnologico e intrattenimento). In particolare, il convenuto imputava tutti i costi soltanto alla prima attività e da tale errore scaturiva l’accertamento del fisco con rideterminazione delle maggiori imposte e sanzioni.
Per il collegio capitolino la domanda del cliente va accolta in parte. Emerge, infatti, dagli atti che nel modello unico manca qualsiasi riferimento all’attività di intrattenimento dell’imprenditore ma, nonostante ciò, i costi sono stati cumulati con l’attività informatica. È «evidente» la negligenza professionale del commercialista che non ha provveduto «a indicare entrambe le attività, di carattere diverso, svolte dalla ditta individuale e a separare i costi inerenti a un’attività da quelli inerenti all’altra». Da questo basilare errore è derivata la contestazione del fisco della non inerenza dei costi e la rideterminazione della somma dovuta dal cliente. La domanda è accolta relativamente alla somma richiesta dal contribuente a titolo di applicazione di sanzioni e interessi.
di Vanessa Ranucci
È il proprietario che paga l’Imu anche se l’immobile è occupato da terzi in modo abusivo
La Suprema corte decide nel merito rigettando il ricorso del contribuente: ai fini del tributo risulta irrilevante la mera detenzione, ad esempio quella dell’utilizzatore dopo la scadenza del contratto
È il proprietario che paga l’Imu anche se l’immobile è occupato da terzi in modo abusivo. Pertanto, è valido l’accertamento a carico della spa perché l’illecita detenzione non esclude la situazione di possesso del bene. Lo ha stabilito oggi la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 29868/21.
La Ctr aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di una spa per il pagamento dell’Imu da parte del Comune: per la commissione l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di terzi aveva escluso l’applicazione del pagamento dell’imposta da parte del proprietario. L’amministrazione ha proposto ricorso in sede di legittimità denunciando l’erronea valutazione da parte della Ctr nel considerare l’abusiva occupazione dell’immobile come prerogativa per escludere la debenza dell’imposta in capo al proprietario.
La Suprema corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente. L’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’imposta Imu. Al riguardo, infatti, il collegio ha ricordato che «ai fini della debenza di tale tributo rilevante è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’articolo 1140 Cc, mentre risulta irrilevante la mera detenzione».
Insomma: è irrilevante, ad esempio, l’abusiva detenzione del bene da parte dell’utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto, perché rimane al soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale la debenza del tributo Imu.
di Dario Ferrara
Licenziato chi rallenta la produzione per boicottare il capo. Illegittimo lo sciopero alla rovescia
Scarso rendimento se la prestazione dura oltre il 50% rispetto alla media richiesta. In malafede l’ostruzionismo travestito da osservanza delle norme di sicurezza: pesa il danno creato all’impresa
Licenziato. Perde il posto per giusta causa il dipendente che rallenta il lavoro per mettere in difficoltà il capo e farlo rimuovere. Non è infatti riconducibile alla nozione di legittima astensione dal servizio lo sciopero alla rovescia, ad esempio l’applicazione cavillosa di direttive in materia di sicurezza, che deve essere valutata rispetto alla diligenza e alla buona fede prescritte per l’adempimento della prestazione. Di più. Si configura lo scarso rendimento quando la prestazione ha tempi più estesi del 50 per cento rispetto a quelli in media impiegati per concludere le attività. È quanto emerge dalla sentenza 147/21, pubblicata dalla sezione lavoro e previdenza del tribunale di Forlì.
Obiettivi e risultati
Bocciato il ricorso del lavoratore contro il recesso adottato dall’azienda che opera nel settore della logistica. E ciò perché lo «sciopero pignolo» che ritarda lo scarico delle merci dai camion e ingolfa l’attività dei magazzini è organizzato per boicottare il preposto, da tempo inviso ai colleghi. Va ricordato in generale che lo scarso rendimento rileva in quanto il lavoratore-debitore rende una prestazione non utile per il datore-creditore in violazione di quanto stabilito dall’articolo 1174 Cc. In tal caso il licenziamento può scattare quando risulta provata un’evidente inosservanza dell’obbligo di diligente collaborazione dovuta dal dipendente, che non può non comprendere anche i tempi di produzione e lavoro. E che si configura in caso di sproporzione fra obiettivi programmati e risultati ottenuti nel periodo di riferimento.
Gravità intollerabile
Inutile per il lavoratore, nella specie, invocare la legittimità della condotta che sarebbe ispirata al meticoloso rispetto dei protocolli di sicurezza: non è verosimile che sia questa la vera ragione dei rallentamenti perché la questione delle norme antinfortunistiche non risulta posta in alcuna precedente diffida o richiesta, individuale o collettiva. Mentre è senz’altro legittimo lo sciopero a singhiozzo, realizzato ad intervalli nella stessa unità di tempo, non lo sono altre iniziative che contraddicono il significato dell’astensione dal lavoro, che in quanto tale deve riguardare l’intero complesso delle mansioni da svolgere. L’episodio è giudicato di gravità intollerabile, nonostante l’assenza di precedenti disciplinari: pesa il disinteresse del lavoratore per le ragioni dell’impresa, costretta a riorganizzare i turni.
di Emiliana Sabia
Il basso consumo di energia nel triennio prova che l’abitazione non è principale
No alle agevolazioni: le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo sul luogo di residenza effettiva superabili solo con la prova contraria
I bassi consumi di energia elettrica nel triennio provano che il contribuente non utilizza l’immobile come abitazione principale, da ciò deriva che non può beneficiare delle agevolazioni Imu.
È quanto stabilisce la Cassazione che, con l’ordinanza n. 29505/21, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso di un cittadino, destinatario di tre accertamenti. Il Comune riteneva che al ricorrente non spettassero le agevolazioni per l’abitazione principale perché, pur risultando residente anagraficamente, non la utilizzava come tale. In particolare, la Ctr che respingeva la domanda del contribuente, era del parere che gli scarsi consumi di energia elettrica nell’arco di tre anni fornissero la prova che l’immobile non era l’abituale dimora.
La Corte suprema si allinea alla decisione di merito: al contribuente non spettano le agevolazioni. La sesta sezione ricorda, infatti che ai fini dell’agevolazione prevista dal Dlgs. n. 504/92 (art. 8), per l’immobile adibito ad abitazione principale, i risultati anagrafici hanno un «valore presuntivo» circa il luogo di residenza effettiva che possono essere superati da prova contraria. Nel caso concreto, la Ctr ha correttamente ritenuto che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, debitamente riscontrata dall'ente locale, «fosse una sufficiente fonte di convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel Comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d’imposizione non abituale».
Ora lo dice la Cassazione: niente multa e taglio-punti perché è fuori legge lo scout speed sulla pattuglia
Il dm Bianchi prima e Delrio poi non possono derogare al Cds che impone la segnalazione preventiva e ben visibile delle postazioni. Irragionevole distinguere fra strumenti fissi e mobili
Addio polizia “fuorilegge”. La Municipale e la Stradale non possono utilizzare gli scout speed a bordo delle pattuglie multando gli automobilisti per eccesso di velocità senza avvisare che è in corso il controllo elettronico della velocità. E ciò perché è lo stesso articolo 142, comma 6 bis, Cds a stabilire che l’attività di rilevamento deve essere segnalata in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada: al decreto del ministro dei Trasporti spetta soltanto disciplinare «le modalità d’impiego degli strumenti».
E dunque il dm Bianchi, ripreso sul punto dall’attuale dm Delrio, non può derogare alla legge esonerando dall’obbligo di segnalazione gli strumenti che rilevano con «modalità dinamica» l’andatura dei mezzi sulla carreggiata: sarebbe d’altronde irragionevole una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili. È quanto emerge dall’ordinanza 29595/21, pubblicata il 22 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione, che interviene su di una questione nuova per la giurisprudenza di legittimità, tanto da compensare le spese di lite fra le parti.
Rango superiore
Il ricorso del Comune è bocciato dopo una doppia sconfitta in sede di merito: devono essere annullati la multa e il taglio di tre punti sulla patente inflitti al proprietario-conducente dell’auto che viaggia a 85 chilometri l’ora in un tratto dove il massimo è di 70. Vedono giusto il giudice di pace e il Tribunale: come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il comma 6 bis dell’articolo 142 Cds prevede un obbligo di segnalazione preventiva che ha carattere generale e non può essere eluso dai decreti ministeriali, i quali rappresentano una fonte normativa subordinata. E devono essere disapplicati dal giudice ordinario quando risultano in contrasto con la legge. Il dm, d’altronde, può derogare alla fonte di rango superiore soltanto le possibilità se prevista in modo chiaro dalla legge.
Messaggi luminosi
Il Cds, nella specie, rimette al dm la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli e segnali luminosi per avvisare che è attivo il rilevamento elettronico. È proprio il dm Bianchi che contempla la possibilità di installare sulle pattuglie messaggi luminosi con l’iscrizione «controllo velocità» visibili sia frontalmente sia da tergo, assicurando così il rispetto della legge. Al Comune non resta che pagare il contributo unificato aggiuntivo.
Al medico non basta osservare le linee guida per essere assolto
Non sono regole di cautela a carattere normativo: sanitario tenuto a verificare la praticabilità nel caso concreto. La Gelli-Bianco subordina la non punibilità all’adeguatezza delle best practice
Se qualcosa va storto con il paziente, al medico non basta aver osservato le linee guida per essere assolto: non si tratta, infatti, di regole di cautela a carattere normativo. E dunque non esonerano dunque il sanitario dal dover di verificarne la praticabilità nel caso concreto. La stessa legge Gelli-Bianco, d’altronde, esclude che il camice bianco sia punibile, nonostante l’imperizia che ha causato l’evento dannoso, ma a patto che le linee guida applicate risultino adeguate alla specificità del caso concreto. E dunque è annullata la decisione favorevole all’imputato laddove il giudice del merito non verifica se fosse sufficiente l’osservanza delle linee guida o non fosse invece necessario trattenere il paziente in osservazione presso l’ospedale. È quanto emerge dalla sentenza 37617/21, pubblicata il 18 ottobre dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Ambiente protetto
Accolto il ricorso delle parti civili dopo che la Corte d’appello ha assolto il ginecologo per l’interruzione della gravidanza procurata alla paziente, riformando la condanna del Tribunale. Frettolosa la motivazione: il giudice del gravame che non fornisce una spiegazione logica del suo convincimento. La donna alla trentunesima settimana di gravidanza si presenta in ospedale con abbondanti perdite ma viene dimessa. Manca il giudizio controfattuale: non si verifica se il ricovero nel nosocomio avrebbe consentito ai sanitari di verificare la rottura del sacco amniotico in ambiente protetto. Il feto muore per il prolasso del funicolo, ciò che «ha una mortalità pari a zero» - attacca la parte civile - quando si verifica in un buon ospedale. Il tutto mentre a carico dell’imputato si sovrappongono profili di negligenza, imprudenza e imperizia: il ginecologo non dispone esami necessari, dimette la paziente mentre era necessario il monitoraggio in ospedale e sbaglia nel leggere il tracciato cardiotocografico.
Raccomandazioni di massima
La Gelli-Bianco non è applicabile ratione temporis nel caso di specie. Ma la natura delle linee-guida non risulta cambiata anche se con la legge 24/2017 risultano recepite in elenchi regolamentati e aggiornati con decreti ministeriali: si tratta di «raccomandazioni di massima» la cui osservanza nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato a ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all’autonomia e alla responsabilità del medico, che deve curare l’ammalato con i presidi diagnostici o terapeutici di cui la scienza medica dispone al momento. Insomma, l’errore della Corte d’appello sta nel non verificare se la peculiarità del caso concreto imponesse di approfondire le condizioni della paziente evitando di dimetterla dall’ospedale. Parola al giudice del rinvio.
di P. Storani
Proroga delle concessioni balneari: diritto interno ed eurounitario
Argomento dell'esauriente contributo, intitolato "Diritto interno ed eurounitario in relazione alla proroga delle concessioni balneari" che presenta LIA Law In Action è l'annosa questione della proroga delle concessioni balneari.
"Lo Stato non è più il luogo privilegiato di formazione del diritto. La conferma di tale assunto è data anche dalla presenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la cui attività interpretativa contribuisce alla delineazione di un ordinamento multilivello, in cui la legge dei singoli Stati è più isolata e fine a sé stessa": sono le lucide espressioni dell'autore Vincenzo Esposito, in attesa della pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato che il 20 ottobre 2021 sulle eterogenee interpretazioni della giurisprudenza amministrativa.
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Povertà e fame non giustificano la sottrazione di uno zaino e la consumazione del panino in esso contenuto
Confermata la condanna per il responsabile del furto. Per i Giudici, difatti, la condizione di indigenza non basta a ipotizzare che l’azione illecita sia stata compiuta per necessità.
Cass. pen., sez. IV, ud. 22 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36160
Povertà e fame non possono giustificare l'uomo che mangia il panino rinvenuto in uno zaino da lui appena rubato (Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2021, n. 36160).
All'origine del procedimento c'è l'episodio che si verifica nella Capitale. Lì un uomo sottrae uno zainetto custodito all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via. Poi dallo zainetto preleva un panino che provvede subito a mangiare.
Il ladro viene prontamente individuato e finisce sotto processo.
Impossibile negare il risarcimento al pedone solo perché la buca in cui è caduto si trova vicino casa
Servono elementi da cui dedurre l’imprudenza che libera il Comune per il sinistro notturno: di fronte alla scarsa illuminazione bisogna motivare la condotta del danneggiato come causa esclusiva
Non si può negare il risarcimento al pedone soltanto perché la buca in cui è caduto si trova vicino a casa sua. E ciò perché la circostanza che il danneggiato abiti in zona, e dunque possa conoscere l’insidia sul manto stradale, non comporta di per sé una colpa. Pesa invece il fatto che il sinistro è avvenuto di sera in una strada illuminata poco e male: per escludere la responsabilità del Comune, in quanto custode della cosa, il giudice del merito deve indicare le ragioni che lo inducono a ritenere la condotta del danneggiato come causa esclusiva dell’incidente. È quanto emerge dall’ordinanza 26235/21, pubblicata il 28 settembre dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Vizio di sussunzione
Il ricorso della danneggiata è accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito. Sbaglia la Corte d’appello a confermare il no al risarcimento ex articolo 2051 Cc, anche se risulta corretta l’affermazione secondo cui la responsabilità da cosa in custodia viene esclusa dal caso fortuito che può anche consistere nell’imprudenza del danneggiato. Il punto è che non risulta corretta l’applicazione della regola per cui il concorso colposo della vittima integra il caso fortuito laddove si attribuisce rilevanza a una condotta che nulla ha di imprudente. Manca del tutto nella decisione del giudice del gravame il momento della sussunzione, cioè del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: la Corte territoriale si limita a ricordare le regole della responsabilità da custodia.
Circostanze pacifiche
La responsabilità ex articolo 2051 Cc è caratterizzata da un’inversione dell’onere della prova. Al danneggiato basta provare la lesione e il nesso fra la cosa in custodia e l’infortunio, mentre spetta al custode, per il principio di vicinanza della prova, dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con uno sforzo diligente adeguato alla natura della cosa oltre che alle concrete circostanze del caso. Di fronte a circostanze pacifiche come la buca sul manto stradale e i lampioni che non funzionano il giudice non spiega perché ha ritenuto efficiente la condotta della danneggiata. E per liberare il Comune servono altri elementi da cui dedurre l’imprudenza al di là del fatto che l’infortunata vive nella zona dove si trova l’insidia. Parola al giudice del rinvio.
di Dario Ferrara
La sentenza: dare del "giornalaio" ad un giornalista è diffamazione
Condannato dal Tribunale di Patti un calciatore per avere ingiuriato il giornalista Gino Pappalardo
La diffamazione viene punita, anche per il tramite dei social network. E' una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella emessa dal giudice del Tribunale di Patti, Rita Sergi, che ha condannato al pagamento di una pena in denaro di 600 euro (pena sospesa) oltre spese legali, un calciatore dell'Asd Città di Sant'Agata che nella stagione sportiva 2013/2014 diffamò il giornalista Gino Pappalardo, corrispondente del Giornale di Sicilia e collaboratore di Messina nel pallone.
L'atleta del club nebroideo apostrofò Pappalardo come “grande giornalaio”, una frase ritenuta «fortemente diffamante e lesiva» delle qualità professionali del nostro collega (difeso dall'avvocato Maurizio Morabito) che all'epoca pubblico la cronaca di una partita sulla testata “Nuova Italia”. Un ingiuria aggravata dalla diffusione tramite Facebook.
Il dipendente può provare per testi che prendeva il “fuori busta” ai fini del tfr
Da ammettere i capitoli articolati che indicano circostanze e modalità della percezione delle somme in nero: possono incidere sul convincimento del giudice. Idem vale per il danno da demansionamento
Il lavoratore ben può provare per testi che durante il rapporto percepiva un fuori busta nella controversia in cui si deve, fra l’altro, calcolare il trattamento di fine rapporto che gli spetta. Sbaglia il giudice del merito a non ammettere i capitoli di prova orale che invece indicano le circostanze di tempo e luogo di percezione delle somme in nero e che, dunque, avrebbero potuto cambiare il suo convincimento. E altrettanto vale per la prova testimoniale articolata per dimostrare non soltanto il demansionamento ma anche il senso di frustrazione derivatone, il tutto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. È quanto emerge dall’ordinanza 24510/21, pubblicata il 10 settembre dalla prima sezione civile della Cassazione.
Omessa valutazione
Accolto il ricorso del dirigente licenziato dopo ventitré anni dall’azienda industriale, fallita poco dopo. Il giudice delegato ammette il lavoratore al passivo solo per indennità sostitutiva del preavviso, tfr e spese legali. E sbaglia il Tribunale ad accogliere solo in parte l’opposizione del creditore riconoscendo che il dirigente ha ricevuto emolumenti fuori busta soltanto per i primi sette anni, mentre non sarebbe dimostrato che nei sedici successivi il lavoratore abbia continuato a prendere soldi in nero. Il che inevitabilmente riduce la somma da liquidare come trattamento di fine rapporto. Non è vero, tuttavia, che la prova testimoniale richiesta sarebbe troppo generica. Sussiste il vizio di mancata valutazione. Nei capitoli non ammessi dal tribunale il dirigente indica i nomi dei testi da escutere, precisando le modalità di tempo e luogo in cui percepiva le somme in nero oltre all’importo incassato: ogni mese la segretaria gli consegnava una busta separata con i soldi “esentasse”. Il tutto mentre il giudice non valuta se le circostanze dedotte trovino riscontro negli atti di causa.
Elementi necessari
Altrettanto vale per le testimonianze sul demansionamento. Con la prova orale il dirigente vuole dimostrare non soltanto che gli sono state ritirate tutte le deleghe, ma anche che lo spoglio da qualsiasi mansione gli ha causato un senso di frustrazione e apatia percepito da familiari e amici. E dunque fornisce elementi necessari per la liquidazione equitativa del danno che il giudice illegittimamente omette di esaminare. Parola al giudice del rinvio.
Le Sezioni unite: crocifisso in aula se decidono gli alunni, ma niente sanzione al prof dissenziente
Conta la volontà della comunità scolastica, possibile esporre i simboli religiosi delle confessioni presenti in classe. No a ordini dal preside né veto del docente. Norme del 1928, manca una legge
Il crocifisso in aula va esposto se lo decide la comunità scolastica: gli alunni, dunque, ma anche i prof. E non può essere un obbligo imposto dai pubblici poteri. Non può allora essere sanzionato il docente che pretende di far lezione in classe rimuovendo il simbolo religioso: la circolare del dirigente che ordina l’affissione non è conforme al modello di una scuola «dialogante», così come il prof dissenziente non ha un diritto di veto. E ciò perché bisogna trovare un accordo fra posizioni difformi, esponendo eventualmente anche i simboli delle altre confessioni presenti in classe. Non va quindi risarcito l’insegnante perché è esclusa la discriminazione: il crocifisso fa parte della tradizione culturale italiana e l’esposizione in classe non comprime la libertà di coscienza e di insegnamento dell’interessato. Va detto, tuttavia, che le disposizioni che regolano l’arredamento delle classi scolastiche risalgono a regolamenti del 1294 e del 1928, mentre manca una legge del Parlamento: la norma può - e deve - interpretata in senso conforme alla Costituzione. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 24414/21, pubblicata il 9 settembre.
Laicità fondamentale
È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dal docente di un istituto professionale statale: risulta illegittima la sanzione disciplinare di trenta giorni di sospensione dall’insegnamento inflitta al lavoratore. Per convinzioni personali il prof di lettere è abituato a staccare il crocifisso dal muro prima di fare lezione e a riappenderlo alla fine della sua lezione. Ma sono stati gli studenti a chiederne l’esposizione: nell’assemblea di classe decidono a maggioranza di mantenere appeso il simbolo religioso durante tutte le ore. Il dirigente emana una circolare in cui richiama i docenti al dovere di rispettare la volontà dei discenti. Il professore, però, continua a fare come prima. Ne nasce un braccio di ferro col preside fra polemiche al calor bianco, che sfocia nel procedimento davanti all’ufficio scolastico regionale. Trova ora ingresso la censura che denuncia la violazione del principio di laicità dello Stato, che impone equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni. L’ordine di servizio è illegittimo perché non ha cercato né promosso «un accomodamento da tutti sostenibile, sollecitando i protagonisti a valutare le molte possibilità praticabili sulle modalità di esposizione». E dunque risulta travolta la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore. Risarcimento escluso perché in Italia al crocifisso si lega «all’esperienza vissuta di una comunità». Parola al giudice del rinvio.
Plagiata dal compagno e a lui legata da un sentimento morboso. Ciò ha spinto la donna ad accettare i soprusi dell’uomo, che ora viene condannato per stalking. Irrilevante, secondo i Giudici, il fatto che la donna abbia continuato ad avere contatti col compagno anche dopo averlo denunciato alle forze dell’ordine (Cassazione, sentenza n. 32381/21, sez. III Penale, depositata il 31 agosto).
A finire sotto processo è un uomo, accusato di stalking per «aver posto in essere reiterate azioni minacciose e violente nei...
Lavoratore non vaccinato, sospensione e niente stipendio: la decisione del Tribunale
L’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi non vuole vaccinarsi contro il coronavirus. Lo ha stabilito con un’ordinanza il tribunale di Modena.
La decisione del Tribunale
Il giudice scrive che “il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.
A supportare la propria decisione, il tribunale cita nella sentenza la direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incuso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Da qui il dovere che incombe sul datore di tutelare il personale anche dal rischio coronavirus, contro il quale – scrive il giudice emiliano – la mascherina non basta come misura di protezione.
La sentenza puntualizza, comunque, che il rifiuto del vaccino anti-Covid non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione del dipendente. Significa che chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione.
Green pass e profili di legittimità costituzionale
L’emergenza ci ha messo davanti tanti aspetti che in tempi “normali” non riuscivamo a vedere nitidamente. Tra di essi vi è il rapporto tra diritti e doveri che rappresenta il punto di equilibrio tra libertà e autorità raggiunto da un ordinamento giuridico.
Un tema di stringente attualità in questa emergenza che stiamo vivendo, dunque, non sembra tanto quello dello “sbilanciamento” del diritto alla salute, bensì un altro, incentrato sul rafforzamento del principio solidaristico per affrontare la crisi, ma anche per aprire lo spazio al principio di giustizia sociale nel post-emergenza.
Questo fenomeno di “recrudescenza” dei doveri che precede sempre il rifiorire dei diritti si offre più nitidamente all’occhio dell’osservatore. In questo frangente, infatti, l’ordinamento mostra un lato più interessante del diritto del tempo ordinario perché consente di capire meglio di quanto si intenderebbe in un regime ordinario: ossia, che non v’è diritto senza dovere.[9]
Pertanto, l’obbligo vaccinale, ribadito autorevolmente dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno 2020 e in data 28 luglio 2021, e di conseguenza la normativa sul green pass che ne costituisce il logico presupposto, diventano una necessità inderogabile di fronte al persistere significativo dei casi di contagio ed in vista di una possibile “quarta ondata”, secondo alcuni già in atto
I cittadini italiani, con enorme sacrificio, hanno garantito il rispetto di regole che hanno messo in pericolo la propria libertà per il bene comune. Ci si augura, pertanto, che questo encomiabile comportamento possa completarsi con l’adesione, totale e conforme alla scienza medica, alla campagna vaccinale in corso e di conseguenza anche all’utilizzo del green pass.
di Dario Ferrara
Col dl semplificazioni la Soprintendenza non può bloccare la sanatoria per la pedana esterna del bar
La deregulation anticrisi del decreto 76/2020 vale anche per le opere già installate: pesano le misure anti contagio che impongono ai locali pubblici di aumentare l’utilizzo di suolo pubblico all’aperto
La Soprintendenza non può bloccare la pedana esterna del bar che si trova in un Comune soggetto a vincoli di natura culturale oltre che paesaggistica. E ciò benché la struttura sia stata già realizzata e l’esercente chieda la sanatoria del manufatto. Il tutto grazie al dl semplificazioni, approvato in piena pandemia Covid-19: dalla formulazione dell’articolo 10, comma quinto, del decreto legge 76/2020, infatti, nulla autorizza a ritenere un’esclusione delle opere già installate. Pesa l’emergenza epidemiologica che ha imposto ai locali pubblici di aumentare l’utilizzo di suolo pubblico per rispettare le misure di distanziamento sociale. È quanto emerge dalla sentenza 5471/21, pubblicata dalla settima sezione del Tar Campania.
Amovibilità fondamentale
L’accoglimento del ricorso proposto dal commerciante fa scattare lo stop tanto per il parere negativo della Soprintendenza quanto per il provvedimento del Comune che nega la sanatoria al manufatto di pertinenza della pasticceria. In realtà già l’allegato A del dpr 31/2017 comprende trentuno voci di interventi minori in aree vincolate per i quali l’autorizzazione paesaggistica è ritenuta superflua per la scarsa rilevanza delle opere, in quanto poco visibili: fra le installazioni esterne agli esercizi pubblici sono comprese le pedane. Il dl semplificazioni, poi, taglia la testa al toro: deroga all’autorizzazione paesaggistica per la «posa in opera di elementi o strutture amovibili», come nel caso di specie. E il regime semplificato si applica anche ai manufatti già esistenti grazie all’emergenza sanitaria.
Danni da polveri ex Ilva, per la Cassazione il risarcimento è legittimo
La terza sezione conferma le sentenze di primo e secondo grado favorevoli al ristoro dei cittadini per l’ inquinamento
di Domenico Palmiotti
Sono legittimi i risarcimenti danni che cinque famiglie residenti nel rione Tamburi di Taranto hanno avuto per i danni procurati ai loro appartamenti dalle polveri e dall’inquinamento dell’Ilva i cui impianti sono a ridosso del quartiere. La Corte di Cassazione (terza sezione civile) ha confermato le sentenze di primo e secondo grado, favorevoli al risarcimento, ed ha rigettato il ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria, subentrata all’Ilva dei Riva. I risarcimenti variano secondo la tipologia dell’alloggio. Vanno da 13.500 a 16.000 euro. «La sentenza di primo grado è del 2014, confermata in appello nel 2018. Ma l’amministrazione straordinaria di Ilva ha ritenuto d’impugnare questa sentenza anche davanti alla Corte di Cassazione e finalmente adesso, nel 2021, si è messo un punto finale», ha detto l'avvocato Massimo Moretti, di Taranto, che ha assistito le famiglie nel giudizio.
L'uso del cellulare alla guida è sanzionato anche se si è fermi al semaforo
La giurisprudenza ha precisato che è vietato utilizzare il telefonino nella circostanza: anzi, il conducente dovrebbe prestare particolare attenzione, essendo un momento di pericolo che non ammette distrazioni.
Niente multa per l’imbarcazione che trasporta i turisti: impossibile parlare di noleggio con conducente
Salva l’agenzia di viaggi. Irrilevante la mancata autorizzazione comunale per l’utilizzo del motoscafo fermato dai Carabinieri. Per i giudici il trasporto era legittimo poiché riguardante i soli turisti che avevano acquistato il ‘pacchetto’ proposto dall’agenzia.
Sequestrato per occupazione di suolo pubblico il furgone «stanziale» che diventa negozio
Per i giudici il veicolo, fermo da 5 anni nello stesso posto, aveva perso la sua caratteristica di mezzo destinato alla circolazione, ma era di fatto un punto vendita per ricambi auto
La Corte d'Appello di Roma ha stabilito che, ai sensi dell’ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2050 c.c., uno smisurato consumo giornaliero di sigarette è sufficiente ad escludere ogni responsabilità dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Stato per i danni alla salute del fumatore.
Cosa si rischia con i massaggi happy ending
I massaggi "happy ending" sono dei massaggi che si concludono con una prestazione sessuale da parte della massaggiatrice. Ecco chi rischia il carcere
Happy ending e prostituzione
I massaggi "happy ending", quando fatti a pagamento all'interno di un apposito centro, possono essere equiparati in tutto e per tutto alla prostituzione.
Si tratta, infatti, di una prestazione sessuale fatta dietro corrispettivo in denaro.
Massaggi happy ending: cosa si rischia
Chi si reca presso un centro di massaggi "happy ending", nel nostro ordinamento, non commette alcun tipo di reato, così come non lo commette la massaggiatrice che si prostituisce.
Se tali soggetti mantengono quindi la propria fedina penale pulita, sono coloro che gestiscono il centro che, semmai, pongono in essere una condotta penalmente rilevante.
Reclusione per il titolare del centro massaggi
Il reato che può essere integrato, in particolare, è quello punito dall'articolo 3 della legge Merlin (legge n. 75/1958).
Secondo tale norma, infatti, commette reato, tra gli altri, chi:
essendo proprietario, gerente o preposto a qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno dello stesso, si danno alla prostituzione;
recluta una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne agevola a tal fine la prostituzione;
induce alla prostituzione una donna;
favorisce o sfrutta in qualsiasi modo la prostituzione altrui.
A prescindere dal fatto che guadagni o meno dalle prestazioni sessuali rese dalle proprie massaggiatrici, quindi, il titolare di un centro massaggi "happy ending" rischia il carcere, in particolare la reclusione da due a sei anni, oltre che la multa da 258 a 10.329 euro.
Green pass falso: quali reati
Cos'è il Green pass
Il Green pass o certificazione verde Covid è un documento che è stato pensato dalle autorità per semplificare la circolazione delle persone all'interno del territorio europeo durante la pandemia da Covid19. Esso attesta l'avvenuta guarigione dalla malattia, l'avvenuta vaccinazione contro il virus o il risultato negativo del test. Il Green Pass può essere richiesto sia in formato digitale che cartaceo.
A che cosa serve il Green pass
Il Green Pass però non serve solo a circolare liberamente tra i vari Stati UE. Di recente infatti in Italia è stato emanato il decreto n. 105/2021, che all'art. 3 elenca i casi in cui è richiesto il possesso della certificazione verde. In base a questo articolo, in zona bianca, chi è in possesso della certificazione verde può accedere ai seguenti servizi e attività;
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';
- concorsi pubblici.
Non hanno l'obbligo della certificazione verde solo "i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute."
La truffa di Telegram
Da quanto appena accennato è chiaro che il Green pass, a parte i casi di esonero appena visti, viene rilasciato in presenza di determinate condizioni, che attestano l'adozione da parte del titolare delle accortezze sanitarie necessarie e richieste per scongiurare il contagio.
Un dovere civico che molti italiani hanno accettato e adempiuto, ma che per alcuni evidentemente è un onere troppo pesante da sostenere. Lo dimostra quanto accaduto nei giorni scorsi. Su Telegram si è infatti realizzato un illecito che ha a che fare proprio con il Green pass.
Agli utenti di Telegram è stato recapitato un messaggio in cui si prometteva il rilascio del Green pass da parte di una Dottoressa, in cambio dei dati necessari alla compilazione della certificazione verde. Operazione in cambio della quale venivano richieste criptovalute o buoni acquisto per piattaforme online d'importo compreso tra i 150 e i 500 euro.
Una vera e propria truffa, punita ai sensi dell'art 640 cp, che al comma 1 infatti così dispone: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032."
C'è anche il reato di falso
La truffa messa in atto per mezzo di Telegram presuppone, come anticipato, la falsificazione della certificazione verde. Il tutto in barba alla sicurezza del Green pass garantita dal Governo, che alla Faq: "E' possibile falsificare o manomettere una certificazione verde Covid?" risponde:
"No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall'ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l'autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19)."
Una risposta di cui è lecito dubitare, visto che c'è chi ha già trovato il modo di fare soldi falsificando il Green pass.
Il reato di falso del resto non è certo una novità per il nostro ordinamento, che ne contempla di vario tipo. Nel caso di Telegram però la falsificazione messa in atto rientra nello schema dell'art. 482, che punisce colui che con la sua condotta compromette la fiducia dei privati nei confronti degli atti pubblici. Privato che, se commette questo reato, è soggetto alle sanzioni contemplate dagli articoli 476, 477 e 478 che prevedono una sanzione minima di sei mesi fino a tre anni di reclusione.
E il reato di sostituzione di persona?
Il reato di sostituzione di persona è previsto e sanzionato penalmente dal nostro codice penale all'art. 494 c.p, il quale dispone che "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno."
Scatta l’odio razziale per le espressioni di intolleranza verso gli immigrati
Aumento di pena per chi aggredisce apostrofando la vittima come “negro di m…”
Scatta l’aggravante dell’odio razziale per le espressioni di intolleranza verso gli immigrati in Italia, in questo caso, “negro di m……”.
In tempi di ddl Zan, arriva la Corte di cassazione – sentenza n. 30512 del 4 agosto 2021 - a rincarare la dose contro le offese agli immigrati.
La vicenda riguarda due ragazzi palermitani che avevano inseguito con la macchina due coetanei marocchini, per poi aggredirli e offenderli.
Ad avviso degli Ermellini, che hanno confermato e reso definitiva la condanna, la circostanza aggravante prevista dall'art. 604 ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente.
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la Corte d'Appello ha valorizzato le ripetute espressioni negri o neri di merda pronunziate dagli imputati in un contesto di forte aggressività e minacce ed accompagnate da frasi di intolleranza verso la presenza in Italia e nel territorio di riferimento di persone di origine africana (che ci fate qua tornatavene in Africa); inoltre, ha condivisibilmente ritenuto che già l'uso della parola negro che, secondo l'opinione ed il liguaggio comuni ha un significato discriminatorio ed offensivo, come se denotasse di per se una inferiorità razziale e genetica è, pertanto, significativo di un sentimento di avversione ed odio razziale verso la persona alla quale la parola stessa è diretta. Tali espressioni, in considerazione del contesto probatorio emerso nel corso del giudizio di merito, sono sicuramente state adoperate dai giovani con la consapevolezza del senso di disprezzo razziale ed etnico ad esse collegato, discendendone, quindi, la configurabilità dell'aggravante.
Giustizia tributaria, l’evasore non può chiedere l’oscuramento della sentenza
La richiesta è giustificabile solo se è in gioco l’onore delle parti, ma non quando il cittadino e l’Erario si confrontano su tesi differenti
11 agosto 2021
Le sentenze di tributario non contengono dati sensibili e non incidono su diritti personalissimi, per questo non c’è ragione di oscurarle. Una decisione diversa il giudice potrebbe adottarla solo se fosse in gioco l’onore e la reputazione delle parti per illeciti o condotte elusive. Mentre il no è giustificato se lo scontro tra contribuente ed Erario riguarda solo la diversa interpretazione di una legge.
Per l’oscuramento servono ragioni valide
La Corte di cassazione, con la sentenza 22561, respinge il ricorso di un cittadino che chiedeva, senza neppure prendersi la briga di dare delle motivazioni, che dalla sentenza della Commissione tributaria che lo riguardava venissero oscurati tutti i suoi dati. Un’istanza che presupponeva, sottolinea la Cassazione, quasi un obbligo di legge. Ma così non è, altrimenti non sarebbe necessario, come invece è, indicare le ragioni, della domanda di anonimizzazione.
Il Garante e le discrezionalità del giudice
La norma, infatti, non specifica quali sono i motivi che legittimano la richiesta. Spetta al giudice pesare i contrapposti interessi, mettendo sul piatto della bilancia le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenza «quale strumento di democrazia e di informazione giuridica».
Un riferimento per il giudice possono essere le linee guida del Garante della privacy, del 2010, in materia di riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica. Indicazioni che spaziano dalla presenza di dati sensibili, alla delicatezza della vicenda oggetto del giudizio. Nulla di tutto questo è, in genere, contenuto nelle sentenze delle commissioni o delle sezioni tributarie. Per questo il giudice può negare il consenso alla nota della Cancelleria volta precludere, in caso di riproduzione del provvedimento, anche per informazione giuridica, l’indicazione di generalità o dati utili a identificare il contribuente. Ad avviso della Suprema corte non c’è motivo.
In più il ricorrente vince anche la causa tesa ad affermare il carattere di pertinenza di un lastrico solare. E i giudici chiariscono: se la proprietà è esclusiva va considerata una pertinenza a prescindere dal fatto che il bene sia censito o meno insieme all’immobile principale.
di Remo Bresciani
Stop al risarcimento se il modello di constatazione amichevole non descrive la dinamica del sinistro
Non basta neanche la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui
Il proprietario del veicolo danneggiato non ha diritto al risarcimento per il sinistro stradale se il modello di constatazione amichevole di incidente non descrive la dinamica del sinistro. Né è sufficiente la confessione di uno dei litisconsorti quando gli elementi di prova sono insufficienti e incongrui.
Lo ha ricordato la terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 22165/21 che ha respinto il ricorso del proprietario di una moto. Il ricorrente sosteneva di avere riportato danni al veicolo causati dal conducente di una vettura che non si era fermata allo stop. La compagnia di assicurazione non aveva dato seguito alla richiesta di risarcimento e pertanto era stata convenuta in giudizio.
Il giudice di pace ha condannato l’assicurazione a esibire copia del procedimento di contestazione e valutazione del danno e a comunicare i motivi specifici della mancata offerta. La compagnia si è però limitata e esibire la perizia meccanica ed è stata quindi chiamata in causa per rispondere a titolo risarcitorio dei danni causati alla moto dal proprio assicurato.
Il giudice ha respinto la domanda e il tribunale ha confermato la decisione affermando che gli elementi di prova erano insufficienti e incongrui e che la confessione di uno dei litisconsorti necessari era liberamente apprezzabile dal giudice. Inoltre il modello Cai prodotto in primo grado, sottoscritto dalle parti risultava incompleto, perché non riportava la descrizione della dinamica del sinistro e il ctu aveva espresso il suo giudizio sulla base di valutazioni astratte, non avendo potuto esaminare il motociclo. Infine vi erano incongruenze tra le dichiarazioni rese e i danni rilevati idonee a far emergere un contrasto tra la dinamica narrata e i dati oggettivi a disposizione.
La controversia è così giunta in Cassazione dove il proprietario della moto ha sostenuto che il Cai contiene una dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, che deve essere liberamente apprezzata. Se, invece, come nel caso in esame, tutte le dichiarazioni dei testimoni e l'interrogatorio convergono con le dichiarazioni contenute si ha un'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente non investono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è mai occupata dell'efficacia probatoria del Cai nei termini prospettati dal ricorrente, cioè non ne ha mai messo in discussione né la portata confessoria, né si è occupata dei suoi eventuali limiti tantomeno si è preoccupata di accertarne la possibilità di utilizzarlo quale indizio, evidenziandone soltanto la lacunosità in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Infatti, ha concluso la Cassazione «l’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è un momento antecedente rispetto all'esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria».
di Emiliana Sabia
L'uso della casa coniugale riduce l'assegno alla ex anche se è comproprietaria dell'immobile
Il provvedimento comporta la sottrazione del bene al godimento dell'onerato e si traduce in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della liquidazione del mantenimento
L'assegnazione dell'uso della casa coniugale incide sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento: ciò significa che va ridotto l'importo da corrispondere alla ex sebbene risulti comproprietaria dell'immobile. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 20858/21, pubblicata lo scorso 21 luglio. Intervenuta la separazione tra due coniugi, il giudice assegnava l'uso della casa familiare alla donna e stabiliva gli importi che l'ex doveva versare a lei e ai figli a titolo di mantenimento. Comparate le situazioni economiche, emergeva che la ricorrente aveva subito un peggioramento dopo la separazione, non potendo più contare sulle consistenti disponibilità del marito medico che, oltre a lavorare per una struttura pubblica, svolgeva anche l'attività libero-professionale.
Inoltre, l'uomo risultava proprietario di diversi immobili in Italia e all'estero e di beni mobili, fonte di ulteriore reddito, mentre la donna era intestataria di un solo immobile che nulla le fruttava in quanto non locato. La Corte di appello, tuttavia, riteneva fosse corretto ridurre l'assegno di mantenimento all'ex perché a fare la differenza era l'assegnazione della casa familiare, considerazione contestata dalla ricorrente. In buona sostanza per l'attrice, l'utilizzo del bene non poteva incidere sulla quantificazione dell'importo dal momento che risultava comproprietaria dell'immobile ma questa circostanza assume rilievo determinante anche per Piazza Cavour. La comproprietà del bene non esclude la possibilità di tener conto, ai fini della quantificazione dell'importo, «dell'incidenza del provvedimento sull'uguale diritto spettante all'altro coniuge, a sua volta comproprietario dell'immobile».
L'esclusività dell'uso del bene «non trova infatti il proprio titolo nella comproprietà del bene, che pur attribuendole la facoltà di trarre per intero dall'immobile le utilità che lo stesso è in grado di offrire, non le consentirebbe di impedire all'altro partecipante di farne parimenti uso secondo il proprio diritto, ma nel provvedimento di assegnazione, che, comportando la sottrazione del bene al godimento dell'ex e limitando anche la facoltà del controricorrente di disporre della propria quota, si traduce in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della liquidazione dell'assegno». In base a queste motivazioni, la Corte decide per il rigetto del ricorso.
Pena pecuniaria al posto della reclusione anche se l’evasione contributiva è rilevante
Il debito con l’Inps non può essere l’unico parametro: da valutare la personalità del condannato e le modalità dell’illecito
L’imprenditore può incassare la pena pecuniaria al posto di quella detentiva anche quando l’evasione contributiva è rilevante. Infatti, il debito con l’Inps non può essere l’unico parametro, sono da valutare anche la personalità del manager e le modalità dell’illecito.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 30682 del 5 agosto 2021, ha accolto il ricorso di un imprenditore accusato di non aver versato 37 mila euro di ritenute.
Premesso che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado, gli Ermellini ricordano che la ratio della applicazione delle pene sostitutive ha natura premiale e il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tener conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso
quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato. La valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, legge n. 689/81 deve, dunque, essere sorretta da congrua e adeguata motivazione, che deve tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, nell'ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato.
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la Corte di Appello non ha adeguatamente giustificato il diniego della conversione della pena detentiva, posto che il solo riferimento all'omesso versamento di una somma consistente all'Inps non costituisce esplicitazione adeguata della considerazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con la conseguente necessità di un nuovo giudizio su tale punto, nell'ambito del quale esaminare la richiesta avanzata dall’imputato valutando tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non solamente la gravità del reato.
Protezione umanitaria all’omosessuale anche se ha fatto outing in Italia a processo già in corso
La delicatezza delle informazioni giustifica la reticenza nell’esternazione da parte dello straniero che verrebbe condannato penalmente nel paese d’origine
Ha diritto alla protezione umanitaria l’omosessuale che ha fatto outing In Italia a processo già in corso se nel paese di provenienza l’orientamento è un reato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22480 del 6 agosto 2021, ha accolto il ricorso di un pakistano al quale era stata negata la protezione in quanto aveva palesato il suo orientamento sessuale troppo tardi.
Ad avviso della prima sezione civile, in tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il racconto sulla base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione dell'omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione invocata.
Né può trascurarsi che, in tema protezione internazionale, la condizione di omosessualità dichiarata dal richiedente costituisce fattore di individuazione del particolare gruppo sociale, la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), dei d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato; tale situazione sussiste non solo quando le persone di orientamento omosessuale, per poter vivere liberamente la propria sessualità, sono costrette a violare la legge penale del loro Paese
e ad esporsi a gravi sanzioni, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito, ma anche se nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata reato, e tuttavia manchi l'accettazione sociale di tale condizione e tale Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.
Cartelle di pagamento: la Cassazione conferma la prescrizione breve
Ennesima sentenza di legittimità conferma la prescrizione breve. La Cassazione nega la prescrizione decennale nonostante l'insistenza dell'Agenzia Entrate
- L'Amministrazione finanziaria non intende allentare la morsa nei confronti dei contribuenti nonostante la unanime giurisprudenza della Corte di legittimità abbia affermato, senza lasciare incertezze, che la prescrizione dei crediti portati da una cartella di pagamento segue il termine sostanziale previsto dalla Legge per ogni singola tipologia, nel caso dei crediti previdenziali assistenziali e dei premi dovuti all'INAIL il termine è di cinque anni.
Ciò nonostante l'Amministrazione finanziaria ha presentato l'ennesima impugnativa per Cassazione, quest'ultima pronunciandosi nuovamente ha ribadito quanto già affermato nella sentenza a Sezioni Unite n. 23397/2016, confermata da ultimo nei seguenti termini dalla sentenza della stessa Corte n. 1652/2020. Nella stessa si legge "E' noto che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 …", e viene ribadito che la notifica di una cartella di pagamento non determina "la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato."
L’assegno vitalizio erogato dall’Assemblea regionale siciliana agli ex deputati di Sala d’Ercole non può essere equiparato alla pensione e, pertanto, può essere sottoposto integralmente a pignoramento. Lo ha deciso il Tribunale di Gela, accogliendo la tesi dell’avvocato Francesco Mario Milia, dello Studio Ferrara, legale dei giornalisti Pietro Nicastro e Giancarlo Felice che hanno intrapreso un procedimento per ottenere dall’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta quanto loro assegnato dalla sentenza emanata dalla prima sezione civile del Tribunale di Palermo nel maggio del 2018.
In quella occasione i due professionisti, assistiti dagli avvocati Salvatore Ferrara e Giovanni Gruttad’Auria, ottennero la condanna del politico per diffamazione, vedendosi assegnare ciascuno a titolo di risarcimento quindicimila euro. Il governatore, peraltro, pochi giorni dopo il suo insediamento li aveva licenziati in tronco insieme a tutti gli altri componenti dell’Ufficio stampa della Regione. Crocetta, nonostante la condanna inflitta dal Tribunale e l'esecutività della sentenza, ha ritenuto di non dovere adempiere spontaneamente.
"Ci saremmo aspettati - dicono Nicastro e Felice - un atteggiamento diverso da chi aveva costantemente professato, almeno a parole, il sacrosanto rispetto della volontà dei giudici. Ma tant'è. Abbiamo dovuto, nostro malgrado, tentare una procedura esecutiva per vedere rispettata la sentenza del Tribunale di Palermo. La procedura, com'è facilmente immaginabile, è stata resa ancora più difficile dall’improvviso trasferimento dell’ex presidente della Regione in Tunisia".
Crocetta ha strenuamente difeso la tesi dell’intangibilità della somma percepita mensilmente dall’Ars ma il Tribunale di Gela, dando ragione a quanto sostenuto dal legale dei due giornalisti, ha dichiarato la netta distinzione tra "vitalizio" e "pensione", in considerazione della diversità dei percettori e delle finalità delle due indennità. Pietro Nicastro e Giancarlo Felice hanno così ottenuto l’assegnazione dell’intero vitalizio dell’ex presidente.
---Concessione edilizia illegittima - l 'annullamento ha in re ipsa l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata ingenerando nella p.a.,il ripristino della legalità violata ingenerando nella p.a.,il potere dovere di annullare in ogni tempo la C.E. illegittimamente assentita.
Consiglio di Stato 28/6/2018 n.2885
di Dario Ferrara
Per combattere il Coronavirus il Governo ha assunto misure che incidono «pesantemente» sulle libertà costituzionali. Ma il decreto legge 6/2020 contro il contagio comprime i diritti soltanto «al ricorrere di tassativi presupposti». E le Regioni non possono andare in ordine sparso nella lotta all’epidemia di Covid-19: è escluso che le Marche potessero chiudere scuole e musei quando non c’era un focolaio di infezione sul territorio. È quanto emerge dal decreto 56/2020, pubblicato dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale di Ancona
Allorquando una concessione sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa.
Risultando azzerato sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà
Consiglio Stato sez.iv 4/4/2019
---A spasso con due gambe di una sedia nello zaino: condotta punibile
Decisiva una segnalazione al 113 che ha poi portato al controllo in strada della Polizia. I due oggetti sono catalogabili come bastoni, cioè come strumenti atti ad arrecare offesa ad altre persone.(Corte di Cassazione)
Il tar Campania con sentenza n 2/ 4 /2015 n.1917 ha stabilito che il permesso di costruire non può essere rilasciato se l'immobile non può ottenere l'agibilita .i giudici hanno spiegato che l'agibilità non indica solo che l'immobile è conforme ai requisiti igienico sanitari ma anche ai requisiti edilizi, urbanistici e paesaggistici.
Per l'annullamento della concessione, erano state rilevanti le considerazioni espresse dall' asl che, sulla base del regolamento edilizio comunale, non aveva concesso il relativo parere.
--La frase "comunque non finisce qui" presa singolarmente non ha sempre un contenuto minaccioso, potendosi anche interpretare, come sostenuto dall'imputato, come l'avvertimento di future azioni giudiziarie, se tra le parti ci sono già delle controversie pendenti. A chiarire il concetto è la Cassazione, con la sentenza n. 9392/2020
L’annullamento d’ufficio in autotutela è l’occasione per il TAR Sicilia per chiarire una serie di principi sui provvedimenti in autotutela e sui presupposti dell’art 21-nonies della Legge 241/1990.
L’obbligo di motivazione in ordine all’interesse pubblico, nei procedimenti di annullamento di ufficio
Posto che l’annullamento in autotutela presuppone che a) l’atto da annullare sia illegittimo e b) che vi sia un interesse pubblico alla sua rimozione, il Tar segnala che l’obbligo di motivazione in materia di presenza di interesse pubblico non è della stessa consistenza per tutti gli atti, in quanto in alcuni settori tale obbligo di motivazione è particolarmente affievolito.
Quanto all’obbligo di motivare in ordine all’interesse pubblico, secondo la giurisprudenza citata in sentenza, “quando il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante“(Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588).
È stato, infatti, affermato che “che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati: “al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi “(Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)”.
Alla luce di queste considerazione, il Tar Sicilia ha ritenuto che l’obbligo motivazionale in materia di interesse pubblico è particolarmente affievolito in materia ambientale.
Infatti, posto che l’interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell’Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa, è stato ritenuto che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell’atto di primo grado, l’onere motivazionale è adeguatamente assolto attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse.



 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431