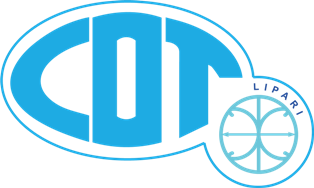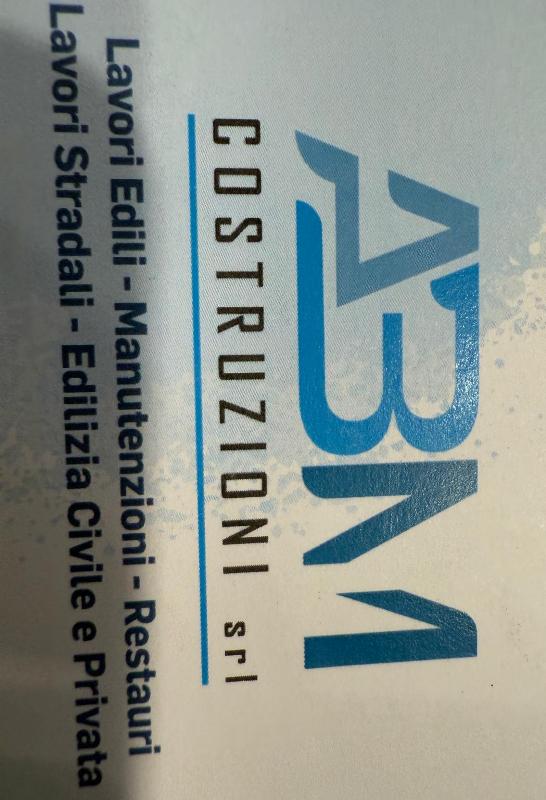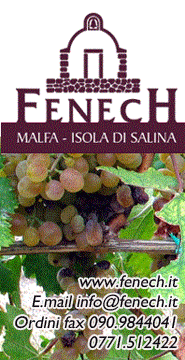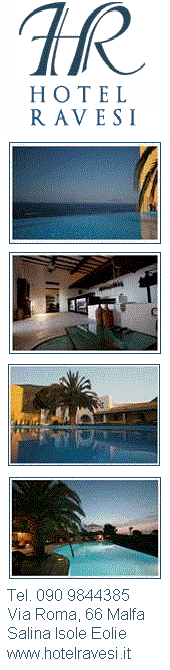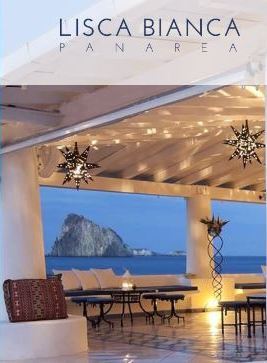di Franco Nicastro*

C’è una foto di Mario Francese, scelta dall’Assostampa e dall’Ordine dei giornalisti per alcuni momenti di memoria, che ha una grande forza simbolica. Riprende Francese con il taccuino in mano mentre annota le parole di un testimone. Questa foto evoca una pratica del giornalismo che ci riporta a un tempo in cui i giovani cronisti svolgevano, svolgevamo, nelle redazioni un apprendistato fondamentale e le redazioni erano assimilabili a una bottega artigianale. Dove ogni cosa era organizzata con cura e secondo criteri gerarchici sì, a volte molto rigidi, ma dove le regole fondanti del mestiere erano seriamente e rigorosamente interpretate.
E quando si parla di regole si fa riferimento a quelle che insegnavano i buoni maestri: indipendenza, libertà di giudizio, autonomia dalle fonti, ricerca metodica e verifica delle notizie. Aggiungerei, senza che questo sia considerato un sovrappiù, cura della buona scrittura. E siccome a quei tempi, ai tempi di Francese, non era stato ancora inventato il copia-incolla e non esistevano gli smartphone, il taccuino era lo strumento e il compagno inseparabile di un vero cronista. Ecco che quella foto ci parla anche visivamente del buon giornalismo.
In Sicilia otto cronisti uccisi perché facevano bene il loro mestiere
Oggi potrà apparire come un’immagine di antiquariato. Vintage. Non ho del mestiere una concezione passatista. Meno che mai nostalgica. So bene che i tempi sono cambiati e che il giornalismo si può declinare anche fuori dalle redazioni, con le nuove tecnologie, anche con i processi di velocizzazione dell’informazione. Ma su una cosa non credo si possa stare tanto a discutere: che possono cambiare i mezzi e le piattaforme, e magari può essere ridimensionato il peso e il ruolo della carta stampata.
E magari la crisi ci lancia la sfida a cercare nuove strade. Ma il giornalismo sempre quello rimane: il giornalismo che in Sicilia, terra di frontiera, e non è solo uno stereotipo, va associato a Mario Francese e agli altri otto cronisti uccisi semplicemente perché svolgevano questa professione con rigore etico e con una forte tensione civile. L’orizzonte di questo modello di informazione è stato tracciato da Pippo Fava nel modo più illuminante: “Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società.
Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza, la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell’ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo”.
Il giornalismo ha un ruolo nevralgico nella democrazia
Ecco il patrimonio morale che questi colleghi ci hanno lasciato: un metodo che si pone come contraltare di una tendenza pericolosa. Quella che mira a sottrarre al giornalismo lo spazio dell’intermediazione, l’esercizio critico della ragione direbbe Sciascia, il ruolo nevralgico per la democrazia.
Quelli che di noi lo hanno conosciuto, serbiamo di Francese il ricordo di un cronista sempre presente nelle aule dove si celebravano i processi. E prendeva posto vicino al pm, quasi a marcare una posizione che in realtà era quella di un testimone attento e preciso, un testimone partecipante. Il mio ricordo si colloca nello spazio degli anni Settanta quando si verificò una convergenza, per nulla casuale, tra una ripresa delle iniziative per opera di alcuni investigatori di prim’ordine – Carlo Alberto Dalla Chiesa, Boris Giuliano, Bruno Contrada – e cresceva una nuova sensibilità a palazzo giustizia dove si faceva avanti una nuova generazione di magistrati preparati e motivati (Falcone non era ancora diventato Falcone).
C’era, va anche ricordato, una commissione antimafia che stava mettendo a nudo il nuovo volto di una mafia pervasiva e spietata con i suoi intrecci con la politica e la pubblica amministrazione. E c’era un’informazione che con le sue cronache e soprattutto con le sue inchieste era diventata il cane da guardia del vecchio sistema di potere, in cui mafia e politica componevano un blocco omogeneo. E contribuiva così, in modo direi determinante, alla maturazione di un nuovo clima civile.
L’Ora, dove svolgevo il mio apprendistato ai tempi della direzione di Vittorio Nisticò, era il posto in cui il tema della mafia era quotidianamente indagato e lo aveva fatto entrare nell’agenda politica del paese portandolo in prima pagina con la prima grande inchiesta del 1958. Il senso di quella coraggiosa scelta giornalistica era quello – lo spiegò Nisticò in un editoriale – di spogliare la mafia dell’alone romantico che la proteggeva e di mostrarne il vero volto, che è l’avidità di denaro e di potere. La mafia lo capì così bene che reagì piazzando una bomba nella tipografia del giornale.
L'assalto della mafia e la svolta nelle redazioni
Per un po’ di tempo L’Ora rappresentò nel panorama della stampa siciliana una voce isolata. Quella esperienza influenzò però le scelte di altre testate e soprattutto il Giornale di Sicilia che cominciava ad allontanarsi dal suo registro tradizionale e moderato. Di Michele Navarra, tanto per fare un esempio, la cui uccisione spianò la strada alla scalata dei corleonesi di Luciano Liggio, Totò Riina e Bernardo Provenzano si parlava come di un uomo di grande prestigio sociale. Era vero anche questo ma la sua vera collocazione era al centro di un sistema di potere fondato sull’alleanza tra Cosa nostra e la politica.
Ma da allora nulla fu più come prima. Il Giornale di Sicilia fu protagonista di una svolta con la direzione di Delio Mariotti a partire dal 1964. La discontinuità stilistica, giornalistica culturale è testimoniata dalla crescita di un nucleo di giovani che diedero un volto nuovo al giornale. C’era Mario Francese, c’erano Roberto Ciuni e Nicola Volpes che venivano dall’esperienza dell’Ora, c’erano Ettore Serio, Marina Pino, Armando Vaccarella, Giuseppe Quatriglio che si confrontavano con temi civili e politici magari con maggiore affinità con il centro sinistra e con il Concilio Vaticano II.
Con Francese il tema della mafia non venne più trattato con le cautele e lo stile notarile del passato. C’era un piglio rigoroso, un’ansia di approfondimento ma anche un impegno civile. Francese si occupava ogni giorno di traffici e delitti di mafia, descriveva i nuovi scenari criminali, intervistava la moglie di Riina. Ninetta Bagarella, ma sosteneva anche i testimoni scomodi nei processi di mafia come Serafina Battaglia e Maddalena Gambino, si impegnava a trovare un legale alle parti civili. E la mafia ricambiava con disprezzo livoroso.
Questo era il lavoro di un testimone animato da grande tensione professionale, che si trovava nei posti dove la cronaca si svolgeva – triplice omicidio in una bettola della Vucciria – e che cercava la notizia sul nascere come avrebbe ricordato l’avvocato Nino Sorgi.
Se questo è vero allora si comprende meglio perché, nella strategia di Cosa nostra dominata dai corleonesi, l’informazione era uno dei bersagli da colpire e una delle voci scomode da spegnere. Un segnale era già arrivato nel 1970 con la scomparsa di Mauro De Mauro e con gli attacchi al giornale L’Ora. La stessa offensiva diversificò poi i suoi itinerari e si indirizzò verso il Giornale di Sicilia. Dove Francese era una punta avanzata ma non era né un cavaliere solitario né una voce nel deserto. Nel complesso c’era una redazione che teneva lo sguardo vigile e un livello alto. Francese scriveva quei pezzi che un direttore accoglieva e un capo cronista passava. E sono il direttore Lino Rizzi a cui venne bruciata l’auto e il capo cronista Lucio Galluzzo a cui venne incendiata la casa a mare.
Il messaggio di intimidazione a tutta la stampa
Ricordare tutto questo serve ad avere del giornalismo siciliano di quella stagione la visione reale di un’esperienza collettiva, una storia originale e complessa che serve a comprendere il senso del caso siciliano. Francese, De Mauro e dopo di loro tutti gli altri come Cosimo Cristina, Giovanni Spampinato, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Pippo Fava, Beppe Alfano furono individuati come obiettivi da colpire perché erano portatori di un valore simbolico e perché erano gli interpreti più autentici, e quindi più pericolosi, di un’informazione con la schiena dritta che veniva esercitata dentro le regole classiche del giornalismo ma fuori da quelle che il sistema di potere mafioso aveva concepito per mettere sabbia negli ingranaggi della democrazia.
È qui, nel sistema democratico, che si annidavano i nemici di Cosa nostra: i giornalisti, gli uomini politici, i magistrati, i poliziotti che a partire dagli anni Settanta cercavano, ognuno nella propria sfera, di portare un’aria nuova e una spinta rinnovatrice nella vita pubblica e sociale. L’informazione venne così percepita dalla mafia come un pericolo concreto. E bisognava quindi spazzarla via, intimidirla, fermarla. Oggi si ricorre alle querele temerarie e all’assedio intimidatorio in carta bollata. Ai tempi di Francese lo strumento più impugnato era quello della violenza.
Lo spiegano molto bene i giudici del primo processo per l’omicidio Francese “volto non soltanto a fare tacere per sempre un cronista che, per il suo coraggioso impegno professionale e per il suo eccezionale patrimonio conoscitivo, costituiva una sicura fonte di pericolo per Cosa nostra, ma anche a dissuadere gli altri giornalisti dal lanciare attacchi contro l’organizzazione mafiosa”.
Proprio questo è ancora il grande tema con cui il giornalismo deve fare i conti.
*Già presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia
Assostampa e Gruppo cronisti siciliani il 26 gennaio in viale Campania per ricordare Mario Francese


 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431