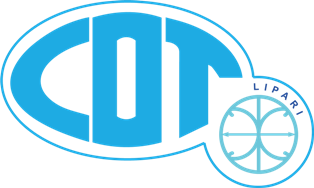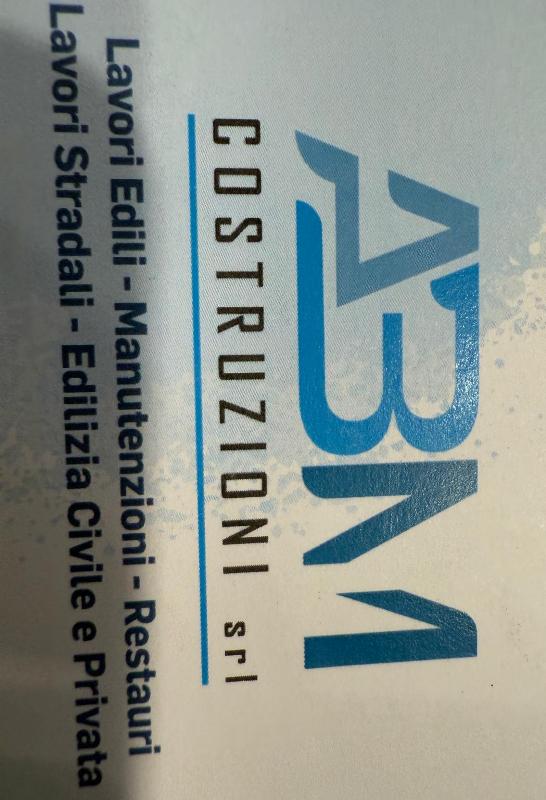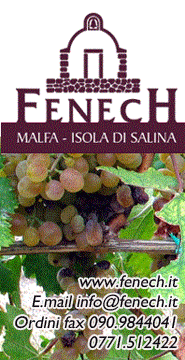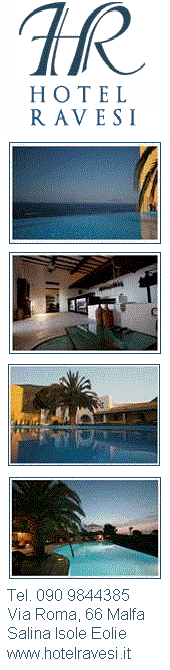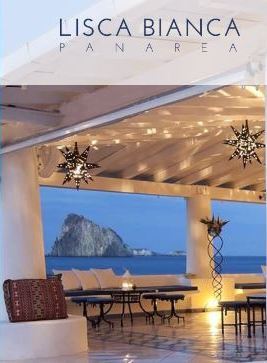Il carattere assoluto del divieto di edificabilità nella fascia di rispetto delle zone costiere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con sentenza è intervenuto in materia di disciplina urbanistica, ribadendo la sussistenza di un divieto edificatorio assoluto nelle zone costiere entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia.
L’art. 15, lett. a), L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78 prevede che “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”.
Il dato letterale della norma non legittima dubbi interpretativi in ordine al carattere assoluto della inedificabilità entro la suddetta fascia di rispetto: la ratio della disposizione è rivolta alla tutela delle coste siciliane e alla loro conservazione; a tal fine, nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate esclusivamente opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e possono essere ristrutturate, entro il rigoroso limite della inalterabilità dei volumi già realizzati, le opere che esistevano prima dell’emanazione della legge regionale in esame.
In particolare, per “opere dirette alla fruizione del mare" si intendono, in accordo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, le infrastrutture concretamente destinate a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta di potenziali utenti, l'uso del mare. Restano escluse, invece, le opere di uso strettamente private, e cioè quelle non aperte, neppure a titolo oneroso, all'uso pubblico (C.G.A. 18 maggio 2007, n. 390), e le iniziative rispetto alle quali l'ubicazione in vicinanza del mare si configuri come meramente accidentale o occasionale e quindi per la medesima non ricorra l'esigenza indefettibile di una ravvicinata prossimità alla costa né un rapporto di stretta e obiettiva strumentalità con la diretta fruibilità del mare (C.G.A. 6 ottobre 2010, n. 1264).
Al di fuori dei casi in cui vi sia la prova che l’opera ricade in zona A) e B) già qualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976, è irrilevante il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio e dell'ambiente (art. 9 Cost.), rispetto ai quali ogni altro interesse è recessivo.
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, infatti, viene considerata, dalla giurisprudenza prevalente, nella gerarchia degli interessi e beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio (Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839), restando a tal fine estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486).
La Corte costituzionale ha ribadito il valore assoluto e primario del paesaggio con le sentenze nn. 218 e 246 del 2017. Coerentemente con la finalità di tutela del paesaggio, da un lato è esclusa ogni discrezionalità dell’organo di gestione del territorio nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto (C.G.A. 8 maggio 2014, n. 242); dall’altro lato, destinatari del divieto in esame sono non soltanto gli enti locali ma anche i privati, in virtù dell'interpretazione autentica che della norma ha dato l'art. 2, L.R. 30 aprile 1991, n. 15 (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2006, n. 27129; Cass. civ., sez. I, 17 aprile 2003, n. 6173). Attesa l'inderogabilità del vincolo, non sussiste alcuna possibilità di rilascio di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria, per il disposto dell'art. 23, L.R. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2006, n. 27129).

“
Demo-ricostruzione e distanze nel nuovo articolo 2-bis del DPR 380/01: rose e spine
di Ermete Dalprato
Tutto risolto in materia di distanze tra fabbricati in caso di ricostruzione dopo il d.l. “Semplificazioni” (oggi legge n. 120/2020) come hanno pubblicizzato le notizie giornalistiche?
Forse no. L’Autore esamina nel dettaglio l’evoluzione della materia, riscontrando ancora ampi (se non addirittura ampliati) margini di indeterminazione interpretativa di una norma frettolosa, mal scritta (che già ha necessitato di interpretazione ministeriale), redatta più per assecondare la realizzazione di interventi diffusi che non per rifondare metodologie di intervento di rigenerazione urbana e che si pone in un confuso rapporto di continuità/discontinuità con interventi recenti di “semplificazione”.
Già l’articolo 5, comma 1, lettera b), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (detto “Sblocca Cantieri” convertito poi con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) aveva introdotto all’articolo 2-bis del DPR 380/01 il comma 1-ter con cui consolidava l’orientamento giurisprudenziale di poter conservare le distanze preesistenti in caso di demo-ricostruzione, a parità però di volume, sedime, altezza (ne abbiamo già parlato in “Distanze degli edifici e dintorni nella legge sblocca-cantieri”).
Questo comma è stato ora modificato dalla legge n. 120/2020 (“Semplificazioni”) per consentire anche ampliamenti di volume, altezza e sagoma, condizionati però ad una previa verifica dello stato di fatto sulla possibilità di traslazione del sedime per adeguare le distanze.
La pessima stesura letterale del comma
Estraiamo testualmente dal comma suddetto: “la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti” … “anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, …”
Queste parole di colore oscuro …” (direbbe il Poeta) non sono di immediata e lineare comprensione.
Ad una prima lettura l’affermazione testuale appare ovvia: se nella situazione di fatto non c’è possibilità di traslazione del sedime del nuovo costruendo edificio è ovvio che la ricostruzione va fatta per forza mantenendo le distanze precedenti: l’asserto appare quanto meno superfluo.
Il fatto poi che la condizione esaminata (impossibilità di traslazione) sia introdotta da un “anche” (che è una congiunzione) significa che è aggiuntiva all’altra situazione (opposta) in cui la traslazione è possibile, per la quale però si applica lo stesso regime di mantenimento delle preesistenze. Sennò non ha senso dire “anche”.
Ne consegue che la demo-ricostruzione in situ è (sarebbe) sempre ammessa.
Ma se così fosse allora non ci sarebbe stato bisogno di dirlo; l’asserto risulterebbe (come dicono i giuristi) ultroneo e anche incongruo visto che non modificherebbe la versione precedente del comma 1-ter.
Prevale l’interpretazione letterale o la volontà del Legislatore?
Però se il Legislatore è intervenuto a modifica del comma 1-ter precedente - che questa condizione di ricostruzione sul sedime preesistente già la prevedeva senza verifica dello stato di fatto - presumibilmente voleva dire altro.
Appare evidente lo scostamento tra interpretazione letterale e interpretazione logica (che sottende presumibilmente la volontà del Legislatore) per cui poco ci aiuta anche la tecnica classica di interpretazione legislativa dettata dall’articolo 12 delle Preleggi che prescrive che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Il testo letterale ci porta ad un esito che però ci fa presumere non sia l’intenzione del Legislatore. Non sarà che c’è un “anche” di troppo?
Possiamo dire che la norma è scritta male (anzi, malissimo)?
Nessuno lo ha fin qui rilevato (e la cosa mi stupisce) forse per rispetto del Legislatore.
La necessità dell’intervento interpretativo ministeriale
Però ha dovuto farlo la Circolare congiunta dei “Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Pubblica Amministrazione” del 2.12.2020 (nel testo ufficiale priva di data e di protocollo !?! - disponibile in allegato PDF in fondo all'articolo), la quale - per poter interpretare correttamente la norma - ha dovuto riscriverla togliendo l’“anche” sovrabbondante e (solo) così potendo affermare che vi è la possibilità di “… mantenimento delle distanze preesistenti se non è possibile la modifica dell’originaria area di sedime …” .
Altrettanto ha fatto poco dopo (il 29 dicembre 2020) anche la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 14 che, nel recepire la norma statale nel nuovo art. 10-ter della legge regionale n. 15/2013, l’ha anch’essa riscritta di sana pianta eliminando l’“anche” superfluo e fuorviante potendo così affermare che le distanze preesistenti sono conservabili solo “qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini”.
Restano spazi interpretativi nell’applicazione
Aderiremo dunque a questa lettura della norma (che, a livello nazionale, è interpretativa mentre per l’Emilia-Romagna è legge) facendo notare però che porta con sé alcune conseguenze e dubbi interpretativi:
intanto va definito come debba essere verificata l’impossibilità della traslazione del sedime: in base al limite fisico di vicinanza di altri edifici o anche solo al limite di particella catastale, del lotto di proprietà, di zonizzazione, … ? Si rammenti che la norma è orientata al rispetto delle distanze sia dai fabbricati che dai confini, e quindi ….
…. si apre un’alea interpretativa nel caso intermedio in cui sia possibile spostare il sedime dell’edificio da ricostruire, ma non in misura tale da “adeguarsi” in toto alle norme sulle distanze, ma solo da “migliorarle”: anzi il caso di spostamento che consenta il contestuale rispetto delle distanze sia dai fabbricati che dai confini risulterà certamente minoritario
Ci si troverà più spesso nel caso intermedio in cui si potranno soddisfare solo alcune di queste.
Si potranno allora conservare le misure preesistenti o ci si dovrà comunque distanziare anche solo un po’? Attuare cioè anche solo un “miglioramento”? A favore di quali distanze e a discapito di quali altre poi? Decide il privato senza un controllo pubblico?
E, se sì, si potranno poi nella nuova posizione intermedia eseguire quegli ampliamenti fuori sagoma (in pianta e in altezza) per realizzare gli “eventuali incentivi volumetrici” consentiti in caso di conservazione delle preesistenze?
La precedente norma e le motivazioni della modifica
Certo è che questa interpretazione pare confliggere con la consolidata giurisprudenza e anche con la precedente stesura del comma 1-ter che ammettevano la ricostruzione in sito (se legittima) tout court senza ipotesi di traslazioni; certo imponevano anche la conservazione di volumi e altezze.
Allora perché è stata modificata la norma? Solo per consentire ampliamenti sul preesistente?
Però così facendo, mentre prima la conservazione delle distanze preesistenti era sempre consentita, oggi non lo è più se è possibile la traslazione per adeguare le distanze alle norme vigenti e ciò anche se volessimo conservare il volume e le altezze. Ad una possibilità è conseguita una restrizione.
Non sarà che per venire incontro alla possibilità di incrementare i volumi in situ per consentire gli “eventuali incentivi volumetrici” ci siamo complicati la vita e ci siamo tolti delle possibilità?
Ma quali ampliamenti poi sono ammissibili?
Forse non tutti hanno notato che gli incrementi realizzabili fuori sagoma non sono quelli genericamente previsti dal piano regolatore, ma solo quelli definibili come “incentivi volumetrici” come già si desume dalla lettura del comma e come la Circolare congiunta 2.12.2020 dianzi richiamata ri-precisa asserendo tassativamente che sono riferibili “non a qualsiasi incremento volumetrico … ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano Casa” ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione”.
Forse questa precisazione raffredderà molti entusiasmi.
Una considerazione metodologica
Anche con questa limitazione comunque non vi ha dubbio che, nel merito il contenuto della norma è impattante (e discutibile).
Perché sarà anche vero che è logico conservare gli edifici esistenti (magari anche rinnovati per demo-ricostruzione) conservando le distanze preesistenti legittime (statuite dal titolo edilizio esistente e valido, come opportunamente dispone l’articolo 9-bis), ma un conto è conservare, un altro conto è ampliare; e, soprattutto, estendere per edilizia diretta e non per esito progettuale di un piano attuativo!
Si favorisce una densificazione conseguente ad interventi singoli e diffusi non controllati da un atto di pianificazione!
Si introduce però una limitazione territoriale innovativa e non irrilevante …
Forse perché è stato preso da questo scrupolo che il Legislatore ha introdotto una restrizione (inesistente in precedenza) e ha aggiunto un terzo periodo al comma 1-ter col quale esclude “gli interventi di demolizione e ricostruzione” per edilizia diretta “nelle zone omogenee A” e nelle “zone a queste assimilabili ….. centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico …”.
In queste aree le demo-ricostruzioni (tutte per come è scritta la norma) sono ammesse solo nei piani attuativi particolareggiati (di recupero e riqualificazione).
E anche questa limitazione (prima inesistente) è una cautela conseguente alla possibilità (anche se eventuale) degli ampliamenti volumetrici incentivanti.
… con difficoltà di individuazione ….
L’intento è chiaro: proteggere queste aree dalla densificazione incontrollata senza una pianificazione di dettaglio; meno chiara è l’individuazione delle aree di cui si è appena detto: per le “zone A” siamo tutti d’accordo e non ci sono margini interpretativi perché sono oggettivamente individuabili e codificate nel Piano Regolatore. L’aggiunta delle “zone a queste assimilabili … ecc. ecc. ecc. … ” o è superflua (perché sono anch’esse già qualificate “zone A” come dovrebbe essere) o introduce un elemento di indeterminazione e soggettività: chi le individua e come oltre le “zone A”?
…. e un superfluo appesantimento descrittivo
La chiusura del periodo è poi inutilmente gravata da un analitico richiamo al rispetto delle competenze preordinate o sovraordinate degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica (?)” e alla necessità di acquisire i relativi pareri “degli enti preposti”; richiamo superfluo perché scontato ed implicito.
L’obiettivo posto e i risultati attesi
L’obiettivo dichiarato è (sempre) la rigenerazione urbana.
A parte la pessima tecnica giuridica di redazione dell’articolo - ben lontana dalla chiarezza cristallina che si dovrebbe comportare la “semplificazione”, e che porterà difficoltà di interpretazione e di applicazione e potenziale contenzioso - si fatica a scorgere congruenza con i provvedimenti precedenti (anche recenti), con i quali si pone ora in continuità, ora in discontinuità (ora amplia, ora restringe le possibilità attuative) senza che si riesca ad individuare una linea coerente di evoluzione metodologica se non interventi parziali indotti per assecondare l’occasionalità del momento.
In questo momento si è evidentemente inclini a consentire la realizzabilità delle opere connesse ai vari incentivi fiscali ai quali pure siamo sensibili, ma pare lo si faccia in modo acritico e senza un disegno organico; questi provvedimenti normativi favoriranno (forse) l’attuazione degli interventi incentivati, ma non (credo) la Qualità Urbana.
Che non potrà, a posteriori, risultare spontaneamente dalla sommatoria di interventi diffusi affidati all’iniziativa privata senza una preordinata pianificazione urbanistica.
Questa non è rigenerazione urbana; al più è rigenerazione immobiliare attuata per legge e non per progetto d’insieme.
Responsabilità sanitaria, sì alla clausola claims made
La Suprema corte, sentenza ha chiarito che “non integra una decadenza convenzionale, nulla ex
La Cassazione torna a ribadire la legittimità della clausola claims made in un contratto assicurativo. La Terza sezione civile, sentenza n. 29483 depositata oggi, affrontando un caso di malpractice sanitaria, con condanna della azienda Ulss e conseguente richiesta di manleva, ha affermato il principio di diritto per cui: “La clausola «claims made» non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile”.
In primo grado, il tribunale aveva rigettato la domanda di manleva ritenendo valida la clausola “claims made” che subordinava, in ciascun contratto, la copertura assicurativa alla proposizione della prima richiesta di risarcimento del danno, da parte del terzo, nel periodo di vigenza del contratto, evenienza, nella specie, non verificatasi. Il giudice di seconde cure, dopo aver confermato la condanna risarcitoria della Usll, ne accoglieva parzialmente il gravame in merito alle domande di manleva, condannando due istituti assicurativi al pagamento dell’indennizzo.
E ciò sul presupposto della nullità della clausola che subordinava l’operatività della polizza all’avvenuta denuncia della richiesta del risarcimento del danno, da parte del terzo, in costanza di rapporto, trattandosi di clausola vessatoria (che avrebbe, come tale, richiesto la specifica approvazione per iscritto). Inoltre, la clausola sarebbe stata apposta in violazione dell’art. 2965 cod. civ, stabilendo una decadenza tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto all’indennizzo.
Proposto ricorso, la Cassazione l’ha rigettato. I giudici di legittimità hanno invece accolto uno dei motivi proposti in via incidentale. In particolare, gli istituti assicurativi contestavano la decisione della Corte di appello – secondo cui il termine per l’escussione dell’assicurazione era nullo, a norma dell’art. 2965 cod. civ., in quanto rendeva eccessivamente difficile l’esercizio del diritto -, perché in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite sulle “on claims made”.
Per la Suprema corte infatti non può darsi seguito – perché rimasto del tutto isolato – al principio al quale si è richiamata la sentenza impugnata, secondo cui deve ritenersi nulla, se non specificamente sottoscritta, la clausola “claims made”, ponendo a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà (n. 8894/2020).
Tale principio, prosegue, è in contraddizione con la giurisprudenza di legittimità e in particolare con le S.U. n. 9140/2016, secondo cui “deve escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle «richieste di risarcimento presentate all’Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione», in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione”.
La condizione racchiusa nella clausola in contestazione, infatti, “consente o preclude l’operatività della garanzia in dipendenza dell’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all’indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso”, con la conseguenza “che non v’è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell’art. 2965 cod. civ.”.
E tale “diversità di piani”, non comunicanti tra loro, in cui si collocano, rispettivamente, la clausola claims made e la disciplina dell’art. 2965 cod. civ. è riaffermata, sebbene in modo implicito, “ma senza equivoci”, dalla successiva sentenza n. 22437/2018, sempre delle Sezioni Unite.
Ne consegue, pertanto, che “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made «perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo», giacché l’atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l’operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell’assicurato”.
In conclusione, in accoglimento del solo terzo motivo del ricorso incidentale, proposto congiuntamente da Unipolsai Assicurazioni, Siat e Groupama Assicurazioni, la sentenza è stata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione sul merito – e sulle spese– in applicazione del citato principio di diritto.
Denunciare un collega che poi è stato assolto non è calunnia
di Pietro Alessio Palumbo
Secondo la Corte di Cassazione la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento di un dovere, rispondente a un interesse pubblico, che risulterebbe frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.
di Giulia Provino
La causale «prestito» dei bonifici prova l’esistenza del contratto di mutuo
Sì alla domanda di restituzione delle somme date a titolo di finanziamento se il convenuto non giustifica il suo diritto a trattenere il denaro ricevuto
La causale «prestito» dei bonifici effettuati è idonea a dimostrare la ricorrenza di un contratto di mutuo tra le parti. È legittima, dunque, la domanda di restituzione delle somme date a titolo di finanziamento, se il convenuto non giustifica il suo diritto a trattenere il denaro ricevuto. Con l’ordinanza depositata il 29 marzo 2023 (qui leggibile in fondo all’articolo) la Cassazione ha accolto il ricorso dell’attrice per la restituzione delle somme versate a titolo di prestito.
Sbaglia la Ctr a non attribuire rilevanza probatoria alle presunzioni gravi, precise e concordanti da cui si sarebbe potuta desumere la sussistenza di un rapporto di mutuo, incorrendo così nel vizio di sussunzione. Ad avviso della parte attrice, la causale «prestito» apposta sugli ordini di bonifico, l’entità delle somme di volta in volta versate, la destinazione delle somme al fine di ripianare l’esposizione debitoria della controparte e della sua impresa individuale avrebbero dovuto indirizzare il giudice verso la conclusione della raggiunta dimostrazione della ricorrenza di un contratto di mutuo e non escluderne l’integrazione in forza di considerazioni non confacenti con i fatti addotti.
In particolare, la parte che domanda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione, purché l’attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra.
In caso di rigetto della domanda di restituzione dell’asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza tale allegazione, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l’una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Nel caso in esame, a fronte di un’espressa imputazione del versamento da parte dell’attrice, documentata dalla causale «prestito» dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova (diretta) dell’esistenza del rapporto di mutuo, come invocato dalla ricorrente, non si è attenuto al principio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un’allegazione difensiva della controparte che si è basata unicamente su asserite cause alternative addotte solo in epoca successiva alla dazione della somma, e non già al momento in cui è stata richiesta, mediante lettere raccomandate, senza elementi presuntivi volti ad avvalorare tali cause alternative e senza che emerga un’altra, plausibile, diversa ragione per il versamento, alla luce delle inferenze offerte.
di Dario Ferrara
Scudo penale su evasione e compensazione indebita a chi paga prima della sentenza d’appello
Non punibilità speciale per omesso versamento ritenute e Iva per chi aderisce alla tregua fiscale della legge bilancio 2023: il versamento stoppa il processo, incidente probatorio durante lo stop
Colpo di spugna sui reati tributari. È in vigore il dl bollette con lo scudo penale per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di Iva e indebita compensazione: all’articolo 23 del decreto legge 34/2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 76/2023, si stabilisce che i tre reati «non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti» dalla tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2023, a patto che «le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello».
di Dario Ferrara
Abuso del processo moltiplicare i pignoramenti: al legale compensi e spese per un’esecuzione sola
In mala fede il frazionamento del credito: riuniti i procedimenti, il giudice liquida somme corrispondenti alla notifica di un unico atto, pari alla somma dei titoli azionati separatamente
È inutile per l’avvocato frazionare l’unico credito azionando tanti pignoramenti quanti sono i titoli: in tal caso il giudice dell’esecuzione liquida al creditore procedente unicamente le spese e i compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e di un unico pignoramento di valore pari alla somma dei titoli azionati separatamente. E ciò perché si tratta di una condotta non conforme a correttezza e buona fede se il frazionamento del credito avviene senza alcun vantaggio o interesse per il creditore: scatta, dunque, la condanna per abuso del processo. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 3 marzo 2023 dalla terza sezione civile della Cassazione (leggibile in fondo all’articolo).
Modica entità
Bocciato il ricorso proposto dal legale: diventa definitiva la decisione che rigetta l’opposizione agli atti esecutivi, condannando il professionista al pagamento di un’ulteriore somma per responsabilità processuale aggravata. L’avvocato è creditore del Comune sulla base di sette titoli giudiziali: aziona altrettanti precetti e pignoramenti presso terzi. Il giudice dell’esecuzione riunisce i procedimenti: assegna al creditore meno di 3.200 a titolo di capitale e spese di precetto, circa 670 di rimborso spese della procedura esecutiva e 625 euro per onorari. Non giova al professionista lamentare la mancata liquidazione delle spese successive all’ordinanza di assegnazione e la sottostima dei compensi: il frazionamento del credito costituisce una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede perché aggrava inutilmente la posizione del debitore, specie se si considera che tre pignoramenti hanno per oggetto crediti di pochi euro.
Condotta colposa
È il principio di autoresponsabilità applicato alle spese processuali a rendere irripetibili gli esborsi sostenuti senza alcun vantaggio per il creditore, che non allega né tantomeno prova quale legittimo frutto intenda trarre dalla moltiplicazione delle procedure esecutive o quale rischio evitare. Insomma: avviare tante procedure esecutive quanti solo i titoli costituisce una condotta colposa che comporta spese superflue. Condanna ex articolo 96, comma terzo, Cpc confermata perché l’opposizione del legale lamenta la «matematica violazione» dei parametri minimi.
Un italiano e un tunisino fermati dai poliziotti mentre cercavano di aprire la cassaforte di un albergo sul litorale veneto, dopo essersi già impossessati di un televisore. Il tentativo di furto c’era, la refurtiva pure, la flagranza di reato era consumata davanti agli occhi degli agenti, eppure mancava il requisito che dall’1 gennaio consente l’azione penale in questi casi, dopo l'entrata in vigore della riforma del governo Draghi: la querela di parte. Il proprietario dell'hotel, infatti, è un magnate russo che in quel momento era assente.
di Dario Ferrara
Demolizione annullata se il giudice non spiega perché è impossibile riportare l’opera a norma
In zona sismica il manufatto va abbattuto solo per l’inosservanza di norme tecniche. Ma anche per le violazioni sostanziali va motivata la scelta di non impartire le prescrizioni necessarie alla conformità
Annullato. Cade l’ordine di demolizione per l’abuso edilizio anche se resta la condanna per il proprietario. E ciò perché pure in zona sismica il manufatto deve essere abbattuto soltanto di fronte a violazioni sostanziali e non formali. Ma anche quando sussiste l’inosservanza di norme tecniche le ruspe non entrano in azione in automatico: il giudice deve comunque spiegare perché ritiene di non impartire le prescrizioni necessarie a rendere le opere conformi alla legge. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 20 gennaio dalla terza sezione penale della Cassazione (leggibile in fondo all’articolo).
Mera denuncia
È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il ricorso proposto dall’imputato. Che in primo grado è condannato per aver realizzato in area a rischio terremoto interventi senza il permesso di costruire, il deposito del progetto al genio civile né l’autorizzazione ai lavori in zona sismica. Il Tribunale ordina la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino. La Corte d’appello assolve l’imputato dal primo reato - per le opere realizzate bastava la semplice denuncia di attività - e revoca l’ordine di ripristino. Ma conferma quello di demolizione perché previsto dalle norme sulle zone sismiche.
Corrispondenza perfetta
Il giudice, tuttavia, può esercitare il potere-dovere ex articolo 98, comma terzo, del testo unico dell’edilizia soltanto a determinate condizioni: deve sussistere una perfetta corrispondenza tra il fatto oggetto di contestazione, quello oggetto di condanna e l’ordine di demolizione nella zona spesso interessata da movimenti tellurici; in caso di contestazione - e condanna - per violazioni soltanto formali non basta l’accertamento in via incidentale anche dell’inosservanza di norme tecniche: senza una contestazione suppletiva l’ordine di demolizione non può scattare, anche se il giudice ritiene che i lavori possano aver minato la stabilità dell’immobile, come nel nostro caso. Trova dunque ingresso la censura della difesa: non risulta contestata la violazione di alcuna norma tecnica né il pm ha disposto accertamenti. La sentenza è annullata senza rinvio soltanto rispetto all’ordine di demolizione, che è eliminato.
di Debora Alberici
Tassati come redditi diversi i proventi dell'abuso d'ufficio
Ai fini dell’imponibilità non è necessaria una sentenza definitiva di condanna
I proventi dell’abuso d’ufficio, anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, devono essere tassati come redditi diversi.
A due passi dall’attesa riforma, la Corte di cassazione – con una ordinanza leggibile in fondo all’articolo – ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, chiarendo un aspetto importante.
Ad avviso della sezione tributaria, i proventi derivanti da fatti illeciti, qualora non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, vanno, comunque, considerati come redditi diversi, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 36, comma 34-bis, di. n. 223/2006, norma quest’ultima avente efficacia retroattiva, in quanto di interpretazione autentica dell’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993.
Di più. Per la Suprema corte non occorre che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.
di Giulia Provino
Sequestrato per reati fiscali l’immobile conferito nel fondo patrimoniale
Il vincolo di destinazione che caratterizza il cespite non ne esclude la disponibilità in capo al soggetto che materialmente ne ha il godimento
Sì al sequestro per omesso versamento Iva disposto sulla villa in cui vive l’indagato, acquistata però dall’ex e costituita in un fondo patrimoniale familiare. Il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo al soggetto che materialmente ne ha il godimento. È quanto contenuto nella sentenza della Cassazione depositata il 12 gennaio 2023 (qui leggibile in fondo all’articolo.
Rigettati i ricorsi dei due coniugi, dichiaratamente separati di fatto, avverso il decreto
con cui, il gip aveva disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di un immobile acquistato in origine dal marito, indagato per evasione fiscale, e conferito in un fondo patrimoniale familiare per poi essere acquistato dalla moglie, da lui separata. In particolare, con riferimento al ricorso della donna, a nulla rileva il fatto che l’immobile era stato conferito in un fondo patrimoniale familiare e successivamente acquistato dalla moglie, pur rimanendo fermo il vincolo segregativo derivante dal ricordato conferimento dell’immobile nel fondo patrimoniale.
Nel caso in esame, il Tribunale si è dato carico di evidenziare gli elementi che chiaramente deponevano nel senso della materiale disponibilità del bene in capo all’ex, quali la circostanza che nell’immobile in questione il marito, cioè il soggetto indagato, viveva stabilmente con una persona diversa dalla moglie, la quale occupava, a sua volta un ulteriore immobile da lei acquistato successivamente all’avvenuto acquisto di quello oggetto di sequestro. Tale circostanza è fortemente indicativa del fatto che la moglie non avesse altro che la formale disponibilità dell’immobile, tanto da doverne acquistare, per abitarlo, un altro. Inoltre, è stata evidenziata anche l’intestazione solo apparente dell’immobile alla donna, in quanto non risultava essere stato pagato da questa il corrispettivo dell’avvenuto acquisto.
Rilevata, così, la non decisività della circostanza che il bene fosse stato conferito in un fondo patrimoniale, considerato che, essendo un siffatto istituto finalizzato a preservare, in quanto destinati alla soddisfazione dei primari interessi familiari, determinati beni dagli effetti delle eventuali esecuzioni derivanti dal mancato adempimento di obbligazioni di carattere civile estranee a quelle contratte nell’interesse, appunto, della famiglia, la segregazione derivante dal conferimento del bene nel fondo patrimoniale familiare non è opponibile alle ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, da disporre nella sede penale, posto che il vincolo di destinazione che caratterizza il bene non ne esclude la disponibilità in capo al soggetto che materialmente ne ha il godimento.
Reato di molestia suonare il clacson per disturbare il vicino
Va condannata per il reato specifico di cui all'art. 660 c.p, che punisce la molestia o il disturbo alle persone, l'imputata che per ben otto mesi suona ripetutamente e con insistenza il clacson nei pressi dell'abitazione del vicino a tutte le ore del giorno, con l'obiettivo, per un motivo biasimevole e petulanza, di disturbare la quiete e la tranquillità della persona offesa. Questa la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 49268/2022 (sotto allegata) che conferma così l'ammenda di Euro 400,00 sancita dal Tribunale.
La vicenda ha infatti inizio con la condanna alla pena condizionalmente sospesa del pagamento di una ammenda di 400 euro per la vicina colpevole del reato di molestie art. 660 c.p che per petulanza e altri biasimevoli motivi ha recato disturbo a un vicino di casa suonando ripetutamente il clacson della sua auto nei pressi dell'abitazione della persona offesa, senza motivo, di giorno e di notte.
Non regge la versione dell'imputata che ha giustificato la sua condotta con la necessità di segnalare la sua presenza in strada.
Il difensore in Cassazione si gioca la carta della sola violazione amministrativa prevista dall'art. 156 dl Codice della Strada, che punisce con una multa minima di 42,00 euro fino a un massimo di 173,00 euro l'utilizzo improprio dei segnalatori acustici. Contesta inoltre la prova dei fatti basata sulle testimonianze dei genitori della persona offesa, trascurando quella di una teste della difesa. Con gli altri motivi poi si duole della qualificazione dei fatti, riconducibili piuttosto all'art. 659 c.p che punisce il disturbo delle occupazioni e del riposo. Contesta la concessione del beneficio della sospensione della pena e infine invoca il riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.
Motivi che però non convincono gli Ermellini i quali escludono che la condotta dell'imputata possa integrare l'illecito amministrativo di cui all'art. 156 del Codice della Strada o il reato meno grave di cui all'art. 659 cp invocato dal difensore. Il comportamento della stessa infatti era finalizzato specificamente a recare disturbo o molestia al vicino di casa per biasimevole motivo e con petulanza.
Cassazione: per condannare il medico vanno indicate le norme violate
Per la Cassazione, non si può condannare il medico per omessa o tardiva diagnosi se non vengono individuate con esattezza le norme che si ritengono violate, in questo modo non è possibile comprendere l'addebito
Una dottoressa viene condannata in primo e secondo grado per il reato di lesioni colpose gravi perchè, a causa della omessa diagnosi di carcinoma mammario, una donna è stata colpita dalla crescita del carcinoma da cui è derivata una malattia di 127 giorni.
Verdetto a cui la dottoressa si oppone nel ricorso in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza. Di carattere assorbente la prescrizione del reato, che conduce all'annullamento della sentenza senza rinvio con esame in ogni caso dei motivi ai fini civili da parte degli Ermellini.
Per la Cassazione, che, con la sentenza n. 46662/2022 (sotto allegata), accoglie il secondo motivo del ricorso, nel valutare i profili di colpa medica il giudice deve prima di tutto individuare puntualmente la regola dell'arte medica violata, precisando, se il caso di specie è regolato da linee guida o da buone pratiche clinico assistenziali, verificando se e in che misura il medico si è discostato dalle stesse.
Dalle prove è emerso che una diagnosi c'è stata e che la dottoressa ha proposto alla paziente due prelievi, suggerendo quello istologico. Non è quindi chiaro se l'addebito è stato mosso in ragione di una omessa o tardiva diagnosi o di una scelta inappropriata dell'intervento diagnostico o terapeutico.
Il quadro è lacunoso e contraddittorio tanto che non è dato comprendere esattamente l'addebito e le norme violate dalla dottoressa.
Annullata senza rinvio quindi la sentenza impugnata agi effetti penali perchè il reato si è estinto per prescrizione e annullata con rinvio ai soli effetti civili.
di Vanessa Ranucci
L’appello contro la sentenza di separazione va trattato con rito camerale e introdotto con ricorso e non con citazione
Respinto il ricorso di un ex marito che ha depositato l'atto oltre il termine
L’appello contro la sentenza di separazione va trattato con rito camerale e introdotto con ricorso e non con atto di citazione. Lo ha stabilito oggi la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 11964/22.
Il gravame promosso da un ex marito in un giudizio di separazione era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello perché proposto con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il prescritto termine breve, benché la sua notificazione fosse avvenuta entro il termine. Per il Giudice di merito, l’appello contro le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio.
Il ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato la decisione di merito ritenendo tempestiva e rituale l'impugnativa di appello alla sentenza di primo grado con l’atto di citazione invece che del ricorso.
Per i Supremi giudici, concordi con il magistrato distrettuale, il ricorso va respinto. “L'appello avverso le sentenze di divorzio rese dal tribunale, - si legge nel documento - ai sensi dell’art. 4, comma 12, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987, - a norma del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio" - è soggetto al rito camerale, sia quanto alla fase decisoria sia quanto all'intero procedimento, e quindi anche con riferimento all'atto introduttivo, il quale deve avere la forma del ricorso ed essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 Cpc, con la conseguenza che l'appello, che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione dagli atti giuridici viziati, solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto di tali termini”.
Pertanto, il ricorso va respinto con condanna delle spese.
Stop a Google Analytics: secondo il Garante viola la normativa dei dati personali
Dall’indagine condotta dal Garante Privacy è emerso che Google Analytics invia i dati personali degli utenti agli Stati Uniti, un paese privo di adeguati livelli di protezione.
Secondo il Garante Privacy, Google Analytics viola la normativa sulla protezione dei dati personali perché trasferisce le informazioni negli Stati Uniti, un paese privo di un sufficiente livello di protezione.
Dall’indagine dell’Autorità, infatti, è emerso che i gestori di Google Analytics raccolgono le informazioni sulle interazioni degli utenti con i siti, tra cui l’indirizzo IP del dispositivo, che è un dato personale, oltre alle informazioni sul browser, sul sistema informativo, sulla lingua selezionata e sulla data e l’ora della visita al sito web.
In particolare, l’Autorità ha sottolineato la possibilità, da parte dell’intelligence statunitense, di accedere ai dati degli utenti trasferiti negli USA, rilevando che «alla luce delle indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti».
di Dario Ferrara
Grazie alla Ue il datore non può di fatto pagare meno il dipendente quando è in ferie
Prassi e omissioni che disincentivano la fruizione dei riposi sono incompatibili con la finalità di tutela della salute. Nulla la clausola del Ccnl che esclude alcune indennità dalla base della retribuzione
Il datore non può, di fatto, risparmiare sulla retribuzione soltanto perché in quel momento il dipendente si trova in ferie. E ciò perché il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante per l’Unione europea. In base all’articolo 7 della direttiva 2003/88 i periodi di riposo servono al lavoratore per svagarsi oltre che per recuperare le energie. E ogni incentivo a rinunciare al congedo è incompatibile con gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza. Risultato: è nulla la clausola del contratto collettivo di lavoro che esclude alcune indennità percepite dai lavoratori dalla base di calcolo della retribuzione durante le ferie. È quanto emerge da una sentenza della sezione lavoro della Cassazione.
Efficacia vincolante
Bocciato il ricorso della compagnia aerea: è nulla la clausola del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore laddove esclude l’indennità di volo integrativa dalla base di computo dello stipendio da versare nel periodo feriale. E ciò perché la disposizione pattizia risulta in contrasto con la norma imperativa ex articolo 4 del decreto legislativo 185/05, così come interpretato alla luce del diritto europeo. Decisiva sul punto la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea nella causa C-514-20, pubblicata il 13 gennaio scorso: pronuncia che non è qualificabile come ius superveniens ma ha efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale.
Effetto deterrente
È la direttiva Ue a prescrivere che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché ogni lavoratore possa beneficiare di almeno quattro settimane di ferie retribuite: i Paesi partner possono definire le condizioni di esercizio e attuazione ma non subordinare ad alcuna condizione la costituzione del diritto. E dunque ogni azione o omissione del datore che, anche potenzialmente, può dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie annuali è incompatibile con l’obiettivo di garantire un riposo effettivo del prestatore: non c’è dubbio che la prospettiva di guadagnare di meno rispetto al periodo di ordinario servizio costituisca un deterrente, almeno sulla carta. La parola passa al giudice del rinvio.
Gli inerti da costruzione e demolizione non sono più rifiuti In vigore le nuove norme per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni
A partire dal 4 novembre scorso i rifiuti inerti derivanti da costruzione e demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, non sono più qualificati come rifiuti.
Lo stabilisce il DM 152 del 27 settembre 2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR. Il DM 152/2022, composto da 8 articoli e 3 allegati, definisce:
- i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
- gli obblighi documentali.
Il provvedimento - spiega il Ministero - individua anche un percorso amministrativo innovativo, una sorta di ‘tagliando’, frutto delle interlocuzioni con il Consiglio di Stato, per tenere conto delle specificità applicative e della complessità di un settore che interessa piccole, medie e grandi imprese.
Al tal fine, i tecnici del dicastero, secondo gli indirizzi del ministro Gilberto Pichetto stanno già lavorando con il supporto di ISPRA ed ISS, per acquisire gli elementi tecnici necessari, sotto il profilo ambientale e sanitario, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti al provvedimento, prima del termine della fase di monitoraggio di 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma.
Comuni: per l'affidamento dei servizi legali serve la procedura concorsualeTAR, Campania-Salerno, sez. II, sentenza 16/07/2014 n° 1383
L'affidamento di servizi legali in ambito comunale, configurabile quando l’oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma nella modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, deve avvenire nel rispetto di una procedura di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
Così ha deciso il TAR Campania nella sentenza in commento.
Nella fattispecie, un avvocato aveva impugnato la delibera con la quale un Comune aveva conferito ad altri due avvocati “l’incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità” da svolgersi per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a tutti gli organi comunali, per la durata di un anno.
Per il ricorrente, il Comune, vista la natura dell’incarico in questione, avrebbe dovuto porre in essere una procedura concorsuale di tipo selettivo, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, aspiravano al conseguimento dell’incarico.
Il Tar, in via preliminare, ha dichiarato la propria giurisdizione in materia in quanto “il petitum sostanziale fatto valere nel presente ricorso non attiene alla pretesa del ricorrente di conseguire l’incarico, bensì alla pretesa di legalità dell’azione amministrativa, ossia alla pretesa che l’amministrazione, pur quando agisce secondo il diritto privato, pervenga alla selezione del contraente sulla base di procedure amministrative trasparenti e non discriminatorie, aperte alla partecipazione di tutti gli aventi diritto, con la conseguenza che la cognizione sulla presente controversia deve ritenersi a pieno titolo ascritta al giudice amministrativo” (T.a.r., Campania, Napoli, Sez. V, 24 gennaio 2008, n. 382).
In secondo luogo, osserva il giudice amministrativo, l’interesse a ricorrere dell’avvocato è rinvenibile nella circostanza che lo stesso non invoca il diritto a vedersi conferire l’incarico di cui alla delibera impugnata. Piuttosto, lamenta la mancata attivazione di una procedura di tipo comparativo idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente.
Quanto al merito della vertenza, il Tar ha osservato che nella fattispecie in esame l’incarico affidato ai legali esterni non consisteva nell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma nella organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.
Ora, mentre il patrocinio legale è un contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, il servizio legale rappresenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa.
In tal senso è l’orientamento della giurisprudenza sia contabile che amministrativa, secondo cui occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d’opera intellettuale.
La complessità e articolazione del servizio legale giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.
Ciò è conforme anche alla previsione di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/01, per cui le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificamente individuati dal legislatore.
Per tali ragioni, in conclusione, il giudice amministrativo ritiene che il Comune avrebbe dovuto attivare una procedura comparativa allo scopo di selezionare, secondo logiche concorrenziali, il proprio contraente, e che pertanto la delibera impugnata debba essere annullata.
Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale sull'abitazione principale
di Stefano Baldoni*
La Corte costituzionale ha sciolto il nodo relativo all'applicazione dell'agevolazione prevista in materia di Imu per l'abitazione principale, nell'ipotesi di coniugi con residenze separate. Aprendo la porta alla possibilità che il medesimo nucleo familiare possa avere due abitazioni principali ai fini del tributo. La questione era sorta in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, prima, e dell'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019, dall'anno di imposta 2020, in base alle quali l'abitazione principale, non soggetta al tributo nell'ipotesi in cui non appartenga alle categorie catastali A/1-A/8 o A/9, è l'unità immobiliare a uso abitativo destinata a dimora abituale e a residenza anagrafica tanto del possessore che del suo nucleo familiare.
Le disposizioni appena sopra richiamate disciplinano il caso in cui due coniugi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni site nel medesimo Comune, prevedendo che una delle due possa beneficiare dell'agevolazione di legge. Nell'ipotesi in cui, invece, i due coniugi abbiano residenze anagrafiche ubicate in due Comuni diversi, la Corte di cassazione, con numerose pronunce (tra le tante ordinanze n. 416-4170/2020, 1199/2022), aveva ritenuto che, in base al principio della stretta interpretazione letterale delle norme agevolative in campo tributario, nessuna delle due abitazioni potesse ritenersi residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare, con la conseguente tassabilità di entrambe.
Il legislatore aveva cercato di porre parzialmente rimedio a suddetta drastica conclusione, all'inizio di quest' anno, adottando una disposizione, non interpretativa, in base alla quale veniva estesa, anche all'ipotesi di residenze separate dei coniugi in comuni diversi, la possibilità per il nucleo familiare anagraficamente scisso di beneficiare comunque dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale per una delle due abituazioni, da individuarsi a scelta dei componenti del nucleo familiare (utilizzando una formulazione assai infelice che, in ogni caso, voleva intendere quella scelta come dimora abituale della famiglia - articolo 5-decies del Dl 146/2021).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, dichiara l'illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del Dl 201/2011 e nell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della legge/ 160/2019, come anche modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021. In particolare, la Corte ritiene che l'abitazione principale debba essere l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come prevedono le norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare.
Tuttavia, la Corte costituzionale non ha voluto estendere tout court ai coniugi con residenze separate il diritto all'agevolazione per entrambi gli immobili, ma solo a quelli in cui effettivamente ciascun coniuge risiede anagraficamente ed ha la propria dimora abituale (ossia dove vive abitualmente).
Quali sono le conseguenze della pronuncia di illegittimità? Le pronunce di illegittimità costituzionale hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comportano non già l'abrogazione, la cauducazione, l'annullamento o la nullità della norma illegittima, ma solo la sua disapplicazione, producendo un effetto che si pone in una posizione intermedia tra l'abrogazione, che ha efficacia ex nunc (non retroattiva) e l'annullamento, che ha invece efficacia ex tunc (retroattiva). La Corte di cassazione ha evidenziato che la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e nei rapporti ancora in corso di svolgimento, al di là dei casi eccezionali in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima (avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima).
La Corte di cassazione ha sostenuto in più occasioni come la decisione di illegittimità costituzionale di una norma non abbia effetto sui rapporti esauriti. «Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza». (Cassazione civile, sezione III, 28 luglio 1997 n. 7057). Premesso il sopra consolidato principio, si possono ipotizzare le seguenti casistiche:
• Avvisi accertamento notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini, siano essi pagati o non pagati: si tratta in questo caso di rapporti esauriti, sui quali non ha effetto la decisione della Corte, come precisato dalla sentenza della Cassazione n. 969/2016. In proposito ci si domanda se l'ente possa provvedere comunque al loro annullamento ed all'eventuale rimborso delle somme pagate, esercitando il proprio potere di autotutela, eventualmente sollecitato dal contribuente. Nel rammentare che l'autotutela è una facoltà e non un obbligo per la pubblica amministrazione, facoltà che può interessare anche avvisi di accertamento definitivi, va evidenziato che il suo esercizio deve derivare dalla valutazione discrezionale, spettante alla pubblica amministrazione, in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, alla eliminazione dell'atto. In sostanza effettuando un bilanciamento tra l'interesse pubblico volto al ripristino della legalità e quello legato alla conservazione dell'atto.
Peraltro, nell'eventuale considerazione che l'amministrazione ritenesse di dare all'interesse ad essere ristorati delle somme pagate (o comunque all'annullamento) dei soggetti che sono stati oggetto di accertamento in base ad una norma di legge dichiarata successivamente incostituzionale, va senza dubbio dato il giusto peso, dall'altra parte, all'interesso pubblico dell'ente alla conservazione delle somme e degli equilibri di bilancio, principio fissato dalla Costituzione. Specie alla luce dell'indisponibilità della pretesa tributaria, che condiziona l'eventuale valutazione della responsabilità amministrativa potenzialmente conseguente.
Appare infatti ardito sostenere che l'annullamento di atti divenuti definitivi (tra l'altro si evidenzia non illegittimi ad origine) possa essere sicuramente scevro di qualunque potenziale responsabilità erariale. In questo caso resta sempre la possibilità che il contribuente impugni il diniego di autotutela, rammentando però che la giurisprudenza ritiene che l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo diventato definitivo «è atto discrezionale dell'amministrazione finanziaria e che nell'ambito del processo tributario il sindacato sull'atto di diniego a procedere all'annullamento del provvedimento impositivo in autotutela può riguardare solo la eventuale sussistenza di profili di illegittimità del predetto rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere che si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali, non costituendo strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente» (Cassazione n. 17723/2022).
• Contenziosi decisi con sentenza passata in giudicato, ossia quelli oggetto di decisione definitiva: si tratta di rapporti esauriti, non interessati dalla sentenza della Corte.
• Contenziosi pendenti: per quest'ultimi, qualora la ragione del contendere sia solo il mancato riconoscimento del beneficio per l'assenza della destinazione dell'immobile a residenza anagrafica di entrambi i coniugi, ovvero se il contribuente abbia sollevato l'eccezione di incostituzionalità, l'ente andrà incontro alla soccombenza, per cui dovrà valutarsi l'abbandono del contenzioso. Non altrettanto invece se il contenzioso è fondato su motivazioni diverse da quella di oggetto di esame da parte della Corte (ad esempio, motivi formali o procedurali, ossia contestazione sull'effettiva destinazione a dimora abituale, eccetera).
• Pagamenti spontanei effettuati dai contribuenti: i contribuenti che hanno provveduto al pagamento dell'imposta (ad esempio i coniugi che hanno pagato l'imposta in quanto residenti in comuni diversi, ovvero che residenti in immobili diversi nello stesso comune hanno limitato l'esenzione ad uno solo di essi) possono richiedere il rimborso delle somme pagate entro il termine di 5 anni, stabilito dal comma 164 dell'articolo 1 della legge 296/2006. In questo caso il rapporto non è esaurito ed il rimborso dovrà essere concesso, maggiorato dei relativi interessi, calcolati con il tasso stabilito dall'ente.
Ovviamente a condizione che i contribuenti dimostrino comunque che l'immobile di residenza anagrafica sia anche la propria dimora abituale, in base al principio per cui compete a chi invoca un'esenzione tributaria dimostrare la sussistenza dei suoi presupposti (pur se occorre valutare se la presunzione di legge di dimora abituale della residenza possa esimere da prova). É da ritenere che il termine iniziale del periodo quinquennale decorra dalla data del pagamento, come afferma il comma 164 citato, come si evince dalla sentenza della Corte di cassazione n. 969/2016. E' evidente che l'impatto in termini di oneri per gli enti è ben differente. I pagamenti effettuati prima del termine per la richiesta di rimborso sono da ritenere invece esclusi, in quanto il rapporto è esaurito. Per i pagamenti effettuati nel corso del 2022 il contribuente, qualora abbia altri cespiti imponibili, potrà compensare le somme versate con il saldo di dicembre.
• Accertamenti non definitivi: si tratta degli avvisi di accertamento per i quali non è scaduto il termine per la presentazione del ricorso, ovvero per i quali è pendente il giudizio avanti alle Corti di giustizia tributaria o alla Corte di cassazione. Rientrano in questa casistica anche gli avvisi per i quali il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione, nel periodo di 90 giorni successivi alla scadenza del termine originario di impugnazione dell'avviso. In questo caso l'ente dovrà annullare totalmente o parzialmente gli avvisi a seconda che basino in tutto o in parte il recupero del tributo accertato sulla mancata coincidenza della residenza dei coniugi. In questo caso, infatti, il rapporto non è esaurito e viene travolto dalla pronuncia di incostituzionalità.
Nell'ipotesi in cui, invece, l'ente abbia contestato la debenza dell'imposta non solo evidenziando la mancata coincidenza della residenza anagrafica dei coniugi, ma anche dimostrando la mancata destinazione a dimora abituale dell'immobile da parte del possessore, l'avviso resterà pienamente valido. Come ha ricordato la Corte costituzionale nella sentenza qui commentata, la dichiarazione di incostituzionalità non determina «in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta». Questa è la situazione di molti comuni turistici, nei quali è frequente la presenza di abitazioni con residenze "fittizie", ossia non assistite dalla contemporanea destinazione dell'immobile a dimora abituale. Verifica, quest'ultima, tutt'altro che agevole e che riporta indietro le lancette a prima del 2012, allorquando nella vecchia Ici solo l'assenza della destinazione a dimora abituale faceva perdere il beneficio dell'agevolazione.
Occorre evidenziare che ancora una volta i comuni si trovano a scontare gli effetti di interventi normativi non sempre del tutto felici, pur avendo gli stessi operato sulla base della stretta interpretazione letterale delle norme, nonché di un largamente consolidato orientamento della Corte di cassazione, subendone oggi le conseguenze finanziarie ma, soprattutto, procedurali, che finiscono per ingolfare ancora di più gli uffici tributi degli enti locali.
*Vice presidente Anutel
di Remo Bresciani
Il notaio risarcisce la banca se non rileva l’uso civico sull’area dove è costruito il bene oggetto del mutuo
Quando ci sono indici di allerta legati alla localizzazione dell’immobile il professionista incaricato è tenuto a effettuare indagini approfondite anche sui terreni
Il notaio risarcisce la banca se non rileva l’uso civico sull’area dove è costruito il bene oggetto del mutuo. Infatti, quando ci sono indici di allerta legati alla localizzazione dell’immobile, il professionista incaricato è tenuto a effettuare indagini approfondite anche sui terreni acquisendo il certificato di destinazione urbanistica.
È quanto emerge dalla sentenza 4911/22 del 15 febbraio che ha respinto il ricorso di un notaio. Una banca aveva agito nei suoi confronti per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento del professionista in occasione della stipula di un mutuo. Il notaio, infatti, non aveva accertato che l’immobile ipotecato, in quanto gravato da usi civici non affrancati, non era commerciabile.
Il tribunale ha respinto la domanda ma la corte d’appello ha ribaltato la decisione condannando il notaio a risarcire l’intero importo del mutuo.
La controversia è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che l’acquisizione del certificato di destinazione urbanistica sarebbe obbligatorio solo in caso di atti relativi a terreni ovvero terreni costituenti pertinenze di edifici censiti nel catasto urbano di superficie superiore a 5 mila mq, mentre nella specie si trattava di costituzione di ipoteca su un appartamento e un locale deposito. Né si poteva considerare fatto notorio che molti terreni della zona in cui si trovava l’immobile fossero gravati da usi civici. Infine ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha escluso che la prestazione omessa comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che nessuna censura può essere mossa alle conclusioni di merito avendo la corte d’appello affermato che il notaio, conoscendo la zona e operando in quel territorio, avrebbe dovuto svolgere indagini ulteriori rispetto a quelle di natura ipotecaria e catastale sull’eventuale esistenza di usi civici. Infatti in caso di stipula di atti relativi a immobili siti in zone in cui via sia il potenziale rischio di sussistenza di vincoli di qualsiasi natura che incidono sulla loro commerciabilità, il notaio è tenuto a effettuare indagini ulteriori e più approfondite di quelle svolte ordinariamente, onde accertare l’effettiva libertà dei beni oggetto degli atti rogati a suo ministero. Né rileva, ai fini di una riduzione del risarcimento, che il perito della banca non abbia rilevato a sua volta il vincolo dal momento che il soggetto che si rivolge a un notaio per stipulare un determinato atto non può certo essere ritenuto corresponsabile dell’omissione delle indagini che ha commissionato al professionista.
Tari e servizio carente da parte del Comune.
La Corte di Cassazione con un’ordinanza depositata il 31 agosto 2022, ha accolto il ricorso di un ente che aveva chiesto l’annullamento dell’accertamento Tari. Nel caso di specie, il servizio di smaltimento dei rifiuti non era proprio partito, per cui, al contribuente è bastato produrre in giudizio le fatture relative ai pagamenti in favore di una società privata che aveva curato lo smaltimento.
Pertanto, per sfuggire al pagamento dell’imposta sui rifiuti, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare del diritto alla riduzione della tassa o addirittura l’esenzione dalla stessa. Nel caso di specie infatti, il contribuente è stato costretto a rivolgersi ad una società privata per lo smaltimento e le fatture pagate alla stessa (società) sono state ritenute sufficienti dalla Corte di Cassazione per accogliere il ricorso ed annullare l’accertamento Tari.
Sette cani in una stanza "angusta" e "senza luce", scatta il reato di "abbandono di animali"
di Francesco Machina Grifeo
Tenere sette cani (huski e samoiedo), di cui cinque cuccioli, dentro una camera priva di luce naturale e in precarie condizioni igieniche, all'interno di una abitazione che complessivamente non supera i 40 mq, integra il reato di "abbandono di animali" (727 c.p.). Lo ha confermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39844 d
Il giudice di merito aveva accertato "le condizioni di sporcizia dell'immobile e la totale assenza di igiene dell'abitazione".
di Vanessa Ranucci
Sì all’azione di indebito arricchimento verso il Comune dall’amministratore convenuto dal privato
Senza un contratto scritto sorge un rapporto obbligatorio diretto tra chi ha fornito la prestazione e il funzionario inadempiente che l'ha consentita
E' legittima l’azione di indebito arricchimento verso il Comune dall’amministratore convenuto dal privato: senza un contratto scritto sorge un rapporto obbligatorio diretto tra chi ha fornito la prestazione e il funzionario inadempiente che l'ha consentita. Lo ha stabilito oggi la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 10432/22.
Un avvocato, nei confronti del sindaco e dell'assessore di un Comune, aveva chiesto la condanna in solido al pagamento dei compensi professionali per un’attività svolta per il Comune su incarico della giunta senza contratto scritto. I convenuti si erano costituiti svolgendo domanda di manleva o di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente locale. Il giudice di pace, però, aveva dichiarato inammissibile le domande di arricchimento. Il Tribunale, successivamente, aveva ritenuto che nella specie difettasse l'impoverimento “ingiustificato” a carico degli appellanti, dal momento che questi erano stati condannati al pagamento delle spettanze dell’avvocato per una precisa giustificazione causale derivante dall’art. 191 Dlgs 267/2000.
I ricorrenti, in sede di legittimità, hanno dichiarato che il giudice non aveva rilevato che il Comune era l'unico effettivo beneficiario della prestazione professionale. Al riguardo, il Palazzaccio ha osservato che la prestazione dell’avvocato era stata attuata senza l'osservanza del procedimento formale e contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale. Così, la Suprema corte ha ricordato che “in questi casi il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà: egli è legittimato a esercitare l’azione ex art. 2041 Cc nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 Cc, con gli oneri probatori a ciò correlati. In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita; ma proprio per salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte costituzionale ha affermato che in linea generale ben sussistono in questi casi in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l’azione ex 2041 Cc verso l’ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito”.
Insomma, per il collegio ha sbagliato il giudice a non ritenere che l'amministratore convenuto dal privato può esercitare l'azione di arricchimento ed essere rilevato indenne dall’esborso: ciò significa che l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore per il rapporto obbligatorio con lui. Pertanto, al giudice del rinvio il nuovo giudizio sul punto.
di Giulia Provino
Accertamento induttivo puro se la contabilità di magazzino è inaffidabile
Pur senza l’obbligo delle scritture contabili, le rimanenze finali devono essere valutate accorpando i beni in categorie omogenee per natura e valore
L’inaffidabilità dei dati delle scritture contabili può fondare l’accertamento induttivo puro. La non obbligatorietà alla tenuta della contabilità di magazzino non esonera il contribuente che le abbia comunque redatte dall’inserirvi i dati corretti; in particolare per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino si procede con l’accorpamento dei beni in categorie omogenee per natura e valore. Con la sentenza 12127/22, depositata il 14 aprile, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Il fisco nell’emettere gli avvisi di accertamento Ires, Iva e Irap aveva focalizzato l’attenzione sull’analisi delle rimanenze di magazzino, accertando che le stesse, indicate su due distinte colonne, presentavano valori dati una dal costo di acquisto e l’altra dai costi accessori. Pertanto, aveva adottato il metodo induttivo, in ragione dell’inaffidabilità delle scritture contabili e l’assenza di riscontro documentale o contabile delle giustificazioni addotte, e aveva ritenuto che la sopravvalutazione delle rimanenze celasse in realtà operazioni non contabilizzate e in specie acquisti, quanto alle rettifiche inventariali positive, e cessioni di beni, quanto a quelle negative. La Ctr ha erroneamente reputato giustificabili gli errori recati nella contabilità di magazzino in ragione della non obbligatorietà della sua tenuta.
Tuttavia, l’obbligatorietà o meno della tenuta delle scritture contabili non soltanto non esonera il contribuente che le abbia comunque redatte dall’inserirvi dati corretti, ma non incide neppure sulla legittimità del ricorso al sistema di accertamento induttivo puro. La scorrettezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, ancorché non obbligatorie, e la loro conseguente inaffidabilità possono fondare l’accertamento induttivo puro e consentire di rideterminare il reddito attraverso un sistema di presunzioni super-semplici, che rovesciano l’onere della prova in capo al contribuente.
Inoltre, la disciplina civilistica, pur non imponendo metodi obbligatori di valutazione delle rimanenze finali di magazzino, prescrive che il valore ad esse attribuito non sia inferiore a quello “minimale” ottenuto dall’applicazione dei criteri previsti dall’articolo 92 del dpr 917/86 e che il valore da assumere fiscalmente, quando non determinato per singoli beni a costi specifici, non sia inferiore a quello che si ottiene raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore.
Ciò che rileva, dunque, non è tanto il principio della libertà di scelta tra i vari metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino, quanto il rispetto delle modalità operative prescritte dal dpr 917/86, che impongono di procedere all’accorpamento dei beni per natura, ossia in ragione delle proprietà e delle caratteristiche merceologiche sostanziali degli stessi, e per valore, ossia in ragione del loro valore economico sulla base del valore normale.
Gettoni d’oro e regole flessibili alla Cassa forense
La Corte dei conti: troppi 600 euro a seduta. Mancano regolamenti su investimenti e strutture. Più pensioni, meno contributi. Netto patrimoniale accresciuto, ma occhio al saldo negativo 2042-2062
Gettoni d’oro e regole fin troppo flessibili alla Cassa forense. «Particolarmente cospicui» i costi per la partecipazione dei componenti alle sedute degli organi collegiali: troppi 600 euro a presenza. L’ente previdenziale degli avvocati, inoltre, non ha ancora un regolamento che fissa i criteri generali dell’attività d’investimento patrimoniale; come pure è privo d’un regolamento di organizzazione delle strutture amministrative. Aumentano le pensioni e diminuiscono le entrate contributive, ma niente paura: l’incremento dei ricavi resta superiore a quello dei costi mentre il netto patrimoniale risulta accresciuto. E il regolamento unico per la previdenza forense è comunque un risultato. Normali le spese per il personale, pesano le consulenze esterne. Occhio, però, al futuro: nel ventennio 2042-2062 si profila un saldo previdenziale negativo «che è necessario monitorare con attenzione». È il monito della Corte dei conti nella relazione sulla gestione finanziaria di Cassa forense negli esercizi 2018-2019 presentata al Parlamento (cfr. in allegato).
Aspetto sensibile
«Particolarmente elevati», dunque, i costi di funzionamento delle sedute: i ministeri dell’Economia e del Lavoro che vigilano sulla Cnpaf hanno raccomandato di ridurre la fiche di presenza perché l’importo di 600 euro è «superiore alla media degli altri enti del comparto». Senza dimenticare i rimborsi spese, diretti e indiretti. Nel 2018 come nel 2019 i gettoni ammontano a 1,7 milioni di euro: importi più alti rispetto al 2017. E cresce il trend dell’incidenza sul totale dei costi per gli organi. Sulle passività, evidenzia la magistratura contabile, non pesano soltanto i gettoni per il comitato dei delegati, i quali non percepiscono alcun compenso; ma incidono, «anche in misura rilevante», quelli dei componenti il consiglio d’amministrazione e il collegio sindacale, che sono già remunerati: il 36 per cento del totale nel 2018 e il 31 nel 2019. Nel primo dei due esercizi passati ai raggi x, in particolare, i componenti del cda incassano oltre 35 mila euro soltanto a titolo di presenza e i sindaci oltre 49 mila contro i circa 14 mila dei delegati, secondo la media pro capite calcolata nella relazione.
A fine 2016, fra l’altro, il comitato dei delegati ha elevato da quindici a diciotto il numero massimo di partecipazioni indennizzabili ad attività collegiali. È «un aspetto sensibile della gestione», sottolinea in sede di approvazione del bilancio 2019 il Mef, che invita a «misure di contenimento»: la razionalizzazione trova fondamento «nei principi di sana gestione delle risorse contributive degli iscritti», parola della Corte costituzionale nella sentenza 7/2017. Insomma: dalla Corte dei conti «fermo» è il «richiamo all’ente, che non risulta aver recepito le indicazioni ministeriali su entrambi i bilanci». E dovrà invece «agire in conformità»: i magistrati si riservano «verifiche puntuali nei prossimi cicli di controllo».
Flessibilità intrinseca
di Remo Bresciani
L’assemblea può vietare di adibire le cantine a uso abitativo anche se non c’è ancora il servizio igienico
L’astratta possibilità tecnico-amministrativa di variare la destinazione d’uso dei locali non intacca la delibera volta a salvaguardare il decoro e la sicurezza dello stabile
È legittima la delibera condominiale che vieta di adibire le cantine a uso abitativo anche se non è ancora stato installato il servizio igienico. L’astratta possibilità tecnico-amministrativa di variare la destinazione d’uso dei locali non intacca, infatti, la scelta dell’assemblea volta a salvaguardare il decoro e la sicurezza dello stabile.
Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 12056/22 del 13 aprile che ha respinto il ricorso di un uomo. Il ricorrente aveva impugnato la delibera adottata dall’assemblea condominiale con la quale gli era stato rivolto l’invito a staccare tutti gli allacci ai servizi comuni e chiudere le aperture nei muri perimetrali realizzate nelle cantine di sua proprietà, nonché al divieto di adibire i vani cantina a uso commerciale o professionale. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che la delibera era nulla o annullabile perché adottata con votazione irregolare quanto ai condomini legittimati a esprimere il voto e perché le modifiche apportate ai vani cantina di sua proprietà costituivano una questione che aveva solo rilievo amministrativo e, comunque, erano afferenti esclusivamente alla sfera dei suoi diritti dominicali, non rientranti nella competenza dell'assemblea condominiale.
Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d’appello ha confermato la decisione. La vertenza è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto che la delibera doveva essere comunque dichiarata nulla o annullabile. Infatti il collegio aveva ritenuto che i vani cantina erano stati destinati a uso abitativo, pur dando atto che non erano stati installati i servizi igienici. Al contrario sussisteva l’astratta possibilità di tecnico-amministrativa di variare la destinazione d’uso dei locali. Inoltre l’assemblea aveva dettato disposizioni incidenti sull’uso di un bene esclusivo, sicché risultavano travalicati i limiti di competenza riservati all’assemblea condominiale.
La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha affermato che le modifiche di fatto apportate ai vani cantina erano illegittime in quanto lesive dei diritti dominicali degli altri condomini su beni e servizi comuni, sicché l’astratta possibilità o meno, sul piano urbanistico-amministrativo, di mutare la destinazione d'uso dei vani in questione non assume rilievo di sorta. La delibera inoltre conteneva solo l’invito a staccare gli allacci e chiudere le prese d’aria realizzate nei muri comuni, con la conseguenza che non dettava prescrizioni inerenti al godimento del bene in proprietà esclusiva, bensì ribadiva le modalità di un corretto utilizzo dei beni comuni. In sostanza, ha concluso la Cassazione, la corte di merito, si è limitata a puntualizzare “come l’uso in concreto dei vani cantina, mediante gli allacci e le opere fatte, a fini abitativi era lesivo del diritto degli altri comunisti al decoro abitativo e alla sicurezza del condominio, oltre che comportante aggravio all’uso dei servizi comuni, in presenza di persone che de facto vivevano nei vani cantina non all'uopo funzionalmente destinati”.
Di qui il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Circolazione stradale - Zone a traffico limitato - Pass a persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Sussiste - Ulteriore obbligo di comunicare targa del veicolo - Non sussiste - Illegittimità della sanzione amministrativa
La persona affetta da disabilità può accedere alle corsie preferenziali e alle aree riservate senza alcun obbligo di preventiva comunicazione della targa del veicolo anche se diversa da quella del veicolo "master" originariamente registrato.
di Dario Ferrara
Pignorabile il reddito di cittadinanza
Assimilabile alle entrate da lavoro e staggito nella quota di un quinto, in quanto misura di politica attiva dell’occupazione. Nessuna deroga: il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni
Pignorabile e pignorato. Il reddito di cittadinanza è staggito nella misura di un quinto, come fosse lo stipendio, nell’ambito dell’esecuzione presso terzi. E ciò perché costituisce una misura di politica attiva dell’occupazione, mentre non risultano gli estremi per derogare al principio secondo cui il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni. È quanto emerge dall’ordinanza per l’assegnazione dei crediti emessa dalla sesta sezione civile del tribunale di Catania (giudice dell’esecuzione Giuseppina De Farfalla).
Stretta interpretazione
Vittoria per la società di recupero crediti difesa dall’avvocato Fabio Mastrorosa: l’ordinanza ex articolo 552 Cpc assegna oltre 1.600 euro a carico di una banca, oltre che dell’Inps che eroga il Rdc al debitore; sul totale circa 1.100 saranno versati dall’istituto di credito e la restante somma dall’ente previdenziale, nella misura corrispondente a un quinto dell’importo erogato in concreto al netto delle ritenute di legge in favore del debitore. Il tutto perché il Rdc deve ritenersi assimilabile al reddito da lavoro e, dunque, può formare oggetto di assegnazione negli stessi limiti da parte del giudice dell’esecuzione nel pignoramento presso terzi. In effetti, si legge nel provvedimento, nel decreto 4/2019, manca qualunque riferimento a un’eventuale natura alimentare dell’istituto, mentre le norme che introducono eccezioni alla pignorabilità hanno carattere eccezionale oltre a essere di stretta interpretazione.
Forma di sostentamento
Sull’inquadramento del reddito di cittadinanza è di nuovo intervenuta proprio ieri la Cassazione nell’ordinanza 10450/22, che ha detto stop al mantenimento dei maggiorenni da parte degli ascendenti se prima non si è valutato il ricorso al Rdc: la Suprema corte confermato che l’erogazione di somme mensili da parte dell’Inps ha «natura di politica attiva del lavoro», oltre che di «contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale», che va integrare «i redditi familiari». In precedenza ha indicato il reddito di cittadinanza come forma di sostentamento per il disoccupato, al posto degli alimenti a carico dei genitori, e per il figlio maggiorenne non indipendente, in luogo del mantenimento da mamma e papà (ordinanze 40882/21 e 38366/21).
di Dario Ferrara
Imputato messo alla prova anche se non può riparare tutto il danno
Non si può escludere il beneficio solo perché l’attività di pubblica utilità non vale quanto il pregiudizio cagionato: conta lo sforzo massimo sostenibile nell’ottica della riabilitazione
L’imputato può essere messo alla prova anche se non è in condizioni di riparare tutto il danno che ha causato. E ciò perché la norma ex articolo 168 bis Cp non prevede alcun automatismo retributivo, anzi tende a favorire la riabilitazione del prevenuto attraverso “opere buone”: è irrilevante, allora, che lo svolgimento di un’attività di pubblica utilità non produca un valore pari all’importo del pregiudizio cagionato. Conta invece la disponibilità dell’interessato ad assicurare la prestazione a fini ripristinatori con lo sforzo massimo che può sostenere, alla luce delle sue condizioni economiche. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 7 luglio 2022 dalla terza sezione penale della Cassazione (e qui leggibile in fondo all’articolo).
Retroattività esclusa
È accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato per omessa dichiarazione al fisco, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’inammissibilità. Sbagliano i giudici del merito a escludere il beneficio sul rilievo che l’evasione supera i 200 mila euro e il prevenuto non ha pagato il debito con l’erario: da una parte i reati contestati risultano commessi prima che entrasse in vigore la stretta, introdotta in sede di conversione del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, che non può essere applicata in senso retroattivo; dall’altra non si può subordinare l’ammissione alla probation all’integrale risarcimento del danno, che è indicato «ove possibile» fra le condizioni del beneficio. E dunque il risarcimento è auspicabile ma non costituisce una condizione ostativa se non risulta realizzabile.
Condizioni economiche
Va detto che né il tribunale né la Corte d’appello valutano l’adeguatezza del programma presentato dall’imputato per la messa alla prova. Il giudice di secondo grado esclude il beneficio sul rilievo che anche svolgendo una prestazione di lavoro di pubblica utilità l’imputato non potrebbe pagare il debito tributario maturato negli anni d’imposta incriminati. Ma così valorizza profili che non rilevano sul piano legislativo per l’accoglimento dell’istanza. Rispetto alla riparazione da compiere il giudice può verificare le condizioni economiche del prevenuto ex articolo 464 bis, comma quinto, Cpp.
di Remo Bresciani
Va condannato per influenza illecita chi falsifica il libro soci per ottenere la maggioranza nell’assemblea dell’ente. Il reato previsto dall’articolo 2636 del codice civile, infatti, è integrato da qualsiasi operazione che consenta di alterare la situazione rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge.
Lo ha ricordato la Cassazione (il documento è consultabile in fondo all’articolo) che ha respinto il ricorso di due soci di una cooperativa. Gli imputati, in vista dell’assemblea dell’ente, avevano falsificato il libro soci retrodatando la data di ingresso di alcuni soci ottenendo in tal modo la maggioranza e quindi la possibilità di estromettere altre persone, a loro non gradite, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società.
Il tribunale li aveva condannati a quattro mesi di reclusione e la corte d’appello ha confermato la pronuncia.
La vertenza è così giunta in Cassazione dove gli imputati hanno sostenuto di non avere conseguito un ingiusto profitto ottenendo l’estromissione di altri soci dal momento che tale estromissione non era mai avvenuta e i ricorrenti non avevano conseguito il pieno controllo della società.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha ricordato che il reato previsto dall’art. 2636 cod. civ. è posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare e ciò che rileva è che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza assembleare. In altre parole, il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ., è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge.
Si tratta, ha spiegato il collegio di legittimità, di un reato di evento a forma vincolata che, sotto il profilo psicologico, è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto l'agente, oltre ad avere la consapevolezza di determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati o fraudolenti, deve agire al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, che può essere anche di natura non patrimoniale.
Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti non contestano che la loro condotta abbia influito sulla corretta formazione della maggioranza assembleare, ma intendono rivalutare, in fatto, l'esistenza della necessaria componente fraudolenta del reato. Tuttavia, ha concluso il collegio, entrambe le sentenze di merito hanno rilevato l’illecita influenza esercitata sull’assemblea dei soci attraverso la falsificazione del libro soci e la creazione di una maggioranza assembleare non genuina. Inevitabile pertanto il rigetto del ricorso.
Vigili urbani, non è vilipendio l'insulto sui social
La Cassazione, accoglie il ricorso di un ragazzo colpevole di aver postato su Instagram una foto davanti a un'auto della Polizia locale con la dicitura "fuck the police
Non scatta il reato di vilipendio per l'offesa alla Polizia municipale. Non trattandosi infatti di "forze armate" non opera la tutela prevista dall'articolo 290 del codice penale nel caso di offesa alla Repubblica, alle Istituzioni costituzionali e - appunto - alle Forze armate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35328 depositata oggi, accogliendo il ricorso dell'imputato all'epoca minorenne reo di aver pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritraeva dinanzi a un'autovettura in uso alla Polizia locale, accompagnata dalla dicitura "fuck the police".
La Corte di appello di Milano, sezione minorenni, aveva confermato la sentenza emessa dal G.u.p. (all'esito di giudizio abbreviato) che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della concessione del perdono giudiziale.
Proposto ricorso, l'imputato ha sostenuto che il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto definire il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, "considerando che l'imputato aveva ammesso sin da subito l'addebito, dichiarandosi dispiaciuto per la propria condotta, e che aveva effettuato un risarcimento simbolico in favore delle Forze dell'ordine". Inoltre, la frase incriminata era inserita sui social "in un contesto goliardico e inconsapevole", essendo stata riportata "dopo aver partecipato quale comparsa in un video musicale.
La Prima sezione penale, nell'accogliere il ricorso, svolge però un ragionamento del tutto diverso. "La Polizia locale di un Comune – spiega la Suprema corte - non possiede la qualifica di ‘forza armata' anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco". In Italia, infatti, le forze armate sono costituite dall'Esercito, dalla Marina militare, dall'Aeronautica militare. Mentre l'Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il Dlgs n. 297 del 5 ottobre n. 297. Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili, dunque, "non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 290 cod. pen.".
"Un fatto commesso con riferimento alla Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare – conclude la Corte -, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all'art. 290 cod. pen.".
La sentenza impugnata è stata così annullata senza rinvio, "perché il fatto di reato così come contestato non sussiste".
Il marito malato sparisce dalla struttura sanitaria e per la moglie non c'è nessun risarcimento.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che aveva fatto causa ad una struttura sanitaria per la “scomparsa” del marito malato dal luogo di cure.
La suocera invadente può essere causa di separazione
Sulla separazione dei coniugi un solo episodio di violenza è sufficiente per condurre all'addebito della stessa al marito, disinteressato dal punto affettivo alla moglie, costretta
Accordata la separazione alla moglie, che ha dato 5 figli al marito, che però non la ricambia con l'affetto e la comprensione di cui ha bisogno e che in un episodio, anche se isolato, la picchia in presenza del primogenito.
Una crisi aggravata anche dalla presenza costante e controllante della suocera, che si intromette nella gestione dei nipoti e che, da quanto rivelano tate e collaboratrici, fa sentire la nuora ospite della sua villa, concessa in comodato al figlio per mettere su famiglia.
Una separazione che costa cara al coniuge, visto che se lo stesso ha avuto dei problemi economici, è solo per colpa sua. Queste in sintesi le conclusioni del Tribunale di Teramo contenute nella sentenza.
Addebito della separazione al marito anaffettivo
Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere la separazione con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e per lesione della propria integrità fisica.
Chiede altresì l'assegnazione della casa di proprietà della suocera, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, un assegno mensile per i 5 figli di 8.000 euro complessivi e di 20.000 per il proprio mantenimento.
La donna lamenta il disinteresse morale e sessuale del marito nei suoi confronti e dichiara di essere vittima di vessazioni da parte dello stesso, culminate nell'episodio del 2016, quando l'ha picchiata in presenza del figlio, intervenuto in sua difesa.
Da sempre esclusa dalla vita lavorativa del marito e ostacolata nello svolgimento di una sua attività esterna all'ambiente domestico, la donna fa presente di avere sempre subito la presenza autoritaria e invadente della suocera, che l'ha sempre trattata come un ospite della sua villa.
Il marito, costituitosi in giudizio, acconsente alla assegnazione della villa alla moglie fino alla scadenza del comodato concesso loro dalla sua famiglia di origine, ossia fino al 30 novembre 2017, il riconoscimento di un assegno mensile in favore dei figli di 1250 euro e di 750 euro per il mantenimento alla moglie, sostenendo che il tenore di vita goduto all'inizio del matrimonio è venuto meno a causa di debiti e problemi giudiziari.
Il Presidente, sentiti i coniugi, assegna la casa alla moglie, dispone l'affidamento congiunto dei figli con collocazione presso la madre e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di 1500 euro per i figli e di ulteriori 1500 euro per la moglie.
Sulla separazione pesa anche l'invadenza della suocera autoritaria
Il Tribunale, ritenendo fondata la domanda avanzata dalla moglie, pronuncia la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito in quanto "il grave episodio di violenza fisica è da solo sufficiente a fondare la responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che ne è stato l'autore" come confermato dalla testimonianza del figlio, di anni 16 all'epoca dei fatti.
Il Tribunale conferma inoltre la versione della donna in relazione alla lamentata ingerenza della suocera autoritaria nel menage familiare, confermata dalle testimonianze rese in giudizio dalle collaboratrici domestiche e dalle tate. Dichiarazioni da cui è emersa la volontà dell'anziana donna di gestire la vita e le abitudini anche alimentari dei nipoti, di esercitare un continuo controllo, anche telefonico, sugli stessi e di far pesare alla nuora di vivere nelle villa di sua proprietà.
Dal punto di vista economico, dalle prove è emerso inoltre che il marito, oltre a svolgere una sua attività di impresa, è titolare di partecipazioni societarie in 13 società, mentre la moglie, di anni 47 è disoccupata.
Dalla valutazione comparativa delle rispettive situazioni dei coniugi il Tribunale dispone quindi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, conferma il mantenimento di 5000 euro al mese per i figli, a cui sommare le spese straordinarie, a totale carico del padre.
Alla moglie spetta invece un assegno mensile di 3000 euro, alla luce del suo stato di disoccupazione e della sua età (47 anni), a conferma di quanto deciso in sede di appello, dopo il reclamo della donna contro le decisioni del Presidente.
Il privato può installare la telecamera per scoprire chi danneggia l’auto parcheggiata sulla via
A ricorrere alla videosorveglianza una donna la cui automobile era stata più volte rovinata. No alla tesi del vicino sulla violazione della privacy
Via libera all’installazione di una telecamera che inquadra la propria macchina, parcheggiata sulla pubblica via, per scoprire l’autore di ripetuti danneggiamenti. Il privato può utilizzare la videosorveglianza, con un collegamento con la polizia, predisposto in modo tale che le riprese inutili siano cancellate ogni 24 ore. Per la Cassazione (sentenza 27223) la decisione della privata cittadina è legittima. Mentre è infondato il ricorso del vicino, che lamentava la lesione della sua privacy, sacrificata sull’altare di un’esigenza futile, come quella di proteggere una vecchia auto, lasciata dalla proprietaria davanti alla propria abitazione per anni.
La Suprema corte esclude, come primo passo, che la telecamera inquadrasse la porta di ingresso del vicino, per negare poi che il motivo che aveva indotto la signora ad adottare l’iniziativa fosse futile. La video camera aveva, infatti, consentito di individuare e denunciare il responsabile dei danneggiamenti e delle minacce subìte dalla donna in passato.
Il vicino aveva lamentato la lesione del diritto fondamentale alla vita privata e personale, garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritto dell’Uomo e la violazione del Codice della privacy, anche perchè l’autore dell’illecito era già stato scoperto senza che l’impianto fosse rimosso.

Ad avviso del ricorrente la macchina era rimasta parcheggiata per anni davanti casa, solo per creare il pretesto per mettere un sistema di controllo intrusivo della sfera privata di vicini e passanti, perché inquadrava la sua porta di casa e la pubblica via. Non in linea, con il diritto Ue e con la giurisprudenza di Lussemburgo, anche il trattamento dei dati raccolti senza il consenso dei diretti interessati.
Non ci sarebbe stato dunque un giusto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. Chiara la sproporzione tra le violazione del diritto alla riservatezza e l’esigenza di impedire piccoli graffi su un’autovettura vecchia abbandonata in strada.
Per finire l’apparecchio non era neppure adeguatamente segnalato. Ma per i giudici di legittimità, le contrapposte esigenze sono tutelate in modo adeguato. La porta di casa del ricorrente non era inquadrata, scongiurando così l’interferenza nella sua sfera privata, mentre lui stesso ammetteva che la telecamera era stata utile a identificare il responsabile dei danneggiamenti.
Per i giudici dunque è stata lecita l’installazione, segnalata, della telecamera, almeno per il periodo utile a trovare l’autore degli atti vandalici.
di Remo Bresciani
Niente pronuncia sulle spese nel decreto di reclamo contro l’ordinanza presidenziale sul mantenimento
Il provvedimento è adottato in pendenza della lite e spetta al tribunale che conclude il giudizio provvedere anche per la fase cautelare
La corte d’appello che decide in sede di reclamo contro l’ordinanza presidenziale sul mantenimento nell’ambito della separazione dei coniugi, non deve statuire sulle spese. Il provvedimento infatti è adottato in pendenza della lite e spetta al tribunale che conclude il giudizio provvedere anche per la fase cautelare.
Lo ha ricordato la Cassazione (il documento è consultabile in fondo all’articolo) che ha accolto il ricorso di un uomo.
La corte d’appello, in parziale riforma dell’ordinanza del presidente del tribunale, ha fissato il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia e statuito sulle spese di lite.
L’uomo ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il collegio non aveva tenuto conto del carattere interlocutorio del reclamo che dava luogo a un provvedimento privo di definitività che poteva essere modificato o confermato all’esito del giudizio di separazione, destinato a regolare anche le spese.
La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha ricordato che nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d‘appello, adita in sede di reclamo avverso l‘ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, cod. proc. civ., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio. Infatti, ha spiegato il collegio, i provvedimenti previsti dall’articolo 708 del cpc, hanno natura cautelare perché mirano a regolare per il tempo necessario allo svolgimento del
giudizio di merito, quegli aspetti della vita della prole e dei coniugi che troveranno un assetto definitivo nella sentenza emessa a conclusione del giudizio e ciò al fine di evitare che, per effetto della durata del processo, i componenti del nucleo familiare vedano pregiudicati i propri diritti. La pronuncia sulle spese, anche per la fase cautelare, pertanto, sarà emessa a conclusione del giudizio tenendo conto, a tal fine, dell‘esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.
di Dario Ferrara
Entro domani la notifica dei ricorsi per Cassazione per rottamare le liti col fisco
Il decreto Aiuti bis approvato al Senato cancella il riferimento alle cause pendenti al 15 luglio: giovedì l’ok definitivo alla Camera. Superbonus: cedenti responsabili solo per dolo o colpa grave
Si allungano i termini per i contribuenti che vogliono rottamare le liti col fisco. La definizione agevolata si applica ai giudizi in corso per i quali il ricorso per Cassazione è notificato alla controparte entro domani: il 16 settembre 2022, infatti, è la data in cui entra in vigore la riforma della giustizia tributaria, che ha introdotto la sanatoria. Lo
prevede un emendamento “chiarificatore” approvato al Senato al decreto legge Aiuti bis, che ha ottenuto l’ok di Palazzo Madama e da oggi è al vaglio della Camera per il via libera definitivo (cfr. il testo in allegato). Il provvedimento varato dal Governo ad agosto contiene misure per 17 miliardi di euro per il sostegno delle imprese e delle famiglie, con la riformulazione del superbonus per l’edilizia e la proroga dello smart working.
Addio dubbi
All’articolo 41 ter il ddl di conversione del decreto aiuti bis fuga ogni dubbio sulla data di riferimento per individuare la pendenza del giudizio in Cassazione, che consente di accedere alla definizione agevolata: cancellando il riferimento «alla data del 15 luglio 2022» dall’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 130/22, il provvedimento chiarisce che la rottamazione vale per le controversie in corso nelle quali il ricorso di legittimità risulta notificato alla controparte entro l’entrata in vigore della riforma della giustizia tributaria, dunque domani venerdì 16 settembre.
Ora per allora
Dal testo approvato al Senato, poi, novità anche in tema di Superbonus e lavoro agile. La responsabilità per chi cede i crediti fiscali scatterà solo per dolo o colpa grave. Per i crediti maturati prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni richieste dalla normativa, il cedente acquisisce, ora per allora, la documentazione richiesta ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave; a condizione, però, che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo o da imprese di assicurazione. Lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e per i genitori dei figli under quattordici.
di Debora Alberici
Multa valida anche se l’autovelox è segnalato pochi metri prima
Per l’apparecchiatura mobile fa fede la distanza scelta dagli agenti di polizia
È valida la multa per eccesso di velocità anche se l’autovelox mobile è segnalato pochi metri prima. Spetta agli agenti di polizia scegliere una distanza congrua e non vale il limite minimo di un chilometro previsto dalle norme per la postazione fissa.
Il monito a non correre in auto arriva dalla Corte di cassazione che, con una ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso di un automobilista beccato dall’autovelox a 103 km/h, su una strada provinciale.
I Supremi giudici hanno spiegato che preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.
Tuttavia, ecco il nodo della questione, l'art. 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioè siano collocati ai sensi del citato art. 4 del decreto n 121e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente.
La prescrizione del reato non cancella la verifica sulla responsabilità dell’ente
di Sandro Guerra
In presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto il giudice deve comunque procedere all’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o vantaggio l’illecito penale si ipotizzi commesso procedendo ad una verifica, quantomeno incidentale, del fatto di reato. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 30685 depositata il 4 agosto 2022
In presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto (e, quindi, di una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato), il giudice deve comunque procedere all’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o vantaggio l’illecito penale si ipotizzi commesso procedendo ad una verifica, quantomeno incidentale, del fatto di reato. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 30685 depositata il 4 agosto 2022.
Accolto dal tribunale di Pesaro il ricorso del ristoratore disobbediente leader del movimento #IoApro
Sentenza pubblicata da parte del Tribunale di Pesaro che ha accolto il ricorso avverso ordinanza di ingiunzione di pagamento del leader del Movimento #IoApro il quale aveva tenuto aperto i propri ristoranti durante il periodo del lockdown disobbedendo così ai DPCM che ne imponevano la chiusura.
I fatti di causa
In data 15.01.2021 il gestore di un esercizio di ristorazione a Pesaro decideva di aprire al pubblico il proprio locale nonostante i divieti governativi e quindi in violazione del DPCM 03.12.2020.
In seguito all'intervento delle forze dell'ordine veniva multato con apposito verbale di contestazione per violazione di quanto stabilito dal DPCM 03.12.2020 o dalle linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVD-19 nell'attività di "Pubblico Esercizio somministrazione alimenti e bevande" in quanto: "alle 23:10, veniva svolta attività di ristorazione al di fuori della fascia oraria consentita, dalle ore 05:00 fino alle ore 18,00, in violazione di quanto disposto dall'art. 1 c. 10, lett. gg) del DPCM 03.12.2020. All'interno dell'esercizio vi erano circa 25 avventori che hanno consumato cibi e bevande nelle precedenti ore, dalle 20:00 alle 23:30 circa". Con applicazione di sanzione di € 400,00 e contestuale chiusura dell'esercizio per 5 giorni.
In data 18.06.2021 gli veniva notificata - da parte della Prefettura di Pesaro - Ordinanza di Ingiunzione nella quale veniva ordinato: di pagare - entro 30 giorni dalla notifica - la somma complessiva di € 803,60 nonché la chiusura per giorni 20 dell'attività.
Avverso la suddetta ordinanza il ristoratore, mediante il proprio avvocato proponeva ricorso avanti al Tribunale di Pesaro ritenendo il DPCM profondamente ingiusto e sostanzialmente illegittimo in quanto non motivato e quindi in contrasto con l'art. 3 L. 241/1990 che impone alla Pubblica Amministrazione il dovere di trasparenza nei propri processi decisionali e di motivazione dei propri provvedimenti.
Con sentenza n. 97/22 (sotto allegata) il Tribunale di Pesaro (Giudice Dott. Mazzini) accoglieva il ricorso dell'Avv. Lorenzo Nannelli disapplicando il DPCM ed annullando l'ordinanza di ingiunzione.
Le motivazioni
Innanzitutto il Tribunale di Pesaro dopo aver svolto un richiamo alla normativa emergenziale di riferimento (D.L. 23 Febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni della legge 5 marzo 2020 n. 13 ed il D.L. 19/2020) tenta di dare una qualificazione giuridica ai DPCM previsti dal D.L. 6/2020 e successive modificazioni, senza nascondere che la natura degli stessi risulta controversa.
Quindi il giudice inizia una lunga disamina concludendo che il DPCM sia che lo si voglia considerare assimilabile alla ordinanza contingibile ed urgente, sia che lo si voglia piuttosto assimilare alla tipologia dell'atto amministrativo necessitato, rientra in ogni caso nella categoria degli atti amministrativi, e come tale riveste carattere di fonte normativa secondaria.
La funzione dei DPCM introdotti dal D.L. 6/2020 è quella di dare concreta attuazione e regolazione alla situazione di epidemia da Covid 19, proprio perché la sua velocità di emanazione consente di rispondere meglio alla velocità di diffusione del virus.
Individuati i principi fondamentali dal decreto convertito, l'esatta definizione tecnica ed attuazione delle norme per la convivenza civile a seconda del rischio epidemiologico individuato, è affidata allo strumento del DPCM, ma nell'esercizio di una specifica discrezionalità amministrativa.
Tuttavia, quest'ultima, per espressa previsione del D.L. 19/2020, deve necessariamente rispondere a criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza che connotano ogni fonte di diritto amministrativo.
Lo strumento attraverso cui si rendono visibili la logicità e la ragionevolezza della decisione, consiste nell'enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda un atto amministrativo "necessitato" come ritenuto dalla stessa pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 198/2021): da un lato, individua le circostanze di fatto e di diritto a base del provvedimento (la cd. giustificazione), dall'altro l'esposizione dei motivi in senso stretto, vale a dire del percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto ad una determinata decisione.
Del resto, l'espresso riferimento operato dalla Corte Costituzionale alla sindacabilità dei DPCM da parte del giudice impone di far riferimento unicamente alla logicità della motivazione, giacchè l'opportunità delle scelte riservate all'Amministrazione non consente al giudice di sostituirsi ad essa, ma unicamente di verificare la congruità del percorso logico seguito dalla P.A..
Quanto alla motivazione dell'atto amministrativo occorre che la stessa espliciti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in coerenza alle risultanze dell'istruttoria, e ciò anche avuto riguardo all'atto amministrativo necessitato in cui l'Amministrazione si limiti ad un accertamento delle condizioni di fatto che impongono l'adozione dell'atto amministrativo medesimo.
Ammissibile anche una motivazione per relationem, prevedendo che, qualora le ragioni della decisione risultino da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima debba essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.
L'omessa esternazione del percorso giustificativo e dell'iter logico seguito dall'amministrazione determina pertanto l'illegittimità del provvedimento, ed il conseguente dovere del giudice civile di disapplicarlo.
La motivazione deve essere esternata chiaramente attraverso espressioni comprensibili, logiche e percepibile all'esterno.
In sintesi, l'attestazione dell'avvenuto rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza non può emergere se non dalla motivazione dell'atto stesso che garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, rendendola controllabile da parte dell'opinione pubblica, affermando la responsabilizzazione degli organi della P.A. (art. 97 Cost.).
Poiché la proporzionalità deve essere misurata in concreto in base al livello di rischio, l'adozione dell'atto amministrativo nello specifico, troverebbe giustificazione nelle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico, a cui il D.L. 19/2020 fa espressamente riferimento per l'adozione delle misure sanitarie.
Nell'ipotesi di specie, il DPCM del 03 dicembre 2020 indica tra i presupposti di fatto: "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio nazionale; […] le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale".
Come da indicazioni del D.L. 19/2020, il DPCM del 3 dicembre 2020 fa espresso riferimento al verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 Febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni e integrazioni.
L'attività comparativa svolta, comportando la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, necessitava di un adeguato impianto giustificativo, soprattutto nel momento in cui le decisioni adottate dal DPCM del 3 dicembre 2020 determinavano una modifica delle disposizioni precedentemente adottate, che consentivano senza limitazioni di orario e di luogo lo svolgimento dell'attività di ristorazione, non differenziando ad esempio il ristorante dalle aree di servizio.
In tal caso, la precisa differenziazione, all'interno delle disposizioni richiamate, tra le attività consentite e non consentite, nonché l'identificazione della fascia oraria consentita per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, si traduce in una precisa scelta da parte dell'Amministrazione che avrebbe dovuto essere supportata da dati scientifici precisi, nonché da spiegazioni tecniche in relazione al maggior rischio di diffusione del contagio nelle attività e negli orari non consentiti.
Nessuna indicazione è stata fornita sul punto, se non tramite generici riferimenti "all'evolversi della situazione epidemiologica" ed "alla congruità delle misure adottate".
In altri termini, la specificità delle misure adottate non si rivela congrua e logica rispetto alla genericità dei presupposti addotti, privi di specifiche indicazioni di rischio, sia dal punto di vista sanitario che tecnico.
Neppure erano state indicate le ragioni per le quali quelle (precedenti) misure restrittive in vigore che elencavano minuziosamente le cautele da osservarsi nell'esercizio dell'attività di ristorazione, non erano ritenute più idonee a prevenire il contagio, tanto da aver determinato la chiusura delle attività.
Ne consegue l'illegittimità del DPCM, sia che lo si intenda assimilare alla tipologia dell'ordinanza contingibile ed urgente, sia che lo si voglia piuttosto assimilare alla tipologia dell'atto amministrativo necessitato, non risultando esplicitati, neanche tramite l'istituto della motivazione per relationem, i presupposti di fatto, nonché le ragioni tecnico-scientifiche poste a fondamento dell'adozione delle misure prescelte.
In proposito, non può ritenersi utile allo scopo il richiamo al verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 Febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto, all'interno del verbale suddetto altro non è dato leggere se non una valutazione di "congruità" in ordine alle misure adottate con il DPCM qui in commento, per contenere il contagio, rapportate all'imminente periodo natalizio e alla fase epidemiologica in essere.
Il tutto senza alcuna specificazione che tenesse conto, ad esempio, dello specifico livello di contagiosità al momento dell'adozione del DPCM, in relazione alle attività fino a quel momento autorizzate e consentite; della probabile curva di contagio prevista per l'imminenza delle festività, sulla base della diffusività del virus e delle restrizioni che si andavano ad introdurre; senza alcuna specificazione delle motivazioni tecnico scientifiche per le quali veniva prevista una regolamentazione differenziata per la medesima attività di ristorazione (ad esempio ristoranti per i quali veniva introdotto il limite orario di esercizio dalla ore 5.00 alle ore 18.00, ed aree di servizio in cui veniva svolto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande senza limitazioni di orario, e ancora, le strutture alberghiere nelle quali era ammesso per la propria clientela il medesimo servizio di ristorazione senza previsione di alcun limite di orario -articolo 1 comma 10 lettere gg) e hh) DPCM 3.12.2020).
Si intende dire che ogni valutazione contenuta nel DPCM deve ritenersi sia mancante di riferimenti specifici utili a giustificare (rectius motivare) l'adozione di un siffatto strumento che, avrebbe imposto la previsione di una motivazione specifica, non soddisfatta da un generico riferimento ai Verbali del Comitato tecnico-scientifico (Cts); verbali che il governo stesso, non si dimentichi, aveva classificato come "riservati" o "secretati.
Proprio l'insufficienza e l'incompletezza di motivazione nei termini anzidetti che è dato ravvisare nel DPCM 3.12.2020, determina l'impossibilità di ritenere rispettati i parametri di proporzionalità e adeguatezza previsti dall'art.2 comma 1 D.L.19/2020, e autorizza la disapplicazione da parte del giudice ordinario nell'esercizio del potere derivante dall'art.5 della legge n.2248 del 1865 Allegato E), ed il conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
di Debora Alberici
Il bambino deve continuare a vedere il padre nonostante si rifiuti
Sanzionata la pressione della madre sulla decisione del minore. Si all’intervento dei servizi sociali
Il bambino deve continuare a vedere il padre nonostante il suo rifiuto. A maggior ragione se la volontà del minore è influenzata dalla madre che, per questa condotta, può essere sanzionata con una multa.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con una ordinanza leggibile in fondo alla pagina, ha respinto il ricorso di una donna che ostacolava i rapporti fra la figlia e suo padre, un alcolista.
La prima sezione civile ha bocciato la tesi con la quale la difesa cercava di far annullare la sanzione a carico della sua cliente ma soprattutto di far valere il rifiuto della minore a vedere suo padre.
Per gli Ermellini, infatti, la censura è radicalmente inammissibile in quanto volta a contestare l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’Appello, sull’esistenza e reiterabilità dei comportamenti impeditivi dell’esercizio del diritto di visita da parte del padre, fondato sull’acquisizione di fatti concreti, nella loro materialità neanche contestati dalla ricorrente, mediante la negazione di scientificità di una teoria scientifica astratta, ritenuta il fondamento acritico della decisione.
La censura si fonda sulla dedotta adesione meramente ipotetica ad una teoria scientifica della decisione come se ne costituisce la conseguenza logica. Per la Cassazione, si tratta di una deduzione del tutto astratta e disancorata dall’accertamento svolto e dalla ratio decidendi che poggia sul comportamento impeditivo e sull’effetto pregiudizievole per la minore di questa reiterata assenza della figura materna. A questa valutazione segue, in relazione al padre, solo la decisione di ripristino e prosecuzione continuativa dei rapporti padre figli senza tuttavia scalfire la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente.
di Dario Ferrara
Con Fornero-Jobs Act rapporti non stabili: i diritti dei lavoratori iniziano a prescriversi dopo la fine
Solo residuale oggi la reintegra: precario il rapporto a tempo indeterminato perché mancano i presupposti per predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione e una tutela adeguata
Sono precari anche i posti fissi dopo Fornero e Jobs Act. Decorre soltanto dalla cessazione del rapporto la prescrizione del diritto del lavoratore, ad esempio la rivendicazione delle differenze retributive. E ciò perché, oggi, anche il contratto a tempo indeterminato non risulta assistito da un regime di stabilità: con le modifiche apportate all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori - prima dalla legge 92/2012 e poi dal decreto legislativo 23/2015 - mancano i presupposti per predeterminare in modo certo le fattispecie di risoluzione.
E soprattutto manca una tutela adeguata, visto che nel frattempo la reintegra nel posto di lavoro è diventata residuale: non si può dunque escludere che il lavoratore eviti di dar valere un proprio credito nel corso del rapporto perché ha paura di essere licenziato. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 6 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione (qui leggibile come documento correlato).
Tutela reale
Accolto il ricorso proposto dalle lavoratrici: sbaglia la Corte d’appello a rigettare la domanda di differenze retributive per lo straordinario notturno, eccedenti la prescrizione quinquennale. E ciò sul rilievo che dovrebbe essere escluso il metus che induce il lavoratore a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando reazioni del datore che comportano la risoluzione del rapporto. Il tutto perché anche dopo la legge Fornero e il Jobs Act è rimasta una tutela ripristinatoria piena in caso di licenziamento intimato per «per ritorsione, e dunque discriminatorio» ovvero per motivo illecito determinante.
Trova ingresso la censura secondo cui deve ritenersi stabile soltanto il rapporto che ha come forma ordinaria di tutela quella reale, in tutte le ipotesi di licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo o comunque illegittimo.
Carattere recessivo
Non c’è dubbio, invece, che oggi il legislatore attribuisca alla tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale mentre la reintegra abbia assunto un carattere recessivo. E la prescrizione del rapporto decorre in corso di rapporto solo quando la reintegra non soltanto è, ma anche appare, la sanzione contro ogni illegittima risoluzione del rapporto nel corso dello svolgimento. La parola passa al giudice del rinvio.
di Vanessa Ranucci
Va arretrato il muro di contenimento del terrapieno artificiale che delinea un fondo perché è una costruzione
L'opera rientra nella nozione di edifici e il regolamento comunale è una norma secondaria che non può modificare la disciplina codicistica
Va arretrato il muro di contenimento del terrapieno artificiale che delinea un fondo perché è una costruzione. Lo ha stabilito oggi la seconda sezione civile della Cassazione che, con l'ordinanza 12203/22, ha ricordato che i regolamenti comunali sono norme secondarie che non possono modificare la nozione codicistica sia pure al limitato fine del calcolo delle distanze legali.
Il proprietario di un immobile aveva chiesto che il confinante arretrasse il muro di contenimento da lui realizzato violando la distanza di cinque metri dal confine prescritta dal Piano Regolatore Generale del Comune e dalle relative norme tecniche di attuazione sul presupposto che l’opera potesse essere considerata veduta ai sensi della suddetta norma.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, decisione poi confermata in sede d'appello. Secondo il giudice di merito il muro costituiva una costruzione, svolgendo funzione di contenimento di un terrapieno artificiale in conseguenza di un’alterazione dell’originario piano di campagna, e in quanto tale soggetta al rispetto delle distanze legali. Tuttavia, non si trovava applicazione tale distanza di cinque metri dal confine stabilita dal Prg del Comune se non per i soli edifici.
Il ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato la decisione di merito nel ritenere che l’opera non rientrasse nella nozione di “edificio” e che la cognizione di “costruzione” utilizzata all’art. 873 Cc andava considerata unica.
Il Palazzaccio ha accolto il motivo ricordando che “mentre non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare smottamenti o frane, all'inverso, nel caso di dislivello di origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della normativa sulle distanze legali, il muro di fabbrica che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell’uomo, o che questa abbia pure soltanto accentuato rispetto a quello già esistente per la natura dei luoghi.
Basta, dunque, che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell’uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l’apporto di terra e pietrame (senza che abbia rilievo chi, dei proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento), e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni”.
Inoltre, “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 Cc, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 Cc ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore”. Pertanto, la causa è stata rinviata alla Corte d'appello.
Rifiuti - Rifiuti urbani - Tassazione servizio gestione rifiuti urbani (Tari) (N.d.R.: articolo 1, comma 641, legge 147/2013) - Applicazione - Determinazione delle tariffe Tari da parte di un Comune ex articolo 651, legge 147/2013 - Regolamento comunale - Attività di Bed and breakfast - Equiparazione alle attività alberghiere - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Prestazione di attività complessa che oltre alla cessione di immobile in godimento prevede prestazione di servizi come colazione, riassetto del locale e fornitura di biancheria da letto e da bagno - Maggiore idoneità a produrre rifiuti rispetto a una civile abitazione - Sussistenza
È legittimo il regolamento comunale che applica agli immobili adibiti a "bed and breakfast" una tassa rifiuti (Tari) più alta rispetto a quella delle abitazioni civili e le equipara agli alberghi.
L'affermazione arriva dalla Corte di Cassazione civile (ordinanza 16 maggio 2022, n. 15545) che ha ritenuto legittimo il regolamento di un Comune della Campania che ha previsto una tariffa della tassa rifiuti (Tari) più alta per i "bed and breakfast" rispetto alle civili abitazioni, assimilando i primi agli alberghi. La Tari è correlata alla capacità dell'immobile di produrre rifiuti e l'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" che non prevede solo una cessione del godimento dell'immobile, ma vi aggiunge servizi quali la prima colazione, il riassetto del locale e la fornitura di biancheria da letto e da bagno, e determina una maggiore produzione di rifiuti giustificando (anche in termini "costituzionali" di capacità contributiva ex articolo 53, Costituzione) la tariffa superiore rispetto alla civile abitazione.
E la tassazione differente prescinde dalla destinazione d'uso dell'immobile; pertanto anche se l'immobile catastalmente resta una "civile abitazione" quel che conta ai fini Tari e va verificato è l'utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a "bed & breakfast".
di Dario Ferrara
Inamovibile anche se indagato. Il sindacalista non può essere trasferito a un’altra sede di servizio senza il nulla osta dell’organizzazione di appartenenza. E ciò anche se si trova invischiato in un procedimento penale e l’amministrazione rileva un problema d’incompatibilità ambientale: le ragioni del datore non possono condizionare l’applicazione dell’articolo 22 dello statuto lavoratori; norma che vale anche nel pubblico impiego per il combinato disposto del testo unico che disciplina la materia e dei contratti collettivi nazionali. Può essere anche lo stesso dirigente sindacale ad agire in giudizio per far dichiarare illegittimo il provvedimento dell’azienda. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 30 giugno 2022 dalla sezione lavoro della Cassazione (e qui leggibile in fondo all’articolo).
Presunto perseguitato
Diventa definitiva la declaratoria di illegittimità del trasferimento adottato nei confronti del funzionario di un’agenzia fiscale. E ciò benché l’amministrazione lamenti che, continuando a operare nell’attuale sede, il dipendente finirebbe per lavorare fianco a fianco con i militari della Guardia di finanza che hanno investigato su di lui nel procedimento penale. Il che, tuttavia, non basta secondo la Corte d’appello: l’incompatibilità ambientale «si deve realizzare in concreto». Di più. Resta comunque viziato da una presunzione di anti-sindacalità il provvedimento disposto a carico del rappresentante sindacale senza il placet della Rsu, oltre che dell’organizzazione di riferimento, per quanto risulti sorretto ex articolo 2103 Cc dalla situazione di incompatibilità ambientale.
Spirito e volontà
Non coglie la ratio della decisione l’amministrazione quando deduce che bisognerebbe limitare la portata della norma che tutela l’attività sindacale di fronte a fatti di possibile rilevanza penale, altrimenti si andrebbe contro «lo spirito e la volontà» del legislatore: senza nulla osta neppure si possono scrutinare le motivazioni del trasferimento. E oltre all’organizzazione sindacale anche l’interessato può proporre l’azione per denunciare che è stato violato l’articolo 22 della legge 300/70. Nelle amministrazioni sono gli articoli 42, comma 6, e 51 comma 2, del testo unico del pubblico impiego a tutelare le prerogative sindacali insieme ai contratti collettivi.
La bomba d’acqua non esonera il condominio dal risarcire le infiltrazioni nell’appartamento
Mai le forti piogge integrano gli estremi del caso fortuito, il proprietario esclusivo ha segnalato la cattiva pendenza delle acque di scolo sul terrazzo. Liquidazione equitativa con le foto dei locali
Il condominio risarcisce il proprietario esclusivo dell’appartamento per le infiltrazioni d’acqua nell’immobile derivanti dal tetto, nonostante il nubifragio che si è abbattuto sulla città. E ciò perché in nessun caso le precipitazioni atmosferiche, per quanto di rilevante entità, possono essere considerate un evento eccezionale che integra il caso fortuito, esonerando l’ente di gestione dal pagamento dei danni. È quanto emerge dalla sentenza 7535/22, pubblicata dalla seconda sezione civile del tribunale di Napoli.
Precipitazioni prevedibili
Accolto l’appello proposto dal singolo condomino contro la decisione del giudice di pace: ottiene un risarcimento di 2 mila euro, liquidato secondo equità. Bastano le foto dei locali depositate in giudizio a far scattare il ristoro quantificato ex articolo 1226 Cc: evidenti i danni ai mobili e soprattutto alle pareti, che devono essere riverniciate. Sbaglia il magistrato onorario a riconoscere rilievo alle deduzioni dell’ente di gestione, secondo cui il condominio sarebbe esentato dal risarcimento a causa della bomba d’acqua che
si è abbattuta sul capoluogo partenopeo il primo maggio 2016, con una rilevante “coda” nei giorni successivi. Le piogge, per quanto forti, non possono essere considerate un evento imprevedibile che esclude la responsabilità ex articolo 2051 Cc dell’ente di gestione, il quale ha un effettivo potere di controllo sulle parti comuni dell’edificio. Le infiltrazioni d’acqua, invece, devono ritenersi fisiologiche, specie se si considera che il condomino interessato aveva segnalato la cattiva pendenza delle acque di scolo sul terrazzo dell’edificio in epoca precedente al nubifragio. Pesa anche la testimonianza resa da una congiunta dell’interessato. La liquidazione è effettuata in via equitativa laddove non risulta possibile provare il preciso ammontare del danno.
di Pietro Alessio Palumbo
Portare a scuola il bambino non vaccinato può costare l’arresto dei genitori
La Corte di Cassazione, sottolinea le conseguenze per chi non rispetta un obbligo dettato da ragioni di salute pubblica
L'inosservanza del provvedimento emesso dal dirigente scolastico che stabilisce la sospensione dalla frequenza scolastica dell'alunno privo di vaccinazioni obbligatorie può far scattare l'arresto dei genitori. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 10241 depositata il 23 marzo scorso. La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che nel nuovo assetto normativo del nostro Paese basato sulla obbligatorietà delle vaccinazioni, il legislatore ha ritenuto di dover preservare un adeguato spazio per il rapporto con i cittadini basato sull'informazione, sul confronto, e sulla conseguente persuasione.
Deriva che in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale deve essere avviato un procedimento rivolto innanzitutto a fornire ai genitori dell'alunno maggiori approfondimenti sulle vaccinazioni e sulla loro importanza per la salute del figlio. Soltanto al termine di tale procedimento e previa concessione di un adeguato tempo di riflessione sulle conseguenze per la salute del minore possono essere inflitte sanzioni ai genitori. Su queste basi il legislatore ha previsto che la presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo costituisca requisito di accesso ai servizi educativi erogati dalla scuola.
Va poi precisato che il provvedimento di sospensione dalla frequenza scolastica è attività doverosa e funzionale all'esecuzione di quanto stabilito dalla normativa: costituisce strumento necessario e imprescindibile per garantire la sicurezza della frequenza scolastica degli altri bambini, e la prevenzione dal rischio di contagio da malattie infettive spesso molto trasmissibili. Secondo la Suprema Corte di Cassazione nella ricorrenza dei prescritti presupposti di legge e della natura dell'atto di sospensione del dirigente scolastico - quale “ordine” dettato da ragioni di salute pubblica - non vi è ragione di negare l'applicabilità delle conseguenze penali per la violazione del contenuto obbligatorio del provvedimento scolastico.
Addio accertamento se il fisco non produce in giudizio la delega al funzionario che l’ha firmato
Anche se risulta demandata solo la sottoscrizione e non la funzione dal dirigente dell’ufficio, il mancato deposito agli atti impedisce al giudice di scrutinare l’esistenza e l’identità dell’interessato
Annullato. Addio all’accertamento a carico del contribuente perché il fisco non deposita in giudizio la delega del dirigente dell’ufficio che autorizza il funzionario di carriera a sottoscrivere l’atto impositivo. E ciò benché si tratti di una delega di firma e non di funzioni. La mancata produzione, infatti, impedisce al giudice di scrutinare l’esistenza del documento oltre che l’identità del sottoscrittore dopo le contestazioni avanzate dalla parte privata. È quanto emerge dall’ordinanza 7441/22, pubblicata l’8 marzo dalla sezione tributaria della Cassazione.
Sindacato precluso
La Suprema corte decide nel merito accogliendo l’originario ricorso proposto dal contribuente contro l’accertamento sintetico sul reddito che quantificava maggiori imposte per oltre 43 mila euro più interessi e sanzioni. Trova ingresso la censura rivolta contro la sottoscrizione degli atti impositivi relativi alle due annualità incriminate. Secondo la parte privata gli accertamenti sarebbero stati firmati in modo illegittimo dal capo area controllo mentre l’unica firma legittima poteva essere quella del direttore titolare dell’Agenzia delle entrate oppure quella di un funzionario di carriera dirigenziale munito di delega ad hoc. E, denuncia il contribuente, un “direttore tributario”, corrispondente all’ex nono livello, non sarebbe di per sé legittimato a spiccare da solo un atto di accertamento. Come che sia, è certo che l’amministrazione finanziaria non ha depositato agli atti la delega anche in grado d’appello nonostante il soccorso istruttorio all’epoca vigente. E la mancata produzione impedisce il sindacato sulla legittimità della sottoscrizione di chi non ha istituzionalmente la rappresentanza esterna dell’ufficio fiscale, una circostanza oggetto di censura ad hoc da parte del contribuente fin dal primo grado di giudizio.
No al licenziamento del dipendente lento, se il datore non ha esposto il Codice disciplinare
Annullata la massima punizione inflitta ad un operaio per un rendimento, inferiore del 50% alla media del suo reparto. Per il datore una lentezza volontaria
Il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento, se il datore non ha esposto ben visibile a tutti il Codice disciplinare che sanziona la condotta. La Cassazione (sentenza 24722) considera illegittima la massima “punizione”, inflitta al dipendente di un’azienda, perché il suo rendimento era del 50% sotto la media del suo reparto.
Il licenziamento era arrivato, con preavviso, dopo una sanzione disciplinare con la quale si addebitava al dipendente «una voluta lentezza», nello svolgere la mansione che le era stata affidata e alla quale era idoneo, malgrado una riconosciuta invalidità del 50 per cento. In più, al lavoratore si contestava la recidiva. E dunque una lentezza “cronica”. Per la Suprema corte però, il licenziamento non è valido, in assenza dell’affissione, in un luogo ben visibile a tutti, di un regolamento disciplinare, nel quale si avvertiva che la condotta era censurata.
I doveri fondamentali del lavoratore
In tema di sanzioni disciplinari, spiegano i giudici di legittimità, quando le violazioni contestate «non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cosiddetto minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, l’ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori»
La pubblicizzazione delle norme disciplinari
La pubblicizzazione preventiva delle norme disciplinari, relative alle sanzioni e alle infrazioni, in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata -assolve alla funzione sostanziale di garanzia di legalità e prevedibilità. Una forma di pubblicità che il datore deve provare di avere adottato, e che non ammette alternative. «Come il lavoratore non può invocare la personale ignoranza delle norme disciplinari regolarmente affisse, così il datore di lavoro, ove sia mancata la regolare affissione delle stesse norme - si legge nella sentenza - non può utilmente sostenere che il lavoratore ne fosse altrimenti a conoscenza». Nel caso esaminato la società non aveva provato di aver fatto questo passaggio obbligato, esponendo il Codice.
di Attilio Ielovella
Ditta ristruttura un immobile privato e piazza un autocarro su strada per raccogliere i materiali di risulta: illogica la multa
Per i Giudici è palese, checché ne dica il Comune, l’assenza di cantieri aperti o di opere realizzate o di depositi sulla sede stradale. In sostanza, è escluso che la ditta depositasse, senza autorizzazione, materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta.
Niente multa per la ditta che sta effettuando la ristrutturazione di un immobile e che sulla strada utilizza un autocarro, dotato di sollevatore e di cassone, per caricare il materiale di risulta dei lavori.
I giudici di merito sono concordi nel ritenere nulla la multa comminata, nel febbraio del 2016, a una ditta dalla Polizia municipale.
Fondamentale, in Tribunale, la ricostruzione dell'episodio che ha fatto finire sotto accusa la ditta.
Il Comune di Pordenone proponeva appello avverso la sentenza del locale giudice di pace che aveva accolto il ricorso di F.P. e annullato il verbale di contestazione redatto dagli agenti della polizia municipale il 5 febbraio 2016.
Il Tribunale di Pordenone rigettava l'impugnazione.
Milano bocciata sul pass invalidi per la Ztl: no alla comunicazione preventiva della targa
di Francesco Machina Grifeo
La Corte di cassazione, ordinanza n. 24015 depositata oggi, ha accolto il ricorso di una automobilista contro i verbali con i quali la Polizia municipale
Il comune di Milano inciampa sul pass invalidi per le zone a traffico limitato. Il Municipio, infatti, non può imporre con una ordinanza sindacale l'obbligo di comunicazione preventiva della targa agli uffici. Perché in tal modo contravviene alla normativa nazionale che favorisce la circolazione su tutto il territorio nazionale di persone con difficoltà nella deambulazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24015 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una automobilista contro i verbali della Polizia municipale che gli aveva contestato la violazione dell'articolo 7, comma 14, Cds 1992, per aver circolato nei giorni 8 e 11 novembre 2016 nella corsia riservata ai mezzi pubblici benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto.
In primo e secondo grado invece il ricorrente aveva visto respinte le proprie doglianze. Al guidatore, titolare di un pass rilasciato dal Comune di Rho, veniva contestato di non aver informato per tempo gli uffici meneghini che avevano previsto l'obbligo di comunicazione della targa, al fine di inserirla nella banca dati dell'Amministrazione, consentendo così il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.
Sul punto la Corte ricorda che, in tema di sanzioni amministrative, il cosiddetto "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, "è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale".
Pertanto, l'esercizio di tale diritto "non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla previsione generale di cui all'art. 7 C.d.s., con il quale è stabilito che, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze".
Esiste dunque, prosegue la Corte, un obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti invalidi. Mentre il pass deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo "senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, la cui mancata osservanza non può, perciò, determinare la configurazione della violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s. "
Inoltre, come di recente evidenziato dalla Cassazione (ordinanza n. 8226/2022) "non può frapporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione (come, ad es., tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresì, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi".
Tale autorizzazione infatti è diretta a ridurre il più possibile "impedimenti deambulatori" e non può trovare ostacoli "generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge".
Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, "ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di elevare verbali di accertamento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà predisporre apposite modalità di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l'utente stradale affetto da disabilità legalmente riconosciuta, senza, però, imporre a quest'ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative".
''Bisogni'' in autostrada, per la Cassazione la multa è legittima
La Cassazione civile conferma l’infrazione a causa della mancata adozione di cautele idonee, atte ad evitare la visibilità da parte di altri soggetti.
A chi non è capitato di dover fare pipì durante un viaggio in autostrada? Un’esigenza decisamente comune, che tuttavia può avere conseguenze importanti.
Lo sa bene un automobilista che si è visto multare dalla Polizia per esser stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail che delimitava la corsia di emergenza, in un tratto dell’Autostrada A11.
L’uomo si è giustificato lamentando di non aver potuto soddisfare altrimenti il proprio bisogno impellente e di aver adottato comunque tutte le cautele per evitare di essere visto.
Giustificazioni che però non sono servite: la Polizia lo ha infatti sanzionato per oltraggio alla pubblica decenza e il Tribunale di Pistoia ha successivamente confermato la multa, rilevando che, malgrado le cautele asseritamente adottate, l’uomo era risultato ben visibile alla pattuglia che lo aveva appunto multato.
Contro la pronuncia l’uomo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il reato contestatogli, peraltro successivamente depenalizzato, impone al giudice di verificare l'offensività in concreto della condotta contestata: il Tribunale avrebbe quindi errato, non tenendo conto delle circostanze di tempo e luogo in cui era avvenuto il fatto e che erano state adottate tutte le cautele necessarie affinché non fosse percepito da terzi.
Del tutto omessa, secondo il ricorrente, anche la scriminante dello stato di necessità, che consente la sosta in corsia d’emergenza in caso di malessere del passeggero o del guidatore, come appunto in caso di minzione urgente.
Nessuna delle censure ha però convinto la VI Sezione civile della Cassazione.
I giudici, con ordinanza 25 marzo - 17 giugno 2022, n. 19573 (testo in calce), hanno rigettato il ricorso osservando che la sanzione era stata confermata non tanto perché l’uomo era stato sorpreso ad urinare ma proprio perché, a causa di lavori in corso (circostanza ammessa dallo stesso ricorrente), questi aveva occupato la corsia preferenziale risultando quindi ben visibile a terzi, in primis alla pattuglia che lo aveva fermato e multato.
Il Tribunale aveva quindi ben presente il contesto concreto in cui era avvenuta l’infrazione e proprio la mancata adozione di cautele idonee, atte ad evitare la visibilità da parte di altri soggetti, ha giustificato la pronuncia di conferma e la successiva ratifica anche da parte della Cassazione.
“Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”.l Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale che prevedeva un aumento della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per colmare dei debiti degli anni precedenti che non erano stati interamente coperti con le tasse dei relativi anni finanziari a cui facevano riferimento.
La sentenza ha chiarito che “La Tari è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”.
La tariffa annuale deve pertanto bastare a sé stessa relegando a eccezionali le ipotesi in cui le amministrazioni possono colmare la copertura dei debiti pregressi attraverso un aumento della tariffa dell’anno successivo.
Aumentare la tassa dell’anno successivo rispetto al precedente è sicuramente la strada più semplice da seguire per l’amministrazione soprattutto quando deve rimediare agli errori commessi negli anni finanziari precedenti, in tal modo infatti sono i cittadini e le imprese a pagare per gli errori o le negligenze degli amministratori.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Sentenza n. 1458 del 5 settembre 2019
(presidente Maria Cristina Quiligotti, estensore Calogero Commandatore)
L’art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; sicché la complementare regola fissata dal successivo comma 654 del citato art. 1 della l. n. 147/2013, secondo cui deve essere assicurato l’integrale recupero dei costi di investimento “e di esercizio relativi al servizio, […] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”) correttamente interpretato «va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza) […] le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie […] l’inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo; [giacché] una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via ordinaria – eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – di annualità pregresse» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 352).
Il comma 654 bis dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, poi, nel prevedere la possibilità che tra le componenti di costo della T.A.R.I. possano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, consente l’esclusivo recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla T.A.R.I. (T.I.A.1, T.I.A.2 e T.A.R.E.S.) e non invece ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.
In ogni caso − pur volendo ammettere che anche i crediti inesigibili afferenti alla T.A.R.I. possano costituire costi da coprire con l’aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi − la deliberazione impugnata ha fissato la T.A.R.I. per l’anno
2018 computando tra i costi anche le perdite degli esercizi precedenti afferenti agli oneri necessari a effettuare l’integrale e immediato pagamento dei servizi prestati e fatturati dalla “Catanzaro Costruzioni s.r.l.”, società gestrice della discarica, e dalla “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, A.T.O. cui il Comune intimato è socio di minoranza.
Ne consegue che non emergono, neppure in astratto, ipotesi eccezionali legittimanti delle deroghe alle regole fin qui esposte, giacché i costi ut supra indicati costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, dalla corretta e legittima determinazione della tariffa per l’anno precedente e dalla sua regolare e sistematica riscossione. Inoltre, una diversa interpretazione – sostenuta dalla difesa del Comune intimato – potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.
Deve, inoltre, evidenziarsi che gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la delibera impugnata deve essere annullata.
di Remo Bresciani
Chi promette di vendere un bene comune non è inadempiente se con la divisione è assegnato ad altri
Lo stipulante resta obbligato a procurare il trasferimento del cespite da parte del terzo senza che il compratore possa chiedere la risoluzione prima della scadenza del termine
Il comproprietario che promette in vendita un immobile indiviso non è inadempiente se, in sede di divisione, il bene è stato assegnato a un altro. Lo stipulante, infatti, resta obbligato a procurare il trasferimento del cespite da parte del terzo senza che il compratore possa chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine. Ne consegue che il promittente venditore può intimare ai compratori di adempiere la loro obbligazione.
Sono questi i principi seguiti dalla Cassazione (il documento è consultabile in fondo all’articolo) che ha respinto il ricorso del promissario acquirente di un immobile.
La lite trae origine dal contratto preliminare di vendita concluso da uno solo dei comproprietari del bene. La comproprietà del bene era stata resa manifesta già nel preliminare nel quale c’era la precisazione, resa dal venditore, che il bene sarebbe stato a lui assegnato in sede di divisione. L’immobile, però, a seguito di verbale di conciliazione tra i comproprietari, è stato assegnato a un’altra persona. Il venditore ha comunque intimato ai compratori di adempiere e di pagare il prezzo ma i compratori hanno chiesto di differire la data della stipula. Le parti hanno quindi sottoscritto un nuovo accordo che prevedeva il pagamento con cambiali che sono rimaste tutte insolute.
La parte acquirente ha poi inviato una diffida ad adempiere e convenuto in giudizio il venditore chiedendo di accertare la risoluzione del preliminare per inadempimento del venditore.
Il tribunale ha accolto la domanda stabilendo che nel momento in cui il promittente venditore aveva inviato la diffida, era già inadempiente, avendo acconsentito all’attribuzione del bene a un terzo. La corte d’appello ha però riformato la pronuncia rilevando che l’attribuzione della porzione promessa in vendita a compartecipe diverso dall’alienante non determinava, per ciò solo, l’inadempimento del venditore, potendo questi procurare il trasferimento del bene dall’effettivo proprietario.
La vertenza è così giunta in Cassazione dove il compratore ha sostenuto che l’inadempimento era del venditore il quale non avrebbe mantenuto la promessa di acquistare il cespite in sede di divisione.
La Suprema corte ha però respinto la domanda stabilendo che in caso di promessa di vendita di un immobile indiviso da parte di uno solo dei comproprietari, l’attribuzione del cespite in sede divisoria a un compartecipe diverso dall’alienante “non configura definitivo inadempimento del promittente, potendo egli procurare direttamente l’acquisto da parte del terzo”. Di qui la legittimità della prima diffida.
Il Tribunale Amministrativo catanese ha statuito che il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dal mare previsto dall’articolo 15 legge della Regione Siciliana numero 78/76 non si applica alle parti di territorio dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge possedevano di fatto e non sulla sola base di quanto previsto dallo strumento urbanistico – adottato o approvato – le caratteristiche o meglio connotati di densità edilizia delle Zone A e B (così anche (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 9 ottobre 2018, n. 554). Inoltre, ha chiarito come ai sensi dell’art. 142 del d. lgs. n. 42 del 2004, deve ritenersi legittima la scelta del Pianificatore Paesaggistico di escludere l’operatività del vincolo di Tutela per tutte le aree che alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della cosiddetta legge «Galasso») si trovassero in determinate
condizioni, e in particolare: b.2.1.) quelle delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 («Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765»), come zone territoriali omogenee «A» e «B»; b.2.2.) quelle delimitate come zone diverse dalle «A» e «B», limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione e a condizione che le relative previsioni fossero state concretamente realizzate; b.2.3.) quelle ricadenti, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; Infine ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica è
espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica; ed è pertanto tendenzialmente insindacabile innanzi al (e dal) giudice amministrativo, se non per (eccesso di potere per) intrinseca illogicità o travisamento dei fatti indotto da uno o più errori obiettivamente rilevabili, quali gli errori di calcolo (matematico, topografico, antropometrico) e/o gli errori nell’applicazione di regole mutuate da scienze esatte (matematica, geometria, geologia, biologia, chimica, fisica, ecc.) o di regole sulle quali si basano discipline applicative di queste ultime (cfr., fra le tante, Cons., Stato, sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747).
Il Tar Palermo blocca demolizione in centro storico e smentisce l’operato del comune di Agrigento e della Soprintendenza
La sig.ra T.E. è proprietaria di un’unità immobiliare sita in Agrigento, all’interno del perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Agrigento.
Nel 2014, durante l’esecuzione di lavori di ripristino, regolarmente assentiti dal Comune di Agrigento, l’immobile è crollato.
Successivamente, il Comune di Agrigento con permesso di costruire del luglio 2021, ha approvato il progetto di fedele ricostruzione dell’immobile crollato, consentendo, tra l’altro, il miglioramento delle strutture portanti da realizzarsi in cemento armato.
Per la tipologia di intervento, il Comune di Agrigento, alla luce della normativa vigente aveva ritenuto che l’intervento in questione, ai sensi del D.P.R. 31/2017 non rientrasse tra quelli soggetti a preventivo parere da parte della Soprintendenza.
Nel corso dei lavori, tuttavia, a seguito di un esposto, il Comune di Agrigento ha sospeso i lavori ritenendo opportuno di dover acquisire il parere della competente Soprintendenza.
La Soprintendenza di Agrigento, nel mese di gennaio 2022 , sulla richiesta del Comune di Agrigento, ha espresso parere negativo ritenendo che l’intervento proposto, nella parte in cui prevede una modifica delle strutture portanti dell’edificio, sarebbe risultato in contrasto con l’art. 16 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Particolareggiato del Centro storico (P.P.C.S.) del Comune di Agrigento, secondo il quale sarebbe consentita la demolizione e ricostruzione soltanto “con l’uso di tecnologie analoghe al preesistente”.
A seguito del parere della Soprintendenza, il Comune di Agrigento oltre a confermare la sospensione dei lavori, ha disposto la revoca dei titoli edilizi rilasciati in precedenza ed ha intimato l’integrale demolizione delle opere realizzate.
A questo punto, la sig.ra T.E. con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo deducendo diversi motivi di censura rispetto all’operato del Comune e della Soprintendenza di Agrigento.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’, oltre a contestare la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e le regole che disciplinano il potere di autotutela in tema di titoli edilizi, hanno censurato nel merito il parere della Soprintendenza di Agrigento rilevando come fosse frutto di una lettura erronea delle disposizioni del P.P. del Centro Storico anche alla luce delle novità legislative introdotte successivamente alla sua adozione.
Secondo i legali, infatti, l’assunto della Soprintendenza di Agrigento secondo il quale l’intervento di fedele ricostruzione dell’edificio con intelaiatura in c.a, risulterebbe in contrasto con l’art. 16 delle NTA del P.P.C.S., appare erroneo poiché tale previsione contempla gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, mentre alla luce delle sopravvenienze normative l’intervento in questione, quale “ristrutturazione edilizia”, deve trovare la sua disciplina nelle previsioni degli artt. 13, 14 e 15 che consentono espressamente la possibilità di sostituire le strutture portanti con miglioramento della statica complessiva dell’edificio “con le tecnologie più appropriate”.
In accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, il TAR Palermo ha accolto la domanda cautelare volta alla sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo che: <
Considerato, sotto altro profilo, che ricorre il pericolo di un danno grave ed irreparabile, atteso che è stata disposta la demolizione delle opere realizzate;>>.
Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo la sig.ra T.E. non dovrà demolire le opere realizzate nell’attesa della definizione del giudizio nel merito.
Il TAR Sicilia sul quantum della tassa rifiuti (Tari) per aziende e cittadini: “attenzione ai debiti pregressi”
“Illegittimo l’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi”.l Tar Sicilia, Sezione Terza, n. 2158/2019, ha accolto il ricorso proposto da alcuni cittadini ed aziende del Comune di Campobello di Licata, assistiti dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, contro una delibera comunale che prevedeva un aumento della tariffa della tassa sui rifiuti (Tari) per colmare dei debiti degli anni precedenti che non erano stati interamente coperti con le tasse dei relativi anni finanziari a cui facevano riferimento.
La sentenza ha chiarito che “La Tari è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”.
La tariffa annuale deve pertanto bastare a sé stessa relegando a eccezionali le ipotesi in cui le amministrazioni possono colmare la copertura dei debiti pregressi attraverso un aumento della tariffa dell’anno successivo.
Aumentare la tassa dell’anno successivo rispetto al precedente è sicuramente la strada più semplice da seguire per l’amministrazione soprattutto quando deve rimediare agli errori commessi negli anni finanziari precedenti, in tal modo infatti sono i cittadini e le imprese a pagare per gli errori o le negligenze degli amministratori.
Impianto di rifiuti sequestrato, il Cga: "No allo stop delle autorizzazioni"
I giudici amministrativi hanno ritenuto di accogliere la linea difensiva dell'impresa
Era stato sequestrato dai carabinieri nei mesi scorsi a causa di presunte irregolarità nella gestione: impianto di trattamento dei rifiuti di Licata potrà continuare a lavorare nei limiti delle prescrizioni della Procura.
A deciderlo, con un'ordinanza, è il stato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia. A rivolgersi ai giudici, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, erano stati i titolari dell'impianto dopo che l'Assessorato regionale dell’Energia (a seguito del sequestro) avevano disposto la sospensione dell'autorizzazione regionale per tutta la durata del provvedimento.
In particolare i legali hanno sostenuto che "la normativa di riferimento, prevede una procedura sanzionatoria amministrativa del tutto indipendente da quella penale e non è prevista un’ipotesi di sospensione automatica delle autorizzazioni in ragione di un provvedimento di sequestro penale".
Il Cga ha accolto la domanda cautelare ritenendo che "essendo, in atto, la struttura oggetto esclusivo degli accertamenti della competente Procura della Repubblica, le esigenze cautelari possono essere tutelate consentendo a parte ricorrente di svolgere la propria attività nei i limiti imposti dal provvedimento di sequestro adottato dal pubblico ministero e secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Procura della Repubblica. A tal fine i provvedimenti impugnati devono, nelle more, essere sospesi fino a quando perduri il sequestro disposto in sede penale. All’esito di un eventuale dissequestro la competente pubblica amministrazione nell’ambito delle materie di propria competenza ed in forza della propria discrezionalità, valuterà se permangono profili tali da adottare atti inibitori, fondati su autonome esigenze".
La ditta, quindi, potrà continuare la propria attività secondo le indicazioni della procura della Repubblica e sulla base delle autorizzazioni ottenute in sede penale.
Lavori di bonifica ambientale e iscrizione camerale: la sentenza del CGA Sicilia
E’ necessaria una corrispondenza contenutistica tendenzialmente completa tra l’iscrizione camerale e l’oggetto del singolo contratto d’appalto da assegnare.
Con la recentissima sentenza del 7 febbraio 2022 (numero 181), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso importanti principi sul tema del rapporto tra l’iscrizione camerale dell’operatore economico e l’oggetto dell’appalto, confermando la sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 2594 del 2021.
Il caso di specie concerneva un grosso affidamento relativo a lavori di bonifica e messa in sicurezza (per l’importo di circa 15 milioni di euro), finalizzati a rendere fruibile a parco l’area di Monte Calvario nel Comune di Biancavilla.
Il ricorso introduttivo del giudizio del primo grado era stato proposto dalla società Teseco Bonifiche s.r.l., difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Giampaolo Barsotti, partecipante alla gara, avverso l’iniziale aggiudicazione disposta nei confronti di altro operatore, contestando l’insussistenza dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla documentazione di gara, tra cui quello riguardante l’iscrizione camerale per attività inerenti l’oggetto della gara.
Il TAR Catania ha accolto il ricorso con la citata sentenza 2594/2021, che è stata impugnata dall’originaria aggiudicataria tanto nel merito della decisione, quanto per un profilo attinente alla presunta violazione del contraddittorio dovuta alla circostanza che il TAR avrebbe deciso il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. nonostante la riserva di ricorso incidentale manifestata dalla parte.
Con la sentenza in commento, il CGA ha tuttavia respinto l’appello, confermando definitivamente la pronuncia di primo grado e, dunque, l’aggiudicazione dei lavori di bonifica in capo alla Teseco Bonifiche.
Relativamente alle censure di merito, ossia alle questioni riguardanti l’iscrizione camerale per attività inerenti l’oggetto della gara, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha affermato il seguente principio:
“La giurisprudenza afferma la necessità di una corrispondenza contenutistica tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto del singolo contratto d’appalto da assegnare e ciò in quanto l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gare dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. Cgars n. 231 del 2020, che richiama un’ampia e conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato)”.
Sul piano della disciplina processuale, la sentenza ha poi chiarito un importantissimo aspetto relativo alla corretta applicazione dell’art. 60 c.p.a. (definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare) nei casi in cui una delle parti si riservi di proporre ricorso incidentale.
Il giudice di appello siciliano ha infatti affermato che:
“La dichiarazione dell’intenzione di proporre ricorso incidentale, tale da precludere la possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, postula la compiuta valutazione in ordine alla proposizione della detta azione e la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi di tale strumento processuale, mentre è evidentemente insufficiente a tal fine la riserva dell’eventuale proposizione dell’azione incidentale, che postula, diversamente, la non compiuta valutazione in ordine a tale facoltà e che non costituisce affatto una sicura manifestazione di volontà”.
di Dario Ferrara
Imputato messo alla prova anche se non può riparare tutto il danno
Non si può escludere il beneficio solo perché l’attività di pubblica utilità non vale quanto il pregiudizio cagionato: conta lo sforzo massimo sostenibile nell’ottica della riabilitazione
L’imputato può essere messo alla prova anche se non è in condizioni di riparare tutto il danno che ha causato. E ciò perché la norma ex articolo 168 bis Cp non prevede alcun automatismo retributivo, anzi tende a favorire la riabilitazione del prevenuto attraverso “opere buone”: è irrilevante, allora, che lo svolgimento di un’attività di pubblica utilità non produca un valore pari all’importo del pregiudizio cagionato. Conta invece la disponibilità dell’interessato ad assicurare la prestazione a fini ripristinatori con lo sforzo massimo che può sostenere, alla luce delle sue condizioni economiche. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 7 luglio 2022 dalla terza sezione penale della Cassazione (e qui leggibile in fondo all’articolo).
Retroattività esclusa
È accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato per omessa dichiarazione al fisco, mentre il sostituto procuratore generale concludeva per l’inammissibilità. Sbagliano i giudici del merito a escludere il beneficio sul rilievo che l’evasione supera i 200 mila euro e il prevenuto non ha pagato il debito con l’erario: da una parte i reati contestati risultano commessi prima che entrasse in vigore la stretta, introdotta in sede di conversione del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020, che non può essere applicata in senso retroattivo; dall’altra non si può subordinare l’ammissione alla probation all’integrale risarcimento del danno, che è indicato «ove possibile» fra le condizioni del beneficio. E dunque il risarcimento è auspicabile ma non costituisce una condizione ostativa se non risulta realizzabile.
Condizioni economiche
Va detto che né il tribunale né la Corte d’appello valutano l’adeguatezza del programma presentato dall’imputato per la messa alla prova. Il giudice di secondo grado esclude il beneficio sul rilievo che anche svolgendo una prestazione di lavoro di pubblica utilità l’imputato non potrebbe pagare il debito tributario maturato negli anni d’imposta incriminati. Ma così valorizza profili che non rilevano sul piano legislativo per l’accoglimento dell’istanza. Rispetto alla riparazione da compiere il giudice può verificare le condizioni economiche del prevenuto ex articolo 464 bis, comma quinto, Cpp.
di Dario Ferrara
Condannato il dirigente comunale per l’incidente sulla strada scivolosa se non cura la manutenzione
Il distacco del new jersey costa la vita a un bambino: responsabile insieme al conducente il responsabile delle opere pubbliche che ha poteri di spesa ma non dispone un intervento straordinario
Condannato. È responsabile anche il dirigente del Comune oltre che il conducente del veicolo per la morte del bambino nell’incidente automobilistico. E ciò perché il sinistro avviene su una strada rattoppata e scivolosa: la velocità eccessiva del pulmino sull’asfalto bagnato fa il resto. Risultato: il mezzo finisce contro lo spartitraffico e un blocco di cemento del new jersey colpisce l’auto in corsa. Ed è titolare di una posizione di garanzia il responsabile del settore opere pubbliche dell’ente: deve curare la manutenzione delle infrastrutture e ha potere di spesa oltre che di intervento straordinario eppure nulla ha disposto in un tratto di strada dove si sono già verificati sinistri. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 17 giugno dalla quarta sezione penale della Cassazione (e qui leggibile in fondo all’articolo).
Fonti di rischio
Bocciato il ricorso di entrambi gli imputati. La velocità del pulmino è inadeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni meteo. E dire che al volante c’è un autista professionista che percorre spesso quella strada per lavoro, ma quella sera compie una serie di manovre errate e inappropriate alla situazione obiettiva. Insieme al conducente, tuttavia, risponde anche il dirigente comunale anche se ha segnalato alla Giunta comunale i problemi del tratto “incriminato”.
È in base all’articolo 14 Cds che gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla manutenzione delle infrastrutture mentre l’articolo 107 Tuel riconosce ai dirigenti comunali poteri di spesa per intervenire. E fra le competenze del responsabile del settore ci sono gli interventi straordinari e d’urgenza oltre la manutenzione ordinaria. Proprio ciò che è mancato nella specie: il dirigente deve ritenersi consapevole del pericolo assoluto rappresentato dallo spartitraffico degradato che si trova in prossimità dello svincolo.
Si trova, d’altronde, in una posizione di garanzia rispetto a fonti di rischio note da anni a lui agli amministratori locali. Ma non interviene, anzi: poco prima del sinistro destina 18 mila euro alla manutenzione delle aree verdi invece che al rifacimento della strada-killer, dove peraltro aveva disposto in passato sui guard-rail e rappezzi dell’asfalto.
Tarsu, l’annullamento delle delibere non azzera la pretesa tributaria. Scatta per il giudice l’obbligo di applicare le tariffe corrette
L’annullamento delle delibere tariffarie della tassa rifiuti non comporta il venir meno della pretesa tributaria ma determina l’obbligo del giudice di applicare le tariffe corrette (quelle dell’anno precedente). L’annullamento di una delibera Tarsu, inoltre, non ha alcun effetto sulle delibere degli anni successivi, anche se meramente ripetitive della prima, trattandosi di atti autonomi.
Penalisti in sciopero il 27 e 28 giugno: no a cedimenti sui diritti
L'Unione delle Camere Penali Italiane denunzia la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento: una prassi ormai "abituale"
L'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto due giorni di astensione - il 27 e 28 giugno prossimi - degli avvocati penalisti per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo. In particolare, i legali denunciano la compromissione del diritto dell'imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento. Una prassi ormai "abituale" denunciano i penalisti in quanto a seguito del mutamento del giudice non viene disposta la rinnovazione della prova. (Sono esclusi dall'astensione i circondari di Benevento e Napoli Nord interessati da astensioni indette dalla Camera Penale di Benevento per il 15 giugno e dalla Camera Penale di Napoli Nord per il 6 luglio 2022).
Con la legge delega n. 134/2021, si legge nella nota delle Camere penali, firmata dal Segretario, Eriberto Rosso, e dal Presidente Gian Domenico Caiazza, il Parlamento ha stabilito il principio per il quale il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e al loro ascolto, al fine di percepirne il contesto e anche tutti gli elementi che compongono la comunicazione non verbale. In buona sostanza, spiega l'Unione, la "delega Cartabia" ha inteso recepire le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132/2019. Dove, la Corte delle leggi, tramite un obiter dictum, ha prospettato al Legislatore la possibilità di una limitazione dell'operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni quando vi sia quantomeno la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza.
Nonostante il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento in quanto oggetto della legge delega, prosegue il comunicato dei penalisti, ogni giorno continua a verificarsi nelle nostre aule di giustizia il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019). Secondo tale pronuncia è possibile per il nuovo giudice non procedere alla rinnovazione dell'acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. "Conseguenza di tale pronuncia sono le devastanti prassi in atto per le quali con inquietante frequenza mutano le composizioni dei collegi e dei tribunali monocratici, di fatto così bilanciando principi costituzionali con esigenze organizzative, trasferimenti a richiesta dei singoli magistrati, esigenze private degli stessi giudici".
È già stata richiesta – proseguono - la previsione di una disciplina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell'attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell'udienza. Ma i penalisti italiani "intendono reagire a questo stato di cose e, proprio nell'imminenza della chiusura dei decreti delegati, richiedono che siano previste quantomeno misure che diano certezza che il giudice della decisione abbia nel suo bagaglio di conoscenza la concreta visione delle videoregistrazioni". I provvedimenti attuativi debbono dunque prevedere l'obbligo, sanzionato da nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, di quelle videoregistrazioni.
Inoltre, l'Unione delle Camere Penali chiede un "immediato intervento nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario volto a prevedere l'obbligo per il giudice richiedente il trasferimento di previamente esaurire il proprio ruolo portando a termine i processi già iniziati". "Tale onere, in realtà, è già contemplato in una precisa direttiva del CSM, semplicemente rimasta inattuata. Laddove il previo esaurimento del ruolo assumesse la forma di un preciso obbligo avente forza di legge troverebbero immediata soluzione almeno le più gravi storture determinate dalla infausta decisione delle Sezioni Unite".
La suocera invadente può essere causa di separazione
Sulla separazione dei coniugi un solo episodio di violenza è sufficiente per condurre all'addebito della stessa al marito, disinteressato dal punto affettivo alla moglie, costretta a sopportare una suocera invadente e controllante
Separazione dal marito anche per colpa della suocera
Addebito della separazione al marito anaffettivo
Sulla separazione pesa anche l'invadenza della suocera autoritaria
Separazione dal marito anche per colpa della suocera
Accordata la separazione alla moglie, che ha dato 5 figli al marito, che però non la ricambia con l'affetto e la comprensione di cui ha bisogno e che in un episodio, anche se isolato, la picchia in presenza del primogenito. Una crisi aggravata anche dalla presenza costante e controllante della suocera, che si intromette nella gestione dei nipoti e che, da quanto rivelano tate e collaboratrici, fa sentire la nuora ospite della sua villa, concessa in comodato al figlio per mettere su famiglia. Una separazione che costa cara al coniuge, visto che se lo stesso ha avuto dei problemi economici, è solo per colpa sua.
Addebito della separazione al marito anaffettivo
Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere la separazione con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e per lesione della propria integrità fisica.
Chiede altresì l'assegnazione della casa di proprietà della suocera, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, un assegno mensile per i 5 figli di 8.000 euro complessivi e di 20.000 per il proprio mantenimento.
La donna lamenta il disinteresse morale e sessuale del marito nei suoi confronti e dichiara di essere vittima di vessazioni da parte dello stesso, culminate nell'episodio del 2016, quando l'ha picchiata in presenza del figlio, intervenuto in sua difesa.
Da sempre esclusa dalla vita lavorativa del marito e ostacolata nello svolgimento di una sua attività esterna all'ambiente domestico, la donna fa presente di avere sempre subito la presenza autoritaria e invadente della suocera, che l'ha sempre trattata come un ospite della sua villa.
Il marito, costituitosi in giudizio, acconsente alla assegnazione della villa alla moglie fino alla scadenza del comodato concesso loro dalla sua famiglia di origine, ossia fino al 30 novembre 2017, il riconoscimento di un assegno mensile in favore dei figli di 1250 euro e di 750 euro per il mantenimento alla moglie, sostenendo che il tenore di vita goduto all'inizio del matrimonio è venuto meno a causa di debiti e problemi giudiziari.
Il Presidente, sentiti i coniugi, assegna la casa alla moglie, dispone l'affidamento congiunto dei figli con collocazione presso la madre e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di 1500 euro per i figli e di ulteriori 1500 euro per la moglie.
Sulla separazione pesa anche l'invadenza della suocera autoritaria
Il Tribunale, ritenendo fondata la domanda avanzata dalla moglie, pronuncia la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito in quanto "il grave episodio di violenza fisica è da solo sufficiente a fondare la responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che ne è stato l'autore" come confermato dalla testimonianza del figlio, di anni 16 all'epoca dei fatti.
Il Tribunale conferma inoltre la versione della donna in relazione alla lamentata ingerenza della suocera autoritaria nel menage familiare, confermata dalle testimonianze rese in giudizio dalle collaboratrici domestiche e dalle tate. Dichiarazioni da cui è emersa la volontà dell'anziana donna di gestire la vita e le abitudini anche alimentari dei nipoti, di esercitare un continuo controllo, anche telefonico, sugli stessi e di far pesare alla nuora di vivere nelle villa di sua proprietà.
Dal punto di vista economico, dalle prove è emerso inoltre che il marito, oltre a svolgere una sua attività di impresa, è titolare di partecipazioni societarie in 13 società, mentre la moglie, di anni 47 è disoccupata.
Dalla valutazione comparativa delle rispettive situazioni dei coniugi il Tribunale dispone quindi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, conferma il mantenimento di 5000 euro al mese per i figli, a cui sommare le spese straordinarie, a totale carico del padre.
Alla moglie spetta invece un assegno mensile di 3000 euro, alla luce del suo stato di disoccupazione e della sua età (47 anni), a conferma di quanto deciso in sede di appello, dopo il reclamo della donna contro le decisioni del Presidente.
Abuso d'ufficio
I giudici iniziano a restringere il campo sul reato di abuso d’ufficio, applicando i principi portati avanti con la riforma del 2020 (decreto legge 76). Infatti, la Corte costituzionale prima (sentenza 8/2022) e la Cassazione poi (sentenza 13136/2022) hanno sottolineato l’esigenza di evitare controlli eccessivi del giudice penale sulla discrezionalità dell’attività amministrativa. Due decisioni che paiono segnare un’inversione di tendenza rispetto alle pronunce seguite alla riforma.
Morte da Covid-19: sì all’indennizzo se la polizza privata copre l'infortunio
Il Tribunale di Torino, ha accolto la domanda avanzata dagli eredi di un uomo, titolare di una polizza assicurativa privata che copriva il rischio “infortuni”, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria da infezione SARS-CoV-2, tesa ad ottenere la condanna della Compagnia convenuta al versamento, a titolo di indennizzo, delle somme
assicurate da contratto per il caso di morte conseguita ad infortunio. In particolare, secondo il giudice di merito, ben interpretando la clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto (secondo cui va ritenuto infortunio anche un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni le quali abbiano per conseguenza la morte), anche l’infezione da SARS-CoV–2 va considerata, in assenza di specifica esclusione contrattuale, evento inquadrabile quale infortunio coperto dalla polizza e, come tale, tecnicamente indennizzabile.
Nel mese di gennaio 2019 un uomo, di professione medico dentista in regime di libera professione, sottoscriveva con una Compagnia assicurativa una polizza infortuni, a mente della quale, come riportato nelle condizioni generali di contratto, era considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che producesse lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali avessero per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Per il caso di morte, nello specifico, era assicurata una somma pari a centomila euro. La polizza prevedeva anche, per il caso in cui l’infortunio avesse come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, l’obbligo della Compagnia di corrispondere la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. Nel mese di marzo 2020, purtroppo, l’uomo contraeva una infezione da coronavirus e decedeva in ospedale quale conseguenza di una grave insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2. La moglie della vittima (erede al pari del figlio minore, autorizzato ad accettare l’eredità paterna in forza di un intervenuto provvedimento del giudice tutelare) rivendicava pertanto le somme previste nella suddetta polizza in aderenza alle previsioni contrattuali, ritenendo la morte del marito la conseguenza di un infortunio verificatosi per causa fortuita, violenta ed esterna, proprio come previsto nelle condizioni generali di contratto.
Nonostante la puntuale denuncia del sinistro alla Compagnia, tuttavia, quest’ultima negava il ristoro alla richiedente, sostenendo che l’evento denunciato non rientrasse nella definizione contrattualmente indennizzabile ai sensi delle condizioni generali di assicurazione. A nulla valeva, peraltro, il successivo invito del legale degli eredi a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, alla quale la Compagnia aveva ritenuto di non partecipare, come pure ogni altro tentativo posto in essere in via stragiudiziale a scopo transattivo e deflattivo del contenzioso processuale. Gli eredi pertanto adivano le vie legali per ottenere la condanna della Società assicurativa al pagamento della somma prevista in polizza per il caso di morte per infortunio del contraente.
La domanda da porsi nel caso oggetto di valutazione, si legge in sentenza, è se l’infezione da SARS_CoV-2 sia da considerarsi evento inquadrabile quale infortunio tecnicamente indennizzabile ai sensi delle “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” sottoscritte dal de cuius, titolare della polizza.
Più in generale, esulando un attimo dalla fattispecie in commento ma rimanendo in tema, è noto come l’equiparazione: “infezione da coronavirus=infortunio”, sia da tempo stata presa in considerazione dal legislatore e, de relato, dalle Compagnie assicurative.
L’art. 42 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, più noto come Decreto “Cura Italia”) ha, in effetti, equiparato l’infezione da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro.
Più precisamente, il secondo comma della norma appena citata (intitolata: “Disposizioni Inail”), recita testualmente: “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
La successiva circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13, ha ulteriormente precisato quale fosse la disciplina alla base del riconoscimento dell’infortunio per le persone contagiatesi a lavoro.
Nella pratica, non pochi sono stati, tuttavia, i dubbi applicativi:
a) la copertura assicurativa dell’Inail in caso di infezione da Covid-19 contratta durante l’attività lavorativa è stata, infatti, riconosciuta unicamente a chi lavora come dipendente in una struttura pubblica o privata, e non ai liberi professionisti, titolari di polizze assicurative private a copertura del rischio “infortunio”, in quanto in questo caso l’infezione da Covid-19 è stata fatta rientrare nel concetto di “malattia”, e non di infortunio;
b) ciò ha fatto ritenere la sussistenza di una evidente disparità di trattamento tra chi lavora come dipendente in una struttura pubblica o privata e chi invece svolge la medesima attività come libero professionista.
L’Inail, d’altronde, seguendo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie (come indicato nelle “Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie” di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74), ormai da tempo tutela le affezioni morbose, inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro ed effettuando una equiparazione tra causa violenta e causa virulenta.
In tale ambito delle affezioni morbose sono stati, dunque, ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto: la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, è stata ritenuta operante anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
Come conseguenza, sono stati ritenuti destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.
Al contrario, con riferimento alle coperture “infortuni” private, l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha tenuto a far propria una interpretazione in virtù della quale:
a) il Covid-19 non può ritenersi coperto dalle polizze infortuni private, in quanto il sopra citato art. 42 del decreto c.d. “Cura Italia” rappresenterebbe una norma di carattere speciale, emanata in un contesto emergenziale, e che, come tale, non troverebbe applicazione in ambito privatistico;
b) nell’ambito delle coperture infortuni private, pertanto, occorrerebbe fare riferimento a una definizione di infortunio strettamente medico-legale, intendendolo come un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa esterna, che produce delle lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
c) i contagi da Covid, pertanto, andrebbero fatte rientrare nell’ambito delle coperture malattia.
Non a caso, con riferimento alle polizze con copertura del rischio “malattia” molte Compagnie, per andare incontro alle esigenze dei propri clienti, hanno modificato la propria offerta sviluppando prodotti assicurativi ad hoc e prevedendo garanzie specifiche in caso di contagio da Covid-19 come, ad esempio, indennità giornaliere (in genere previste solo in caso di ricovero) per il periodo di quarantena.
A seguito dell’introduzione del suddetto articolo 42, molte Compagnie, in un’ottica prudenziale, hanno comunque preferito disciplinare nelle condizioni contrattuali delle proprie polizze infortuni il caso delle infezioni, prevedendone, a scanso di equivoci, l’esclusione esplicita dalla copertura (pur ritenendosi una simile clausola di esclusione espressa in realtà non necessaria dal momento laddove il Covid venga appunto considerato quale malattia e non come infortunio).
Il Tribunale piemontese ha inteso valutare positivamente le istanze di parte attrice:
a) giudicando inquadrabile l’infezione da SARS-CoV-2 contratta dalla vittima alla stregua di un infortunio tecnicamente indennizzabile ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni contenute nella polizza sottoscritta dal libero professionista;
b) individuando quale danno ristorabile quello da morte da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna ex art. 12 delle suddette Condizioni;
c) condividendo pienamente l’iter argomentativo posto alla base della consulenza tecnica di ufficio, appositamente eseguita;
d) ritenendo, di conseguenza, pienamente accoglibili le domande attoree, atte ad ottenere il pagamento, da parte della Compagnia convenuta, della somma di centomila euro prevista contrattualmente per il caso di morte per infortunio del sottoscrittore della polizza.
Come evidenziato anche nella richiamata consulenza tecnica di ufficio, le Condizioni contenute nel contratto sottoscritto dal de cuius ricomprendevano espressamente nel concetto di “infortunio” coperto da polizza un evento dovuto a tre presupposti (causa fortuita, violenta ed esterna) in grado di determinare constatabili lesioni tali da determinare, come conseguenza, anche la morte.
Ebbene, il giudice di prime cure ha evidenziato:
a) quanto al primo presupposto (causa fortuita), come sia da prendere atto che l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario. Nel caso che ci riguarda, in particolare, il soggetto infettato si era venuto a trovare in siffatta condizione “senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione” (l’epidemia da coronavirus non era ancora conosciuta bene, all’epoca dei fatti, e la si riteneva comunque confinata alla Cina (solo l’11 marzo 2020, come noto, l’OMS proclamò il Covid-19 come “pandemia”);
b) quanto al secondo presupposto (causa violenta), come ben possa dirsi violenta l’infezione da Covid-19, con un’alterazione dello stato normale di intere parti dell’organismo (in particolare dell’apparato respiratorio), tale da causare gravissime sofferenze e, alla fine, addirittura la morte del soggetto interessato;
c) quanto al terzo presupposto (causa esterna), come il virus sia un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno (non a caso, precisa il giudicante, si è disposto l’utilizzo di una mascherina, atta proprio ad evitare il contatto con detta causa esterna).
Un altro aspetto da tenere in grande considerazione nel caso che qui ci occupa, si legge in sentenza, è poi rappresentato dal fatto che il contratto di assicurazione stipulato nella fattispecie dalla vittima non escludesse affatto le infezioni virali e batteriche: pertanto, proprio l’assenza di una specifica esclusione contrattuale fa sì che l’infezione da SARS-CoV-2 soddisfi pienamente, secondo la corte di merito, la definizione di infortunio come contemplata nelle Condizioni di polizza.
Più precisamente, la circostanza che non fosse presente in polizza alcuna clausola contrattuale di esclusione di indennizzo, ha reso tecnicamente indennizzabili anche le infezioni acute virulente che provengano dall’esterno, soddisfacendo esse la definizione di infortunio.
Il magistrato torinese si è spinto tuttavia ancora oltre, richiamando, a rafforzare ulteriormente la validità delle istanze attoree, il disposto di cui all’art. 1370 del Codice Civile, a mente del quale “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.
Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, “le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo” (così, ex multis, Cass. Civ., 17.01.2008, n. 866).
Ad ulteriore corollario, il giudicante ha peraltro rigettato, in modo perentorio, i rilievi del consulente di parte nominato dalla convenuta:
a) circa le pretese distinzioni da porre tra infortunio e malattia, ironicamente – ed amaramente – asserendo: “quasi che il contrarre una malattia non costituisse un infortunio (la cui stessa etimologia latina - in-fortunium - squaderna il riferimento ad un evento sfortunato, malaugurato), ma semmai, allora ... un colpo di buona sorte!”.;
b) circa la pretesa impossibilità, per chiunque appartenga alla classe medica, “di indennizzare in infortunistica privata una polmonite qualificandola quale infortunio e non, piuttosto, malattia”.
Per smentire tale asserzione, il giudicante ha richiamato una dichiarazione resa alla stampa addirittura dal Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, secondo cui:
b1) è inequivocabile che la dottrina medico legale abbia costantemente considerato un’infezione virale o batterica, sulla cui trasmissione vi sia nozione delle modalità di contagio anche ambientale, ovvero non mediato da energie meccanica, un infortunio a tutti gli effetti, dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell’esteriorità causali;
b2) non vi è dubbio che un momento infettante, nella massima parte dei casi, per quanto fondato su evidenze scientifiche, rappresenti un preciso e ben circostanziato evento violento, fortuito ed esterno;
b3) in considerazione di un’articolata e costante dottrina medico legale nonché dei suoi sviluppi, deve affermarsi che, ontologicamente, anche nell’ambito della polizza privata contro gli infortuni, prescindendo da qualsiasi condizione o clausola speciale ovvero diversa specificazione contrattuale nonché dalla valutazione medico legale dell’indennizzabilità e della quantificazione delle sue conseguenze, l’evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso.
Il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la Compagnia di assicurazioni al pagamento nei confronti degli eredi del dentista della somma di centomila euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali,le spese di lite, liquidate in complessivi diciottomila euro oltre ad accessori di legge, ed il rimborso delle spese per laconsulenza tecnica di ufficio.
Onorari avvocati, interessi dalla data della domanda
ha affermato che non si deve fare riferimento alla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice
In tema di onorari di avvocati, gli interessi decorrono dalla messa in mora e cioè dalla data della domanda. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 17122, accogliendo sotto questo profilo il ricorso di un legale e confermando l'indirizzo più recente.
L'avvocato ricorrente aveva denunciato la violazione dell'articolo 1282 c.c. e dell'articolo 1284 c.c., quanto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme delle quali era stato riconosciuto creditore. Il professionista deduce che sebbene in dispositivo la condanna al pagamento del saldo residuo preveda la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda fino al pagamento, "il capitale sul quale calcolare gli interessi sia quello frutto della riduzione anche in conseguenza dei versamenti effettuati in corso di causa". Invece, sostiene "gli interessi andavano riconosciuti sul capitale originariamente richiesto, sebbene ridotto a seguito delle decurtazioni compiute dal Tribunale".
Per la VI Sezione civile, che si è espressa in difformità alla proposta del Consigliere Relatore, il motivo è fondato. La Corte, prosegue la decisione, non ignora come in passato sia stato affermato che (Cass. n. 17655/2018) in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel Dm n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (oggi art. 14 del Dlgs n. 150/2011; conf. Cass. n. 2954/2016 che ribadisce che è dalla data dell'adozione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti). In ragione di tale principio doveva quindi escludersi che sulla somma vantata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell'adozione del provvedimento di liquidazione.
Tuttavia, prosegue la Corte, la più recente giurisprudenza di legittimità, nel rimeditare la questione, ha invece affermato il principio di diritto secondo cui: "Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del Dlgs n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l'attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all'esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole" (n. 8611/2022).
Per il Collegio è questo il principio a cui dare continuità. Ne consegue – conclude la Cassazione - che "ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo, palesandosi quindi erronea la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito".
Testimoni di Geova, esenzione Tarsu anche senza Intesa con lo Stato
Lo ha deciso la Corte di cassazione affermando un principio di diritto ed accogliendo il ricorso dell'Associazione dei testimoni di Geova di Sulmona contro il Comune
"Non è consentito escludere dal beneficio fiscale previsto per locali destinati a culto religioso quelle confessioni religiose che pur potendosi qualificare tali non hanno ancora stipulato le intese di cui all'art. 8 comma 3 della Costituzione". Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza n. 16641 depositata oggi, affermando un principio di diritto ed accogliendo il ricorso dell'Associazione dei testimoni di Geova di Sulmona contro il Comune.
Nell'accertare se una determinata comunità sociale può qualificarsi come confessione religiosa, prosegue la decisione, il giudice "può avvalersi di alcuni indici presuntivi quali, esemplificativamente, la sussistenza di un riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1159/1929 ovvero la circostanza che sia in fase di perfezionamento l'intesa di cui all'art. 8 della Costituzione, oppure operare detto accertamento tramite l'esame dello statuto, che ne esprima chiaramente i caratteri".
La Suprema corte ha poi stabilito che: "È facoltà dei singoli Comuni prevedere nel regolamento comunale che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti da Tari e Tarsu purché la norma venga applicata in armonia con il principio comunitario ‘chi inquina paga' e con le disposizioni degli artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507/ 1993".
"Pertanto – conclude - , possono essere esentati da Tari e Tarsu soltanto gli edifici effettivamente destinati all'esercizio del culto e come tali specificamente indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera classificazione catastale. Se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo".
TARSU/TARI - Riduzione della superficie tassabile solo in caso dell'autosmaltimento fornita dal soggetto occupante
La riduzione della superfice tassabile ai fini TARSU /TARI è possibile solo in caso di autosmaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da parte del produttore.
E' quanto ha disposto dalla Corte di Cassazione con la Sentenza N°14487 del 0505/2022 . Anche in caso di assolvimento dell'onere della prova ( in ordine all'autosmaltimento) ex art.2697 cc da parte del soggetto interessato al beneficio, comunque, a suo carico la debenza Tarsu.
Principio di rotazione solo per le procedure con prestazioni omogenee
di Dario Immordino
Il principio di rotazione di cui all’art. 36 del codice degli appalti, che prescrive l’avvicendamento degli inviti e degli affidamenti per le gare sotto soglia, non si applica alle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.
L’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione costituisce infatti l’indefettibile presupposto logico del principio di rotazione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524).
Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza 8030/2020, con la quale viene sottolineato che, ai fini dell’operatività del principio di avvicendamento dei partecipanti e degli aggiudicatari delle procedure di appalto, non basta che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (Linee guida ANAC n. 4,
punto 3.6.), in quanto “ciò che conta è l’identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime” (Cons. Stato, V, n. 1524 del 2019, cit.).
di Vanessa Ranucci
Per evitare la diffamazione al giornalista non basta invocare il comunicato della polizia senza esporne il contenuto
Non scatta il legittimo esercizio del diritto di cronaca se manca la dimostrazione della verità anche putativa della notizia
Per evitare la diffamazione al giornalista non basta invocare il comunicato della polizia senza esporne il contenuto: insomma, non è legittimo esercizio del diritto di cronaca se manca la dimostrazione della verità anche putativa della notizia. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 12985/22.
Un signore aveva chiesto il risarcimento dei danni per la pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio che, a suo avviso, non riportava fatti corrispondenti al vero. La Corte d'appello aveva respinto la domanda perché il ricorrente non aveva provato la non corrispondenza della notizia contenuta nel quotidiano con la verità dei fatti e con la conseguente lesione della sua immagine. Inoltre, secondo il giudice, l'articolo era espressione di legittimo esercizio del diritto di cronaca in quanto riportava un episodio realmente accaduto e comunicato dalla polizia giudiziaria.
Il ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato il fatto che il giudice aveva basato la propria decisione sul principio secondo il quale al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità deve dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa è stata diffusa, non poteva ritenersi attendibile.
Per Piazza Cavour il ricorso è fondato perché ha sbagliato la Corte distrettuale a ritenere sufficiente, per provare la verità del fatto storico, la circostanza che lo stesso non fosse stato contestato dal ricorrente. Al riguardo, gli ermellini hanno ricordato che, "secondo l’art. 2697 Cc, l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell’eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza
\della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all’attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte stessa". Nel caso in esame, è stato indicato un comunicato della polizia giudiziaria come fonte senza dare conto dell’esatto contenuto del documento che aiutasse a trovare il "requisito della verità" (assoluta o putativa) in relazione a ogni profilo della notizia. Pertanto, al giudice del rinvio il nuovo giudizio.
Avvocati "sotto soglia", la Consulta salva la Gestione separata ma taglia le sanzioni
La Corte costituzionale, sentenza n. 104 di oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del Dl 6 n. 98/2011 nella parte in cui non esonera gli avvocati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione prima della sua entrata in vigoreContenuto esclusivo Norme & Tributi Plus
È legittimo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps a carico degli avvocati del libero foro iscritti al relativo albo, ma non iscritti – né tenuti a iscriversi – alla Cassa di previdenza forense (e non obbligati, quindi, al versamento del contributo soggettivo) per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari (articolo 22 della legge n. 576 del 1980). È stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del Dl 6 n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, nella L. 111/2011), nella parte in cui non prevede che costoro siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 104 depositata oggi .
L'ordinanza di rimessione è stata emessa in un giudizio in cui sono state riunite le cause di due avvocati del libero foro che avevano ricevuto dall'Inps intimazioni di pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata in ragione del reddito da attività professionale maturato nell'anno 2010. Il primo, ha impugnato l'avviso del 22 giugno 2016, con cui l'Inps aveva richiesto il pagamento di complessivi 1.920,70 euro (di cui 1.098,46 a titolo di contributi ed 822,24 a titolo di sanzioni), in ragione del reddito imponibile di 4.111,00 euro tratto dall'attività professionale nell'anno 2010. Il secondo, a sua volta, ha impugnato l'avviso del 4 dicembre 2019 con cui l'Inps gli aveva richiesto il pagamento della somma di 2.743,35 euro (di cui 1.511,00 a titolo di contributi ed 1131,06 a titolo di sanzioni), in ragione del reddito imponibile di 5.655,00 euro tratto dall'attività professionale nell'anno 2010.
L'obbligo di iscrizione alla gestione separa, spiega la Consulta nella lunga decisione che ricapitola l'intera disciplina previdenziale, si iscrive nella tendenza dell'ordinamento verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. "Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario […] assume una funzione di chiusura del sistema…".
Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, del resto, "si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità". Il legislatore della riforma del 1995, con l'introduzione della Gestione separata, non ha voluto dunque "fissare in astratto un rigido riparto di competenze tra essa e le casse professionali, ma ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione del nuovo istituto, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale". Si ha quindi che, se la cassa professionale, proprio nell'esercizio del potere di autoregolamentazione riconosciutole dalla legge, decide di non includere taluni professionisti (eventualmente per mancato raggiungimento di soglie reddituali stabilite da propri organi interni) nell'obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, l'operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandersi la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti; ossia che ricorra l'esercizio abituale di un'attività professionale che abbia prodotto un reddito superiore a un determinato importo.
Inoltre, non vi è alcuna duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell'unicità dell'attività professionale esercitata. Il professionista con reddito (o volume di affari) "sottosoglia" non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un'unica attività, ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo.
Per la Consulta è invece fondata, nei limitati termini di cui si dirà, la questione sollevata in via subordinata, per effetto della quale è sospettata di illegittimità costituzionale la norma interpretativa introdotta dall'articolo 18, comma 12, del Dl n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che l'obbligo degli avvocati del libero foro (non iscritti alla cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di cui all'articolo 22 della legge n. 576 del 1980) di iscriversi alla Gestione separata istituita presso l'Inps decorra dalla data della sua entrata in vigore.
Il giudice rimettente richiama infatti l'iniziale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva sposato un'interpretazione restrittiva della disposizione successivamente oggetto di interpretazione autentica (l'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995), nel senso che il suo ambito soggettivo di applicazione sarebbe stato limitato ai professionisti esercenti attività per le quali non era prevista l'iscrizione in albi professionali. In seguito all'introduzione, nel 2011, di tale disposizione di interpretazione autentica l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è mutato, così estendendosi l'obbligo di iscrizione nella Gestione separata anche ai lavoratori autonomi iscritti agli albi professionali, ma non iscritti alla relativa cassa previdenziale.
Una doglianza condivisa dalla Consulta che ricorda come la Corte di cassazione – in alcune pronunce precedenti alla censurata disposizione di interpretazione autentica (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 giugno 2006, n. 14069, 16 febbraio 2007, n. 3622 e 22 maggio 2008, n. 13218), pur rese con riferimento all'ipotesi dell'esercizio di attività di lavoro autonomo in assenza dell'obbligo di iscrizione ad albi o elenchi abilitanti – è apparsa univocamente orientata ad affermare un'interpretazione restrittiva dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe trovato applicazione nel caso di attività professionale forense, sussistendo già una specifica cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
L'affidamento in questa interpretazione, prosegue la Consulta, trovava quindi l'avallo della giurisprudenza di legittimità e, in ragione di ciò, "assumeva una connotazione più pregnante, raggiungendo un livello di maggiore significatività, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame".
Prima di quest'ultima, il comportamento dell'avvocato con un reddito (o un volume d'affari) "sottosoglia", che ometteva di iscriversi alla Gestione separata e che poi sarebbe risultato essere "inadempiente" per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava però una scusante proprio nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità, maturati peraltro in un contesto in cui il regime previdenziale di categoria, centrato sulla regolamentazione della cassa di previdenza forense, aveva carattere di specialità.
Il legislatore, dunque, pur fissando legittimamente, con l'articolo 18, comma 12, del Dl n. 98 del 2011, come convertito, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell'ordinamento previdenziale.
Ma la Consulta offre anche una soluzione. La reductio ad legitimitatem della norma censurata, afferma, "può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata Inps relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
"In tal modo – conclude la Corte - è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa".
di Dario Ferrara
Roma diventa Regione
In commissione alla Camera sì unanime al testo-base di riforma. Alla Capitale poteri legislativi come le metropoli Ue: escluse sanità e altre materie, in legge ordinaria l’intesa con Stato e Lazio
Roma Capitale diventa Regione. Avrà i poteri legislativi degli enti territoriali, la città eterna: esattamente come le altre metropoli europee. È approvato all’unanimità il testo base della riforma costituzionale dalla commissione Affari istituzionali della Camera, predisposto dai relatori Annagrazia Calabria (Fi) e Stefano Ceccanti (Pd) sulla base di quattro proposte di legge (cfr. il documento in allegato).
Sistema pattizio
L’ente del Campidoglio disporrà, come ampiezza massima, dei poteri legislativi di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, cioè le materie di competenza concorrente e di competenza residuale delle Regioni. Ma risultano comunque escluse la tutela della salute e le altre materie che saranno stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato con una legge nazionale, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Che stabilirà forme di coordinamento fra l’ente della Pisana e quello dell’Urbe. Roma Capitale potrà delegare per legge proprie funzioni amministrative ai municipi. Ora comincia la fase degli emendamenti, poi si andrà in aula: l’iter di approvazione “aggravato” prevede la doppia lettura delle Camere.
Tempi e modi
In sede di prima attuazione della riforma si applicheranno alla città eterna le leggi della Regione Lazio precedentemente in vigore. Il trasferimento dei poteri legislativi a Roma Capitale scatterà dopo due anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale. Va affrontato il nodo dei rapporti con la Città metropolitana. «Dedichiamo questo voto - spiega Ceccanti - all’impegno del professor Beniamino Caravita, che ci ha lasciato qualche mese fa, che tanto ha dato anche su questo tema». «Auspico che questo processo riformatore possa concretizzarsi entro la fine della legislatura», twitta la ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini.
Il marito malato sparisce dalla struttura sanitaria e per la moglie non c'è nessun risarcimento.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che aveva fatto causa ad una struttura sanitaria per la “scomparsa” del marito malato dal luogo di cure.
Il marito malato sparisce dalla struttura sanitaria e per la moglie non c'è nessun risarcimento.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che aveva fatto causa ad una struttura sanitaria per la “scomparsa” del marito malato dal luogo di cure.
di Dario Ferrara
Il padre non mantiene più il figlio che lavora anche se non ha sostenuto l’esame di abilitazione
Revocato l’assegno perché il maggiorenne si è inserito in un settore produttivo pertinente agli studi effettuati: grazie all’usufrutto sull’immobile può crearsi una vita autonoma dal nucleo familiare
Addio mantenimento al figlio maggiorenne. Il padre divorziato non versa più l’assegno al quasi trentenne che lavora, anche se il rampollo non ha ancora sostenuto l’esame di abilitazione alla professione: ciò che conta è che l’interessato si sia inserito in un settore produttivo coerente con gli studi compiuti. E che grazie all’usufrutto su un immobile possa crearsi una vita autonoma dal nucleo familiare. È quanto emerge dall’ordinanza 11047/22, pubblicata il 5 aprile dalla sesta sezione civile della Cassazione.
La suocera invadente può essere causa di separazione. Sulla separazione dei coniugi un solo episodio di violenza è sufficiente per condurre all'addebito della stessa al marito, disinteressato dal punto affettivo alla moglie, costretta a sopportare una suocera invadente e controllante
Separazione dal marito anche per colpa della suocera. Addebito della separazione al marito anaffettivo. Sulla separazione pesa anche l'invadenza della suocera autoritaria. Separazione dal marito anche per colpa della suocera
Accordata la separazione alla moglie, che ha dato 5 figli al marito, che però non la ricambia con l'affetto e la comprensione di cui ha bisogno e che in un episodio, anche se isolato, la picchia in presenza del primogenito. Una crisi aggravata anche dalla presenza costante e controllante della suocera, che si intromette nella gestione dei nipoti e che, da quanto rivelano tate e collaboratrici, fa sentire la nuora ospite della sua villa, concessa in comodato al figlio per mettere su famiglia.
Una separazione che costa cara al coniuge, visto che se lo stesso ha avuto dei problemi economici, è solo per colpa sua. Queste in sintesi le conclusioni del Tribunale di Teramo contenute nella sentenza n. 1052 del 26 novembre 2021 (sotto allegata).
Addebito della separazione al marito anaffettivo
Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere la separazione con addebito al marito per violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e per lesione della propria integrità fisica.
Chiede altresì l'assegnazione della casa di proprietà della suocera, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso di sé, un assegno mensile per i 5 figli di 8.000 euro complessivi e di 20.000 per il proprio mantenimento.
La donna lamenta il disinteresse morale e sessuale del marito nei suoi confronti e dichiara di essere vittima di vessazioni da parte dello stesso, culminate nell'episodio del 2016, quando l'ha picchiata in presenza del figlio, intervenuto in sua difesa.
Da sempre esclusa dalla vita lavorativa del marito e ostacolata nello svolgimento di una sua attività esterna all'ambiente domestico, la donna fa presente di avere sempre subito la presenza autoritaria e invadente della suocera, che l'ha sempre trattata come un ospite della sua villa.
Il marito, costituitosi in giudizio, acconsente alla assegnazione della villa alla moglie fino alla scadenza del comodato concesso loro dalla sua famiglia di origine, ossia fino al 30 novembre 2017, il riconoscimento di un assegno mensile in favore dei figli di 1250 euro e di 750 euro per il mantenimento alla moglie, sostenendo che il tenore di vita goduto all'inizio del matrimonio è venuto meno a causa di debiti e problemi giudiziari.
Il Presidente, sentiti i coniugi, assegna la casa alla moglie, dispone l'affidamento congiunto dei figli con collocazione presso la madre e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di 1500 euro per i figli e di ulteriori 1500 euro per la moglie.
Sulla separazione pesa anche l'invadenza della suocera autoritaria
Il Tribunale, ritenendo fondata la domanda avanzata dalla moglie, pronuncia la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito in quanto "il grave episodio di violenza fisica è da solo sufficiente a fondare la responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che ne è stato l'autore" come confermato dalla testimonianza del figlio, di anni 16 all'epoca dei fatti.
Il Tribunale conferma inoltre la versione della donna in relazione alla lamentata ingerenza della suocera autoritaria nel menage familiare, confermata dalle testimonianze rese in giudizio dalle collaboratrici domestiche e dalle tate. Dichiarazioni da cui è emersa la volontà dell'anziana donna di gestire la vita e le abitudini anche alimentari dei nipoti, di esercitare un continuo controllo, anche telefonico, sugli stessi e di far pesare alla nuora di vivere nelle villa di sua proprietà.
Dal punto di vista economico, dalle prove è emerso inoltre che il marito, oltre a svolgere una sua attività di impresa, è titolare di partecipazioni societarie in 13 società, mentre la moglie, di anni 47 è disoccupata.
Dalla valutazione comparativa delle rispettive situazioni dei coniugi il Tribunale dispone quindi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, conferma il mantenimento di 5000 euro al mese per i figli, a cui sommare le spese straordinarie, a totale carico del padre.
Alla moglie spetta invece un assegno mensile di 3000 euro, alla luce del suo stato di disoccupazione e della sua età (47 anni), a conferma di quanto deciso in sede di appello, dopo il reclamo della donna contro le decisioni del Presidente.
di Vanessa Ranucci
Sì all’azione di indebito arricchimento verso il Comune dall’amministratore convenuto dal privato
Senza un contratto scritto sorge un rapporto obbligatorio diretto tra chi ha fornito la prestazione e il funzionario inadempiente che l'ha consentita
E' legittima l’azione di indebito arricchimento verso il Comune dall’amministratore convenuto dal privato: senza un contratto scritto sorge un rapporto obbligatorio diretto tra chi ha fornito la prestazione e il funzionario inadempiente che l'ha consentita. Lo ha stabilito oggi la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 10432/22.
Un avvocato, nei confronti del sindaco e dell'assessore di un Comune, aveva chiesto la condanna in solido al pagamento dei compensi professionali per un’attività svolta per il Comune su incarico della giunta senza contratto scritto. I convenuti si erano costituiti svolgendo domanda di manleva o di arricchimento senza causa nei confronti dell'ente locale. Il giudice di pace, però, aveva dichiarato inammissibile le domande di arricchimento. Il Tribunale, successivamente, aveva ritenuto che nella specie difettasse l'impoverimento “ingiustificato” a carico degli appellanti, dal momento che questi erano stati condannati al pagamento delle spettanze dell’avvocato per una precisa giustificazione causale derivante dall’art. 191 Dlgs 267/2000.
I ricorrenti, in sede di legittimità, hanno dichiarato che il giudice non aveva rilevato che il Comune era l'unico effettivo beneficiario della prestazione professionale. Al riguardo, il Palazzaccio ha osservato che la prestazione dell’avvocato era stata attuata senza l'osservanza del procedimento formale e contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale. Così, la Suprema corte ha ricordato che “in questi casi il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà: egli è legittimato a esercitare l’azione ex art. 2041 Cc nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus
dell'amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 Cc, con gli oneri probatori a ciò correlati. In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita; ma proprio per salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte costituzionale ha affermato che in linea generale ben sussistono in questi casi in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l’azione ex 2041 Cc verso l’ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito”.
Insomma, per il collegio ha sbagliato il giudice a non ritenere che l'amministratore convenuto dal privato può esercitare l'azione di arricchimento ed essere rilevato indenne dall’esborso: ciò significa che l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore per il rapporto obbligatorio con lui. Pertanto, al giudice del rinvio il nuovo giudizio sul punto.
di Vanessa Ranucci
Chi riconsegna l’immobile danneggiato risarcisce il costo delle riparazioni e il reddito perso per la ristrutturazione
Il locatore deve provare il maggior danno ma non di aver dovuto rinunciare a richieste di affitto
Nel caso in cui il conduttore di un immobile restituisca la cosa con danni, deve risarcire il proprietario pagando sia le riparazioni sia il corrispettivo dovuto per l’impossibilità di locare l’immobile per tutta la durata dei lavori. Inoltre, il proprietario deve provare il maggior danno ma non è tenuto a dimostrare di aver avuto e rinunciato a richieste di affitto durante il periodo della ristrutturazione. Così ha stabilito oggi la terza sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 9849/22.
La Corte d'appello aveva condannato un’inquilina a pagare, alla proprietaria dell’immobile, una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni per aver restituito l’immobile a lei locato ad uso abitativo in stato di degrado. Il totale della quantificazione era stato raggiunto sommando le spese affrontate per le necessarie riparazioni e quello riconosciuto a titolo di danno per mancato reddito percepito durante il periodo di esecuzione dei lavori.
La ricorrente, in sede di legittimità, ha lamentato che la Corte territoriale aveva ritenuto provato e liquidabile il danno da lucro cessante. Per il Palazzaccio il ricorso va respinto, ricordando che “qualora, in violazione dell’art. 1590 Cc, al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto, fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Ogni qualvolta il locatore per fatto del conduttore non può disporre della cosa locata, Io stesso ha diritto a conseguire il corrispettivo convenuto, nonché eventuali danni, ulteriori, ove ne dimostri l'esistenza. Il locatore, in caso di anormale usura dell’immobile, ha diritto al risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per l’esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione".
Dunque, il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della mancata disponibilità del bene durante il periodo occorrente per il restauro non costituisce un danno in re ipsa. Il periodo di indisponibilità dell'immobile reso necessario dall'urgenza del restauro, è equiparato quoad effectum alla ritardata restituzione dell‘immobile, con la conseguenza che spetterà per tale periodo al proprietario il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 Cc, salva la prova del maggior danno, che grava sul locatore.
di Remo Bresciani
Avvocato risarcito per perdita di chance se il numero di studio non è inserito nell’elenco telefonico
È irrilevante che il legale abbia ottenuto un incremento di reddito nel periodo considerato perché ciò che va indennizzato è il sacrificio della possibilità di un risultato migliore
La compagnia telefonica deve risarcire all’avvocato il danno da perdita di chance se il numero dello studio non viene inserito nell’elenco. È irrilevante, peraltro, che il professionista abbia ottenuto un incremento di reddito nel periodo considerato perché ciò che va indennizzato è il sacrificio della possibilità di un risultato migliore.
Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 9565/22 del 24 marzo che ha accolto il ricorso di un avvocato.
Il tribunale aveva respinto la sua domanda di risarcimento ritenendo insussistente la prova del nesso di causalità tra la riduzione del fatturato relativo all’attività professionale del legale e il mancato inserimento nell’elenco del suo recapito telefonico dello studio. La corte d’appello ha poi confermato la decisione e la vertenza è così giunta in Cassazione.
In sede di legittimità il legale ha contestato la decisione nella parte in cui aveva escluso il nesso causale tra il pur riscontrato inadempimento della società di telefonia e il danno patrimoniale lamentato. Inoltre ha censurato l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui,
essendo lo studio legale situato in un Comune di appena tredicimila abitanti, la mancata inserzione del suo nominativo nell’elenco telefonico non sarebbe stata ostativa alla possibilità di contattarlo. In questo modo però, ha sostenuto il ricorrente, la corte di merito avrebbe disatteso il principio secondo cui il danno ipotizzabile in questa ipotesi è da ravvisare non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, potendo, inoltre, essere liquidato anche in via equitativa.
La Cassazione, nell’accogliere la domanda, ha affermato che ciò che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare a essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della «perdita» può essere pretesa, se non in termini di «possibilità» e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa. Né rileva che il professionista abbia depositato una parziale o incompleta documentazione fiscale dal momento che l’omissione incide sulla liquidazione del risarcimento ma non consente di
escludere che un danno ci sia comunque stato. Addirittura è irrilevante che nell’anno di riferimento il legale abbia avuto un incremento di reddito. Infatti, ha concluso la Corte, essendo il pregiudizio economico lamentato un danno da “perdita di chance”, e dunque da lucro cessante, nulla esclude che, in presenza, invece, dell’inserimento del nominativo del legale negli elenchi telefonici, il suo reddito da attività di lavoro autonomo “potesse conoscere un’ancora maggiore ripresa, se è vero che la perdita di chance si sostanzia nel sacrificio della possibilità di un risultato migliore”.
Di qui il rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame della vicenda.
di Dario Ferrara
Nessuna responsabilità all’automobilista se il pedone investito spunta all’improvviso nel traffico
Escluso il concorso di colpa per il conducente che non può avvistare ed evitare il danneggiato, sbucato da un’aiuola: decisivi i testi nel confermare il rispetto delle regole di Cds e comune prudenza
Escluso il concorso di colpa dell’automobilista che investe il pedone. Nessuna responsabilità al conducente che all’improvviso vede sbucare il danneggiato davanti alla macchina e non può dunque evitarlo con una manovra d’emergenza: pesano in favore del primo l’osservanza delle norme di comune prudenza oltre che del codice della strada e carico del secondo la condotta anomala e imprevedibile; decisivi i testimoni. È quanto emerge dall’ordinanza 8940/22, pubblicata il 18 marzo dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Condotta esigibile
Bocciato il ricorso dell’uomo investito, che pure è rimasto invalido al 95 per cento dopo il sinistro: diventa definitivo il no dei giudici alla domanda di risarcimento per oltre 776 mila euro. Il punto è che il pedone si materializza di botto nel traffico da un’aiuola da spartitraffico: spunta letteralmente dalla vegetazione e l’automobilista non lo vede o lo vede troppo tardi, complici le prime ombre della sera autunnale in Sicilia. Il tutto in una zona poco illuminata, caratterizzata da una complessa circolazione dei veicoli: attorno alla rotonda che dà ingresso alla città si convoglia il traffico di ben quattro arterie. Insomma: dall’automobilista non risulta esigibile una condotta diversa.
Attraversamento repentino
La responsabilità del conducente è esclusa all’esito di un’applicazione molto rigorosa dall’articolo 2054 Cc. Da una parte risulta necessario ma non sufficiente che il guidatore rispetti le regole della circolazione stradale, dall’altra non basta che il pedone cammini fuori dalle strisce per superare la presunzione sfavorevole alla controparte: è necessario un attraversamento repentino e non prevedibile. Esattamente come avviene nella specie: al momento dell’impatto l’auto procede a 20-30 chilometri orari e la circostanza non risulta smentita dalle lesioni riportate dal pedone; che è appena sceso dall’aiuola, come confermano le tracce di sangue, e non si trova in pieno attraversamento come sostiene la controparte. Anche se il guidatore avesse visto il pedone un paio di metri prima non avrebbe potuto compiere una manovra salvifica. Infine: il fatto che il conducente sposti l’auto dopo il sinistro non impedisce di ricostruirne la dinamica.
di Debora Alberici
Niente mantenimento al figlio che dopo la scuola non ridimensiona le sue aspirazioni pur di lavorare
Accolto il ricorso del padre che chiedeva la revoca del contributo economico: è il giovane che deve dimostrare di aver cercato un lavoro accontentandosi di ciò che gli capita
Stop ai trentenni ancora a casa mantenuti dai genitori. D’ora in poi i ragazzi, una volta terminati gli studi, dovranno cercare subito un impiego e, se necessario, ridimensionare le proprie aspirazioni e ambizioni.
Con una decisione segno di civiltà e al passo con i tempi, la Cassazione – ordinanza n. 8049 dell’11 marzo 2022, dà un monito preciso ai giovani d’oggi: non cercate scuse, andate a lavorare, uscite da casa e crescete.
La vicenda riguarda un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno in favore del figlio perché dopo qualche anno dalla fine degli studi era ancora a casa disoccupato.
Sarà ora il 24 enne a dover dimostrare di aver fatto l’impossibile per cercare un impiego, anche sacrificando le sue aspirazioni e ambizioni.
Sul punto i Supremi giudici hanno in prima battuta chiarito che «il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso».
Insomma, l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne «non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni».
Ma la decisione di oggi segna una netta inversione di rotta rispetto ai tempi dei “bamboccioni”. Per la Cassazione, infatti, «il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni».
di Deborah Alberisi
Anche nel processo tributario il compenso del legale non può scendere sotto i minimi
Accolto il ricorso del contribuente che chiedeva una liquidazione delle spese più adeguata
Nell’ambito del processo tributario, come già avviene nelle cause civili, il compenso del legale non può scendere sotto i minimi.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 8889 del 18 marzo 2022, ha accolto il ricorso del contribuente che chiedeva una liquidazione maggiore per il suo difensore.
La tesi del legale ha fatto breccia presso i Supremi giudici che hanno esteso un principio già noto nell’ambito delle cause civili.
Infatti, si legge nella breve quanto interessante motivazione, «in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del dm. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle».
Nel caso sottoposto all’esame della Corte sbaglia la Ctr a liquidare a titolo di spese processuali un importo determinato complessivamente per entrambi i gradi di giudizio e in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense, peraltro senza adottare alcuna motivazione sull’applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe, ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi.
di Fario Ferrara
Il dl semplificazioni condanna il Comune ad attestare il silenzio-assenso sul permesso di costruire
Illegittima la condotta dell’ente che tace dopo aver chiesto una mole di documenti: è tenuto a rilasciare il titolo o a certificare che è decorso il termine previsto dalla legge per il procedimento
Il Comune ha venti giorni per concedere il permesso di costruire oppure per certificare che sulla richiesta del privato si è formato il silenzio assenso. Il tutto grazie al dl semplificazioni che ha voluto conferire certezza sull’effettivo decorso del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, prescrivendo l’attestazione da parte dell’amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza 165/22, pubblicata dalla terza sezione del Tar Toscana.
Senza ostacoli
Il ricorso dei proprietari del terreno è accolto perché risulta illegittimo il silenzio serbato dall’ente locale, dopo che gli uffici hanno ottenuto un’ampia documentazione a integrazione dell’originaria istanza del titolo edilizio: gli interessati vogliono costruire un fabbricato con sei unità abitative e relative autorimesse. Il decreto legge 76/2020 ha modificato l’articolo 20, comma ottavo, del testo unico dell’edilizia: entro quindici giorni l’amministrazione deve attestare su richiesta del privato che non ci sono provvedimenti negativi sull’istanza né richieste degli uffici rimaste inevase, ciò che consente al richiedente di accertare che si è formato in modo tacito il titolo autorizzativo per gli interventi richiesti.
Buona fede
L’obbligo in capo al Comune non scatta soltanto per legge: pesa il principio di leale collaborazione fra privati e pubblica amministrazione, che impone a quest’ultima di agire secondo buona fede, facendo chiarezza sulle situazioni giuridiche pendenti. L’ente locale non l’ha fatto e adesso deve eseguire l’ordine del giudice.
Quando il dipendente s’infortuna il datore non può essere condannato «con il senno del poi»
Stop alla condanna emessa perché il macchinario non ha uno schermo protettivo: il giudice non considera la fase della produzione in cui si verifica il sinistro e quali siano le relative misure di protezione
Se il lavoratore s’infortuna, il datore non può essere condannato «con la logica del senno del poi». È escluso, infatti, che il giudice possa ritenere l’imprenditore penalmente responsabile senza considerare la fase della produzione in cui il sinistro si verifica né porsi il problema di quali siano le misure di protezione previste per quello specifico segmento della lavorazione. Insomma: l’errore sta nell’individuare la regola cautelare in base a una valutazione ricavata ex post a evento avvenuto, in modo del tutto astratto e svincolato dal caso concreto. È quanto emerge dalla sentenza 836/21, pubblicata il 13 gennaio dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Giustizia creativa
È accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale il ricorso dei tre imputati per lesioni colpose. L’operaio riporta la frattura scomposta del mignolo nel tentativo di recuperare il tondino di alluminio lavorato mentre il tornio è ancora in movimento. Al datore si rimprovera di non aver dotato il macchinario di uno schermo frontale di protezione per evitare il contatto del lavoratore con gli ingranaggi in movimento. E con lui alla sbarra siedono il responsabile della sicurezza, per aver sottovalutato il rischio, e il titolare ditta produttrice, per aver venduto una macchina non a norma. Almeno secondo i pm. In realtà il tornio è conforme alla norma di riferimento Uni En 12840/2003, che non prevede lo schermo “vagheggiato” dai giudici del merito: la cui necessità, osservano gli “ermellini” appare frutto di un ragionamento creativo.
Mere congetture
La responsabilità colposa, invece, non può essere fondata sul senno del poi: il riscontro della colpa deve essere frutto di un processo cognitivo che individua a monte la regola cautelare che si assume violata, secondo una valutazione ex ante. Lo schermo non avrebbe salvato l’operaio che avrebbe comunque dovuto aggirarlo per infilare la mano nel tornio: lo strumento di protezione deputato, in quella fase, è il pedale del freno, mentre il lavoratore aziona la frizione, la rotazione continua per inerzia e il guanto impigliato fa il resto. Risultato: la regola cautelare dello schermo protettivo è ricavata in maniera congetturale. Parola al giudice del rinvio.
Addio accertamento se il fisco non produce in giudizio la delega al funzionario che l’ha firmato
Anche se risulta demandata solo la sottoscrizione e non la funzione dal dirigente dell’ufficio, il mancato deposito agli atti impedisce al giudice di scrutinare l’esistenza e l’identità dell’interessato
Annullato. Addio all’accertamento a carico del contribuente perché il fisco non deposita in giudizio la delega del dirigente dell’ufficio che autorizza il funzionario di carriera a sottoscrivere l’atto impositivo. E ciò benché si tratti di una delega di firma e non di funzioni. La mancata produzione, infatti, impedisce al giudice di scrutinare l’esistenza del documento oltre che l’identità del sottoscrittore dopo le contestazioni avanzate dalla parte privata. È quanto emerge dall’ordinanza 7441/22, pubblicata l’8 marzo dalla sezione tributaria della Cassazione.
Sindacato precluso
La Suprema corte decide nel merito accogliendo l’originario ricorso proposto dal contribuente contro l’accertamento sintetico sul reddito che quantificava maggiori imposte per oltre 43 mila euro più interessi e sanzioni. Trova ingresso la censura rivolta contro la sottoscrizione degli atti impositivi relativi alle due annualità incriminate. Secondo la parte privata gli accertamenti sarebbero stati firmati in modo illegittimo dal capo area controllo mentre l’unica firma legittima poteva essere quella del direttore titolare dell’Agenzia delle entrate oppure quella di un funzionario di carriera dirigenziale munito di delega ad hoc. E, denuncia il contribuente, un “direttore tributario”, corrispondente all’ex nono livello, non sarebbe di per sé legittimato a spiccare da solo un atto di accertamento. Come che sia, è certo che l’amministrazione finanziaria non ha depositato agli atti la delega anche in grado d’appello nonostante il soccorso istruttorio all’epoca vigente. E la mancata produzione impedisce il sindacato sulla legittimità della sottoscrizione di chi non ha istituzionalmente la rappresentanza esterna dell’ufficio fiscale, una circostanza oggetto di censura ad hoc da parte del contribuente fin dal primo grado di giudizio.
Rifiuti. Discarica, responsabilità sindaco
Con sentenza del 29/1/2003 la corte di appello di Lecce ha confermato quella resa il 19/3/2002 dal tribunale monocratico di Tricase, che aveva condannato B.C., con i doppi benefici di legge, alla pena di nove mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda quale colpevole dei reati di cui all’art. 51, comma 3, D.L.vo 22/1997 e all’art. 1 sexies legge 431/1985 [1], perché, quale sindaco del comune di Corsano, aveva realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi (sino al 12/10/1999).
Il C., col ministero del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.
In particolare lamenta: violazione dell’art. 107 D.L.vo 18/8/2000 n. 267 (testo unico sugli enti locali) secondo cui la responsabilità per i fatti de quibus doveva fare carico al dirigente del settore tecnico del territorio, cioè all’organo burocratico, e non all’organo politico; violazione degli artt. 195, 177 e 507 c.p.p., atteso che il giudice, su richiesta del PM aveva sentito come testi di riferimento i dipendenti comunali B.C. e L.C., che invece dovevano essere sentiti sin dall’origine come imputati, in quanto colti nell’atto di scaricare rifiuti nella discarica; mancanza o illogicità di motivazione in ordine alla affermata responsabilità del sindaco.
Nel corso della discussione pubblica il difensore ha sollevato questione di nullità per incapacità del giudice di primo grado, dott. Paolo Moroni, che in data 19/3/2002 ha emesso sentenza contro l’imputato, come giudice monocratico del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, senza aver maturato i tre anni di anzianità nell’esercizio della funzione giurisdizionale prescritti dall’art. 7 bis, comma 2 quater, dell’ordinamento giudiziario.
Al riguardo ha depositato copia delle delibere del CSM che hanno rifiutato l’approvazione della proposta tabellare relativa al tribunale di Lecce in ordine al dott. Moroni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bisogna affrontare la dedotta questione sull’incapacità del giudice di primo grado.
Invero, a norma dell’art. 7 bis, comma 2 quater, dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30/1/1941 n. 12), introdotto dall’art. 57 legge 16/12/1999 n. 479, il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.
E, come risulta dalle delibere del CSM prodotte dal difensore, alla data della sentenza (19/3/2002), il dott. Moroni, sebbene assegnato tabellarmente alla sezione distaccata di Tricase in composizione monocratica, non aveva ancora raggiunto l’anzianità richiesta.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.p., modificato dall’art. 169 D.L.vo 51/1998, le disposizioni sulla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari e alle sezioni non si considerano attinenti alla capacità del giudice, con la conseguenza che la violazione di dette disposizioni non integra quella incapacità del giudice che l’art. 178 lett. a) c.p.p. prevede come causa di nullità, assoluta e insanabile.
Secondo una corrente distinzione dottrinale, infatti, da luogo a nullità assoluta solo il difetto di capacità generica del giudice, cioè il complesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della funzione giurisdizionale generalmente intesa, mentre non è causa di nullità il difetto di capacità specifica, intesa come l’insieme delle condizioni richieste per l’esercizio della funzione giurisdizionale in un determinato processo: appunto in dette condizioni rientrano le disposizioni relative alla destinazione del giudice nell’ufficio giudiziario competente in ordine al processo medesimo.
Passando alle censure di merito, si deve osservare che la ripartizione delle funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune stabilita dall’art. 107 D.L.vo 18/8/2000 n. 267, non può esonerare il sindaco dalla sua responsabilità per aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata in un’area di proprietà comunale.
In materia di gestione dei rifiuti, questa corte ha avuto modo di ritenere che detta ripartizione funzionale può liberare il sindaco da responsabilità inerenti a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente (Sez. III, n. 8530 del 4/3/2002, Casti, rv. 221261), o da responsabilità inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta differenziata (Sez. III, n. 23855 del 21/6/2002 PG in proc. Pino, rv. 222706), che invece spettano ai dirigenti amministrativi.
Ma ha anche escluso l’effetto liberatorio nel caso di realizzazione di una discarica non autorizzata, attese le specifiche competenze del sindaco, il quale, come capo dell’amministrazione comunale, ha il compito di programmare l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, come ufficiale di governo, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente (Sez. III, n. 3878 del 27/3/2000, Stillitani, rv. 216212).
Ciò significa che il sindaco va esente da responsabilità solo per quelle condotte che rientrano nell’ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti amministrativi, ma deve sempre rispondere delle scelte programmatiche e di quelle contingibili e urgenti che egli adotti nell’ambito dei suoi poteri, o anche eccedendo da questo abito.
Che nella fattispecie sia stato il sindaco C. a disporre l’apertura non autorizzata della discarica in un’area di proprietà comunale è stato accertato dai giudici di merito con motivazione congrua, esente da vizi logici e giuridici.
In particolare, è stato accertato che alcuni dipendenti comunali avevano ripetutamente scaricato rifiuti vari nell’area in questione da una moto Ape con l’effige del comune.
Sentiti come testi di riferimento ex artt. 195 e 507 c.p.p., nonostante una iniziale reticenza, uno, R.C., ammetteva di aver scaricato materiali vari col consenso del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’altro L.B., ammetteva di essere stato verbalmente autorizzato dal sindaco per lo smaltimento dei rifiuti.
Il difensore ha contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei dipendenti comunali, giacché essi dovevano essere sentiti come coimputati ex art. 210 c.p.p. e non come testimoni.
Ma la tesi va disattesa perché è infondato il suo presupposto.
Infatti chi abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti risponde solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 50, comma 1, a meno che non sia titolare di imprese o responsabile di un ente, nel qual caso risponde del reato di cui all’art. 51, comma 2, D.L.vo 22/1997, o a meno che non si provi un suo concorso consapevole del reato di gestione non autorizzata di discarica di cui all’art. 51, comma 3, D.L.vo 22/1997.
Nel caso di specie i dipendenti comunali, essendosi resi responsabili di un illecito amministrativo e non dei reati di cui all’art. 51, potevano essere sentiti come testimoni.
Tutte le censure sono quindi infondate e il ricorso va respinto.
Consegue ex art,. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto dei motivi non si commina anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sanzioni disciplinari, al preside spetta valutare (solo) quelle lievi
Non tocca al dirigente disporre conseguenze superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per oltre 10 giorni
In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo. E ciò essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo.
Corte di Cassazione 26 dicembre 2021
Obbligo di mantenere il figlio 40enne all’università se ha ritardi di appredimento
Secondo la Corte, in un caso del genere, il ritardo negli studi non è dovuto a indolenza ma a una patologia che rende più difficoltoso il percorso
di Pietro Alessio Palumbo
Secondo le regole del Codice civile l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla dichiarazione della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica; ovvero che è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente; ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di “inerzia” o addirittura di ingiustificato “rifiuto”. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 40283/2021 specificando che se il figlio quarantenne ha ritardi d'apprendimento i genitori devono comunque pagargli l’università.
L’obbligo di mantenimento
In particolare la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal ragazzo, dal raggiungimento della maggiore età.
Il caso
Nella vicenda affrontata dalla Corte con l'ordinanza n.40283 del 15 dicembre scorso, la Cassazione ha acclarato che la situazione del figlio della coppia coinvolta nei fatti, il quale privo di redditi al momento della pronuncia della sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all’università benché fosse quasi quattro anni fuori corso, aveva una spiegazione documentata da certificati medici che davano conto di un chiaro ritardo nell’apprendimento correlato a problemi insorti al momento della nascita. Problemi che avevano condizionato il percorso scolastico del “ragazzo” il quale si era infatti diplomato all’età di 24 anni.
Ebbene secondo la Corte in tali casi il ritardo negli studi non può dirsi riconducibile a una “indolenza” del figlio, o al rifiuto di svolgere una prestazione lavorativa, quanto a una patologia che in tutta evidenza rende difficoltoso ciò che per altre persone non lo è. In tali situazioni permane l’obbligo di mantenimento del figlio da parte dei genitori.
di Dario Ferrara
Il patrocinio del Comune va al legale col preventivo più basso perché non vale l’equo compenso
Amministrazione non tenuta a corrispondere all’avvocato un compenso in linea con i parametri ministeriali: sceglie la proposta più conveniente quando c’è una contrattazione con il professionista
Altro che equo compenso. A patrocinare il Comune nella causa sarà l’avvocato che ha presentato il preventivo più basso. E ciò benché l’importo sia inferiore alle somme previste dai parametri forensi. L’amministrazione, infatti, ben può scegliere la proposta più conveniente fra quelle dei legali che ha consultato: quando il professionista contratta la sua prestazione su di un piano paritetico con la committente, infatti, non ha bisogno della speciale tutela introdotta dal decreto legge 148/17. Lo sostiene la sentenza 1088/21, pubblicata il 20 dicembre dalla sede di Brescia del Tar Lombardia.
Base d’asta
Niente da fare per uno dei tre legali contattati dall’ente locale per farsi difendere in giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale. Il Comune procede all’affidamento diretto evitando la procedura a evidenza pubblica perché l’incarico è ben sotto i 40 mila euro: vince l’avvocato che si contenta di meno di 3.200 euro, fra compenso e oneri di legge. Il punto è, scrivono i giudici, che l’equo compenso si applica quando l’amministrazione definisce in modo unilaterale gli emolumenti del professionista, ad esempio laddove determina la base d’asta nella gara d’appalto. La tutela del contraente debole è invece esclusa quando il prestatore d’opera intellettuale non deve accettare supinamente le scelte dell’ente pubblico. Nella specie, si legge nella sentenza, ciascuno dei tre professionisti ha potuto formulare il proprio preventivo «senza essere vincolato a criteri predeterminati e senza subire condizionamenti».
Spending review
È stato il collegato fiscale alla manovra 2018 a modificare la legge forense introducendo l’equo compenso per garantire all’avvocato la percezione di un compenso «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» oltre «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale». Attenzione, però: l’applicazione dei parametri ministeriali di cui al dm 55/2014 deve ritenersi obbligatoria soltanto quando i committenti sono «determinati soggetti imprenditoriali come banche e assicurazioni, che notoriamente godono di una certa forza contrattuale». E non anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che del resto non sono contemplate in modo esplicito dall’articolo 13 bis, comma primo, della legge 247/12. Risultato: per gli enti pubblici si applica sì il concetto di equo compenso in favore del professionista, ma non entro i rigidi limiti dei parametri forensi; l’applicazione dell’istituto deve essere ancorato a criteri di maggiore flessibilità, legati da una parte a esigenze di contenimento della spesa pubblica e dall’altra alla natura e alla complessità dell’attività di difesa da svolgere. Imporre alle amministrazioni gli standard inderogabili anche quando non c’è un significativo squilibrio a carico del professionista, conclude la pronuncia, «comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità nell’affidamento dei servizi legali». Spese di lite compensate per la novità e la complessità della questione.
di dario Ferrara
Il Comune risarcisce la caduta nella buca perché la bici può circolare in zona pedonale
Sì al ricorso del danneggiato, finito in una cavità del terreno per evitare un passante sulla ciclabile: da verificare la responsabilità di manutenzione dell’ente, che deve provare di aver segnalato le restrizioni
Impossibile gettare la croce addosso al ciclista che finisce in una buca per schivare un passante, mentre percorre la pista riservata alle due ruote. Sbagliano i giudici del merito a ritenere la responsabilità esclusiva del danneggiato sul rilievo che l’uomo in sella alla bici invade prima una zona pedonale e poi l’area verde: la prima, infatti, è interdetta solo alla circolazione dei veicoli, mentre altre restrizioni devono essere segnalate; quanto al manto erboso, è tutta da verificare la responsabilità dell’ente che lascia aperta e incustodita una buca di notevoli dimensioni. È quanto emerge dall’ordinanza 2667/22, pubblicata il 28 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Regime giuridico
È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso del ciclista, che ha riportato lesioni al volto cadendo in una cavità del terreno profonda 40 centimetri e larga 50 centimetri per 50. L’errore compiuto dal Tribunale prima e dalla Corte d’appello poi sta nel ritenere l’evento pregiudizievole interamente imputabile alla «condotta negligente e imprudente del danneggiato». Non ha senso in sede di legittimità discutere della qualificazione dell’area in cui cade il ciclista perché si tratta di una questione che rientra nel merito della vicenda: inutile dunque interrogarsi se il tratto sia o no una prosecuzione della pista, come sostiene il danneggiante, sul rilievo che il Comune avrebbe creato un passaggio ad hoc per consentire ai ciclisti di portarsi sul lato opposto della strada evitando la rotatoria. Risulta invece fondata la questione posta sul regime giuridico dell’area teatro del sinistro. È l’articolo 3, comma primo numero 2, Cds a imporre al Comune di segnalare restrizioni alla circolazione delle bici nell’area pedonale: sbaglia dunque la Corte d’appello a ritenere irrilevante la mancanza di segnaletica orizzontale.
Omesso accertamento
L’eventuale imprudenza del ciclista, fra l’altro, non esclude una responsabilità dell’amministrazione che ha lasciato aperta e non intercettabile una buca di rilevante profondità. La parola passa al giudice del rinvio.
di Paolo Storari
Sospensiva-lampo di Palazzo Spada su paracetamolo e vigile attesa, ma la partita è aperta sulle cure domiciliari in attesa della discussione del 3 febbraio 2022
Abbiamo dedicato uno spazio molto ampio alla sentenza del TAR Lazio - Sezione Terza Quater - Pres. Riccardo Savoia e Rel. Roberto Vitanza, del 15 gennaio 2022 che ha eliminato l'inconcepibile imposizione al paziente Covid di Tachipirina (paracetamolo) e vigilante attesa: il concetto di "vigile attesa" è un autentico ossimoro paragonabile al consenso tuttora richiesto ai vaccinandi obbligati che così a lungo ha ostacolato i nostri medici di medicina generale nell'erogazione sui territori delle terapie domiciliari precoci delle quali avrebbero avuto necessità i pazienti affetti da Covid.
Per contro, come ha ricordato il 18 gennaio 2022 la Prof.ssa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica e virologia dell'Ospedale Sacco di Milano, durante la trasmissione "Fuori dal coro" di Mario Giordano, si era burocratizzata in modo elefantiaco proprio quella fase delle prime 72 ore dal manifestarsi della sintomatologia, decisive per la sorte del paziente.
Continuiamo a ritenere che il protocollo tanto caro al due volte Ministro della Salute Roberto Speranza sarà bandito in quanto inammissibile dal punto di vista medico-scientifico oltre che illogico.
Ad ogni modo, s'impone annotare che il Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con una fulmineità che d'ora in avanti i cittadini saranno legittimati ad attendersi anche per le restanti vicende processuali (sospensiva del 19 gennaio 2022!), ha già disposto con decreto inaudita altera parte la sospensione in via cautelare della pronuncia appellata dal Ministero della Salute e commentata su questa Rivista.
di Remo Bresciani
Vietato senza eccezioni il terzo mandato consecutivo ai consiglieri dell’ordine dei commercialisti
Esclusa l’applicazione analogica della normativa prevista per gli avvocati che consente la terza rielezione se la carica cessa prima di metà dell’incarico
È vietato senza eccezioni il terzo mandato consecutivo ai consiglieri dell’ordine dei commercialisti. Esclusa, infatti, l’applicazione analogica della normativa prevista per gli avvocati che consente la terza rielezione se la carica cessa prima di metà dell’incarico. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 38333/21 del 3 dicembre che ha respinto il ricorso di alcuni dottori commercialisti contro la delibera del consiglio dell’ordine che li aveva esclusi dalla competizione elettorale per il rinnovo delle cariche.
I consiglieri e il presidente non sarebbero rieleggibili al terzo mandato neanche in presenza di dimissioni.
Di qui il ricorso in Cassazione dove i professionisti hanno sostenuto che doveva essere applicata in via analogica la disciplina dettata per l’elezione del consiglio degli ordini forensi che ha ritenuto non ostativo alla ricandidatura l’espletamento di due precedenti mandati consecutivi, di cui il secondo interrotto prima della metà del tempo.
La Suprema corte, nel decidere la questione, ha ricordato che il fondamento dell’ineleggibilità sta nell’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par conditio tra i candidati, la quale è suscettibile di essere alterata da rendite di posizione, ed evitare il manifestarsi di fenomeni di “sclerotizzazione” nelle relative compagini. Né è possibile ricorrere all’analogia con la disciplina dettata per gli avvocati dal momento che una lacuna normativa non esiste. Infatti se il principio generale è proprio quello della limitazione ai due mandati, l’irrilevanza del parziale espletamento di uno dei due, contenuta nell’articolo 3, comma 4, della legge 113/17, si palesa regola non applicabile in via analogica, né tantomeno espressione di un principio generale limitativo dell’incapacità.
Al contrario, nel ricordato contesto normativo e sistematico, la regola del limite a due mandati consecutivi per gli organi elettivi professionali costituisce un principio di carattere generale, mentre la rieleggibilità per il terzo mandato a date condizioni si configura come eccezione insuscettibile di interpretazione analogica. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che il ricorso deve essere respinto in esecuzione del principio di diritto secondo cui «in tema di elezione dei consigli dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’art. 9,
comma 9, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica, senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell’avvicendamento nelle cariche rappresentative, che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 legge 12 luglio 2017, n. 113, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato».
di Debora Alberici
L’ex amministratore della srl non risponde dei debiti fiscali della società estinta
Accolto il ricorso di un consulente accusato di aver ideato la frode dell’ente poi liquidato
L’ex amministratore della srl non risponde dei debiti fiscali della società estinta. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 25530 del 21 settembre 2021, ha accolto il ricorso di un consulente fiscale accusato di aver ideato la frode per evadere l’Ires.
L’uomo ha presentato ricorso al Palazzaccio chiedendo di annullare la decisione con la quale la Ctr lo aveva condannato a versare i tributi evasi dall’ente.
Il gravame della difesa ha fatto breccia presso la sezione tributaria che, sul punto, ha accolto. Per i Supremi giudici , infatti, la particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti.
Va quindi esclusa una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società.
In altre parole, la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dall'art. 36 del d.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege (per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 cod. civ., e per i soci di natura sussidiaria), avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.
Con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all'amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.
Il tasso usurario sul finanziamento si calcola al lordo delle spese di assicurazione
Accolto il ricorso del consumatore che aveva chiedeva il riconoscimento dei costi per avere il prestito
È al lordo dei costi di assicurazione che si calcola la natura usuraria di un finanziamento.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 22465 del 6 agosto 2021, ha accolto il ricorso del consumatore.
Per la sesta sezione civile – 1 male ha fatto la Corte territoriale a non spiegare la compatibilità di tale decisione che nega il collegamento tra i contratti di Finanziamento e di assicurazione con il principio secondo cui, ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo,
devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, fermo restando che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
di Debora Alberici
Chi contribuisce economicamente alla costruzione dell’immobile sul terreno del coniuge non ne acquista la proprietà
Irrilevante la comunione legale dei beni. Al più l’ex può incassare le spese sostenute per manodopera e materiali se riesce a provarle
Chi contribuisce alla costruzione o alla manutenzione dell’immobile che insiste sul terrendo di proprietà esclusiva del coniuge non ne acquisterà mai la proprietà, nonostante la comunione legale dei beni. Al più, qualora riesca a provarle, può ripetere le somme spese per materiali e manodopera.
Cosa che non è riuscita a fare una casalinga di Roma alla quale, con l’ordinanza 22193 del 3 agosto 2021, la Corte di cassazione ha dato torto respingendo in pieno il ricorso del suo difensore.
La prima sezione civile ha spiegato che la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione.
Per gli Ermellini, ciò si legittima sul presupposto che il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ., hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale.
di Emiliano Sabia
Il fisco non può imputare maggiori ricavi al contribuente solo perché ha la delega a operare sul c/c del partner
I versamenti in entrata trovano corrispondenza nelle fatture di vendita e non rileva il lasso temporale intercorrente tra la data di emissione del documento e i movimenti bancari
La delega a operare sul conto corrente del partner non basta al fisco per imputare al contribuente maggiori ricavi. I versamenti in entrata, inoltre, trovano corrispondenza nelle fatture di vendita, non rilevando il lasso temporale intercorrente tra la data di emissione del documento e le movimentazioni bancarie. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza n. 21849/21, pubblicata oggi dalla sezione tributaria. Il Palazzaccio respinge il ricorso del fisco contro la sentenza della commissione regionale che annullava un accertamento emesso nei confronti di un contribuente operante nel settore del commercio.
Al termine di una verifica condotta nei confronti della società della partner del contribuente e da cui risultava un conto corrente intestato al contribuente e un altro alla compagna, l'amministrazione recuperava a tassazione un maggior reddito di impresa. Il fisco lamentava che il giudice tributario avesse in modo errato ritenuto che il conto corrente intestato alla donna, ma con delega a operare del contribuente e il rapporto sentimentale tra i due, non erano utili a provare che il maggior reddito fosse imputabile al contribuente. Non solo: le fatture di vendita emesse nell'anno di accertamento giustificavano i versamenti in entrata indipendentemente dal lasso temporale tra la data di emissione del documento e le movimentazioni bancarie. La Corte suprema non condivide l'operato dell'amministrazione.
Secondo la Ctr, il contribuente ha dimostrato di aver tenuto conto «dei versamenti registrati sui c/c che trovano corrispondenza nelle fatture di vendita, non rilevando a tal fine il lasso di tempo intercorrente» tra la data di emissione della fattura e i movimenti bancari. Ad avviso del Palazzaccio, «a confortare la fondatezza e la legittimità di tale determinazione» è anche il comportamento dell'ufficio che, «nella fase precontenziosa, si era dichiarato disponibile a scomputare dai maggiori ricavi accertati i ricavi già dichiarati per effetto dell'emissione delle fatture di vendita, e ha correttamente applicato il regime probatorio avendo accertato che il contribuente aveva fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse». Il ricorso va, pertanto, respinto.
di Debora Alberici
I figli restano a scuola dalle suore anche se il padre si oppone
Sradicare i minori dalla propria vita sociale dopo la separazione potrebbe avere conseguenze negative
I ragazzini restano a scuola privata di matrice cattolica quando erano già iscritti lì prima della separazione. Infatti, sradicare i minori dalla propria vita sociale dopo la separazione potrebbe avere conseguenze negative.
Con una decisione che farà discutere la Corte di cassazione - ordinanza n. 21553 del 27 luglio 2021 - ha respinto il ricorso di un padre, affidatario insieme alla ex dei bambini, che avrebbe voluto mandarli a una scuola pubblica e laica.
Per i giudici, che hanno condiviso in pieno le valutazioni della Corte d’Appello, la separazione era già stata un trauma per i bambini e il cambio di scuola avrebbe potuto rivelarsi ancora più dannoso.
Per gli Ermellini, «in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche all’adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psicofisica o lo sviluppo».
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, i giudici di merito si sono allineati a questo principio. La scelta così compiuta non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica. Dipende, invece, dall'acuito bisogno dei minori di avere - nel frangente – una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
POMERIGGI CULTURALI EOLIANI DEL CENTRO STUDI EOLIANO
Giovedì 29 luglio 2021- ore 19,00 Villa Famularo - Portinente
Presentazione del volume: “L’ECO DELLA FUGA” Di Martino Lo Cascio Edizioni Sce Intervengono con l’autore: Valeria Amendola Ornella Costanzo
__________________________________________________________
di Emiliana Sabia
Domiciliari al detenuto perché se la scuola chiude per i contagi la madre non può farcela da sola col bimbo disabile
Il tribunale sbaglia a ritenere un fallimento educativo il coinvolgimento del condannato in procedimenti penali
L'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 può incidere anche sulla concessione o meno degli arresti domiciliari. Scatta, infatti, la detenzione domiciliare del condannato, padre del bambino disabile, se la madre, con l'ipotetica chiusura delle scuole non può provvedere da sola alla gestione del figlio. La richiesta non può, inoltre, essere respinta perché i precedenti penali non sono un esempio edificante per il figlio. Lo sancisce la Cassazione che, con la sentenza n. 28973/21, pubblicata oggi dalla prima sezione penale, accoglie il ricorso di un detenuto, padre di un bambino con disabilità e necessità di assistenza continua, contro l'ordinanza del tribunale che rigettava la richiesta degli arresti domiciliari. Due sono gli aspetti su cui si basa il provvedimento del tribunale: la madre può provvedere in modo adeguato alla cura del figlio, a maggior ragione con la riapertura delle scuole materne dopo il lockdown legato alla pandemia e poi sul rigetto della richiesta peserebbe l'esempio non molto edificante del ricorrente, coinvolto in diversi procedimenti penali.
La Corte suprema di tutt'altro avviso accoglie il ricorso. Il provvedimento è discordante laddove non si confronta con la costante preoccupazione del ricorrente per la situazione familiare caratterizzata dalla difficoltà della moglie di gestire un bambino disabile e laddove insiste sul «fallimento educativo del genitore, inidoneo a causa dei coinvolgimenti in vicende penali, a indirizzare la prole verso scelte socialmente orientate». Il tribunale omette di considerare che nel bilanciamento tra le esigenze «di tutela della collettività da possibili ricadute nel reato e necessaria protezione dei figli», la sentenza della Corte costituzionale (n. 18/20) ha messo in evidenza la primarietà della cura e dell'assistenza che minori con disabilità debbano avere da parte dei genitori. Per tali motivazioni, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio.
Assolto il medico dell’ospedale che consiglia ai pazienti lo studio del primario per cure specifiche
I suggerimenti per eseguire l'innesto di protesi dentali che la struttura pubblica non è in grado di fornire non sono idonei a determinare l'invio degli utenti alle cliniche private del professionista
Non commette il reato di abuso di atti d'ufficio il medico dell'ospedale che suggerisce ai pazienti di rivolgersi allo studio privato del primario per interventi specifici.
Lo sancisce la Cassazione che, con la sentenza n. 28653/21, depositata oggi dalla sesta sezione penale, assolve il medico di una struttura ospedaliera condannato in appello a quasi un anno di carcere per abuso d'ufficio. La condanna scattava perché il ricorrente suggeriva ai pazienti di rivolgersi per l'innesto di protesi dentali presso gli studi privati del primario che si procurava così ingiusti vantaggi patrimoniali. Il Palazzaccio annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste perché «i consigli dati dall'imputato ai pazienti che si erano rivolti all'azienda sanitaria per eseguire una tipologia di intervento che la struttura stessa non era in grado di fornire, sono strutturalmente inidonei a determinare l'invio dei pazienti alle strutture private del primario e, dunque, a integrare il contributo dell'imputato alla commissione del reato di abuso in atti di ufficio».
I suggerimenti del medico erano in realtà diretti ai pazienti che, secondo la ricostruzione in fatto svolta nella sentenza impugnata, «erano approdati» al reparto dell'ospedale sulla base delle pubblicità delle cliniche del primario e che ritenevano che «tali interventi potessero essere eseguiti presso la struttura pubblica, che non poteva eseguirli». Non c'è stata, insomma, «alcuna opera di convincimento, da parte dell'imputato, per eseguire quella specifica tipologia di intervento e di indirizzamento dei pazienti presso le strutture private del primario». Il ragionamento della Corte di appello è, pertanto, errato perché i consigli elargiti dal professionista non integrano la condotta materiale del reato. Per Piazza Cavour non c'è dubbio: il ricorso va accolto e l'imputato assolto.
L’art. 15, lett. a), della della legge Regione Sicilia n. 78/1976 ha imposto un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, che consente solo opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare (da parte di tutti) e la sola ristrutturazione, entro rigorosi limiti, delle opere che esistevano prima dell’indicata legge regionale. Lo stabilisce il C.G.A.
Risarcita la dipendente che al rientro dalla maternità è assegnata a mansioni dequalificanti
Bocciato il ricorso del datore che per giustificare il demansionamento espone generiche deduzioni sui motivi riorganizzativi aziendali
Va risarcita la lavoratrice che, rientrata dalla maternità, è demansionata perché assegnata a mansioni inferiori rispetto alle precedenti. Lo stabilisce la Cassazione che, con l'ordinanza n. 20253/21, depositata oggi dalla sezione lavoro, respinge il ricorso di un'azienda nella causa contro una dipendente demansionata al rientro dalla maternità. La Corte di appello condannava il datore al risarcimento dei danni patrimoniali e non dopo aver accertato l'assegnazione della donna a mansioni dequalificanti e, nello specifico, a compiti amministrativi, predisposizioni di ordini sotto il controllo e la responsabilità di un collega.
La Cassazione non ha dubbi: il datore dovrà risarcire la dipendente perché la Corte territoriale ha correttamente accertato il demansionamento della lavoratrice, nella concretezza delle mansioni svolte prima e dopo la sua assenza per maternità così come evidenziate dalle risultanze istruttorie. Né basta, per giustificare il demansionamento, «la generica deduzione di una ragione riorganizzativa aziendale» dal momento che, quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile «a inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di
lavoro ai sensi dell'articolo 2103 Cc», è su quest'ultimo che incombe l'onere di provarne «l'esatto adempimento o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova della sua giustificazione per il legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'articolo 1218 Cc, per impossibilità della prestazione derivante da una causa a sé non imputabile». Tutto ciò è mancato nel caso in esame perché il datore non ha fornito alcuna prova, motivo per cui la Corte respinge il ricorso dell'azienda.
L’Ilva risarcisce ai proprietari il deprezzamento delle case per l’inquinamento a Taranto
Danno pari al 20 per cento del valore degli immobili: compresso dalle polveri minerali nell’aria il diritto dominicale, i residenti nel quartiere Tamburi non possono godere pienamente dei loro beni
L’Ilva risarcisce ai proprietari il deprezzamento delle case per l’inquinamento a Taranto. Il danno è quantificato in misura pari al 20 per cento del valore degli immobili: le polveri minerali sparse nell’aria dall’impianto siderurgico comprimono il diritto dominicale dei residenti nel quartiere Tamburi che non possono godere pienamente dei loro locali a causa dell’inquinamento. È quanto emerge dalla sentenza 18810/21, pubblicata il 2 luglio dalla terza sezione civile della Cassazione.
Prova per presunzioni
Diventa definitiva la decisione che condanna la spa a pagare il ristoro determinato in via equitativa: le emissioni effettuate per anni dallo stabilimento salentino superavano la normale tollerabilità di cui all’articolo 844 Cc. E che la propagazione delle polveri minerali fosse «continua» e «massiva» lo dimostrano «l’emergenza» e le «sentenze penali» oltre che «l’accurata descrizione dei luoghi». compiuta dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio di merito. Senza dimenticare gli stessi provvedimenti legislativi che a partire dal 2013 hanno cercato di tutelare l’ambiente oltre che i livelli occupazionali della fabbrica. Dai procedimenti penali, poi, emergono i disagi provocati dalle polveri che si depositano su strade e abitazioni di Tamburi: è provata per presunzioni, dunque, la lesione al diritto dei proprietari che non possono arieggiare gli appartamenti né uscire sui balconi.
Neminem laedere
È vero: l’articolo 844 Cc impone di sopportare le inevitabili propagazioni legate alle attività produttive, ma soltanto nei limiti della normale tollerabilità; bisogna insomma contemperare le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, che va gestita nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio; fuori da quest’ambito, invece, si determina un’attività illegittima che non può imporre un sacrificio ai proprietari degli immobili: il fatto illecito che genera il danno a terzi fa scattare l’azione generale di risarcimento ex articolo 2043 Cc. La liquidazione equitativa scatta perché è molto difficile quantificare il danno nel suo preciso ammontare. Ed è giustificata dal «grave e persistente fenomeno di spandimento» delle polveri provenienti dai parchi minerali dell’impianto che compromettono in modo significativo le potenzialità d’uso degli appartamenti.
Sì alla sanatoria se il locale ricavato nel sottotetto è solo uno sgabuzzino
Il Comune manca di spiegare perché la posa in opera di semplici tramezzi non sarebbe conforme alla normativa: non risultano impianti di servizio, immutata la destinazione a locale di sgombero
Impossibile negare la sanatoria al proprietario dell’immobile per l’intervento nel sottotetto: il Comune, infatti, non spiega perché non sarebbe conforme alle norme urbanistiche ed edilizie la posa in opera di semplici tramezzi, che serve a ricavare un piccolo sgabuzzino senza alterare la destinazione d’uso a locale di sgombero. E che manchi la creazione di superficie utile lo dimostra anche il fatto che non sono realizzati impianti di servizio. È quanto emerge dalla sentenza 624/21, pubblicata ieri dalla prima sezione del Tar Liguria.
Motivazione postuma
L’amministrazione locale boccia la Scia e il privato chiede l’accertamento della conformità urbanistica in base alla legge regionale anche se resta convinto che per i lavori basterebbe la segnalazione certificata. Il punto è che l’intervento proposto risulta diverso da quelli realizzati da altri condomini che hanno tentato di ricavare locali abitabili nel sottotetto: lo dimostra la presenza di arredi e dagli allacci di luce, acqua, fogne e riscaldamento. Né il Comune contesta il cambio di destinazione d’uso nel preavviso di rigetto e nella motivazione del provvedimento impugnato: si tratta dunque di una motivazione postuma effettuata in sede di giudizio negli scritti difensivi. E come tale è certamente inammissibile se non rappresenta - come nel caso di specie - che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Natura vincolata
L’ente locale, insomma, viene meno all’unica possibile motivazione del diniego di sanatoria, cioè la mancanza della doppia conformità, che ha invece ha natura vincolata, mentre non assumono alcuna rilevanza le giustificazioni o i motivi soggettivi del richiedente, ove non illeciti.
Assolto il giornalista che si avvale dello scritto anonimo per denunciare i favoritismi nella gestione di appalti pubblici
Utilizzabile il documento perché è evidente l'interesse pubblico se il professionista ha ritardato la notizia per verificare con prudenza fonti e fatti
Non scatta la diffamazione se il giornalista, dopo le doverose verifiche, si avvale di uno scritto anonimo per pubblicare un articolo in cui denuncia che un'importante carica dello Stato favorisce aziende a lui vicine per gestire appalti pubblici. Lo scritto, infatti, può ben essere utilizzato per dare diffusione a una notizia di evidente interesse pubblico. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24818/21, depositata oggi dalla quinta sezione penale. Bocciato il ricorso della parte civile, all'epoca dei fatti vice capo polizia di Stato contro la sentenza di appello che assolveva giornalista e direttore di un noto quotidiano dal reato di diffamazione. Stando ai fatti, il giornalista pubblicava un articolo, prendendo spunto da uno scritto anonimo, con cui muoveva accuse sul ricorrente di favoritismi nella gestione degli appalti dell'ufficio logistico del Viminale per acquistare impianti tecnologici da imprese a lui vicine.
Per la Corte territoriale, la notizia doveva essere pubblicata perché sussiste l'esimente del diritto di cronaca giornalistica; peraltro, nulla poteva imputarsi al giornalista in termini di mancato controllo delle fonti e della veridicità dei fatti. Secondo il Palazzaccio, è condivisibile l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il giornalista si era trovato a valutare uno scritto anonimo, le cui informazioni precise e dettagliate «lasciavano ragionevolmente ritenere la probabile fondatezza di quanto riportato o perlomeno la parvenza di veridicità riguardo ai favoritismi descritti, essendosi puntualizzato che lo stesso ministro dell'Interno, in ragione dell'apprezzabile serietà, aveva trasmesso l'anonimo alla Procura che, a sua volta aveva avviato le prime formalità di sua competenza e aveva ritenuto di darne notizia all'opinione pubblica tramite un apposito comunicato stampa». Il professionista ha verificato, inoltre, la «plausibile veridicità» delle notizie riportate nell'articolo e le ha pubblicate «ritenendone in buona fede l'autenticità».
Non solo. Va sottolineata la condotta prudente del professionista che, per nulla «animato dalla volontà di fare uno scoop», ha addirittura «bucato la notizia», con «inevitabili ricadute negative» sotto il profilo professionale, essendo in possesso dello scritto anonimo già da tempo e decidendo consapevolmente di non pubblicarlo subito ma solo dopo essersi confrontato «sull'opportunità della divulgazione con lo stesso prefetto». Sussiste, pertanto, l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo putativo e, più in generale, va detto che la condotta del giornalista è stata corretta avendo il professionista verificato l'attendibilità delle sue fonti e operato i doverosi controlli prima di dare alle stampe l'articolo. Alla luce di queste considerazioni, la Corte rigetta il ricorso della parte civile.
di Remo Bresciani
La dichiarazione di aver versato il prezzo contenuta nell’atto notarile non esclude la simulazione
L’affermazione proveniente dalla parte non fa fede fino a querela di falso perché di fronte al pubblico ufficiale non è avvenuto alcun pagamento
La dichiarazione di aver versato il prezzo contenuta nell’atto notarile non esclude la simulazione della vendita. L’affermazione che proviene dalla parte, infatti, non fa fede fino a querela di falso perché di fronte al pubblico ufficiale non è avvenuto alcun pagamento.
Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 17566/21 del 18 giugno che ha respinto il ricorso di una coppia.
Il tribunale aveva accolto la domanda, proposta da una banca nei confronti dei coniugi, di simulazione del contatto di vendita immobiliare. Ad avviso del giudice il compratore non aveva provato l’effettivo pagamento del prezzo convenuto. La corte d’appello ha poi confermato la decisione rilevando che il contratto era stato stipulato meno di un anno dopo l’emissione da parte del tribunale di un decreto ingiuntivo. Inoltre il rapporto di parentela tra le parti del contratto e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento deponevano sicuramente per la simulazione. Né si poteva desumere la prova del pagamento dall’atto notarile in cui le parti si erano limitate a dichiarare che il prezzo era stato corrisposto in epoca anteriore al rogito.
La vertenza è così giunta in Cassazione dove i ricorrenti hanno contestato la decisione per avere desunto la natura simulata dell’atto, in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti.
La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha ricordato che la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
Né, ha concluso la Cassazione, si può attribuire alcuna efficacia probatoria all’indicazione, contenuta nell'atto notarile di vendita, che il pagamento del prezzo sia avvenuto contestualmente alla firma del rogito, posto che tale dichiarazione, che proviene dalle parti, “non è assistita dal valore fidefacente fino a querela di falso derivante dall'attestazione del pubblico ufficiale, di fronte al quale non si è verificato, in concreto alcun pagamento”.
Anche le macchinette foto-tessera devono pagare l’imposta sulla pubblicità
Corte di cassazione: la dicitura «foto per documenti» presenti sulle macchinette pubbliche foto-tessera devono versare la tassa sulla pubblicita'
di Vanessa Ranucci
È diffamatorio denunciare all’Ordine che l’avvocato di controparte si è comportato da mercenario
L'assenza di una critica argomentata alla condotta professionale rende le frasi un attacco gratuito e denigratorio
Scatta la diffamazione per chi denuncia all'Ordine degli avvocati che la controversia è stata gestita in malafede dall'avvocato che si è comportato da mercenario se manca una critica argomentata alla condotta del professionista: in tal caso, le espressioni usate diventano denigratorie perché sono un attacco gratuito. Così ha stabilito oggi la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 23708/21.
Un sessantasettenne era stato condannato per il reato di diffamazione per aver inviato una missiva all'ordine degli avvocati in cui aveva offeso la reputazione del Ctp e dell'avvocato della controparte in una controversia civile. Nella lettera egli aveva affermato che la controversia era stata gestita in malafede dai professionisti “non seri”.
L'uomo, proponendo ricorso in Cassazione, aveva basato la linea difensiva sull'esercizio del legittimo diritto di critica. E che il riferimento alla malafede era rivolta non alle persone in quanto tali ma alla loro condotta professionale.
Per il Palazzaccio il motivo è inammissibile perché il principio richiamato dal ricorrente è applicabile quando l'esposto contenga espressioni, sì offensive, ma pertinenti all'esercizio di un legittimo diritto di critica, non già quando le espressioni siano gratuitamente e immotivatamente denigratorie. “Integra il reato di diffamazione – si legge in sentenza - la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria a un Ordine professionale; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità”.
Nel caso esaminato, il tenore delle frasi e il contenuto diffamatorio della lettera hanno arrecato pregiudizio alla reputazione professionale delle persone offese: ossia, le espressioni usate sono risultate denigratorie perché erano un attacco gratuito contro i professionisti, viso che mancava una censura argomentata alla loro condotta professionale.
di Dario Ferrara
Scaricabile da Internet e con le app Immuni e Io il green pass per tornare a viaggiare (e a vivere)
Presto in Consiglio dei ministri il dpcm sul certificato digitale a chi è vaccinato, guarito o negativo al tampone per partecipare a cerimonie e spostarsi nella Ue senza quarantena. Qr code antifrodi
Sì, viaggiare. Dopo mesi di “morte civile” causa Covid, conto alla rovescia per il dpcm sul green pass: la certificazione verde servirà a spostarsi nell’Unione europea senza tamponi e quarantene ma anche in Italia, per muoversi fra eventuali Regioni rosse o arancioni e soprattutto per partecipare a cerimonie come i matrimoni o visitare un parente anziano in una residenza sanitaria assistita: è previsto in settimana il Consiglio dei ministri per il via libera al provvedimento messo a punto da Palazzo Chigi con i ministeri della Salute, Innovazione tecnologica e Finanze (cfr. la bozza del decreto). Il certificato si potrà consultare e scaricare online, mentre il Qr code garantirà autenticità.
Chiavi digitali
Al certificato, gratuito, ha diritto chi: è stato vaccinato (con entrambe le dosi nel caso di Pfizer, Moderna e AstraZeneca); è risultato negativo a un tampone molecolare o un antigenico rapido effettuato entro le quarantotto ore; è guarito dall’infezione da Sars-Cov-2 e dopo il tampone negativo risulta uscito dall’isolamento. Il green pass di fatto esiste già nel nostro Paese ma dal primo luglio confluirà nel sistema europeo: si aspetta solo la digitalizzazione con il codice a barre di identificazione che contiene le informazioni necessarie per consentire di svolgere le diverse attività. È già operativo il gateway, la piattaforma informatica Ue che fornisce le chiavi virtuali per la validità transfrontaliera.
Dati sensibili
Il documento si potrà scaricare dal web grazie a un sito ad hoc, oppure con le app Immuni e Io (quella utilizzata per il cashback, per intenderci). E altrettanto si potrà fare dal fascicolo sanitario elettronico e tramite il sistema tessera sanitaria. Sarà il ministero della Salute il titolare del trattamento dei dati della piattaforma nazionale attraverso la Sogei. Sul certificato sono riportati: nome e cognome del titolare; data di nascita; struttura che ha rilasciato la certificazione; codice unico attribuito in automatico dal sistema Digital green certificate; Stato di appartenenza; scadenza del documento, che è valido nove mesi dopo la seconda dose di vaccino; a proposito: per i vaccinati sono riportati anche il tipo di farmaco inoculato, numero di dosi e data di somministrazione. E se un medico comunica alla piattaforma nazionale la positività al Sars-Cov-2 scatta subito la revoca con notifica all’interessato.
Informazioni utili
Il sito web del green pass offrirà nelle Faq le risposte a tutti i quesiti. A disposizione degli utenti ci saranno il numero di pubblica utilità del ministero della Salute (1500) e il call center di Immuni (800.91.24.91).
Vai col mix
Via libera dal ministero della Salute, infine, al mix di vaccini sotto i sessant’anni per la seconda dose a chi ha ricevuto la prima di Johnson & Johnson o AstraZeneca: si punta ad arrivi anticipati di dosi Pfizer e Moderna per rifornire i centri vaccinali.
di Debora Alberici
Il professionista può dedurre le fatture solo quando viene pagato l’assegno postdatato
Il principio di competenza vale se il titolo riporta lo stesso anno di consegna. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate
Il professionista può dedurre i costi delle fatture ricevute solo quando l’assegno postdatato viene effettivamente pagato. Infatti, l’agevolazione segue il principio di competenza.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16711 del 14 giugno 2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate spiegando che l’agevolazione approfitta del principio di competenza solo se viene dimostrato che l’assegno riporta la data dell’anno nel quale la spesa viene messa a bilancio.
Per gli Ermellini è senz’altro valido il principio secondo cui il momento rilevante cui imputare una spesa sostenuta con assegno bancario, ai fini della deducibilità per i lavoratori autonomi è, in base al principio di cassa, quello della consegna del titolo e non quello dell'effettivo incasso (risoluzione 138/e del 2009 per l'assegno circolare, ma il principio può ritenersi applicabile anche per l'assegno bancario).
Tuttavia, fa notare Piazza Cavour, il punto critico è un altro: il fatto che gli assegni siano stati consegnati nel 2005 la Ctr deve averlo dedotto da dichiarazioni sostitutive di terzi, e gli assegni sono datati 2006, probabilmente perché la data è stata apposta al momento dell'incasso.
Ciò che viene contestato, con una tesi condivisa dalla Suprema corte, è proprio questo tipo di prova. Le dichiarazioni sostitutive, in questo caso dei fornitori, non dimostrano che gli assegni erano stati consegnati nel 2005.
Fra l’altro per la Cassazione, la Ctr avrebbe dovuto scrutinare a fondo il valore delle dichiarazioni di terzo contenute in atti sostitutivi di notorietà, sulla base del principio per cui l'inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario non comporta l'inutilizzabilità, in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi, sia raccolte dall'amministrazione procedente nella fase procedimentale, ma anche contenute in dichiarazioni sostitutive, per quanto alle stesse non debba essere riconosciuto valore probatorio pieno, rappresentando, piuttosto, un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti.
Ora saranno i giudici di merito a riconsiderare il caso alla luce dei principi affermati in sede di legittimità.
di Dario Ferrara
Due terzi d’Italia in zona bianca, ma con mascherine e distanze. Da luglio green pass Ue
Senza coprifuoco oltre 40 milioni di cittadini, in fascia gialla a casa a mezzanotte fino al 21 giugno. A luglio liberi tutti. Firma finale sul certificato digitale europeo per spostamenti e ripresa economica
Da oggi oltre 40 milioni di italiani si trovano in zona bianca, dunque senza coprifuoco. Ma devono continuare a usare le mascherine, a osservare il distanziamento personale di un metro e a lavarsi spesso le mani, raccomanda il ministro della Salute. Decisivo nello spostare due terzi del Paese nella fascia più bassa l’ingresso di Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia e la provincia di Trento, avvenuto oggi grazie all’ordinanza di Roberto Speranza (cfr. il provvedimento in allegato). In zona gialla il coprifuoco continuerà fino lunedì 21 giugno, fissato alle 24.
E grazie alla campagna vaccinale, con l’attuale riduzione del contagio, tutta Italia potrebbe trovarsi in zona bianca a fine giugno, ha spiegato il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. Dal primo luglio, intanto, arriverà il Digital green pass (Dgc), il certificato europeo anti Covid nato per facilitare gli spostamenti all’interno dell’Unione e contribuire alla ripresa economica: oggi la firma finale da parte delle istituzioni eurounitarie.
Rischio malamovida
Dopo l’ultima ordinanza si trovano dunque in area bianca: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto. Ancora in giallo Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Il divieto di assembramento resta anche con l’addio al coprifuoco in gran parte del Paese. Preoccupa la malamovida dopo gli scontri fra giovani e polizia di sabato notte a Roma, a Campo de’ fiori. «Oggi più che mai occorre conservare le corrette abitudini per non vanificare i tanti sacrifici fatti, insiste Speranza.
Ristoranti e discoteche
In zona bianca serve il green pass per andare a matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, compleanni, feste di laurea e anniversari: per partecipare, quindi, bisogna avere il certificato di vaccinazione o di guarigione oppure il tampone negativo effettuato nelle quarantotto ore precedenti. Nel dcpm che sarà approvato approvato nei prossimi giorni è previsto che la verifica delle certificazioni spetta ai soggetti che erogano i servizi e agli organizzatori degli eventi per cui è prescritto il possesso della certificazione, oltre che ai pubblici ufficiali. Fino al 21 giugno nei ristoranti in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Nella fascia più bassa di rischio le discoteche possono aprire ma soltanto per l’attività di ristorazione e somministrazione, mentre resta vietato ballare in pista.
Viaggiare in prossimità della linea di mezzeria non fa scattare il concorso di colpa
Ai fini del risarcimento del danno va accertato se il conducente non ha effettuato manovre di emergenza per evitare l'impatto
Solo se il giudice accerta la mancanza di manovre di emergenza per evitare l'impatto può ascrivere al conducente che viaggia in prossimità della linea di mezzeria il concorso di colpa nel sinistro e condannarlo, di conseguenza, a risarcire il danneggiato. L'inosservanza di una norma cautelare, come ad esempio quella che prevede qual è la posizione che il conducente deve mantenere sulla carreggiata, non comporta, infatti, alcuna colpa ascrivibile all'agente in termini di responsabilità aquiliana.
Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 16192/21, depositata oggi dalla sesta sezione civile, accoglie il ricorso principale presentato da un motociclista, condannato a risarcire i danni non patrimoniali perché responsabile al 40 per cento di un sinistro. Il danneggiato, motociclista come il ricorrente, cadeva perché l'automobilista che lo precedeva frenava improvvisamente e, proprio in quel frangente, veniva investito dall'attore che procedeva nel senso opposto di marcia.
La Corte di appello riteneva il danneggiato responsabile al 60 per cento perché non rispettava le distanze e il ricorrente della restante parte perché viaggiava in prossimità della linea di mezzeria. La violazione del dovere di comune prudenza di viaggiare al centro della strada non basta però a far scattare il concorso di colpa per Piazza Cavour. Va riconosciuto l'errore del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata che «lungi dall'inferire la misura del contributo del ricorrente nella causazione del sinistro dal solo posizionamento del veicolo in prossimità della linea di mezzeria, avrebbe dovuto accertare se il motociclista abbia effettivamente mancato di effettuare eventuali manovre di emergenza per evitare collisioni con veicoli marcianti nel senso opposto».
Non basta, infatti, la riscontrata violazione degli articoli 141 e 143 del codice della strada, potendo ricorrere dei casi in cui «l'inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all'agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede, in ogni caso, il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l'inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto di esame». La Corte accoglie il ricorso principale.
di Dario Ferrara
Le Sezioni unite: aliquota al 3% e non all’8 per la cessione della cubatura Prg al terreno del vicino
Atto immediatamente traslativo del diritto di costruire, che non ha natura reale ma contenuto patrimoniale, non richiede la forma scritta ai fini della sostanza ed è trascrivibile. Pesa il dl sviluppo
Sconta l’imposta di registro al 3 e non all’8 per cento la cessione della cubatura autorizzata sul terreno dal piano regolatore generale, effettuata in favore del fondo del vicino. E ciò perché il proprietario trasferisce un diritto che non ha natura reale: va dunque assoggettato all’aliquota proporzionale prevista per l’atto a contenuto patrimoniale. Pesa il dl sviluppo, che per primo ha tipizzato i diritti edificatori prevedendo la trascrizione: la cessione della cubatura non richiede la forma scritta ai fini della sostanza e risulta trascrivibile ex articolo 2643, numero 2 bis, Cc. In caso di trascrizione e voltura scatta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 16080/21, pubblicata il 9 giugno.
Autonomia negoziale
La Suprema corte accoglie il ricorso dei contribuenti e decide nel merito annullando l’avviso di liquidazione. Sbaglia la Ctr a riformare la decisione della Ctp sul rilievo che avrebbe «sicure caratteristiche di realità» l’atto con cui i proprietari del terreno, che non sono soggetti Iva, vendono una parte della cubatura edilizia ottenuta dalla convenzione col Comune: a comprarla è una società titolare di un fondo omogeneo dal punto di vista urbanistico. A chiudere il contrasto di giurisprudenza contribuisce il decreto 70/2011, che ha aggiunto il numero 2 bis all’articolo 2643 Cc, nonostante gli «evidenti limiti» segnalati dai giudici di legittimità perché non dà una definizione dei diritti edificatori in termini di contenuti e sostanza. Ma consente comunque di qualificarli come diritti veri e propri e aiuta a qualificare la cessione di cubatura dal punto di vista giuridico. È solo per effetto del contratto fra le parti che i diritti edificatori sono costituiti, trasferiti e modificati, il che consente il trasferimento con il consenso delle parti ex articolo 1376 Cc.
Correttezza e buona fede
Resta, comunque, il ruolo autorizzativo e regolatorio del permesso di costruire: quando il cessionario presenta il progetto per edificare, il cedente deve operare per il rilascio del titolo edilizio secondo correttezza e buona fede. Insomma: non si può applicare alla cessione di cubatura l’aliquota più alta prevista per il trasferimento della proprietà degli immobili o altri diritti reali.
Telefonata di raccomandazione?
Concorso in abuso d’ufficio per il «notabile» locale
La chiamata per evitare il ritiro della carta di circolazione all’automobilista amico fa scattare il concorso nel reato anche per l’estraneo al pubblico servizio, se l’agente viene influenzato nella decisione.
di Emiliana Sabia
Cade l'accertamento al contribuente se l'immobile acquistato è pagato dal figlio per celare un'operazione finanziaria
La compravendita è un'intestazione fiduciaria e non una donazione indiretta. No all'avviso di maggior reddito perché la disponibilità del denaro è del familiare
E' un'intestazione fiduciaria e non una donazione indiretta la compravendita di un fabbricato acquistato dal padre tramite la società del figlio che mette il contante per celare un'operazione finanziaria. L'accertamento di maggior reddito è, pertanto, illegittimo perché chi la disponibilità di denaro è un soggetto diverso dal contribuente. Lo dichiara la Ctr Lazio che, con la sentenza n. 2744/21, pubblicata dalla diciassettesima sezione, accoglie l'appello di madre e figlio, eredi di un contribuente destinatario di un accertamento di maggior reddito. Gli appellanti proponevano ricorso in riassunzione dopo il rinvio alla commissione regionale disposto dalla Cassazione in relazione a una compravendita con cui il contribuente acquistava dalla società di un altro figlio, noto imprenditore, un fabbricato.
Il fisco notificava l'atto perché risultava un'incongruenza in dichiarazione, vale a dire che i redditi imponibili del contribuente erano insufficienti a consentire l'operazione di acquisto. Non c'era, sempre secondo l'avviso, la prova dell'erogazione di liberalità effettuata dal figlio al padre; in altre parole, il figlio trasferiva direttamente alla sua società denaro contante senza avvalersi di intermediari. Il collegio ritiene fondato l'appello; l'operazione in questione va inquadrata come «un'intestazione fiduciaria, tesa a celare un'operazione finanziaria finalizzata ad apportare liquidità alla società venditrice piuttosto che di donazione indiretta ex articolo 809 Cc, non evidenziandosi dalla documentazione in atti un intento liberale del figlio nei confronti del padre». L'accertamento di maggior reddito è, in definitiva, illegittimo perché ad avere la disponibilità di denaro è un soggetto diverso dal contribuente e, dunque, non può essere qualificato come reddito imponibile di quest'ultimo. Il collegio accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento.
di Debora Alberici
Niente diritto di abitazione al coniuge superstite nella casa in comunione fra il de cuius e la prima moglie
Respinto il ricorso della partner di secondo letto e confermato il verdetto di merito
Il coniuge superstite non è titolare del diritto di abitazione nella casa in comunione fra il de cuius e la prima moglie.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15000 del 28 maggio 2021, ha respinto il ricorso della moglie di primo letto del de cuius.
La vicenda riguarda una donna che chiedeva, dopo la morte dell’ex marito, il diritto di abitazione nella casa intestata al de cuius e alla prima moglie.
I giudici di merito hanno negato la legittimità dell’occupazione con una decisione condivisa e resa definitiva in sede di legittimità.
Per gli Ermellini, infatti, “a norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano in favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo".
In altre parole, “i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti".
di Dario Ferrara
Conducente condannato anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce
Il guidatore deve essere sempre in grado di padroneggiare il veicolo di fronte all’imprudenza altrui, se prevedibile: velocità da regolare in base a visibilità e tempi di reazione per la frenata
Scatta la condanna per omicidio colposo a carico del conducente, anche se il pedone non usa le strisce bianche per attraversare. E ciò perché il guidatore deve essere sempre in grado di padroneggiare il veicolo e di compiere manovre d’emergenza per evitare incidenti; il tutto pure quando il danno è dettato dall’imprudenza altrui, a patto che sia prevedibile: la velocità del mezzo, infatti, deve essere regolata in proporzione alla visibilità e considerando i tempi tecnici per l’eventuale frenata. Insomma: l’automobilista è colpevole perché non rallenta nei pressi della fermata dell’autobus, che crea comunque traffico pedonale. È quanto emerge dalla sentenza 20912/21, pubblicata il 27 maggio dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Principio di affidamento
Diventa definitiva la condanna inflitta alla signora: l’investimento avviene a sei metri dallo spartitraffico, in un posto dove l’automobilista e il pedone potevano vedersi reciprocamente, secondo le risultanze del consulente del pubblico ministero. E il punto d’urto non è messo in discussione dal perito della difesa. Pesa sulla sanzione penale il principio dell’affidamento così come maturato in ambito stradale, che riduce i suoi margini di fronte alla diffusività del pericolo: la responsabilità del conducente è proporzionale alla prevedibilità del comportamento scorretto o anche irresponsabile degli altri utenti della strada.
Colpa generica
La velocità del mezzo deve essere adeguata alle condizioni ambientali oltre che alle caratteristiche del veicolo: bisogna essere in grado di compiere la manovra d’emergenza necessaria se si concretizza il pericolo temuto, dovuto al comportamento negligente o imprudente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi. Sempre rilevante, anche in termini di colpa generica, la violazione delle norme ex articoli 141 e 145 Cds: l’una impone al conducente di mettersi in condizione di poter sempre frenare la marcia del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile; l’altra prescrive di usare la massima prudenza nei pressi degli incroci. L’attraversamento del pedone, nella specie, non può dirsi imprevedibile per la vicinanza della stazione degli autobus.
Niente diffamazione per il giornalista che riporta alla lettera le dichiarazioni lesive dell'intervistato perchè conta anche l'interesse pubblico all'informazione
Applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca: il professionista non è responsabile delle affermazioni del soggetto
Si applica la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca al giornalista che riporta alla lettera le dichiarazioni dell'intervistato lesive della reputazione altrui perché in ballo c'è anche il diritto dell'opinione pubblica di venire a conoscenza dei fatti. Lo ha sancito la Cassazione con l'ordinanza n. 14380/21, pubblicata oggi dalla prima sezione civile. Con la pronuncia, gli Ermellini accolgono il primo motivo del ricorso di una giornalista, condannata in solido con l'intervistata, a risarcire ben 20mila euro di danni a una cooperativa dopo la pubblicazione di un'intervista su un noto quotidiano. Dall'intervista, rilasciata da una persona molto conosciuta in ambito locale in quanto vicepresidente della commissione sanità, emergevano una serie di affermazioni sulle disfunzioni del sistema sanitario e, in particolare, l'intervistata affermava che ai bambini affetti da fibrosi cistica ricoverati presso un ospedale erano somministrate "porcherie" per avantaggiare un colosso della ristorazione con note amicizie qual era appunto la cooperativa convenuta.
Per la Corte di appello non c'è alcun dubbio: le dichiarazioni sono diffamatorie e a risponderne non doveva essere solo l'intervistata ma anche il giornalista che aveva omesso qualsiasi controllo sul contenuto. Il Palazzaccio non condivide l'operato del giudice di appello perché si applica la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, «pubblicando "alla lettera" il testo di un'intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione, questa sì, riservata al giudice dei merito, i necessari profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista».
Al giudice viene chiesto, prima di tutto, di accertare che ci sia «la condizione di interesse pubblico all'informazione» ma, «ove ciò sia, il giornalista che non abbia manipolato o elaborato le dichiarazioni dell'intervistato, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere ritenuto responsabile di quanto affermato dall'intervistato stesso». La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e cassa con rinvio la sentenza per un nuovo approfondimento.
di Vanessa Ranucci
Il concorso di colpa nel sinistro blocca la revoca della patente nonostante le lesioni stradali gravi
Accolto il ricorso di un automobilista a cui non sono state contestate le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti
Il concorso di colpa nel sinistro ferma la revoca della patente nonostante le lesioni stradali gravi. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 20437/21 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un automobilista a cui non sono state contestate le aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Il tribunale romano ha applicato a un automobilista la pena sospesa di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 CdS, per il reato di cui all'art. 590 bis Cp. Al conducente era stato contestato di avere, per colpa generica e specifica, cagionato lesioni personali guaribili in 60 giorni ai danni di un uomo.
Il conducente ha denunciato in Cassazione l'erronea applicazione della legge penale laddove il giudice ha ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida: in particolare, ha osservato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, l'art. 222, comma 2 Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, “è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti peri reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis Cp, non consente di disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa allorché non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.589 bis e 590 bis Cp”. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato il fatto che il giudice non abbia dato spiegazioni sul perché applicare la revoca della patente di guida.
Al riguardo, la Suprema corte ha ricordato che “la corte Costituzionale, con sentenza n.88 del 19/2/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, CdS nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del Cpp, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) Cp, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma dell'art. 222 CdS, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis Cp. L'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art 590 bis Cp”.
Dunque, secondo il Palazzaccio, il caso portato in esame dal ricorrente può rientrare nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della corte Costituzionale perché non erano contestate all'automobilista le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Non solo: per gli Ermellini il magistrato di merito, quando ha disposto la revoca della patente, è stato lacunoso nel motivarne la decisione. “Deve rammentarsi che – si legge nel testo - il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria in assenza delle aggravanti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 590 bis Cp, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), dovrà dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento meno favorevole. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218, comma 2, CdS, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida”.
Pertanto, sentenza annullata e al tribunale capitolino il nuovo giudizio.
di Dario Ferrara
No alla prima rata Imu con cali di fatturato del 30 per cento. Acconto Irap rinviato al 30 settembre
La Camera converte in legge il dl sostegni: ristori per le imprese al di là dei codici Ateco. Stralcio per le cartelle fino a 5 mila euro emesse tra il 2000 e il 2010. Non cedibile il credito su bonus mobili
Sono esentati dalla prima rata dell’Imu per il 2021 gli immobili posseduti dalle partite Iva che hanno i requisiti per accedere ai ristori previsti dal dl sostegni a marzo e che ora sono rifinanziati: è necessaria, dunque, una perdita di fatturato oltre il 30 per cento rispetto al 2020. Slitta poi al 30 settembre il pagamento del primo acconto dell’Irap, il tutto senza more e oneri. Sono due delle novità introdotte in sede di conversione al dl sostegni, che è legge dopo il via libera ottenuto dall’aula della Camera con 375 voti favorevoli, nessun contrario e 45 astensioni (cfr. il testo in allegato).
Il provvedimento è finanziato con i 32 miliardi di euro dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso per uscire dalla crisi Covid: interviene in via prioritaria con nuovi ristori a favore delle imprese, svincolando le provvidenze dai codici Ateco utilizzati durante il lockdown.
Il decreto legge ha prorogato a fine giugno il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione ordinaria e al 31 dicembre quella in deroga. Previsto anche lo stralcio per le cartelle fino a 5 mila euro emesse tra il 2000 e il 2010, da più parti definito un condono fiscale. Non possono essere ceduti a terzi i crediti fiscali del bonus mobili ed elettrodomestici. Idem vale per quelli sull’acquisto di beni strumentali legati a Transizione 4.0, il cosiddetto superbonus per le aziende.
Fra le novità introdotte al Senato il fondo da 10 milioni per aiutare i genitori separati o divorziati che non possono pagare l’assegno di mantenimento ai minori perché sono rimasti senza lavoro causa Covid: il beneficio massimo è di 800 euro al mese.
Medico condannato solo indicando la probabilità con cui la condotta doverosa avrebbe evitato il danno
Al paziente provare il nesso causale intervento-lesione: manca di attestare l’assolvimento dell’onere il giudice che non precisa in che misura percentuale l’esecuzione corretta avrebbe escluso il pregiudizio
Dopo l’operazione fallita niente condanna al risarcimento a carico del medico sui cui vuole rivalersi l’azienda ospedaliera. E ciò perché il giudice del merito non indica in quale misura probabilistica l’eventuale corretta esecuzione della prestazione avrebbe evitato il danno al malato o almeno l’avrebbe ritardato. Nelle cause fra sanitario, struttura e danneggiato, infatti, si applica il principio del «più probabile che non»: quando il giudice non precisa la percentuale delle possibilità con cui la condotta doverosa avrebbe salvato il paziente, viene meno al dovere di attestare che il danneggiato ha adempiuto l’onere della prova. La causa per danno erariale a carico del primario, poi, è indipendente dall’azione per responsabilità civile. È quanto emerge dalla sentenza 13677/21, pubblicata il 19 maggio dalla terza sezione civile della Cassazione.
Omissione decisiva
Sono accolti i ricorsi del medico e dell’ospedale contro la sentenza che condanna l’azienda sanitaria a risarcire la paziente e il sanitario a tenere indenne la struttura. Tutto per i gravi danni patiti dalla signora per l’inadempimento del professionista agli obblighi di cura. Entrambi i mezzi di impugnazione trovano ingresso laddove criticano la decisione che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e i danni alla persona denunciati dall’interessata. Spetta al malato, in effetti, dimostrare l’esistenza del nesso causale provando che è stata l’azione del medico la causa del danno secondo il principio civilistico del «più probabile che non»; mentre se la condotta resta incerta la domanda di risarcimento deve essere rigettata. L’omissione del giudice del merito pesa sul piano probatorio: non precisare in quale misura probabilistica la prestazione a regola d’arte avrebbe scongiurato la lesione equivale a non dar conto se il paziente abbia adempiuto l’onere di dimostrare il dedotto nesso di causalità.
Interessi distinti
Inutile invece per il medico dedurre la carenza di giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che spetterebbe alla Corte dei conti pronunciarsi sul punto nell’ambito della domanda di rivalsa spiegata dall’azienda ospedaliera. Si tratta di azioni diverse: quella per danno erariale punta a tutelare l’interesse pubblico al buon andamento dell’amministrazione, quella per responsabilità civile al pieno ristoro del danno. Parola al giudice del rinvio.
Orientamenti sessuali e comunicazione via Facebook con terzi: è diffamazione
L'attribuzione di orientamenti sessuali su Facebook può costituire diffamazione e a nulla rileva che determinate espressioni effettuate in pubblico abbiano perso il carattere dispregiativo per una presunta "evoluzione" della coscienza sociale.
E' quanto statuito dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione in una sentenza del 17 maggio 2021. La vicenda portata all'attenzione della Suprema Corte traeva origine da una sentenza della Corte d'appello di Milano .
RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE COMUNALE IN CASO DI PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO (CASS. 5439/2017)
In capo al dirigente non può aversi una responsabilità omissiva nella realizzazione di opere illegittime, pertanto per configurare un reato occorrono elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta. Superamento di un precedente orientamento giurisprudenziale. La posizione del Sindaco.
La Sentenza Corte di Cassazione 6 febbraio 2017, n. 5439, si è soffermata sulle possibili conseguenze, in capo al dirigente dell’area tecnica comunale, in caso di emanazione di un permesso di costruire illegittimo.
In particolare i giudici di legittimità hanno affermato il principio per cui in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta di tale soggetto, lo stesso non può ritenersi responsabile.
LA DECISIONE DELLA CORTE - Sul punto, la pronuncia sottolinea che la funzione di dirigente dell’area tecnica comunale che ha rilasciato un permesso di costruire illegittimo non implica - in assenza di elementi di fatto indizianti un concorso consapevole, o quantomeno colposo, nella condotta - una responsabilità omissiva nella realizzazione di opere illegittime, in quanto il dirigente non è previsto tra i soggetti attivi del reato proprio indicati dall’art. 29 del D.P.R. 380/2001, e, ai sensi dell’art. 27 del medesimo D.P.R. 380/2001, riveste una posizione di garanzia limitata alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale ed alla demolizione delle opere abusive, non già di carattere generale.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI SUPERATI - Nell’assumere tale posizione, la sentenza ricorda l’esistenza di un precedente, ed invero risalente, orientamento giurisprudenziale (cfr. Sentenza Corte di Cassazione 28 aprile 2004, n. 19566) in base al quale, in materia edilizia, risponde del reato di cui all’art. 20 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 - ora sostituito dall’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - il dirigente dell’area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia (ora permesso di costruire) illegittima, atteso che questi, in quanto incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di quello specifico atto, è titolare in via diretta ed immediata della relativa posizione di garanzia che trova il proprio fondamento normativo nell’art. 40 del Codice penale.
Tale orientamento deve tuttavia ritenersi superato, dovendosi al contrario ritenere che: per poter ritenere configurabile la responsabilità ex art. 40 del Codice penale deve venire in rilievo una omissione, dovendosi quindi ritenere non ricompresa nella previsione normativa l’ipotesi in cui l’agente abbia posto in essere una condotta commissiva, contribuendo con essa alla produzione dell’evento.
Nel caso di specie, in effetti, oggetto di contestazione è proprio il compimento di un’attività, vale a dire il rilascio di un permesso di costruire illegittimo, consentendo l’esecuzione di lavori in una zona vincolata, in quanto rientrante in fascia di rispetto.
LA POSIZIONE DEL SINDACO - La Corte infine ricorda come anche a carico del Sindaco non sia configurabile alcuna responsabilità penale per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive incidenti sull’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale, non sussistendo in capo al medesimo un generale dovere di vigilanza sulle attività in questione (cfr. Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2011, n. 365
di Vanessa Ranucci
Peculato per l'albergatore che non ha versato al Comune le imposte di soggiorno
Escluso che per effetto dell'art. 180 della L. 77/21 la condotta di omesso o ritardato versamento sia stata trasformata con effetto retroattivo in un illecito amministrativo tributario
Condannato per peculato l'albergatore che nel 2015 non versò al Comune le imposte di soggiorno. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza 18105/21 pubblicata oggi, ha escluso che, per effetto dell'art. 180 della L. 77/21, la condotta di omesso o ritardato versamento sia stata trasformata con effetto retroattivo in un illecito amministrativo tributario.
La legale rappresentante di una struttura alberghiera era stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di peculato continuato per essersi appropriata di somme di denaro riscosse per il 2015 a titolo di imposta di soggiorno ma non corrisposte al Comune.
La ricorrente aveva denunciato la violazione di legge in punto di irretroattività della legge penale ex artt. 2, primo comma, Cp e 7 CEDU, sul rilievo che, all'epoca in cui la tassa di soggiorno venne istituita in virtù dei singoli regolamenti comunali, la qualifica di agente di riscossione in capo agli albergatori non era affatto prevedibile, tanto che la condotta di omesso, ritardato o parziale versamento era autonomamente sanzionata in via amministrativa dal regolamento comunale con rinvio alle sanzioni tributarie previste dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. E ancora, che i fatti contestati risalivano a un'epoca precedente alla decisione emessa nel 2016 dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in un quadro di incertezza interpretativa in merito alla natura del ruolo assegnato all'albergatore onerato della riscossione dell'imposta. In particolare, all'imputata venne notificato un atto amministrativo nel 2015 in cui la si informava del riconoscimento della qualifica di agenti contabili di fatto in capo ai gestori delle strutture ricettive e dei profili di rilevanza penale connessi al mancato adempimento dei relativi obblighi di rendicontazione non poteva prevedere la rilevanza penale della propria condotta né l'irrogazione delle gravi pene che ne conseguivano.
Per la Suprema corte sussiste il delitto di peculato per appropriazione attraverso la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento di tale funzione pubblica, "atteso che quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione e che a esso non può attribuirsi alcuna diversa destinazione, laddove l'eventuale imputazione delle somme incassato dai contribuenti alla copertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale quelle somme sono state versate e ricevute, realizza la condotta di cui all'art. 314 Cp".
Per quanto riguarda le implicazioni della modifica dell'imposta di soggiorno dal legislatore operata con l'art. 180, comma 3, ultimo periodo, Dl 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve rilevarsi come alcuna incidenza tale novella legislativa eserciti in ordine alla configurabilità delle condotte di peculato precedentemente commesse. E deve escludersi che sia stata trasformata con effetto retroattivo la condotta di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore, prima punita a titolo di peculato, in un illecito amministrativo tributario. Ne consegue la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla modifica dal legislatore apportata per effetto della disposizione cui all'art. 180, comma 4, cit.
Obbligo di assicurare anche i veicoli fermi che non funzionano
In Italia si attendono le Sezioni unite e un Dm recepisce in parte la stretta
Finora la normativa nazionale non ne ha tenuto conto, ma dal 2018 la Corte Ue ritiene che ogni veicolo immatricolato vada assicurato per la Rc auto, a prescindere dal tipo di area (pubblica o privata) su cui si muova o sia parcheggiato. Ora la sentenza del 29 aprile 2021 nella causa C-383/19 stringe ancora: l’obbligo c’è anche se il veicolo non funziona e quindi è inidoneo a circolare.
Il caso sottoposto alla Corte riguardava un veicolo immatricolato in Polonia che, a seguito di confisca, era passato nella proprietà di un ente locale, poi multato per non averlo assicurato mentre lo teneva in area privata in attesa di rottamazione. Alla Corte era stato chiesto di chiarire interpretazione e portata dell’articolo 3 della direttiva 2009/103, sulla possibilità di escludere l’obbligo «quando il veicolo...è immobilizzato su un terreno privato, è diventato proprietà di un ente...in forza di una decisione giudiziaria definitiva, non è idoneo alla circolazione ed è destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario».
La sentenza è negativa e perentoria. Citando vari suoi precedenti, la Corte afferma che l’obbligo non dipende dall’effettivo utilizzo in un dato momento né viene meno se il mezzo resti, per sola scelta del proprietario che non vuole più usarlo, su terreno privato. Neppur basta il fatto che il veicolo sia non funzionante. Quindi l’articolo 3 va interpretato nel senso che l’obbligo vale «quando il veicolo...è immatricolato in uno Stato membro, qualora...non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile».
Ciò condensa tre princìpi, dettati dall’esigenza di massimo rinforzo della tutela delle vittime di incidenti:
- la nozione di veicolo è oggettiva e non influenzata ai fini assicurativi dall’uso che si fa del mezzo
- l’obbligo non è escluso solo perché in un dato momento un veicolo immatricolato è inidoneo a circolare per via delle sue condizioni;
- la sola scelta di demolire il veicolo non basta a far venir meno l’obbligo di assicurarlo.
In Italia la Cassazione è chiamata a decidere a Sezioni unite (sin dal 18 dicembre 2019) se l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza europea, «nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». In attesa della sentenza nazionale, la Corte Ue ha sposta ancora più in là il baricentro.
La recente disciplina del contratto base Rc auto (Dm 54/2020) pare seguire la giurisprudenza Ue, almeno sull’obbligo anche in aree private. Ma con qualche (risolvibile) problema di coordinamento con la possibilità, riconosciuta dallo stesso Dm e diffusa nella prassi, di sospendere a richiesta la copertura.
di Remo Bresciani
Il giudice del divorzio può determinare l’entità dell’assegno sulla base della ctu disposta in sede di separazione
La scelta di avvalersi di prove acquisite in un altro processo rientra nella discrezionalità della corte di merito a condizione che venga acquisita la documentazione
Il giudice del divorzio può determinare l’entità dell’assegno spettante all’ex coniuge sulla base della ctu disposta in sede di separazione. La scelta di avvalersi di prove acquisite in un altro processo rientra infatti nella discrezionalità della corte di merito a condizione che la documentazione sia acquisita al processo.
Lo ha ricordato la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 11794/21 del 5 maggio che ha respinto il ricorso di una donna nei confronti dell’ex marito.
L’uomo aveva agito per ottenere il divorzio con esclusione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie disposto in sede di separazione.
Il tribunale ha pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e posto al carico dell’uomo l’obbligo di versare una somma. La corte d’appello ha poi confermato la decisione ritenendo congrua la determinazione dell’assegno di mantenimento. La controversia è così giunta in Cassazione dove la donna ha contestato la decisione per avere omesso di disporre le indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, anche a mezzo della polizia tributaria e aver ritenuto di fondare la decisione esclusivamente sulle risultanze della ctu disposta in altro giudizio (di separazione dei coniugi); consulenza, peraltro, sottoposta a rilievi critici da parte del consulente di parte della ricorrente.
La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile la censura, ha stabilito che il potere officioso di disporre, per il tramite della polizia tributaria, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra, nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, “purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti”.
Né, ha concluso la Cassazione, è censurabile la scelta del giudice di appello di avvalersi della consulenza di ufficio disposta nel giudizio di separazione. Infatti, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio - come avvenuto nel caso di specie, trattandosi di consulenza già nota alle parti ed espressamente richiamata dalla sentenza impugnata - al fine di farne oggetto di valutazione critica dei contendenti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
Vaticano: Francesco abolisce un privilegio, cardinali e vescovi giudicati come tutti nel tribunale ordinario
ll Motu Proprio del Papa introduce una grossa novità, anche se resta l'autorizzazione preventiva del Pontefice per portare a processo porpore e presuli
Va sospeso il notaio poco scrupoloso: danneggia l’intera categoria
Riconosciute le ragioni del Consiglio Notarile che contestava le tante infrazioni commesse, tra le quali lo smarrimento di un testamento pubblico
Segreto professionale, sospeso l’avvocato che fa 35 cause contro il cliente rivelando notizie su di lui
Decine di cause contro l’ex assistito, i familiari e la società, per recuperare gli onorari. Nelle memorie indicate informazioni non rilevanti anche private
Falso e abuso d'ufficio per l'agente della stradale che annulla ai carabinieri la multa per eccesso di velocità
Falsa la causale "pubblica sicurezza" e contro la legge la prassi seguita dagli agenti che procedevano in autonomia ad archiviare le multe: solo il prefetto o il giudice di pace possono farlo
Condominio e utilizzatore del lastrico solare pagano i danni da infiltrazioni all’appartamento di sotto
Sì ai pannelli fotovoltaici sul tetto in area vincolata anche se si vedono dalla strada
Addio accertamento perché il canone di locazione non basta a determinare l'avviamento dell'azienda
Cassazione
Non paga l'Irap il professionista nonostante la veste societaria data alla sua attività
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
'Ho il malocchio': condannato il mago che compie rituali in cambio di denaro
Nessuna giustificazione, neanche parziale, per il sedicente professionista dell’occulto. Inequivocabile la condotta da lui tenuta nei confronti di una donna che lo aveva contattato convinta di essere vittima del malocchio. Irrilevante il fatto che i presunti riti magici siano stati effettivamente compiuti.
Cartella nulla se viene indicato solo il direttore dell'ufficio e non il responsabile del procedimento.
Papiro (M5S): “2800 tecnici assunti al Sud, un valido aiuto anche per le amministrazioni del messinese”.
Tra 100 giorni a partire da oggi, le amministrazioni del meridione avranno finalmente tecnici a disposizione per spendere al meglio i fondi del Recovery Plan e non solo.
A darne notizia è la deputata Antonella Papiro (m5s) – “Si tratta di 2800 professionisti di cui 497 per la Sicilia, assunti con contratto a tempo determinato, che daranno una boccata d'ossigeno ai comuni che troppo spesso non riescono a spendere i fondi stanziati dal governo nazionale per mancanza di progettisti, dovuti al blocco turnover, alla riduzione dei dipendenti pubblici e all'aumento dell'età media.
Siamo felici che finalmente si potrà portare a termine un grande impegno preso dal m5s, un intervento finanziato nella scorsa legge di bilancio 2018, che oggi diventa concreto assumendo migliaia di giovani laureati aventi i seguenti profili:
Tecnico ingegneristico - Esperti gestione, rendicontazione e controllo - Progettista, animatore territoriale e innovazione sociale - Amministrativo giuridico -Process data analyst.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in modo digitale accreditandosi con #SPID e utilizzando la piattaforma #StepOne2019, il concorso sarà per titolo ed esami con procedure semplificate e digitalizzate>>.
RESPONSABILITA' CIVILE
Si al risarcimento per la morte della zia anche se non convivente
PER LA PRIMAVERA CHE RITARDA LA NUOVA DEDICA A TUTTI GLI EOLIANI ED AGLI AMANTI DELLE ISOLE SPARSI NEL MONDO
MILVA "SONO NATA IL 21 A PRIMAVERA..."
Arretrato fiscale in Cassazione, la ricetta della sezione tributaria: in tre anni giù di due terzi La sezione Tributaria traccia le linee-guida per abbattere le 54mila pendenze: rottamazione delle cause datate e aumento dell'organico da 40 a 60 consiglieri
Addio multa e taglio punti perché non si legge la targa dell'auto e la foto velox non va ingrandita
Targhe prova, in alto mare la soluzione per i mezzi targati
Non è ancora risolto il problema dell'uso delle targhe prova anche su veicoli targati, dopo che la Cassazione ha ritenuto che sia utilizzabile esclusivamente sui mezzi non ancora immatricolati. Certo, questa è solo un'interpretazione e nella prassi
La ex moglie laureata disdegna i lavori manuali? Il marito può tagliare il mantenimento
Bacchettata la Corte d'Appello per aver affermato che una laureata, abituata ad un alto tenore di vita, non può essere «condannata al banco di mescita o al badantato».
Affermazioni che tolgono dignità ai lavori manuali e all'assistenza alla persona
L'azienda sanitaria paga per la signora che cade sul marciapiede sconnesso del Pronto soccorso
La Corte di cassazione (sentenza 4035) accoglie dunque il ricorso della donna, che aveva perso i precedenti gradi di giudizio, ed era stata condannata a pagare anche le spese, malgrado la rovinosa caduta, su una mattonella del tutto infossata.
La Suprema corte non condivide il ragionamento dei giudici di merito, secondo i quali un pedone è tenuto non solo ad un comportamento normale ma diligente secondo la comune esperienza.
La Cassazione chiede alla donna molto meno.
Covid-19, no al Daspo per il tifoso che viola le norme anti-assembramento
La Corte di cassazione (sentenza 6171) accoglie il ricorso del sostenitore dei neroazzurri - già destinatario del divieto di accesso ai luoghi di transito dei giocatori - al quale era stato imposto, per cinque anni, l'obbligo di presentarsi... Per la Cassazione i cori oltraggiosi e discriminatori dedicati alla squadra partenopea, non potevano essere considerati "violenti", requisito necessario per il Daspo, visto che erano assenti i tifosi del Napoli e non c'era...
Niente assegno ai figli che non trovano mai l'occupazione ideale
Lo puntualizza la Corte di cassazione con ordinanza n. 29779 del 29 dicembre 2020 (relatore Meloni).
Del resto, già con l'ordinanza 17183/2020, la Suprema Corte aveva chiarito che la prole adulta conserva il diritto al mantenimento solamente se, una volta ultimato il prescelto percorso formativo scolastico dia prova – l'onere, quindi, è a suo carico – di un effettivo impegno a trovare un'occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro,...
Alberi secolari in condominio: taglio ammesso solo per motivi seri e all'unanimità
Gli alberi ad alto fusto, anche se inseriti in giardini condominiali, sono beni propri di tutti i cittadini e i danni conseguenti al loro taglio sono irreversibili non solo per i condòmini, ma più in generale per la collettività
Cassazione: è violenza privata costringere l'ex a salire in macchina-
Per gli Ermellini integra il reato di violenza privata e non il sequestro di persona costringere la ex a salire in macchina per sostenere una conversazione non voluta
Foto d'epoca e lettere del padre, provano la paternità di una bambina del '47
Una lunga storia d'amore durata fino alla morte dell'uomo nel '55. Solo l'impossibilità di divorziare negli anni 40 ha impedito al padre naturale di vivere con la nuova famiglia.
No al licenziamento del disabile che prende la 104 a ridosso delle feste per svagarsi e viaggiare
l beneficio non è legato necessariamente ad esigenze di cura, ma è finalizzato al benessere psico-fisico del lavoratore con handicap e a favorire il suo inserimento sociale e familiare
Lo spessore del cappotto termico va calcolato ai fini del rispetto delle distanze?
Il cappotto termico non è un volume tecnico secondo la Cassazione. La problematica del rispetto delle distanze dopo la realizzazione della coibentazione dell'edificio.
Il Supremo Collegio ritiene pertanto che la distanza tra edifici va calcolata dal Cappotto termico.
Reato per l'allevatore che lascia i maiali liberi perché non può sfamarli a causa della crisi Covid
Violazione del provvedimento del sindaco per l'allevatore che non potendo alimentare gli animali sia per la crisi economica sia per il divieto di spostarsi li lascia liberi
Cassazione penale 15 gennaio 2021
Nulla la multa per un abuso edilizio di 40 anni fa
La sanzione pecuniaria e l'ordinanza di demolizione, per un abuso edilizio degli anni 70, arrivano dopo quarant'anni ma sono nulle. Il Tar della Sardegna, accogliendo il ricorso, ha annullato i provvedimenti dell'amministrazione comunale che disponeva la demolizione di una parte del fabbricato abusivo e sanzionava il proprietario dell'immobile per 30 mila euro circa. Il procedimento, arrivato a sentenza l'11 aprile 2018, riguarda un fatto avvenuto Villacidro nel Medio Campidano. E' il 1975 quando il proprietario di un immobile ottiene la concessione edilizia per eseguire delle opere in un suo edificio. Nel 1981 presenta domanda per ottenere l'agibilità. Nel 1982 l'ufficio tecnico del Comune di Villacidro certifica l'abitabilità dopo un sopralluogo “senza rilevare profili di criticità”.
Nell'aprile del 2010, in seguito a un esposto di un terzo, viene eseguito un nuovo sopralluogo da cui emergono alcune difformità rispetto alla concessione edilizia del 1975. Ossia, “al primo piano dell'immobile - nel quale si trovano due piccoli appartamenti attualmente occupati dai figli del ricorrente (si legge nella sentenza) -sarebbe più grande di 68.05 metri quadri rispetto al progetto assentito”. Inoltre “nel giardino di casa il ricorrente avrebbe realizzato due vani adibiti rispettivamente a bagno e a lavanderia per una superficie complessiva di di 9, 18 metri quadri per i quali non risulta sia stata rilasciata concessione edilizia”.
Quindi la decisione del Comune che “dopo aver accertato che la maggiore superficie del primo piano non potrebbe essere demolita senza pregiudicare la staticità della parte realizzata legittimamente, ha dunque comminato al ricorrente la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall'articolo 7 della legge regionale n. 23/1985 determinandola in euro 30.380,24. Quanto al bagnetto e alla lavanderia del cortile, invece, è stata invece emessa un'ordinanza di demolizione”.
Nel 2011 il ricorso al Tar. Tre i motivi per i quali il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei dispositivi. Un primo motivo riguarda “eccesso di potere (manifesta ingiustizia; carenza di motivazione in ordine all'interesse pubblico perseguito e violazione del principio dell'affidamento, carenza di istruttoria per mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento); violazione di legge (art. 3, legge 241/1990 e articolo 97 della Costituzione): in quanto, anche in ragione del lungo periodo di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere in contestazione (35 anni), e tenuto conto che fin dal il 16 marzo 1982 era stata presentata al Comune nell'attuale configurazione dell'immobile, la richiesta di abitabilità senza ricevere alcuna osservazione in ordine ad eventuali abusi, mancherebbe un interesse pubblico concreto ed attuale alla loro adozione”.
Inoltre, come seconda motivazione c'è “eccesso di potere per errore nei presupposti: in quanto non sarebbe stata realizzata alcuna un opera difforme rispetto al progetto approvato anche se visto il lunghissimo lasso di tempo ormai trascorso il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di provarlo, non avendo rinvenuto le tavole progettuali allegate alla concessione edilizia”. Infine : “Prescrizione del diritto a percepire l'importo oggetto della sanzione pecuniaria: in quanto il Comune fin dal 1982 avrebbe avuto a disposizione la documentazione attestante le attuali caratteristiche dal fabbricato e fin da allora avrebbe dovuto perseguire l'eventuale illecito attraverso l'applicazione della sanzione pecuniaria che, per contro, oggi sarebbe prescritta”.
Per il Tar il Comune, “al più tardi dal 16 marzo 1982 disponeva di tutti gli elementi utili all'esercizio del suo potere di vigilanza urbanistica. L'averlo esercitato solo con l'invio della comunicazione di avvio del procedimento del 18 maggio 2010 non può non comportare per l'ufficio comunale, in presenza di un indubbio affidamento suscitato nel ricorrente circa il consolidamento di una situazione di fatto conclamata e computata in sede di pagamento dei correlativi oneri tributari, un onere motivazionale puntuale in ordine alle ragioni di pubblico interesse specifico, ulteriore al mero ripristino della legalità, che giustificavano l'adozione del provvedimento repressivo dell'abuso. E ciò anche tenuto conto dell'orientamento diffuso in giurisprudenza secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, tutt'ora efficace, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità dell'opera.
Troppe pause caffè? È truffa continuata ma il reato è impunito se il danno alla Pa è lieve
Particolare tenuità del fatto applicabile anche al reato continuato, se il pregiudizio, da calcolare in base allo stipendio, non è rilevante e manca una propensione al crimine da parte degli amanti del break al bar
di Patrizia Maciocchi
Lo stipendio basso evita agli impiegati della pubblica amministrazione, habituè della pausa caffè al bar, di essere puniti per truffa continuata. A far scattare, malgrado la continuità, la possibilità di applicare la norma sulla particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice penale) il danno lieve provocato e la scarsa propensione al crimine. Nel caso esaminato il reato era prescritto, ma la Cassazione analizza comunque la condotta prendendo le distanze dalla decisione della Corte d’appello che aveva condannato per truffa continuata alcuni impiegati di una prefettura.
Le violazioni ripetute
Ai patiti del coffee break in un bar di fronte al luogo di lavoro, era stata contestata un’assenza di circa 16 ore per un totale di circa 140 euro, calcolati in base alla retribuzione degli impiegati che uscivano senza passare il badge. Per la Suprema corte la sentenza della Corte d’Appello era contraddittoria per più ragioni: gli episodi erano stati contestati come singoli fatti di reato però era stata affermata la continuazione. In più era stata negata la particolare tenuità del fatto perché le condotte, in quanto reiterate, potevano essere definite abituali. Circostanza questa che, ad avviso dei giudici territoriali, avrebbe impedito di riconoscere la non punibilità.
L’apprezzabilità del danno
Per quanto riguarda l’apprezzabilità del danno, da tarare sullo stipendio, la Suprema corte ricorda che la truffa si doveva ritenere consumata al momento della percezione della retribuzione, quindi gli episodi andavano spalmati su più mensilità. Sbagliato anche il presupposto in base al quale era stato negato il beneficio previsto dall’articolo 131-bis. Secondo la giurisprudenza della Suprema corte più recente, infatti, la continuità tra i reati non rappresenta più, in astratto, un ostacolo insormontabile. Il giudice deve valutare se la condotta sia la manifestazione di una situazione episodica, se la lesione dell’interesse tutelato è minimale, oltre alla gravità del reato e alla capacità delinquenziale di chi lo commette. Considerazioni che giocano a favore dei ricorrenti, la cui ammissibilità del ricorso consente di affermare anche la prescrizione del reato. Anche nella sua complessità il danno era tenue, malgrado il Pm avesse fissato la soglia massima di “tolleranza” in 50 euro, e certo la caratura criminale dei patiti della moka non era un elemento che li qualificava.
Esenzione Ici abitazione principale
Per beneficiare dell'agevolazione prima casa il nucleo familiare deve risiedere e dimorare nella stessa casa.
La moglie quindi non può beneficiare dell'agevolazione se il marito risiede e abita in una casa diversa. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 28534/2020 della Cassazione, che sbroglia la vicenda-
A una contribuente viene notificato un avviso di accertamento relativo all'I.c.i del 2010. La donna si rivolge quindi alla C.T.P, che accoglie il ricorso. La s.r.l incaricata della riscossione dei tributi per conto del Comune ricorre quindi alla CTR, che però respinge l'impugnazione.
Settore idrico: governo Musumeci prepara ddl di riforma
Un'Autorità idrica unica in tutta la Sicilia al posto dei nove attuali Ambiti territoriali provinciali. E' questo uno degli obiettivi del disegno di legge al quale sta lavorando il governo Musumeci per riformare il settore. L'annuncio è stato fatto nel corso di una riunione operativa convocata a Palazzo Orleans dal presidente della Regione Nello Musumeci. Attorno allo stesso tavolo – insieme all'assessore all'Ambiente Toto Cordaro, al dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti Calogero Foti, all'avvocato generale dell'Ufficio legislativo Giovanni Bologna e ai dirigenti generali dei dipartimenti Acqua e rifiuti e dell'Autorità di bacino Franco Greco – i nove presidenti delle Assemblee territoriali degli Ati e i 5 commissari di Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.
«Il caos nel settore idrico – sottolinea il presidente della Regione – non è più tollerabile e dimostra che la normativa vigente non è più adeguata. Dobbiamo tutelare gli interessi del cittadino onesto che paga l'acqua, la riqualificazione della rete distributiva e la omogeneità delle tariffe.
La bozza del disegno di legge verrà inviata agli Ati e ci confronteremo anche con l'Anci Sicilia. L'obiettivo è quello di arrivare possibilmente a un testo condiviso a metà gennaio per avviare il relativo iter all'Assemblea regionale».
Il nuovo sistema, comunque, sarà in stretta continuità con il passato.
PUBBLICA SICUREZZA
Costituisce (ancora) reato l'omessa comunicazione da parte dell'albergatore delle generalità dei clienti all'autorità competente
Nonostante l’abrogazione della l. n. 135/2001, l’art. 109 deve ritenersi ancora vigente, costituendo, dunque, reato la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35573/20; depositata l'11 dicembre)
‘Volume insufficiente’: l’alcoltest inchioda comunque l’automobilista
di Attilio Ievolella
Il dettaglio richiamato dalla difesa non è sufficiente per mettere in discussione il funzionamento dell’apparecchio e la validità del controllo a cui è stata sottoposta la persona alla guida.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35059/20; depositata il 10 dicembre)
Non è razzismo dire sul treno che gli extracomunitari sono asociali che vivono di sussidi
La Suprema corte blocca la consegna alla Germania del cittadino tedesco condannato nel suo paese per istigazione all’odio razziale: manca l’elemento della propaganda
Abuso d'ufficio per il sindaco che scioglie la seduta per non discutere la mozione contro di lui
La Cassazione (sentenza 32174 del 19 novembre 2020) respinge il ricorso del sindaco e conferma la condanna a un anno e otto mesi di reclusione.
Cassazione: riconosciuta la riduzione della TARI se si prova la mancata effettuazione del servizio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19767 2020 prende in esame un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di pagamento con cui un Comune aveva richiesto il versamento della TARI per il quale la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti nell’area in cui operava l’azienda.
La decisione viene ribaltata in appello e il soggetto contribuente si è rivolto alla Cassazione per riaffermare le proprie ragioni a base della riduzione dell’imposta.
La Corte suprema afferma che è ormai consolidato un orientamento interpretativo costante secondo la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.
Dunque, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.
Precisano i giudici che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti, infatti, non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore, tuttavia, ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.
La disciplina delle riduzioni TARI è disciplinata dai commi 656 e 657 dell’art. 1 della legge 147/2013 che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dall’art. 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, rispettivamente ai commi sesto e quarto.
Ai sensi del citato comma 656: “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.”
Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”
In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.
Va dunque estesa alla TARI l’interpretazione già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni TARSU, secondo cui «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il ‘ servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso…..»
In materia di riduzioni TARI rilevano i commi 656 e 657 dell’art. 1 della legge citata, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU dall’art. 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, rispettivamente ai commi sesto e quarto.
Ai sensi del citato comma 656: “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.”
Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”
La riduzione tariffaria, si precisa nell’ordinanza, non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la percentuale massima già individuata dalla norma, equilibrando l’ammontare della tassa comunque pretendibile, che nella misura ordinaria tiene conto dei costi generali del servizio completo svolto nell’area municipale, con i costi che il cittadino è tenuto presumibilmente a sostenere per far fronte alla mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri in un ambito territoriale della zona perimetrata l’intero ciclo di smaltimento, ma lo garantisca solo in parte.
In conclusione, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito, incombendo comunque sul contribuente l’onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile.(SF)
Il datore può far seguire il dipendente dall’investigatore privato per verificare se la malattia è vera
Respinto il ricorso di un uomo assentatosi con certificazione del pronto soccorso e poi sorpreso a fare shopping
Il datore può far seguire da un investigatore privato il dipendente che si mette in malattia con tanto di certificato per accertare se la malattia è vera.
La linea dura arriva dalla Cassazione che, con l’ordinanza n. 11697 del 17 giugno 2020, ha respinto il ricorso di un operaio che si era assentato per una lombosciatalgia con tanto di certificato del pronto soccorso.
Peccato che poi era stato sorpreso a fare shopping con il figlioletto sulle spalle.
Per gli Ermellini, è legittimo servirsi delle agenzie investigative per verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni facenti capo al dipendente con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell'ambito lavorativo disciplinarmente rilevanti.
Infatti, aggiunge il Collegio di legittimità, non si verte in ipotesi di controllo datoriale circa l'esecuzione della prestazione ma, invece, di verifica e controllo di un comportamento extralavorativo illecito, fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell'attività lavorativa per l'insussistenza della incapacità lavorativa nel caso di specie invece presente.
Insomma, in casi quali quello di specie nei quali il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione giustifica l'espletamento del controllo, né rileva la circostanza che si trattasse di infortunio sul lavoro e non di assenza per malattia e, quindi, non fosse richiesta reperibilità ed esperibile visita fiscale.
Infatti, le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa, mirando, piuttosto, esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante
Spetta alla banca provare che il bancomat è stato usato dal titolare
Accolto il ricorso del cliente che si era visto azzerare il conto in due giorni da due malfattori
La banca deve risarcire il cliente che si vede il conto azzerato da prelievi illeciti. Spetta infatti all’istituto di credito dimostrare che a usare la carta è stato il legittimo proprietario.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 9721 del 26 maggio 2020, ha accolto il ricorso del cliente della banca che si era visto azzerare il conto, con oltre 23 mila euro, da due malfattori.
Gli Ermellini hanno precisato che «in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui e richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente».
In poche parole, la banca deve fornire la prova della riconducibilita dell'operazione al cliente. Ma non solo: la terza sezione civile, spiegando che il rapporto fra banca e cliente è di natura contrattuale, ha quindi messo nero su bianco che a responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilita alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.
---L'invalido munito di contrassegno,può entrare nelle zone Ztl, senza alcuna preventiva autorizzazione della Polizia Municipale. Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.719/2008 e ordinanza 7630/19 che ha annullato la compensazione delle spese a danno dell'automobilista. La Corte di Cassazione inoltre ha confermato con la sentenza n.2310/17 i superiori orientamenti. Al Comune non è rimasto che pagare le spese del giudizio.
Multato il lavoratore assente alla visita fiscale anche se ha il figlio all'ospedale. Cassazione sezione lavore,ordinanza n.24492/19
Subordinato e non autonomo. E' un vero e proprio dipendente e non un mero collaboratore il professionista che esegue la sua prestazione nell'ambito di un servizio e secondo orari prestabiliti dai dirigenti dell'azienda svolgendo le stesse mansioni dei colleghi strutturati a tempo indeterminato. Cassazione 2019
Niente assoluzione per la speciale tenuità del fatto al Notaio anche se evade il fisco per poche migliai di euro. Ciò in quanto il Notaio riveste la figura di Pubblico Ufficiale. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha respinto il gravame del prfessionosta con la sentenza n.38744 del 20 settembre 2019
---Il gallo Maurice vince in tribunale: potrà cantare all'Alba
E’ una vittoria schiacciante quella portata a casa dalla proprietaria di un gallo di nome Maurice, grazie alla sentenza della cassazione potrà continuare a salutare l’alba ogni mattina con il suo canto.
Isola di Oléron, la corte del magistrato di Rochefort, nella Charente-Maritime, ha respinto la denuncia dei vicini che accusavano il gallo di svegliarsi troppo presto.
Una lite di quartiere che è diventata il simbolo delle tensioni tra la popolazione locale e i nuovi arrivati nelle campagne.
Corinne Fesseau, proprietaria di Maurice, ha festeggiato la sua vittoria in tribunale con il suo amato gallo in braccio asserendo :”Li abbiamo spennati !!”
Ed è effettivamente il caso di dirlo dato che il tribunale ha deciso che i vicini della donna dovranno continuare a sentire ogni mattina il canto del gallo e sono stati inoltre condannati a risarcire la donna con una somma di 1000 euro come risarcimento danni, e dovranno anche sostenere le spese legali sostenute per il processo.
Sembra infatti che per constatare l’effettivo disagio creato dal gallo un ufficiale giudiziario si sia recato per 3 notti consecutive nei pressi dell’abitazione per verificare il reale disagio che ha detta dei vicini veniva a crearsi ogni mattina verso le 4.
Ma l’orario denunciato dai vicini non è risultato veritiero sembra infatti che il gallo non inizi a cantare alle 4 della mattina ma che canti “in modo intermittente” solo tra le 06:30 e le 07:00, a un volume “appena percettibile quindi non molto intenso” se si tiene la finestra chiusa.
In breve, i vicini, una coppia di agricoltori in pensione dell’Alta Vienne la cui casa di Oléron è la residenza per le vacanze estive, non hanno dimostrato la prova di un disagio effettivo, e secondo il giudice hanno persino “agito in modo abusivo” nel presentare una denuncia, soprattutto perché “non hanno davvero vagliato la possibilità di una soluzione amichevole”, ha dichiarato la corte.
Corinne Fesseau ha affermato:“Questa è una vittoria per tutte le persone nella mia stessa situazione . Spero che questo crei un precedente per loro”.
Meglio mantenerle, le promesse elettorali, a meno che non si voglia finire sbeffeggiati sui manifesti affissi dagli avversari politici che sono legittimati a dare del falso e del bugiardo a chi, dopo essere stato eletto, fa dietrofront sugli impegni presi davanti ai cittadini. La Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto di critica politica a un gruppo di consiglieri comunali dell’opposizione che avevano affisso lungo le vie cittadine di un centro del messinese, Furci Siculo, dei manifesti nei quali l’ex sindaco Bruno Antonio Parisi veniva definito «falso, bugiardo, ipocrita, malvagio» per aver deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione «così tradendo le promesse elettorali».
In primo grado, il Tribunale di Messina nel marzo 2014 aveva escluso l’esimente del diritto di critica politica, «viste le connotazioni personali delle ingiurie contenute nel testo dei manifesti» e aveva condannato i consiglieri di opposizione Sebastiano Foti, Carmelo Andronico, Beniamino Lo Giudice, Alessandro Niosi, Saverio Palato e Agatino Vinci. Su ricorso degli imputati, la Corte di Appello di Messina nel marzo 2016 li aveva invece assolti. Ora la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco Parisi per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione.
Ad avviso degli “ermellini”, il verdetto di assoluzione è corretto perchè è partito «dal presupposto incontestabile della offensività delle espressioni usate per riconoscere che gli epiteti rivolti alla parte offesa presentavano una stretta attinenza alle vicende che avevano visto l’opposizione contrapporsi al sindaco in merito alla erogazione di funzione, a cui il primo cittadino aveva dichiarato di voler rinunciare in campagna elettorale». «In questo ambito, gli epiteti `falso, bugiardo, ipocrita´ si ricollegano, secondo la Corte territoriale - prosegue la Cassazione - al mancato adempimento delle promesse elettorali nonchè all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione e, quanto all’aggettivo `malvagio´, ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici». Per la Suprema Corte, - sentenza 317 depositata oggi - «è apparso quindi chiaro ai giudici di merito che l’attacco al Parisi riguardava specificamente le scelte politiche ed amministrative sue e della sua maggioranza e, del tutto correttamente, si è escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale e intellettuale della persona offesa» come invece ha tentato di sostenere l’ex primo cittadino di Furci Siculo. "lastampa.it)
Anche l’ente pubblico risponde del danno cagionato al privato dal reato compiuto dal dipendente pubblico. E ciò anche se la condotta del agente ha una finalità soltanto personale se non egoistica, come appropriarsi del denaro del privato cui il funzionario ha accesso per lavoro. Sessioni unite civili della Cassazione, sentenza 13000246 del 16 maggio 2019.
La difesa in giudizio batte la privacy. E' legitimo registrare di nascosto le conversazioni tra i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura o imminente. Anzi costituisce l'esercizio di un diritto, a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità. Sentenza Cassazione n.12534 del 10 maggio 2019 sezione lavoro. Avanti con le registrazioni...
Stop della revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017, il provvedimento del fisco dev'essere specifico e puntuale e non può fare riferimento solo al rapporto fra il valore di mercato e quello catastale. Devono essereelencati gli elementi che hanno inciso sulla microzona. Corte di Cassazione orinanza n. 12604 del 10 maggio 2019
Compie reato il commercialista che dopo la revoca del mandato non restituisce la contabilità al cliente per nascondere le sue responsabilità dopo le cartelle esattoriali notificate al contribuente. E ciò perché con il passaggio delle consegne a un nuovo incaricato il collega si accorgerebbe che gli errori del predecessore hanno determinato la grave esposizione dell’assistito nei confronti del fisco. Il delitto ex articolo 646 Cp, infatti, scatta con l’inversione del possesso: risulta dunque sufficiente compiere un atto di dominio sulla cosa, anche se si rassicura il legittimo proprietario di volerla restituire. Sentenza 20231/19, pubblicata il 10 maggio dalla seconda sezione penale della Cassazione.
Dev'essere rinnovato il permesso di soggiorno allo straniero non convivente con il coniuge italiano perchè il requisito della convivenza non è indispensabile,a meno che non si contesti la fittizietà del matrimonio. Cassazione sentenza prima sezione civile del 18 aprile 2019 n.10925.
Le sentenze discordanti fanno scattare l'incertezza normativa che esonera il contribuente dalle sanzioni fiscali. La Corte di Cassazione in forza di tale principio ha acconto il ricorso proposto da una società che aveva impugnato una decisione sull'ici. In molte occasioni i Supremi giudici hanno escluso l'applicabilità delle sanzioni in caso di veri e propri contrasti giurisprudenziali o circolari ministeriali entrate in vigore troppo tardi o ancora in caso di provvedimenti poco chiari. In questa occasione gli Ermellini si spingono oltre ritenendo che la scriminante possa essere applicata anche in caso di sentenze discordanti. Si apre quindi un altro scenario pro-contribuente. Corte di Cassazione ordinanza n. 11084 del 19 aprile 2019.
La corte di Cassazione con sentenza numero 7044 del 12 marzo 2019 ha ritenuto sussistere il repporto di lavoro subordinato tra il giornalista e l'editore del quotidiano se il professionista si occupa di un settore specifico dalla sua zona di provenienza e sta a disposizione dei redattori. Ottiene l 'nquadramento da collaboratrice fissa la giornalista che ha seqguito per dieci anni cultura e spettacoli per conto del quotidiano dalla provincia con una media di tre quattro pezzi alla settimana.
Il ciclista caduto sulla crepa esistente sull'asfalto dev'essere risarcito. A pagare è l'ente proprietario della strada che come custode dell'infrastruttura non fornisce la prova del caso fortuito, mentre in base all'art 14 del cod. della strada l''emministrazione è tenuta alla manutenzione oltre che alla pulizia della carreggiata.Giudice di pace sentenza n,44/2019.
Ai fini dell'agevolazione IMU l'abitazione principale non è quella acquistata nel luogo dove si lavora ma è la dimora abituale di tutta la famiglia. E'onere del contribuente dimostrare che anche coniuge e figli vivono nella casa. Corte di Cassazione. ordinanza n.6634 del 7 marzo 2019.
La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.6500 del 6 marzo 2019 ha statuito che gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni per l'inesatto versamento dell'IMU da parte del De Cuis.
Il superiore Consesso ha accolto il ricorso dei figli del proprietario del terreno edificabile che ha pagato l'imposta come se il terreno fosse edificabile.
Corte Cassazione Sez. 3 del 5 marzo 2019 n.6326.
Il motociclista ha diritto al risarcimento dei danni a seguito della caduta avvenuta di notte sulla strada che lo conduce ogni giorno a casa e dovrebbe sapere che è coperta di ghiaia. La responsabilità da custodia del Comune è oggettiva e,spetta all'amministrazione offrire la prova liberatoria del fortuito, non potendosi rovesciare addosso al danneggiato l'onere di dimostrare l'insussistenza della colpa. non ha nessuna importanza che il centauro ben conosca il luogo dove si è infortunato se il giudice del merito non compie alcuno sforzo per verificare quanto ha fatto l'ente pubblico per rimuovere la sabbia dall'asfalto.
La prima sentenza di merito emessa sulle modifiche al testo unico sulla tutela Inail accende un faro sulle misure introdotte dal bilancio 2019 che riducono i risarcimenti a carico del datore negli incidenti sul lavoro oltre che i premi e contributi Inail a carico delle imprese. Infatti, la Finanziaria 2019 riduce i danni nei confronti del datore di lavoro se aumenta la sicurezza sul cantiere dopo il sinistro.
Con ordinanza n,6174 dell'1 marzo 2019 la Corte di Cassazione ha ritenuto che è legittimo il controllo dell'agenzia investigativa e non violano la privacy del dipendente solo se viene effettuato in luogo pubblico e riguardano fatti estranei alla prestazione lavorativa .La Corte di Cassazione con la predetta ordinanza ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa per essersi ripetutamente allontanato dal posto di lavoro durante l'orario di servizio senza timbrare il badge in uscita e facendo così risultare la regolare presenza in ufficio.
Gli eredi del dipendente vittima dell'amianto hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro nonostante gli importi erogati o erogabili dall'Inail dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 al testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per le malattie profesionali.Ciò perche la novella si applica al solo danno differenziale mentre i familiari del lavoratore morto di cancro devono essere ristorati per il danno alla salute da inabilità temporanea terminale, vale a dire voci non indennizzate dall'Istituto Previdenziale. Sentenza tribunale di Trieste n.26 del 25 febbraio 2019, giudice Silvia Burrelli, che costituisce la prima sentenza in materia dopo l'entrata in vigore della legge 145/18.
La Suprema corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n.6150 del 1° marzo 2019 ha statuito che in forza della legge 104/92 il lavoratore può ottenere il trasferimento alla sede più vicina al familiare disabile anche se non deve prestargli assistenza continua. Il merito deriva dal collegato lavoro che ha eliminato il requisito dell'esclusività: la tutela delle persone svantaggiate,costituisce un valore costituzionale e non si può limitare l'agevolazione alla scelta iniziale della sede di servizio. Motiva la cassazione che, l'esigenza di stare vicino al portatore di handicap può sorgere anche nel corso del rapporto di lavoro. Bocciare la domanda di trasferimento equivarrebbe ad andare contro le sentenze della Consulta. Dev'essere il datore di lavoro a provare che non ci sono posti disponibili nella sede richiesta.
L' imputato assolto a seguito della depenalizzazione del reato, deve pagare le spese del giudizio nonchè il risarcimento dei danni alla parte offesa dal reato.Secondo i giudici Ermellini la revoca delle statuizioni per la sopravvenuta abolitio criminis non può essere equiparata a soccombenza tecnica della persona offesa dal reato. Quinta sezione penale della Corte di Cassazione n.8536 del 27 febbraio 2019.
La morte del paziente appena visitato dalla guardia medica, gli eredi che vogliono il risarcimento danni devono dimostrare che l'omissione del medico è stata "più probabilmente che non la causa del decesso"; spetta poi all'azienda sanitaria provare che la morte sia sopraggiunta per una ragione imprevedibile e inevitabile. Ordinanza della Corte di Cassazione 5487/19 del 26 febbraio 2019 sezione terza.
Assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' stato assolto con tale formula l'imprenditore rinviato a giudizio per omesso versamento dell'IVA e delle ritenute d'acconto. Manca l'elemento soggettivo del reato. L'imputato ha fatto di tutto per salvare l'azienda familiare, tentando di rilanciare la rete di vendita con il suo patrimonio in quanto la banca non gli aveva concesso il muto. Così è prevalsa la tesi della difesa che ha pienamente provato che l'imputato non era riuscito ad assolvere il suo debito con il fisco per motivi non dipendenti dalla sua volontà. Così la prima sezione del Tribunale di Milano con sentenza n.9642/18, con sentenza passata in giudicato, giudice monocratico Flaviana Balloi ha assolto l'imputato con formula piena.



 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431