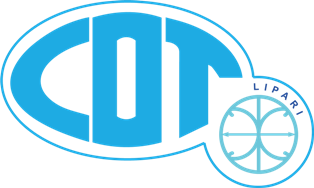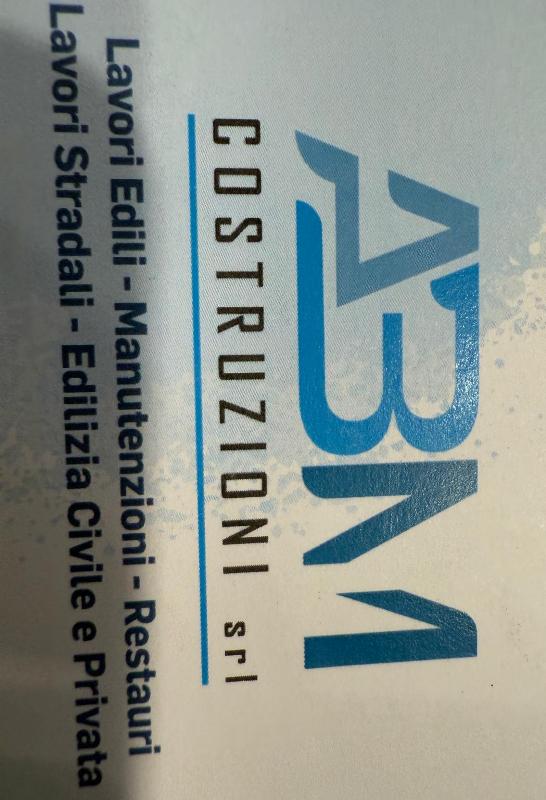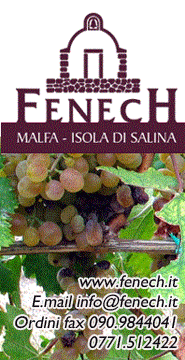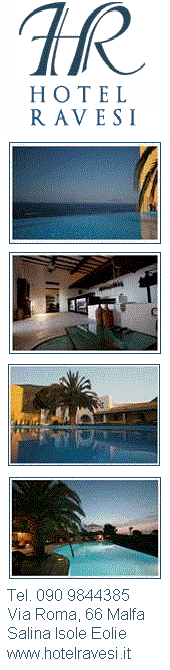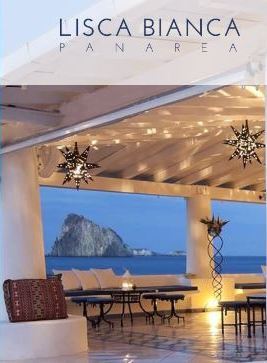di Michele Giacomantonio
di Michele GiacomantonioLa raccolta e lavorazione della pomice si riorganizza e industrializza
Verso l’industrializzazione della raccolta della pomice

Canneto ai primi dell'800
La pomice è stata la grande risorsa naturale che ha inciso nella storia dell'arcipelago soprattutto negli ultimi duecento anni[1]. A portarla agli onori delle cronache sono stati nell'800 due eventi: l'industrializzazione e la commercializzazione del prodotto che dimostrarono che questa pietra – dal punto di vista economico – non rappresentava solo una modesta integrazione per coloro che versavano in condizioni precarie ma poteva rappresentare una vera ricchezza per i privati e per le casse del comune; le nome che colpirono in particolare la chiesa liparese privandola di censi e di decime e la portarono a rivendicare i terreni demaniali per sopperire in qualche modo alle proprie esigenze.
Il primo accenno ad un commercio della pomice di Lipari è del 18 maggio 1276. Carlo d’Angiò autorizza il vescovo ad esportare e commerciare oltre allo zolfo ed all’allume anche la pomice (lapides”).Una chiesetta dedicata a San Cristoforo nasce a Canneto nel 1596 e secondo Iacolino questo è segno che la gente del luogo portava a spalla le ceste del pezzame. Sul finire del XVII secolo si dovettero avviare piccole attività di commercializzazione della pietra[2]e Dolomieu nel 1781 afferma che Lipari è “l’immenso magazzino che fornisce la pomice a tutta l’Europa” e sette anni dopo Spallanzani afferma che a Lipari “vengono bastimenti italiani, francesi e d’altre nazioni per caricare questa merce”[3].
La prima volta che si parla di concessione a proposito della pomice è nel 1813 quando Vito Nunziante chiede al governo borbonico delle terre demaniali ed il governo interpella il vescovo di Lipari perché specifichi, delle terre comunali, quali sono patrimoniali e quali demaniali. Il Nunziante torna alla carica l’8 maggio 1825 e il Decurionato municipale delibera di concedergli in esclusiva, per nove anni, di estrarre dai beni comunali “la materia vitrea” per impiantare una fabbrica di cristalli. Ma ancora una volta non si arrivò a nulla di concreto.
La prima volta che si pensa ad un dazio sulla pomice è il 29 aprile del 1835 e il Decurionato stabilisce che deve essere di grani 10 siciliani per ogni quintale di pietra pomice scavata. Le entrate previste sarebbero ammontate a 100 onze l’anno corrispondenti a circa 600 tonnellate di prodotto e dovevano servire per far fronte all’illuminazione notturna da organizzarsi nel Comune.[4]
La decisione del Comune si scontra prima con i privati che sono possessori dei terreno - o perché se ne sono appropriati e non intendono riconoscere la natura demaniale delle terre o perché li hanno ricevute in enfiteusi dal vescovo a cui pagano il censo – ma si scontra anche con la gente del popolo giacché le terre pomicifere erano considerate da sempre terre comuni, meta di cavatoli singoli e a gruppi, i quali prendevano ciò che potevano, alimentando, comunque, un discreto commercio di esportazione. Sistema che rimase in vigore per tutto l’800 e sino ai primi del 900. Infine si scontra anche col vescovo che si riteneva, fin dal tempo dei normanni, proprietario delle isole Eolie e quindi anche di questi terreni Così mons. Proto, fra il 1839 e il 1840, invia una “memoria” sulle decime all'Intendente magistrato aggiunto per protestare contro il sindaco Antonio Natoli ed alcuni possidenti liparesi che volevano sopprimere le decime sui prodotti della terra. Comunque il 24 giugno1855 il Comune di Lipari ottiene l’autorizzazione di imporre il dazio sulla pietra pomice all’imbarco grazie ad un “sovrano rescritto” e il 28 maggio del 1868 il Consiglio Comunale, su proposta dell’Amministrazione guidata dall’avv. Filippo Carnevale, approva il primo regolamento per il diritto di riscossione sulla pietra pomice che si estrae nelle cave di proprietà del Comune.




Il primo passo in questa direzione si All’inizio, lo sfruttamento delle terre pomicifere era a carattere artigianale e la pomice veniva acquistata in conto proprio dagli stessi capitani dei velieri che provvedevano poi a rivenderla[5] nei vari porti dell’Italia e della Francia, solo nel 1880 assumerà una fisionomia industriale.. ha quando giungono i rappresentanti di società straniere che prima si limitarono ad acquistare il prodotto, poi cominciarono a selezionarlo e lavorarlo nei mulini che fanno costruire a Lipari, Canneto, Porticello e ad Acquacalda.
Il precursore in questo campo è il francese monsieur Firmine Bacot de la Maison de commerce ‘Leonard Bacot’ specialiste en ponces chois, poudres, grain a Paris.[6]. Bacot il 2 settembre 1865 sposa a Pirrera Angelina Restuccia ed il 24 maggio 1867 rivolge una petizione al Sindaco per chiedere una porzione di demani comunali in contrada rocche Pirrera e la esenzione del dazio sulla polvere di pietra pomice che viene manufatta ed esportata all’estero. Il Consiglio Comunale respinge le due richieste . La prima perché i demani comunali o sono dati in enfiteusi o sono gravati da usi civici e quindi sono di libero accesso a tutti i cittadini e rappresentano una fonte di sostegno per numerose famiglie. La concessione quindi per molti liparesi rappresenterebbe un danno. Inoltre l’esenzione dal dazio danneggerebbe le entrate comunali.

La concessione in monopolio
E’ negli anni 80 che si pone il problema di affidare raccolta e commercializzazione della pomice ad un soggetto unico. Il 30 maggio del 1881 il Consiglio Comunale, sindaco Filippo De Pasquale, si riunisce per discutere una richiesta del signor Gabriele Barthe avanzata per mezzo della Prefettura. Si apre una lunga fase che si concluderà solo il 21 novembre del 1884 assegnando al richiedente “in locazione, a trattativa privata, per un ventennio, i demani comunali produttivi di pietra pomice”. In questi tre anni e mezzo che sono trascorsi dalla richiesta alla decisione del Consiglio verranno vagliati diversi problemi ed obiezioni e si dovrà tenere conto di richieste diverse da quella di Barthe.
La prima obiezione che viene avanzata – e che si dimostrerà fondata tanto da mettere in crisi il contratto stipulato – riguarda lo stato dei terreni demaniali molti dei quali sono stati usurpati. L’obiezione è avanzata dall’apposita commissione consigliare costituita per vagliare l’offerta di Barthe. Si propone di sospendere la decisione “fino a che i demani comunali usurpati e principalmente quelli a terreni bianchi dove si trovano le pomici non saranno reintegrati”.
Ma il richiedente torna alla carica visibilmente sostenuto dal Prefetto e così un paio di settimane dopo il Consiglio é richiamato a decidere. Questa volta il consesso si divide perché vi è chi teme il verificarsi di inconvenienti e giudica che sarebbe meglio andare avanti come si era fatto fino ad allora cioè dando in appalto la riscossione dei dazi e magari aumentandoli. Ma a maggioranza di sedici a dieci si decide di mettere all’asta la concessione. Problemi nascono però sulle condizioni del contratto. In particolare due. Il Barthe avrebbe voluto fare uso di mezzi meccanici e di macchinari, il Comune si oppose perché “andrebbe a nulla il lavoro di una gran quantità di gente addetta a questa lavorazione”e su questo punto il Comune la spunta. Non la spunta però su un’altra clausola che riguardava i mezzi autorizzati a eseguire il trasporto nei vari porti.
Il Comune avrebbe voluto che fossero solo i “bastimenti della marina mercantile di Lipari” ma la norma viene respinta dalla deputazione provinciale di Messina la quale non accetta neanche la successiva mediazione di allargare l’ambito dei bastimenti autorizzati a quelli dell’intero Comune e non della sola isola e di prendere in considerazione, per le eccedenze, i bastimenti di Salina e “poi quelli dell’intero compartimento marittimo di Messina”. Ma oltre le condizioni un altro problema riguarda il bando e la selezione dei concorrenti.
Barthe vorrebbe che si andasse a trattativa privata il Comune propende per la gara pubblica. Alla gara vengono presentate tre offerte .Oltre a Barthe vi è quella di Felice Neble e dei francesi Chamencin e compagni. Il Consiglio sceglie la terza offerta ma il Prefetto annulla la decisione. Probabilmente aveva raccolto la protesta di Barthe che lamentava che la sua offerta fosse stata resa pubblica.
Le trattative riprendono ai primi di marzo del 1884 e questa volta le proposte sono solo due: quella di Barthe e quella della Banca Siciliana di Messina. Si procede a trattativa privata ma il 18 luglio la Banca dichiara di non potere accettare tutte le modifiche fatte alle sue condizioni ed stava per avanzare una nuova proposta. Ma il consiglio a maggioranza di otto a sei, di fatto, chiuse la trattativa con la Banca Siciliana ed il 20 novembre tornò a riunirsi per approvare la concessione a Gabriele Barthe.
Il Comune con questo contratto si proponeva due obiettivi: garantire al comune entrate daziari costanti e consistenti; reintegrare con procedura indiretta il demanio pomicifero[7].
I diritti del Comune sulla pomice e quelli del Vescovo
Ma quello che alcuni temevano si verifica. Barthe constata che non può entrare in possesso di estese porzioni delle terre pomicifere. E così appena sei mesi dopo la firma del contratto ne denuncia l’impraticabilità. E proprio perché il Comune non riesce a provare la asserita demanialità, dopo due sentenze favorevoli del Tribunale, Barthe ottiene il 31 luglio del 1885 la risoluzione del contratto per via giudiziaria. Comunque il contenzioso fra Barthe e il Comune, per il pagamento dei danni e gli interessi, si trascinerà sino all’aprile del 1898 quando la causa si conclude in modo favorevole per il Comune.
Intanto il 12 febbraio del 1884 la Giunta municipale approva un nuovo “regolamento per la riscossione del diritto di percezione sulla pietra pomice che si estrae dalle cave dei demani comunali” dopo quello del 1868. L’efficacia del rescritto sovrano del 1855, confermata dai regolamenti, continuò ininterrottamente e senza opposizione da parte dell’Autorità Tutoria fino a tutto il 1887, cioè sino al momento in cui il Comune diede in locazione alla “Eolia” i propri demani pomiciferi.
Due anni dopo il fallimento dell’esperienza Barthe e dopo due aste pubbliche andate deserte l’1 maggio 1886 giunse al Comune la richiesta del signor Giuseppe Lanzi di concessione procedendo a trattativa privata. Il Consiglio comunale cominciò a discutere del nuovo contratto mentre, strada facendo si viene precisando la fisionomia del nuovo richiedente. Il 5 maggio 1887 il sindaco Ferdinando Pajno informa che il Lanzi aveva agito in nome e per mandato del sig. Giovanni Rodriquez fu Leopoldo; il medesimo giorno della sottoscrizione del contratto di locazione, e cioè il 25 gennaio 1888, si costituisce la “Società Eolia” in nome e por conto della quale ha agito il Rodriquez.
Il nuovo contratto[8] concede in locazione, per due anni con possibilità di rinnovi biennali fino al termine massimo del 1905, con un canone annuo di lire 92 mila e cauzione di lire 85 mila, tutti i terreni demaniali produttivi di pietra pomice che il municipio possiede e di cui è in godimento – che vengono elencati con nome delle contrade in cui si trovano - col diritto di scavare nelle cave esistenti ed in altre che vorrà aprire senza limitazione alcuna. Il Comune ed i residenti possono fare uso della qualità detta “alessandrina”, del lapillo e della “stacquatura”, che si trova sulle spiagge, ed anche dei bastardoni purché questo materiale venga adoperato esclusivamente nei fabbricati del territorio comunale.
L’art. 3 del contratto precisa, come era stato fatto anche nel contratto con Barthe, che la concessione riguarda il sottosuolo e non la superficie che rimane nella disponibilità del Comune e che può concedere in enfiteusi. All’art. 8 si chiarisce che “ il concessionario non potrà adibire per l’escavazione della pietra pomice che solo lavoratori ed operai del Comune di Lipari escluso ogni mezzo meccanico di macchine” . I lavoratori ammessi allo scavo della pomice dovranno essere in possesso di un permesso scritto rilasciato dal Comune e dovranno cedere al concessionario tutte le qualità di pomice che scavano. Gli operai non possono scavare più di 50 mila quintali all’anno di pomice salvo che non sia il concessionario a farne richiesta. L’eventuale eccedenza verrà conteggiata nella quota dell’anno successivo.
Questi i passaggi che ci sembrano più significati. Rimane il fatto della generica indicazione dei terreni demaniali e questa sarà ancora una volta fonte di contrasto e causa del fallimento anche di questa esperienza.
Inoltre i lavoratori erano privi di un contratto collettivo di lavoro e ricevevano una retribuzione molto bassa[9]. Ed è anche per questo che fin dall’inizio molti di essi rifiutano di munirsi del permesso di lavoro continuando a scavare per loro conto e vendendola a commercianti-mediatori che esistevano malgrado il monopolio concesso all’Eolia. Infatti, oltre ai lavoratori, l’altra categoria che veniva colpita dal contratto monopolistico erano i commercianti ed i mediatori di pomice che dovevano ridurre il loro giro d’affari perché l’Eolia trattava direttamente con gli importatori nazionali ed esteri[10]. Quindi erano diversi gli eoliani che non erano soddisfatti da questa soluzione e infatti diversi cittadini faranno ricorso contro il contratto patrocinati, per lo più, dall’avv. Antonino Natoli La Rosa, fratello del vescovo Natoli[11].
E fu proprio respingendo uno di questi ricorsi che il Consiglio di Stato diede parere favorevole circa la validità del Decreto reale del 5 gennaio 1889 con cui si riconosce al Comune il diritto di concedere in locazione le terre pomifere demaniali.
La gestione della società Eolia
I primi due anni di attività dell’Eolia, dal 1888 al 1890, furono positivi e le sue azioni inizialmente quotate a 250 lire ciascuna passarono a 450 e si vendettero non solo in Italia ma fino a New York. Poi cominciarono i contrasti perché la società tardava a pagare le quote dell’affitto alla scadenza continuando a evidenziare il fatto che non solo continuava l’escavazione abusiva di molti lavoratori in barba al monopolio ma che non sempre, si riusciva a fare valere, nei confronti di questi il contratto sottoscritto soprattutto per l’incertezza dei confini demaniali. Il primo scontro arriva il 25 maggio 1890 con il rifiuto della società di pagare la rata bimestrale ma, il 3 settembre la giunta ed il 10 il Consiglio, approvano un atto di transazione nel quale si decide di consegnare i terreni liberi demaniali incolti ( con qualche incertezza nei confini), i terreni demaniali che erano usurpati ma per i quali ormai vi erano i verbali di conciliazione approvati dal regio commissario e l’impegno di consegnare gli altri terreni demaniali, già usurpati, per i quali vi erano i verbali di conciliazione ma non ancora la firma del commissario.
Il fatto nuovo che dovette spingere l’Eolia alla transazione fu questo procedimento in corso che portava ad accertare il demanio comunale togliendo alibi agli abusivi.
Ma le controversie con gli operai continuavano ed il Pretore non sempre, in base ai documenti esistenti, riusciva a fare chiarezza. L’Eolia riprese così a protestare col Sindaco con due lettere del marzo 1891 e poco dopo sospese il pagamento del bimestre. Questa volta non c’era materia per nessuna transazione e si andò verso la risoluzione del contratto che venne dichiarato dalla Corte d’Appello con sentenza del 22-29 dicembre 1892. La sua vita era stata di appena quattro anni.
Chiuso il contratto con la Eolia il Comune rientra nel possesso dei giacimenti ed affida l’estrazione della pomice agli operai residenti pagandoli due lire per ogni quintale, affidandoli al controllo di nove vigili e di un capoguardia[12].
La vicenda ha uno strascico in relazione allo svincolo della cauzione che l’Eolia aveva prestato al Comune. Sul finire del 1899 questa non era stata riscossa e in Consiglio comunale ci si interroga sui motivi. Nella seduta consiliare del 12 gennaio 1900 il consigliere Giovanni Caserta, appartenente all’opposizione, lancia l’accusa: la ragione sta nell’esistenza di un forte conflitto d’interessi giacché facevano parte della società Eolia, De Pasquale e Giuseppe La Rosa eredi a titolo universale dello zio avv. Rosario Rodriquez ed allo stesso tempo amministratori comunali e consiglieri comunali. Per questo l’amministrazione non si era costituita.
Comunque la lunga diatriba col curatore fallimentare dell’Eolia si concluderà nel 1903 e nell’agosto di quell’anno il Consiglio Comunale approva la ripartizione della cauzione dell’Eolia destinandola oltre a coprire il deficit del bilancio del 1903 e al pagamento degli onorari degli avvocati, al finanziamento di due opere pubbliche:il completamento del palazzo degli Uffici e la costruzione di serbatoi di acqua potabile.
Intanto un'altra richiesta di concessione in monopolio avanzata dai signori Pietro Scouffos, console greco in Messina, Francesco M. Navone, vice console francese in Messina e avv. Edmondo Catania di Messina, arriva in Consiglio comunale il 14 luglio 1893. Di essa se ne discute per circa un anno ma non arrivò a formalizzarsi. E’ interessante notare che una parte significativa della discussione riguardò, dopo i fallimenti di Barthe e dell’Eolia, i terreni che potevano essere dati in concessione. L’avv. Emanuele Carnevale, intervenendo su questo tema sostenne che “la locazione dei demani comunali pomiciferi di Lipari, abbia a procedere per i terreni incolti, che sono stati sempre nel libero posseso del Comune, e per la consegna dei quali avvi il verbale relativo redatto dall’ing. Placido Catania ed inseriti nel contratto di transazione fatto tra il Comune e la società “L’Eolia” presso il notar Faraci in data del 3 settembre 1890, e per i terreni già regolarmente e definitivamente reintegrati. Per determinare questi con precisione, egli dice che occorre di attenersi strettamente all’ordinanza emessa dal signor Prefetto, quale commissario per gli affari demaniali, in data del 19 giugno 1891, ed a tutti gli atti di reintegra, in base e in virtù dei quali nessuna contestazione esiste e potrà esistere intorno al godimento dei terreni reintegrati, tra i quali bisogna includere quelli per cui seguirono le conciliazioni, con i patti e le obbligazioni ivi ammesse, e che riportarono l’approvazione dell’Autorità amministrativa e la sanzione sovrana”.
La richiesta di Haan
Non migliore esito avrà la richiesta di Theodor Haan di Dresda del 5 aprile 1903 che chiede anch’esso il diritto di escavazione in monopolio per vent’anni sui terreni del demanio comunale. La richiesta si arena quando il consigliere Giovanni Caserta pubblica su “La Sentinella “ di Messina un ampio dossier contro questo progetto supportato da una lettera che lo stesso Teodoro Haan scrive a possibili soci cofinanziatori affermando che l’affare che viene a proporre “ avrà un profitto netto del 20 per cento” e questo attraverso una forte riduzione delle spese di trasporto e di imballaggio che saranno svolte direttamente e non più attraverso intermediari locali. Aggiunge che è ormai “ proprietario di tutte le miniere, incluse quelle del Comune di Lipari, legatosi con un contratto, per 20 anni, per consegnare a me l’intero prodotto delle sue miniere”. E vanta il sicuro consenso del Comune – malgrado ancora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione – grazie all’assistenza” di quattro persone interamente padrone della situazione e di procuratori degni di fiducia da cui ho avuto i documenti”.


Canneto, in alto gli uffici della ditta Haan, qui sopra quelli della ditta Rhodes
L’informazione suscita clamore e più delle pagine e pagine del Caserta sono le righe di Haan a tacitare ogni voce di consenso dell’iniziativa, soprattutto in Consiglio comunale. Nessuno infatti vuole essere accusato di essere una di quelle “quattro o cinque persone interamente padrone della situazione”. Inoltre la lettera faceva intendere che i danneggiati non sarebbero stati solo gli operai cavaioli ma anche i bottai che costruiscono casse e barili e gli armatori dei vaporetti che fino ad allora avevano trasportato la pomice . Questi ultimi, visto la crisi dei prodotti della vite per via della fillossera, facevano ormai affidamento soprattutto sul trasporto della pomice. Anzi era stato grazie a questa prospettiva che diversi armatori liparesi, a cominciare dal comandante Francesco La Cava, avevano potuto riconvertire il loro naviglio passando appunto dalla vela al vapore.[13]
Haan e compagni continuarono la loro attività di industriali pomiciferi sfruttando solo le aree private che avevano già acquisito. E gli affari prosperarono tanto che nel 1909 presero in affitto un mulino per 12 anni. All’inizio del conflitto fu fatto un inventario dell’azienda è risultò una consistenza attiva di oltre 415 mila lire. Nell’aprile del 1915, col precipitare delle relazioni dell’Italia con l’impero austro germanico, Haan chiuse la lavorazione e licenziò il personale. La gestione dell’azienda venne assunta dal procuratore Filippo De Pasquale. La ditta Haan continuò i rapporti con Lipari come distributrice della pomice in Germania, almeno sino agli anni ’70[14].
[1] I riferimenti per questo capitolo sono tratti – quando non riferito diversamente - da G.Iacolino, indedito cit., quaderni X e XI; G. Arena, L’economia delle isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina 1982; M.Saija, La seconda controversia liparitana, in “Dal ‘constitutum’ alle ‘controversie liparitane’, Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano,n.2, Messina 1998; G. La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dagli albori alle concessioni monopolistiche, Milazzo 2002; G.La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dalla controversia con il vescovo Natoli all’avvio della legge sulla pomice, Lipari 2008; G. La Greca, La storia della pomice di Lipari. Volume III. Dal tentativo Haan alla legge del 1908, Lipari 2009.
[2] G.Iacolino, nota n. 32 a P.Campis, op.cit., pag. 465.
[3] G.La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dagli albori alle concessioni monopolistiche, Milazzo 2003, pag.34.D.du Dolomieu, Viaggio alle Isole Lipari, Edizioni del Centro Studi Eoliano; L.Spallanzani, Destinazione Eolie (1788), Lipari 1993.
[4] G. Arena, op.cit., pag. 47.
[5] Ancora nel 1958 qualche anziano di Canneto ricordava questa prassi che comunque dovette andare avanti, parallelamente, anche quando l’attività fu industrializzata.
[6] A.Natoli La Rosa, Prospetto descrittivo delle Isole Eolie, Palermo 1900, p.3. anche G.Arena , op.cit., pp 47-50.
[7] G.Arena, op. cit. pag. 47.
[8] Il test del contratto come i riferimenti ai Consigli comunali in G. La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dagli albori alle concessioni monopolistiche, op.cit. pp.124-125.
[9] Lire 1 a quintale per pomici frantumi e lire 9 per le pomici grosse.
[10] G.Arena, op. cit., pag. 48.
[11] A.Natoli La Rosa, Studii Politico-sociali”, op. cit.
[12] L.S. d’ Austria, Le Isole Lipari, Volume VIII. Parte Generale. Praga 1894.
[13] M. Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit., pag.180.
[14] G. La Greca, La storia della pomice di Lipari, Vol.III. Dal tentativo Haan alla legge del 1908, Lipari 2009, pp.43-60.
La belle epoque eoliana
Le serate pubbliche e...

Via Garibaldi era sul finire dell'800 la strada principale di Lipari ed era lì, all'altezza del Municipio che si teneveano le serate di musica
“Belle époque” fu chiamata, a partire da Parigi, quella stagione un po’ spensierata e di grande fiducia nel progresso che caratterizzò l’ultima fase dell’800 ed i primi anni del ‘900 sino alla prima guerra mondiale. In qualche modo anche Lipari ebbe la sua “belle epoque”. Il simbolo di questa stagione è il maestro Concetto Abate[1] che portò il corpo bandistico di Lipari ad un buon livello di qualificazione. Il maestro , nella stagione primaverile ed estiva, nelle sere di sabato e di domenica, teneva in via Garibaldi, là dove la strada si allarga formando come una piazzuola, dei concerti pubblici che erano molto seguiti ed applauditi. Non c’era palco ma solo una pedana per il maestro e, al di sopra del corpo bandistico, veniva montata, grazie alla competenza di Giuseppe Rodà, stagnino, una illuminazione primordiale fatta di tubi, dentro i quali scorreva l’acetilene, e di coppe di vetro che lasciavano trasparire le fiammelle. Altri lumi erano fissati sulle porte dei negozi e degli esercizi pubblici di via Garibaldi da Marina S. Giovanni alla Civita facendo di questa via il primo salotto di una Lipari che si lasciava alle spalle gli anni della povertà e della fame e voleva credere in una nuova epoca di benessere. Mentre la banda suonava, la gente stava seduta sulle sedie che si portava da casa o passeggiava fermandosi nei diversi locali a consumare. Ed in via Garibaldi c’erano allora la trattoria di Corsini, il ristorante “Due colonne “ di don Vittorio Paino, la trattoria di don Peppinello Zuccaro ; le putìe – che qualcuno cominciava a chiamare bar, all’inglese o anche caffè – di don Pasquale Pagano, di don Peppino Cappadona soprannominato Sabina, di don Filippo Maggiore e lo spaccio di gassose con annessa sala di bigliardo del fratello don Fedinando che aveva fama di poeta. A poche decina di metri, su via Vittorio Emanuele vi erano le caffetterie di don Francesco Orioles e di don Giuseppe Cusolito. Nelle putìe o bar o caffetterie si servivano dolci e gelati.
...le serate private

Il maestro don Giovanni Acunto suonava il piano
Ma oltre alle serate pubbliche vi erano le private, nelle famiglie o nei circoli, come quelle che organizzava don Giovanni Maria Bartolomeo de Ficarra quando riuniva gli amici, approfittando della venuta a Lipari della sorella, la baronessa Lidia sposata Satriani che era cantante lirica a Roma e accondiscendeva ad esibirsi, pressata dal fratello, in serate familiari accompagnata al piano dal giovane maestro don Giovanni Acunto che si era diplomato in pianoforte. In quelle serate anche don Giovanni non disdegnava di esibirsi cantando una romanza in voga o anche qualche canzone d’amore che lui stesso componeva e che nelle notti di luna, indirizzava alle belle ragazze liparesi sotto i loro balconi. E non era il solo don Giovanni perché quello fu il tempo in cui fiorirono le serenate ed i cantanti. Era però quello più in vista e di cui più si parlava tanto che don Giovanni Maggiore gli dedicò – sotto il titolo “A Giovanni Maria de Ficarra dei Baroni di Cianciania e Taviani, drammaturgo insigne” - questi versi ironici:
“O fortunata Lipari,/ che desti a Lui i natali,/vanne orgogliosa! osservalo:/siede fra gli immortali.”
“E dal Parnaso il cantico/ di melodiosi accenti,/segue a salir per l’etere,/ peri vasti firmamenti”.
Dedito alla poesia piuttosto che alla canzonettistica era appunto don Giovanni Maggiore che era stato ufficiale dell’esercito nell’Italia del nord e rientrato a Lipari partecipava al cenacolo dei socialisti dove si discuteva anche della poesia di Pascoli, di Ada Negri, degli Scapigliati e dove il Maggiore leggeva agli amici anche quelle che lui componeva e che aveva pubblicate in un libretto dal titolo “Versi”. In queste composizioni traspariva, anche se con immagini ingenue, la sua passione politica, come in quella intitolata “Momenti:
“O voi, ricchi signori, che gettate/ tant’oro in feste e pranzi, ricordate/
Che lacero disteso in sul letame/ il povero marcisce e muor di fame”.
Oppure la scanzonata allegria della “Dichiarazione”:
“Signorina, mi slancio, mi slancio ad ogni costo
Non posso più resistere, non so più stare a posto…
Io v’amo alla follia, v’amo perdutamente
Talché, se ricusate, mi coglie un accidente.
Pensate che il rimorso d’avermi sotterrato
Vi brucerà poi l’anima come un ferro infocato”.
[1] Concetto Abate (1865-1938) era nato a Piazza Armerina ed aveva cominciato una bella carriera come professore di violincello al Teatro Massimo di Palermo. Improvvisamente all'età di 30 anni decise di stabilirsi a Lipari. Il maestro ben volentieri – annota Giuseppe Iacolino, da cui abbiamo tratto queste informazioni ( in Inediti, doc. cit. ,Quaderno X) – si prestava a preparare e a dirigere il coro e l'orchestra per le liturgie solenni che si svolgevano in cattedrale. Dei testi musicali, che scrisse ed arrangiò, si conserva appena qualche foglio, giacché nulla egli pubblicò all'infuori di un ridottissimo manualetto di “Elementi di musica” di trentadue pagine, uscito per i tipi di Pasquale Conti nel 1900, ed uno studio critico di “Falstaff” di pagine 78 edito dallo stesso Conti nel 1907. Cf. anche Renato de Pasquale, Momenti. Riflessioni e ricordi, Lipari, 1993, pag.69
don Giovanni de Ficarra
Eolie: qualche progresso in un quadro di arretratezze
Migliorano i collegamenti marittimi

Dopo il 1860, grazie anche all’avvento del Regno d’Italia, la situazione delle opere pubbliche va migliorando anche se si rimane lontani da una concezione moderna di servizi ed infrastrutture. Ancora nel 1890 a Lipari il mezzo di trasporto più usato era l’asino. Non esistevano strade carrozzabili ma solo sentieri impervi, mulattiere mal tenute e alvei abbandonati. Le strade rotabili per Canneto e Pianoconte si fecero solo negli anni fra il 1920 ed il 1930. Il prolungamento per Quattropani nell’immediato dopoguerra[1].
 Nel 1867 si inaugura il Cimitero di Lipari mentre nelle isole minori e nelle contrade della stessa Lipari si continuò, fin quasi agli anni venti del XX secolo, a seppellire i cadaveri nelle fosse comuni delle chiese – fosse strapiene – “pigiando con pali o coi piedi” i cadaveri di vecchia data per fare spazio ai nuovi.
Nel 1867 si inaugura il Cimitero di Lipari mentre nelle isole minori e nelle contrade della stessa Lipari si continuò, fin quasi agli anni venti del XX secolo, a seppellire i cadaveri nelle fosse comuni delle chiese – fosse strapiene – “pigiando con pali o coi piedi” i cadaveri di vecchia data per fare spazio ai nuovi.
Anche i collegamenti marittimi postali tra Lipari e Milazzo e le altre isole andarono, sul finire del secolo, assumendo una regolarità un po’ più… moderna. Alla compagnia Florio che già effettuava due scali settimanali a Lipari, inseriti nella linea Messina- Palermo, subentrarono verso il 1880 le Società Riunite che effettuava una linea esasettimanale fra Milazzo e Lipari con proseguimento quadrisettimanale sino a S. Marina e a turni alterni, Rinella e Malfa. Le isole di Panarea e Stromboli venivano raggiunte ogni 15 giorni, mentre la linea Filicudi e Alicudi era servita, almeno una volta la settimana, da natanti di un armatore liparese, il comandante Francesco La Cava che farà agio su questa commessa per consolidare un ruolo preminente nei traffici dell’arcipelago.
Sul finire degli anni 80 il governo sembra voler ridimensionare i grandi monopoli della navigazione, lasciando alle compagnie nazionali i tragitti di lunga gittata e le rotte oceaniche e affidando a compagnie regionali le tratte a percorrenza locale. Ed è in questa prospettiva che nelle Eolie maturano due progetti. Quello di La Cava che cerca di compiere un salto di qualità nella sua organizzazione e la nascita della società anonima “La navigazione Eolica” promossa dall’avv. Ernesto Tripi che raccoglie la maggior parte degli armatori salinari che erano rimasti spiazzati dall’introduzione dei navigli a vapore e vedevano gran parte delle loro commesse passare alla compagnia La Cava.[2] Ma verso questo obiettivo si muove anche una società messinese che riesce a disporre di una flotta di moderni piroscafi ed anche probabilmente di maggiori appoggi politici degli eoliani, per cui si aggiudica la gara.
Nel novembre del 1893 si ha così la grande svolta nei collegamenti dell’arcipelago con il passaggio della concessione governativa alla “Società Siciliana di navigazione a vapore” con sede a Messina. Fu allora che si ebbe il servizio giornaliero Milazzo – Lipari - S. Marina con prosecuzione a giorni alterni per Rinella e Malfa. E uno scalo di ritorno a Lipari e quindi partenza per Milazzo per giungere in coincidenza con il treno per Messina. Si istituì pure una corsa bisettimanale Messina - Lipari - S. Marina, continuata una volta sino a Stromboli e un’altra sino a Filicudi e Alicudi. In Sicilia era già attiva, sin dal 1892 la linea ferrata Messina-Palermo.
La comodità del vaporetto di linea regolare diede ai giovani liparesi delle famiglie borghesi la possibilità di andare a frequentare le scuole superiori e l’università a Messina e di lavorare in diverse città della provincia. Le Eolie finivano di essere remote e anche i forestieri cominciarono a giungere alle isole più frequentemente.

Lo scalo ordinario a Lipari si faceva al largo della Marina San Giovanni e i passeggeri venivano trasbordati con barche che facevano la spola tra la vecchia banchina del Purgatorio e le navi in arrivo. Capolinea per le rotte delle isole minori, invece, era lo specchio d’acqua antistante Sottomonastero, dove c’era un ridottissimo banchinato. Le barche del rollo salpavano a spinta strisciando le carene sulle falanghe e sui ciottoli della battigia[3]. .
Si illuminano le vie cittadine
Le vie della città – osserva Luigi Salvatore d’Austria intorno al 1880 - sono acciottolate e rifinite con lunghi quadroni al centro ed altri più piccoli e trasversali ai lati. Per lo più tortuose, esse sono talmente strette che è possibile “lambire la casa dirimpetto, tendendo una mano dall’altra”.Alcune delle numerose case di Lipari sono imponenti e di recente costruzione, altre vetuste e appena restaurate. Esse hanno quasi tutte, tetti piani a terrazza. I vicoli – dove si raccolgono i rifiuti di case che non hanno fognature - sono scarsamente animati, ma non mancano gli asini che scalpitano numerosi fin dalle prime ore del mattino. Sulla pubblica via sono esposti i banchi dei macellai sui quali si è soliti sgozzare i montoni che si vendono poi scuoiati e tagliati a pezzi[4].
Le vie cittadine, dopo la metà del secolo, di notte, avevano ottenuto la tanto attesa illuminazione ma perché il materiale adoperato non aveva resistito alle intemperie e perché si era venuti nella necessità di risparmiare l’olio, il suo funzionamento non era durato molto a lungo. L’11 ottobre 1860 il consiglio civico – riunito su ordine del comandante del distaccamento dei carabinieri - viene convocato con questo punto al primo posto dell’ordine del giorno: l’illuminazione notturna. Naturalmente – secondo criteri di rigida economia – per cui nelle notti senza luna mentre“ per cinque notti al mese, e propriamente quando accorre la luna, proibire di accendersi” e la durata del lume doveva durare sino a due ore prima dell’aurora. Nella stessa seduta si costituisce una commissione per verificare l’esigenza di nuovi punti luminosi nella cittadina e tre anni dopo, nel consiglio comunale del 24 novembre 1863, viene deciso l’impianto di tre nuovi fanali: uno nella strada Santa Lucia, uno nella strada Lena[5], ed uno nella strada di San Pietro.

Il faro di Vulcano Gelso disegnato dall'Arciduca
Mentre si parlava di un nuovo faro a Gelso di Vulcano in sostituzione di quello borbonico che si trovava sulla vicina altura del Rosario che verrà inaugurato l’1 maggio del 1887, a Pignataro di Lipari nel 1866 si diventa operativi e si chiede al vescovo la seicentesca chiesetta di S. Giacomo perché proprio lì è stata studiata la sua collocazione[6]. Fra il 1890 ed il 1894 si avviano i lavori per il faro di Strombolicchio. Si realizza, a colpi di mine, una piattaforma ed una scalinata ripida. Ma il faro giungerà solo intorno al 1925.
La prima volta che si parla di installare a Lipari un telegrafo elettrico “gettandosi un filo sottomarino per così mettere in comunicazione quest’Isola con la vicina Sicilia” è nel consiglio comunale del 24 maggio 1867 . Esso giungerà intorno al 1876 mentre nel 1882 si aveva il collegamento telegrafico Lipari-Salina[7].

Nel Consiglio comunale del 6 aprile 1866 si approva la proposta del Sindaco Paolo Florio Paino di acquistare un orologio da torre con due campane da fissare in cima al Municipio. Si acquisterà dalla Sommaruga di Milano e verrà inaugurato intorno al 1870. Resterà lì sino al 1926 quando verrà trasferito sul campanile della Cattedrale.
[1] Per il problema viario vedi in particolare il recente libro di Giuseppe Iacolino, Strade che vai, memorie che trovi, a cura del Rotary Club Lipari, 2008
[2] M.Saija e A. Cervellera, Mercanti di Mare, op. cit., pag. 82-83.
[3] Giuseppe Iacolino, inedito Quaderno X.
[4] Le isole Lipari – Terzo volume LIPARI a cura di Pino Paino, Lipari 1982.
[5] Via Lena era una prosecuzione di vico a Sena e quindi la parte inferiore dell’attuale via Vittorio Emanuele fra vico Eolo e sopra il piano ed era divisa dal torrente Cappuccini che allora scendeva dalle attuali via Ausonia e via Ten. Mariano Amendola..
[6] Archivio Vescovile, Corispondenza Carp. H, in un volume manoscritto al n. 60.
[7] Il cavo sottomarino era stato collocato dalla The Eastern Telegraph e giungeva ad un “casotto” realizzato ad Acquacalda in contrada Cala della Sciabica (Archivio Comune, Atti del Consiglio del 26 gennaio 1906.
Il faro di Gelso
Il Comune a rischio di collasso. Poi ripresa e rilancio
Un Comune al collasso

Case di pescatori a Marina lunga
Quando il cavaliere Ferlice Ferlazzo viene eletto Sindaco il 23 dicembre 1919 sa che ha di fronte a se un compito difficile: rimettere la macchina amministrativa in grado di funzionare in nove mesi, quanti ne restano per le elezioni amministrative.
“L’immane guerra con la rovina della finanza nazionale – dirà nel suo discorso programmatico - non ha risparmiato quella del nostro Comune e mentre prima florida dava ragione a ben sperare in una sollecita risoluzione dei diversi problemi cittadini, ora, dissestata come si è ridotta, fa tremare le vene dei polsi anche ai maggiori e provetti regitori, fa far disperare del domani. Prima della guerra eravamo riusciti ad accantonare parecchie centinaia di migliaia di lire per le opere pubbliche all’inizio delle quali con amorevoli e sollecite cure si era accinta la nostra precedente Amministrazione ma poi i mancati incassi della Tassa pomicifera determinati dal sempre diminuirsi delle esportazioni per effetto dello stato di guerra e l’accrescere degli oneri dovuti ai provvedimenti governativi per effetto della guerra stessa, aumenti di spese per rincari di materiali e di manodopera, creazione di nuovi uffici, caro vivere ed aumento di stipendi agli impiegati, ecc. dettero fondo alle economie accantonate, creando man mano il deficit per cui adesso la finanza comune è estremamente critica. La brevità data alla mia amministrazione non mi dà il tempo di espletare un programma qualsiasi e potrei essere dispensato dal fare una esposizione anche minima.”[1]
Ancora più preciso sarà il 14 aprile 1923 quando ricostruisce la vicenda degli sforzi fatti per uscire dalla crisi rispondendo all’inchiesta del Commissario prefettizio Cav. Francesco Bua.
“La guerra aveva inabissato la finanza comunale – spiegherà in una relazione che più che ai consiglieri è rivolta al Prefetto e al Governo - poiché l’unica tassa di entità, sulla quale poggiava tutto il bilancio del Comune, quella della pomice, da oltre 300 mila lire annue che era prima della guerra, si era ridotta a circa 80 mila lire, mentre le spese del Comune si erano triplicate ed anche quadruplicate. Né d’altra parte era stato possibile fronteggiare il forte deficit che man mano si era andato formando, con altre tasse locali , poiché la popolazione priva di ogni risorsa resisteva tenacemente con minaccia grave dell’ordine pubblico. Per le dimissioni del Sindaco il Prefetto affidò l’amministrazione del Comune ad un Commissario prefettizio nella persona dell’avv. Cincotta che nell’agosto venne sostituito dall’avv. Stagni Attilio, Commissario di Pubblica Sicurezza. Egli tenne l’amministrazione fino ai primi del 1920. L’Amministrazione dei due commissari prefettizi, succeduti al Sindaco Paino, non migliorò la situazione del Comune, né essi pensarono un sol momento, ad imporre le tasse, nemmeno tentarono di riscuotere quella sui cani, che pure era stata imposta dall’Amministrazione Paino, e ciò perché era grande la preoccupazione d’insurrezione della popolazione e di turbare l’ordine pubblico. D’altra parte non studiarono, né escogitarono alcun mezzo per poter fronteggiare la incombente situazione finanziaria che si avviava sempre più a gran passi verso la rovina. I pagamenti non si facevano più e i debiti del Comune si accumulavano spaventosamente, si era dunque in procinto di un vero e proprio stato di fallimento. E con gli altri numerosi creditori non si pagavano i debiti verso i medici condotti e la Cassa Provinciale per contributi scolastici[2]”.
Risanare il comune senza aumentare le tasse
Il motivo ridondante è che bisogna risanare il Comune senza aumentare le tasse. Lo dice Ferlazzo nel discorso del 23 dicembre 1919 e lo ripete con forza il 14 aprile 1923. Anzi nel 1923 c’è una motivazione in più, “il bolscevismo”. L’arrivo del fascismo aveva introdotto nel linguaggio abituale nuovi termini e nuovi nemici.
Le tasse non si potevano e non si possono aumentare per ragioni “di ordine pubblico, specie in quel tempo in cui il bolscevismo inquinava ed ammalava lo spirito Nazionale,”e più sommessamente si aggiunge “le quali del resto, in qualunque misura applicate, non potevano risolvere la situazione”.
“La disastrosa e allarmante situazione – incalza il Sindaco - impressionò fortemente la popolazione, la quale, non vedendo altra via di salvezza che nella ricostruzione di una amministrazione naturale che studiasse ed adottasse i provvedimenti più idonei e possibili nella grave contingenza senza però imposizione di tasse , reclamò energicamente e a gran voce che essa, senza ulteriore perdita di tempo si ricostruisse. E si reclamò allora che il dimissionario Sindaco Paino tornasse al suo posto: questi però non volle in nessun modo addivenire, né altri tentativi ebbero migliore fortuna, perché la situazione finanziaria faceva spavento.
Dopo vivissime, insistenti pressioni dovetti cedere io nell’assumere il posto di dovere e di sacrificio, e ciò avvenne nel gennaio 1920.

Il primo calice lo ebbi dagli impiegati[3] del Comune i quali non pagati da circa otto mesi, non prestavano servizio regolare, spesso tumultuavano, e minacciavano ancora uno sciopero generale, onde tutti i servizi erano nel più completo ed assoluto abbandono. Il disordine era generale in tutti i rami di servizio e sovraneggiava spaventosamente. La situazione era più tragica di quanto non immaginassi ed ebbi anch’io, con i miei collaboratori, momenti di grande scoramento e perplessità. Ma la voce del Dovere, l’amore sconfinato per il mio Paese, per il quale in ogni tempo la mia famiglia avea affrontato i più duri sacrifizi mi sostennero nello spirito e nell’azione e mi decisero alla più faticosa resistenza.
Chiamai a me tutti gli impiegati, feci loro comprendere il dovere e la necessità del paziente sacrificio per tutti, promisi loro tutta la mia benevolenza, come pretesi la disciplina ed il compimento del proprio dovere. Promisi di dare la precedenza al pagamento dei loro averi, arretrati di circa otto mesi, a rate ed appena possibili, rinviando il pagamento di tutti gli altri debiti del Comune. Riunii i medici condotti[4], li resi edotti della situazione, li esortai al sacrificio di rinviare l’esazione dei loro averi, al momento possibile e, con nobile sentimento di civismo, ebbi la loro incondizionata adesione[5]”.
Ma dove prendere le risorse? Questo è il primo problema da risolvere per potere ricominciare. Non potendo pensare a nuove tasse due sole sono le strade che Ferlazzo può percorrere: un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e un decreto governativo che lo autorizzi a raddoppiare la tassa sulla pomice. Questa tassa infatti non cade sulle spalle dei contribuenti locali ma sulle ditte che acquistano. L’esportazione ha raggiunto nel 1918 il punto più basso a livello del 1901 ma si spera che da un momento all’altro, finita la guerra, rasserenatisi i rapporti commerciali, riprenderà a salire[6]. Due strade difficili. La più immediata sembrerebbe quella del mutuo ed invece si rivela la più lunga tanto che nell’aprile del 1923 è ancora in itinere. Invece riesce a spuntarla prima per il decreto.
“…escogitai – spiega Ferlazzo - un provvedimento sanitario; l’invocazione al Governo di un Decreto legge che autorizzasse il Comune a raddoppiare la tassa sulla pomice all’imbarco. Appena il Consiglio comunale deliberò il provvedimento, ed ottenuta l’approvazione da parte del Prefetto, e l’inoltro al Governo, corsi a Roma, dove dopo intenso, faticoso ed incalzante lavoro, presso i Ministeri competenti, riuscii ad ottenere il sospirato Decreto, che doveva restaurare le finanze comunali.[7]”.
Quanto al mutuo, che dovrà essere di almeno 300 mila lire, si potrebbe eccepire che esso sposta l’onere in parte sulle generazioni future. Ma al nuovo primo cittadino questo non procura preoccupazioni morali giacché questa generazione ha patito “le più indicibili privazioni e sofferenze e la perdita di tanti cari, è bene [quindi] che i posteri con i benefici che in un prossimo futuro deriveranno dalla vittoria , abbiano anche una parte di oneri[8]”.
La ripresa e il rilancio di opere e servizi pubblici
Il secondo punto – dopo quello delle risorse per ripianare o contenere il deficit - riguarda la ripresa dei lavori pubblici e delle altre opere relative alla vita urbana come la pubblica illuminazione che mancava del tutto. “I fanali - ricorda Ferlazzo - nella quasi totalità, raccolti nei magazzini di deposito del Comune erano fuori uso. Provvedetti a farne riparare il maggior numero possibile e nuovi ne acquistai. Così potetti ripristinare l’illuminazione”[9].
Ma quando in quegli anni si parlava di opere pubbliche si pensava principalmente alle rotabili che si attendevano da anni ed anni. Purtroppo, a questo proposito non si poteva più pensare ad un altro mutuo, e quindi andava conseguito “nel più breve tempo possibile l’assunzione da parte dello Stato dei lavori delle strade statali Lipari Canneto e Lipari Quattropani, ed il proseguimento di quella di Canneto per Acquacalda, onde possano essere presto ripresi i lavori per quella di Canneto, appaltati quelli per Quattropani e redatto il progetto di lavori appaltati nel proseguo Canneto – Acquacalda.” E con i lavori per le strade bisogna sollecitare il Governo anche per la ripresa “dei lavori del porto, la sistemazione dei moli e delle difese degli abitati nelle rade di Sottomonastero e Piazza Sant’Onofrio per la collocazione delle promesseci boe nelle rade di Lipari, Canneto, Acquacalda, Stromboli, Filicudi, Panarea ed Alicudi, per i pontili di sbarco a Lipari e Milazzo, per il miglioramento dei servizi marittimi sia per la nostra Isola sia per Stromboli e Filicudi ed Alicudi.[10]”.
Ed insieme alle opere pubbliche, quello dei collegamenti marittimi.

Piroscafo Adele in rada
“Per effetto della guerra – ricorderà Ferlazzo nel rapporto del 1923 - i servizi marittimi delle Isole Eolie erano stati ridotti e sconvolti, da non corrispondere alle minime esigenze e necessità delle popolazioni, del commercio e dell’industrie. Per le isole che non hanno altro mezzo di comunicazione con il resto del mondo è una delle questioni delle più vitali, e le popolazioni reclamano insistentemente e talvolta eccitatissimi il ripristino dei servizi dell’ante guerra. Le isole di Panarea, Stromboli con la frazione di Ginostra e le isole di Filicudi ed Alicudi, per i loro nuovi bisogni, reclamano energicamente una nuova linea settimanale in aggiunta a quella dell’anteguerra. Sulla linea di Napoli giustamente si pretendeva un piroscafo di maggiore tonnellaggio, e di maggiore velocità, con migliori e più umani adattamenti, per la terza classe e anche per quella unica[11]. … Ma il trionfo della giusta causa arrise ancora una volta, alla sorte delle isole Eolie le quali oltre al ripristino dei servizi dell’anteguerra poterono conseguire:
- una nuova linea Lipari-Panarea- Stromboli con approdi alla frazione Ginostra e ritorno;
- una linea Lipari – Filicudi – Alicudi e ritorno quindicinalmente prolungata a Messina ;
- un piroscafo denominato Jost[12] sulla linea di Napoli di notevole tonnellaggio e di ottima velocità con magnifici adattamenti”.
Senza trascurare rotabili e piroscafo, Ferlazzo ha un occhio anche per le novità delle comunicazioni.
“Nelle mie gite a Roma potei prospettare al Ministro – ricorda il 14 aprile del 1924 - la indifferibile necessità dell’impianto del Telefono, ed alle obiezioni ministeriali delle difficoltà finanziarie, poiché il cavo sottomarino da collocare fra Lipari e Milazzo, sarebbe costato enormemente io potei suggerire di ricercare nel materiale di guerra, dei cavi presi ai tedeschi. Fatte queste ricerche ed avendo dato favorevole risultato, si poté senza troppe spese per lo Stato , ottenere l’impianto del telefono tra Lipari ed il continente, tra i primissimi altri impianti che collegarono i capi luoghi di mandamento”[13].
Non è impegno di poco conto quello che si è assunto il Sindaco Ferlazzo. Un impegno svolto diligentemente. E comunque le emergenze sono esperienza di tutti i giorni e quando si verificano, gli effetti incidono per mesi ed anni.
Il 22 maggio 1919 si era avuta un’altra terribile eruzione dello Stromboli e questa volta non erano stati colpiti solo i beni ma anche le persone. Esplosioni molto forte, grosse “bombe” e blocchi di 30-60 tonnellate si riversarono anche sui luoghi abitati. Il bilancio fu di quattro morti ed una ventina di feriti, otto case distrutte a San Vincenzo e due a Ginostra ( a S. Vincenzo una bomba di 10 tonnellate ridusse in frantumi una casa), 20 danneggiate. L’eruzione non fu preceduta o accompagnata da terremoti, ma da un forte spostamento d’aria. Il mare prima si ritirò, poi invase la spiaggia per lunghi tratti. Il Consiglio oltre a raccomandare al Governo di condonare per cinque annualità le imposte sui terreni e fabbricati perché tutti quegli abitanti sono stati fortemente danneggiati, delibera di assegnare ai cittadini di quell’isola, danneggiati nella proprietà, un sussidio di 3000 lire e si duole di “non potere concorrere per una somma maggiore date le difficili condizioni finanziarie in cui versa il Comune[14]”.

Lipari - Via Vittorio Emanuele nel 1896
Così nel precedente gennaio-febbraio si erano avute delle forti alluvioni che avevano distrutto le strade campestri, isolando diversi centri nelle campagne tanto da impedire il trasporto dei raccolti. Su una spesa preventivata di 35 mila lire per ripristinare i collegamenti, il Ministero dei lavori pubblici ne aveva elargito 15 mila ma il Genio civile non dava inizio ai lavori se non aveva a disposizione l’intera somma. Il Comune non sapeva dove reperire le rimanenti 20 mila e doveva chiede al Governo di provvedervi ampliando il sussidio[15]. Nel rendiconto del lavoro fatto il 14 aprile del 1923 il Sindaco accenna ad “interventi per le strade mulattiere rese assolutamente impraticabili dalle frequenti alluvioni degli ultimi anni che si è provveduto con un mutuo oltre ad altri sussidi dello Stato” e di “interventi per le isole minori che si stanno eseguendo”.
Il sindaco Ferlazzo fra difficoltà e tenacia
Ancora il 12 giugno 1920 il Consiglio deve rescindere il contratto con l’appaltatore, la ditta Onofrio Russo, di via Vittorio Emanuele e di via Maurolico per inadempienza in quanto dopo due anni non ha ancora ripreso i lavori. Il 14 aprile 1923 Ferlazzo può ricordare che “le domande dell’impresa erano di una tale entità e la causa così intricata e manipolata che se non si fosse data tutta la più attenta e incessante assistenza il Comune pericolava di avere la peggio, pure avendo sostanzialmente ragione”.

Nemmeno i cimiteri sono stati trascurati, sosterrà il Sindaco, contestando le affermazioni del commissario Bua. Riconosce che le vecchie mura che ne chiudono il recinto sono in parte in cattive condizioni statiche ed anche cadenti e da qualche parte è anche agevole l’accesso in maniera che qualche volta è possibile eludere la vigilanza. Tale stato di cose si è determinato a causa delle alluvioni recenti e l’amministrazione oltre ai provvedimenti urgenti adottati per i lavori di minore entità, ottenne dal Consiglio comunale nella seduta del 18 agosto 1922 l’approvazione del progetto della ricostruzione delle mura di cinta e la costruzione di nicchie a colombaia. Per cui quanto prima si procederà all’esecuzione dei lavori. Inoltre nel 1922 fu dato incarico all’ing. Amendola di redigere progetti per i cimiteri di Alicudi, Filicudi, Panarea, Ginostra, Vulcano Piano, Vulcano Gelso, Quattropani ed Acquacalda.
La relazione di autodifesa del 14 aprile 1923 trova il voto contrario dell’opposizione anche se quando il nuovo consiglio, dopo le elezioni amministrative, era tornato a riunirsi l’11 ottobre 1920, Ferlazzo era stato rieletto Sindaco all’unanimità. Grazie al raddoppio della tassa sulla pomice ma, soprattutto, alla ripresa della sua esportazione si era riusciti se non a risanare il bilancio quanto meno a contenerne il deficit. Nel dibattito che ne era seguito il consigliere De Mauro si augurava che ora venissero affrontati in particolare tre problemi: la sistemazione della città murata lasciata libera dai coatti sgomberando le casupole cadenti e realizzando, al loro posto, nuove case e magari anche un albergo “per stimolare qui in Lipari il movimento dei forestieri”; la costruzione di un nuovo ospedale giacchè quello esistente – l’Ospedale dell’Annunciata - oltre ad essere malmesso, dovrà subire una demolizione parziale quando si porrà mano alla sistemazione di via Vittorio Emanuele[16]; infine e soprattutto la scuola sia per quanto riguarda i locali, “diversi dei quali sono stati giudicati pericolanti e purtroppo ancora frequentati dagli alunni e dai maestri”, ma soprattutto per quando riguarda l’istruzione : bisogna che l’amministrazione si assuma l’impegno di fare sparire dalle Eolie la parola analfabetismo.
Per il resto questa prima seduta si era consumata fra elogi e convenevoli. Si salutava e si elogiava il prof. Emanuele Carnevale, definito “autorevole milite della concordia cittadina” che tornava in Consiglio dopo molto tempo; si salutava e si elogiava il marchese Ugo di Sant’Onofrio, ”benefattore delle Isole Eolie, venerato cittadino onorario” che era stato nominato Senatore del Regno; si salutava Fiume, “città martire”ed “il suo eroico comandante Gabriele D’Annunzio” e con Fiume tutta la “infelice ed eroica” Dalmazia.
Anche il Consiglio del 22 gennaio se ne andava, in parte, – come abbiamo già detto nei capitoli precedenti – per commemorare il risultato della vittoria alla Corte di Cassazione nella controversia col vescovo per la proprietà delle cave; poi il Sindaco informava sulla missione a Roma – sempre accompagnato dal marchese Ugo di Sant’Onofrio, da altri parlamentari e dal consigliere provinciale De Mauro - per sollecitare i vari ministeri per i collegamenti marittimi, per i lavori pubblici, per i sussidi alla gente di Filicudi che aveva avuto le case danneggiate dal terremoto, dell’acqua potabile per la siccità estiva che sarebbe stata questa volta a carico dello Stato.
Infine illustrava le linee programmatiche del suo quadriennio cominciando col ricordare che i problemi finanziari non erano ancora finiti ed il bilancio presentava un deficit ancora di 300 mila lire. Sui servizi. L’illuminazione pubblica a petrolio non sarebbe stata più gestita direttamente dal Comune ma data in appalto mentre si sperava al più presto di arrivare all’illuminazione elettrica. A questo proposito informava di un progetto che voleva utilizzare le fumarole di Vulcano per ricavare l’energia necessaria a produrre elettricità.
Quanto all’acqua non poteva che constatare che il costo di questa, durante i periodi di siccità, era divenuto pesante. L’anno precedente era costato 60 mila lire e si era riusciti a convincere il Ministero dell’interno a farsene carico ma non era strada che potesse essere ripercorsa facilmente. Bisognerebbe verificare una volta per tutta se nell’isola esistesse acqua sorgiva.
Infine il problema delle scuole. “Le attuali aule scolastiche, sono delle più umilianti, mentre il Comune è costretto a pagare ingenti fitti, per i locali che spesso è difficile trovare. Si faranno sollecitamente studiare i progetti e ottenere la costruzione coi benefici provenienti dalle leggi”[17]. Ma per incamminarsi in questa prospettiva dovranno passare ancora trent’anni.
E’ un Sindaco tenace Ferlazzo, ma i problemi sono tanti e sembra che tutti si avvitino su se stessi. Le strade non ripartono, le opere marittime procedono lentamente, la pomice fatica a riprendere, l’elettricità e l’acqua sufficiente sembrano una chimera. Che fare?
Nel giugno dell’anno precedente è di nuovo al Governo il vecchio Giolitti e Ferlazzo pensa di rivolgersi a lui. Chiede a Sant’Onofrio che gli procuri un appuntamento e lo ottiene. Si prepara bene il Sindaco all’incontro. Scrive una memoria con i problemi più importanti. Ed è un bene che l’abbia fatto perché a Roma – il 18 aprile 1921 - non riesce a vedere il Presidente ma deve accontentarsi del Sottosegretario alla Presidenza a cui consegna la nota. E Giolitti si interessa. Mette in moto il Ministro dei Lavori Pubblici e questo dopo qualche tempo relazione al Presidente del Consiglio e il Sindaco può leggere con soddisfazione la nota al Consiglio. Il Ministro ha interessato il Genio Civile di Messina e le opere pubbliche terrestri e marittime dovrebbero risvegliarsi.
Nella lunga autodifesa del 14 aprile 1923 a proposito dei lavori pubblici Ferlazzo dirà.

Canneto "vucca u vadduni"
“Altro problema vitale per quanto annoso, era quello delle strade rotabili Lipari – Canneto con prolungamento ad Acquacalda e Lipari – Quattropani, che per l’entità della spesa, se non fossero passate al totale carico dello stato e della provincia sarebbero sempre rimaste un’aspirazione. Con Decreto ministeriale del 30 febbraio 1920 furono ammessi al beneficio del Decreto luogotenenziale del 1918 le rotabili a) Lipari Canneto; b) Lipari Quattropani; c) Lipari Porto Pignataro; d) Canneto Acquacalda” e successivamente la mulattiera dalla frazione Ginostra a S. Vincenzo nell’isola di Stromboli.
“Un lavoro veramente estenuante – commenta il Sindaco - ha dovuto affrontare l’Amministrazione comunale e quotidianamente per ottenere la ripresa dei lavori della rotabile Lipari – Canneto e per l’inizio di quella per Quattropani; ed io in ogni mio viaggio a Roma, ho fatto il diavolo a quattro, conferendo con Ministri, sottosegretari di Stato, interessando anche S. Ecc. Giolitti quando presiedeva il Ministero. Ora ho potuto avere sicuri affidamenti da S. Ecc. Carnazza, per sperare che , sotto il Governo di S. Ecc. Mussolini, al fine si potrà conseguire quanto è stato per decine di anni, la costante legittima aspirazione della popolazione di Lipari”.
[1] Il discorso tenuto il 23 dicembre 1919 è riportato nel verbale della seduta del 2 febbraio 1920.
[2] Questo documento comprese le risultanze dell’inchiesta del Commissario Francesco Bua è nel verbale del consiglio comunale del 14 aprile 1923.
[3] Il Comune doveva contare circa 40 dipendenti. Quando il 13 aprile 1925 il Consiglio discute della nuova pianta organica questa prevede appunto 41 dipendenti divisi in sette ruoli. Il primo ruolo riguarda i dipendenti presenti nella casa municipale e sono 17 (un segretario, un vice segretario, un ragioniere, un tesoriere, un archivista, cinque applicati di segreteria, un agente riscossione della tassa pomice in Canneto, un dattilografo copista, un usciere, un messo comunale e tre messi rurali); corpo delle guardie municipali era composto da un capoguardia e da cinque guardie; il corpo addetto alla vigilanza per la pomice comprendeva: un direttore tecnico minerario, un comandante guardie campestri o vigili pomici feri, cinque guardie, un conduttore battello comunale; la custodia del cimitero prevedeva: un custode cimitero di Lipari, un seppellitore cimitero di Lipari e un custode e seppellitore cimitero di Stromboli; un maestro di musica; per le scuole vi erano un bidello scuola tecnica o complementare e due bidelli scuole elementari; per le carceri: un custode carcere mandamentale e un giardiniere.
[4] Il Comune contava allora sette condotte mediche: due a Lipari centro ( 11.000 ab circa.) di cui una sovrintendeva le borgate di Pianoconte (500 ab.) , Quattropani (500 ab.) e Vulcano ( 400 ab.); una a Canneto ( (2.000 ab.) con le frazioni di Sparanello, Lami ed Acquacalda ( 500 ab.); una a Stromboli (2.200 ab,) con Ginostra ( 400 ab.), una a Filicudi ( 1.300 ab.), una ad Alicudi ( (800 ab.).
[5] Verbale del Consiglio comunale del 14 aprile 1923.
[6] Proprio nel 1919 l’esportazione riprenderà a salire ma solo nel 1923 si porterà ai livelli dell’anteguerrà e ciò sulle 30 mila tonnellate all’anno.
[7] Verbale del 14 aprile 1923
[8] Verbale del 23 dicembre 1919.
[9] Verbale del 14 aprile 1023.
[10] Verbale del 23 dicembre 1919.
[11] Le richieste del Comune per i servizi marittimi approvate nella seduta del 18 agosto 1922 erano state::
Linea I Milazzo- Lipari – Canneto- Acquacalda- S. Marina – Malfa – Rinella – e ritorno, giornaliera sia fatta con piroscafo di 500 tonnellate di stazza lorda e di velocità di 14 miglia orarie Che tutti i locali per i passeggeri, anche quelli di terza classe, siano in buone condizioni con istallazioni chiuse in grado di riparare i viaggiatori dalle intemperie. Le stesse caratteristiche deve avere il piroscafo “di rispetto” cioè che dovesse sostituire quello di linea per emergenze o riparazioni.
Linea II che parte da Messina-Lipari- Canneto – Acquacalda, S. Marina – Malf – Capo – Panarea – Ginostra – Stromboli e ritrono, settimanale con piroscafi della velocità di 10 miglia orari e di 500 tonnellate di stazza lorde.
Linea III a – Messina – Lipari – Canneto – Acquacalda – S. Marina – Capo – Malfa – Pollara – Filicudi porto – Filicudi Pecorini – Alicudi e ritorno passando da Flicudi Pecorini – Filicudi porto -
Rinella – Lingua – S. Marina – Acquacalda – Canneto – Lipari – Messina.
Linea III b – invertendo l’andata e ritorno con la linea III a) entrambe settimanali con piroscafi di 500 tonnellate velocità 10 miglia orarie.
Linea IV – Lipari – Canneto – Panarea – Ginostra – Stromboli e ritorno settimanale sempre con piroscafi di 500 t. e 10 /mh.
Linea V – Messina – Lipari- Canneto – Acquacalda – Filicudi Porto – Filicudi Pecorini e ritorno
Linea V bis – Lipari – Canneto – Vulcano Gelso – con ritorno a Vulcano porto – Canneto – Lipari settimanale
Linea II bis ( Gruppo Sicilia) Messin a- Milazzo – Lipari- Canneto- Acquacalda – S. Marina – Lingua – Rinella – Pollara – Malfa – Capo – Panarea- Ginostra – Stromboli – Napoli e ritorno, settimanale con piroscafi di stazza lorda di 1000 tonnellate e dalla velocità minima di 12 mh.
[12] Probabilmente questo piroscafo venne sostituito perché non risulta che sulle rotte per le Eolie sia mai entrato in funzione un mezzo con questo nome.
[13] Verbale del 14 aprile 1923.
[14] Dal verbale del Consiglio comunale del 28 giugno 1919.
[15] Dal verbale del Consiglio Comunale del 21 giugno 1919
[16] Nel Consiglio del 14 aprile 1923 il Sindaco a proposito dell’Ospedale esistente dirà che esso dipende dalla Congregazione di Carità. Esso però è anche un ricovero di mendici inabili al lavoro. L’amministrazione comunale intende provvedere, rassicura il Sindaco, ad un nuovo ospedale secondo le esigenze moderne e ne ha già acquistato il terreno. La demolizione parziale di cui parla il consigliere De Mauro riguarda la parte che si spingeva verso la chiesetta del Rosario lasciando lo spazio di un vicolo, il cosiddetto ‘u strittu a Sena dove terminava, appunto con una strozzatura che doveva essere eliminata, via Vittorio Emanuele.
[17] Dal verbale del Consiglio comunale del 22 gennaio 1921.(Archivio Storico Eoliano.it)
Eruzione dello Stromboli
Il confino politico del fascismo a Lipari con i più importanti oppositori del regime
Il governo pensava ad un confino politico

1913. Raduno di anarchici e coatti al Castello. E' Pentecoste e sta parlando il pastore evangelico Renzi.
Era vero che il Governo pensava a Lipari come luogo di detenzione. Ma non per i delinquenti comuni come era avvenuto per lo più nel passato. Questa volte si aveva in mente un confino tutto politico sulla base del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che sarà promulgato il 6 novembre 1926[1]. E’ l’articolo 184 che recita: “Possono essere assegnati al confino di polizia, con l’obbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1. gli ammoniti; 2. coloro che abbiano commesso, o manifestato il deliberato proposito di commettere, atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici, costituiti nello Stato e menomarne la sicurezza.”
Le forme della detenzione sono, grosso modo, quelle che vigevano per i coatti. Si veniva alloggiati al Castello in delle camerate, sotto la rigida sorveglianza della polizia e della milizia fascista. Per i primi anni le camerate dovettero essere quelle stesse dei coatti sistemate in qualche modo soprattutto dopo la sommossa del 1926. Nel 1927 cominciarono i lavori per creare al Castello – fra la vecchia porta di ingresso e la Cattedrale – due grossi, esteticamente orribili casermoni, oggi occupati dal Museo archeologico. I lavori furono completati nel 1930 e i due edifici furono dedicati uno ai militi fascisti e l’altro ai confinati[2].
Al mattino non si poteva abbandonare il Castello prima di aver risposto all’appello ed aver incassato la “mazzetta” come era chiamata la piccola paga giornaliera di dieci lire. Alla sera si doveva rientrare entro le 19 d’inverno e la 21 d’estate. Era permesso circolare liberamente per il paese, non si poteva però superare una ben determinata linea di demarcazione che circondava il centro abitato e che era controllata in continuazione dalla milizia fascista. Il mare era sorvegliato da motoscafi armati di mitragliatrici.
Era anche permesso prendere in affitto un alloggio nell’abitato dentro la cerchia di vigilanza. Ed era questa la scelta che facevano praticamente tutti. “Anche i più poveri – annoterà Emilio Lussu - si sottopongono ad ogni privazione pur di vivere in una propria cameretta, sia pure squallida…La quasi totalità dei deportati provvede con questa somma [dieci lire] al vitto, l’alloggio, agli abiti, alla luce, all’acqua; l’acqua in estate manca nell’isola, e vi viene portata con navi cisterne. Pochi sono quelli che possono trovare lavoro sul posto:qualche meccanico,elettricista, sarto, calzolaio o muratore. Un centinaio ha ottenuto la facoltà di far vivere con sé moglie e figli: tutti campano sulle dieci lire del capo famiglia[3]”.
“Il confinato – racconta Jaurés Busoni – che arrivava veniva munito di carta di permanenza, consistente in un libretto da portare sempre con sé e dove venivano scritti eventuali permessi. I confinati potevano affittare appartamenti o camere dietro permesso rilasciato dal comando di Polizia; rispettando però gli orari di uscita e di ritirata come gli altri. Chi otteneva questo permesso doveva lasciare sempre la porta di casa aperta per permettere alla Polizia di compiere controlli a qualunque ora del giorno e della notte, senza chiedere permessi a nessuno”[4].
All’inizio, sul finire del 1926, sono poche decine, ma nella primavera del 1927 già sono più di 200. Le risse non mancano e le punizioni anche. Fin dai primi mesi vengono denunciati gli abusi, le provocazioni, le negligenze.
 Francesco Fausto Nitti, un modesto impiegato di banca, serio, riservato, desideroso di anonimato, alla morte di Matteotti avverte una forte indignazione morale ed entra in contatto con la vedova Matteotti e il mondo dell’antifascismo. E’ condannato al confino sul finire del 1926 e nel marzo del 1927 giunge a Lipari.
Francesco Fausto Nitti, un modesto impiegato di banca, serio, riservato, desideroso di anonimato, alla morte di Matteotti avverte una forte indignazione morale ed entra in contatto con la vedova Matteotti e il mondo dell’antifascismo. E’ condannato al confino sul finire del 1926 e nel marzo del 1927 giunge a Lipari.
“Sbarcammo nel centro del paese, ove si trova il porto, sotto la massa oscura e imponente del vecchio castello. Condotti alla direzione e subite le solite formalità, fummo lasciati liberi.
Nei primi giorni della mia vita liparese, abitai in una camera d’albergo . Era uno dei tre modestissimi alberghi che Lipari offre ai viaggiatori. Poco dopo lasciai l’albergo ed alloggiai in una vecchia casa del vicolo Sparviero, una viuzza stretta, male acciottolata e quasi sempre sporca…
La mia pena, la mia sofferenza aumentarono ogni giorno: cercavo di occupare il mio tempo, leggevo, studiavo, davo qualche lezione a un gruppo di deportati, bravi operai desiderosi di apprendere. Ma la mia vita era sempre più triste e vuota. Spesso, seduto al mio tavolo, con un libro aperto davanti, mi sforzavo a leggere e non ci riuscivo… Il libro era aperto là, innanzi a me, ma il mio pensiero era lontano, infinitamente lontano, né mi riesciva dominarlo. Esso correva verso una meta agognata, desiderata, sospirata: la libertà[5]”
Lipari lè la principale colonia di confine
Nel corso del 1927 Lipari diventa la principale colonia di confino degli oppositori del regime. I confinati diventano cinquecento provenienti da ogni parte d’Italia, di tutti i partiti, di tutte le classi sociali. Personaggi illustri e meno illustri. Saranno confinati a Lipari Domizio Torrigiani gran maestro della massoneria, Ferruccio Parri che presiederà il primo governo della liberazione,lo scrittore Jaurés Busoni, e i protagonisti della fuga Rosselli, Nitti e Lussu. Nella piccola cittadina, nel microcosmo della colonia, si riflettevano tutte le contraddizioni della società italiana, le differenze di classe, i contrasti ideologici, le gelosie regionalistiche ma anche la voglia di discutere, di condividere le esperienze della tavola, della cultura e dell’amicizia[6].


A sinistra Domizio Torrigiani e a destra Ferruccio Parri
Vi erano anche agenti provocatori in veste di deportati politici. Si dicevano “fascisti dissidenti”. “Erano individui loschi e pericolosi – scrive Nitti - , pronti a tutto, desiderosi di riguadagnare la stima e la simpatia di quei capi del fascismo che, dopo averli usati nelle peggiori azioni, li avevano gettati come avanzi nelle isole”.Vi erano circa cinquecento fra carabinieri, agenti di PS, militi fascisti, guardie di finanza ed equipaggi di motoscafi della marina incaricati della sorveglianza costiera.
Per sopravvivere e potere mandare qualcosa alle famiglie rimaste a casa i confinati si industriano come possono. Vi è persino chi fabbrica krapfen e li vende per le strade di Lipari su un improvvisato vassoio appeso al collo.
Il momento più atteso era quello della distribuzione della posta che veniva sottoposta a controllo dalla Questura e, se ritenuta del tutto innocente, le veniva apposto sopra un timbro con scritto “Verificato per censura”. Ma bastava una frase, una parola sospetta che la corrispondenza, in arrivo o in partenza, veniva sequestrata oppure cancellata con china. La distribuzione della posta avveniva al castello presso la caserma della milizia e veniva fatta da un poliziotto. “Con quale animo – commenta Nitti – tutti noi ci recavamo a quella distribuzione! E come tristi scendevamo dal Castello quando non ricevevamo nulla!”.
I confinati erano avidi di notizie, sia da casa ma anche degli eventi italiani ed internazionali. E siccome dei giornali non si poteva fare conto perché erano tutti asserviti al regime come unica fonte erano gli stessi deportati politici, “Quelli che giungevano ci portavano le ultime notizie – racconta Nitti – il resoconto degli ultimi avvenimenti, non già deformati dalla censura fascista e falsati dai giornali, ma la verità autentica. In una piccola isola sperduta noi avevamo un vero ufficio di informazioni. Le notizie che ci venivano da ogni parte erano vagliate, confrontate, esaminate”.
“Recarsi a veder giungere il piroscafo – è sempre Nitti che racconta - era una delle occupazioni nostre più importanti. Era anche un avvenimento, oltre che un’occupazione. Alle 11 circa arrivava l’Adele o l’Etrna: i due piroscafi che a turno facevano il quotidiano viaggio Milazzo- Lipari. Molti di noi erano accalcati agli sbocchi delle strade nella piazzetta del porto. Non potevamo avvicinarci al porto oltre un certo limite, durante le operazioni di sbarco. Ma anche da lontano vedevamo l’arrivo della nave, le barche che si recavano intorno, prima tra le quali quella della polizia con un brigadiere, degli agenti, uno dei carabinieri e due poliziotti. Quegli uomini salivano a bordo del piroscafo per primi, si ponevano presso la scaletta e verificavano le carte di tutti coloro che desideravano scendere”.
I confinati aprono una scuola e una biblioteca

Approfittando del fatto che al confino ci sono diversi uomini di cultura e di ingegno i confinati chiedono il permesso alla direzione ed aprono una scuola ed una biblioteca per i deportati e per i loro figlioli. “Avevamo organizzato – aggiunge Nitti - corsi di istruzione elementare e secondaria, di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, di storia di matematica, di fisica, di disegno. Il Gran Maestro della Massoneria, Torregiani, aveva accettato di tenere un corso di letteratura italiana, io ebbi un corso di storia. Avevamo un vasto locale, preso in fitto con la contribuzione di tutti, e lo avevamo diviso in classi, facendo costruire da alcuni deportati del mestiere,cattedre, panche, lavagne. Ricordo che la mia classe era composta di circa cinquanta operai pieni di zelo e che facevano molto profitto delle mie lezioni”. Ma l’esperienza dovette cessare perché un confinato, per acquisire meriti presso la direzione della colonia, affermò che la scuola serviva a mascherare la propaganda politica.
Progetti di fuga ed azioni di provocazione da parte di finti deportati si intrecciano e si moltiplicano . Un primo progetto di fuga che doveva avvenire la notte di Natale del 1927 fallisce perché proprio alcune settimana prima scatta una grande retata dietro denuncia di un agente provocatore che sostiene che a Lipari si stava tramando per fare cadere il regime.


Emilio Lussu in alto e Carlo Rosselli sopra.
“ Si avvicinava – racconta Lussu – il Natale del 1927. La colonia si preparava a celebrare la festa. Erano pronti gli alberi e i doni per i bambini dei nostri compagni. Quando ecco arrivare nella notte , una nave da guerra. Sorpresa generale per il fatto straordinario. Scesero 200 carabinieri, militi, ufficiali, commissari, ispettori e il Procuratore del Re presso il Tribunale Speciale. Duecentocinquanta confinati furono arrestati nella notte e condotti al Castello. Il giorno dopo la città sembrava in stato d’assedio. Gli arrestati furono interrogati il giorno successivo. A notte tarda 200 di essi furono messi in libertà. Solo allora il mistero si chiarì. Si trattava di un ‘complotto’ contro la sicurezza dello Stato miracolosamente sventato. Quattrocento deportati politici, in un’isola così vigilata, mettevano in pericolo l’autorità dello Stato!. I cinquanta e più indiziati furono imbarcati, all’indomani, sulla stessa nave da guerra. Squadre di ammanettati, tenuti uniti tra di loro con lunghe catene, sfilarono per la città. Agli altri deportati era vietato assistere alla partenza e avvicinarsi alle banchine. Ma l’ambiente era elettrizzato. Tutti i confinati si ribellarono al divieto e si riversarono sulla banchina. I cordoni armati furono impotenti a respingerli. Era la prima rivolta collettiva contro un ordine superiore. In seguito a questi arresti, furono fatte chiudere le trattorie cooperative che i deportati si erano organizzate per risparmiare sul vitto, i piccoli clubs sportivi. La vita divenne più pesante.”
A fine dicembre del 1927 giunge al confino di Lipari un altro ospite illustre: Carlo Rosselli[7]che arrivava con la fama di chi aveva organizzato la fuga di Turati in Francia . La descrizione che egli fa di Lipari in una lettera alla madre del 31 dicembre è lusinghiera.” Non ci sono possibilità di confronti fra Ustica e Lipari per quanto attiene la vita materiale. Già questa è una cittadina ricca e pulita con due grandi strade lastricate. Si trova di tutto. Quattro farmacie, salumerie ( ce n’è una bellissima e fornitissima), macellerie, orologerie, bazar, negozio di mobili ec. Insomma un vero Eden per chi ricorda Ustica Petrosa[8]”.
Meno lusinghieri sono gli interrogativi che si pone suoi costumi e la religiosità di questo popolo. “E’ incredibile – scrive in una lettera alla madre il 22 agosto del 1928 – il numero delle feste e conseguenti processioni in questi paesi. Non meno del doppio del normale. Strano che non se ne stufino; giacché sono sempre eguali e soprattutto sono sempre i medesimi a doversi vestire, incolonnare, camminare per ore ed ore. E’ evidente che c’è qualcosa della psiche locale che ci sfugge. Un qualcosa che non è vero profondo sentimento religioso: forse un misto di superstizione, estetismo grossolano, solidarietà paesana, amor di tradizione. Tant’è vero che anche persone evidentemente incredule e miscredenti si guardano bene dal mancare a queste cerimonie ufficiali del clan”[9].
[1] Per la redazione di questo paragrafo abbiamo fatto riferimento soprattutto a L. Di Vito e M. Gialdoni, Lipari 1929. Fuga dal confino, Bari, 2009.
[2] G.Iacolino, Strade che vai, op. cit., pag. 174.
[3] Idem, pag.8. Le frasi sono riportate da Emilio Lussu, Memoria di Lipari, in “Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico” quaderno 8/10, 1977.
[4] J. Busoni, Confinati a Lipari, Milano, 1980.
[5] E. Lussu, op. cit.
[6] L. Di Vito e M. Gialdroni, Lipari 1929, op. cit., pag.13.
[7] Carlo Rosselli. Appena trentenne aveva insegnato economia politica all’Istituto Superiore di Firenze. Aveva aderito al socialismo subito dopo la morte di Matteotti e con Ernesto Rossi aveva creato a Firenze il periodico clandestino “Non mollare”.Aveva organizzato l’espatrio clandestino in Francia del capo del socialismo italiano Filippo Turati.
[8] L. Di Vito e M. Gialdroni, Lipari 1929, op. cit. pag. 67.(Archivio Storico Eoliano.it)
[9] Idem, pag.123.
La sommossa contro il confino coatto ovvero "i vespri liparesi"
L'incauta frase di un commissario di polizia

Non si era dimenticata a Lipari la lunga permanenza della colonia coatta e la preoccupazione di un suo possibile ripristino continuava ad aleggiare nell’isola. Ogni volta che giungeva un’ autorità sconosciuta e si recava a visitare il Castello ecco immediatamente che la cittadinanza entrava in fibrillazione. Così fu nell’agosto del 1926 quando giunse un questore di pubblica sicurezza che appunto salì al Castello e si mise ad esaminare, afferma un testimone dell’epoca[1], i fabbricati esistenti. Subito si diffuse la voce che si volevano portare dei delinquenti e si disse anche un numero: circa duecento. Per la verità – osserva Paino – era da mesi che il Governo si dava gran da fare a riattare le case del Castello, ma nessuno gli aveva posto pensiero.
Quando la voce prese corpo una delegazione di cittadini si recò dal commissario di Pubblica sicurezza Stagno, ma non riuscirono a parlargli. Migliore fortuna ebbero, il giorno dopo un bel gruppo di donne che non si limitò a chiedere di essere ascoltate, ma inscenò una manifestazione gridando “Non vogliamo i coatti”. Questa volta Stagno non poté fingere che non c’era anche perché quelle dichiaravano che non se ne sarebbero andate via finchè non gli avessero parlato.
Così si fece sulla porta e cercò di rasserenarle. Ma non c’era verso. Queste volevano l’impegno che non ci fossero nuovi ospiti al Castello e Stagno questa garanzia non poteva darla. Così ad un certo punto perse la pazienza ed esclamò:
“Ma perché ce l’avete tanto con i coatti? Certo fra voi ci sono anche figlie di coatti”. La frase cadde un macigno in mezzo alla schiera e subito si fece silenzio. “Chi dissi..chi dissi…”, domandavano quelle che si trovavano più in dietro e non avevano capito bene.[2]L’offesa era così pesante che il gruppo si ritirò. E parlottando fra di loro se ne tornarono ai propri impegni. Ma l’eco dell’insulto non si spense. Passò di negozio in negozio, di casa in casa e nel lavorio del passa parola divenne sempre più pesante ed insultante. “Il commissario ha detto è giusto che vengano i coatti perché a Lipari sono tutti coatti e figli di coatti”.

La sera arrivò silenziosa e tranquilla come era una sera d’agosto in una Lipari che non conosceva ancora il frastuono delle macchine e degli altoparlanti. Serena per le strade ma vivace nelle case . Nella villa dei De Mauro a Diana vi erano riuniti i massoni iscritti alla due Logge; alla Cattedrale vi era riunito il Capitolo al gran completo con l’Amministratore apostolico mons. Ballo con la motivazione che si doveva parlare dell’imminente festa di San Bartolomeo. L’Amministratore disse poche parole poi rimasero tutti in silenzio e poco dopo arrivò Nunzio Esposito, un uomo che la Chiesa – commenta Paino – se l’era dimenticata da un pezzo, inviato dalle due logge. Ballo gli andò incontro fraternamente, parlottarono fra loro e poi si abbracciarono congedandosi.
Clero e massoneria si mobilitano
Nella casa di Diana - subito dopo - parlò solo il dottor De Mauro, disse poche parole e poi tutti gli ospiti uscirono alla spicciolata ognuno con un compito ben preciso. Il messaggio da portare in tutte le frazioni era semplice. “All’indomani mattina muniti di tutti gli attrezzi che avevano: pale, picconi, randelli ma non armi da fuoco, dovevano scendere a Lipari ed, al suono delle campane, dare l’assalto al Castello”.
E così sorse la mattina del 19 agosto[3]. Tutte alla stessa ora le campane delle chiese di Lipari suonarono a distesa e da Santa Lucia, dal Vallone, dalla Marina lunga la gente arrivava a flotte ognuno con alla spalla un attrezzo dei campi, gridando “Non siamo coatti e non volgiamo i coatti”. Una massa enorme circondò il Castello ma il Commissario avendo intuito cosa stava succedendo diede ordine di chiudere l’unica entrata e di piantonare la grande porta di diversi quintali mentre lui si trincerava nell’ospedale che era nel vecchio palazzo vescovile accanto alla Cattedrale. Vi era anche un’altra entrata al Castello, la scalinata che da via Garibaldi porta alla Cattedrale, ma questa era barricata perché il muro che era crollato non era stato ancora riparato. Comunque anche questa via era stata piantonata ed era stata affidata ad un sottufficiale liparese che non capiva cosa stava succedendo.

La gente intanto si era ammassata all’entrata chiusa dal portone e non sapeva che fare. Un giovane di diciassette anni disse che aveva un piano. Gli si fecero intorno alcuni uomini ed alcune donne ed egli spiegò che da quella parte non si poteva fare niente ma bisognava tentare dalla scalinata. Bisognava concentrare lì una parte dei dimostranti e tenerli nascosti per non insospettire le guardie e mentre un gruppetto di donne davano discorso al piantone per distrarlo, lui ed un altro ragazzo, il Belletti, si sarebbero aperti un varco nel vicolo sbarrato ed avrebbero tagliato i fili si ferro che bloccavano l’accesso alla scalinata. Finita l’opera il Belletti lancia un grido alle donne e mentre il piantone si allontana per vedere chi ha gridato, il varco si apre e prima le donne e poi gli uomini irrompono urlando e prendendo di sorpresa i militari che sembrano sbandati e non capiscono che cosa è successo. I dimostranti corrono subito al portone dell’entrata principale, tagliano i cardini, lo divelgono e lo gettano in mare. Cominciò così la distruzione delle case e casupole che si stavano riadattando per i nuovi relegati.
“Sette ore – commenta Pino Paino - durò la distruzione del Castello e quando l’ultimo degli insorti si ritirò, sembrò che fosse passato di nuovo il Barbarossa.Solo che questa volta nessuno piangeva come allora, che anzi era ognuno felice di sentirsi nato”.

All’indomani, navigli di guerra, truppe e rinforzi di polizia giunsero da Messina e Milazzo ponendo l’isola in stato di assedio. Furono operati numerosi arresti e De Mauro fu condotto in catene a Messina. Il fratello Giovanni, capitano dei bersaglieri e presidente degli invalidi e mutilati di guerra, fece inviare un telegramma a D’Annunzio che aveva conosciuto nei lunghi anni di guerra del Carso, chiedendogli giustizia per la sua isola “poeticamente bella”.E alcuni giorni dopo il dott. De Mauro tornò a Lipari in libertà, tra le ovazioni della sua gente che continuò a curare come medico, finché non si trasferì a Messina, dove istituì una clinica che portò per lungo tempo il suo nome[4].
[1] Sulla vicenda abbiamo la fotocopia di una memoria stilata da Belletti Antonino il 10 febbraio del 1989 di anni allora 74 e quindi 11 anni all’epoca degli avvenimenti. Inoltre, sempre sulla vicenda, Pino Paino ha pubblicato una memoria in appendice a L.S. d’Austria, Le isole Lipari, vol.VIII, Parte generale.
[2] La versione che abbiamo deciso di seguire è quella di Pino Paino. Il Belletti né dà una differente. L’episodio del commissario con le donne sarebbe avvenuto al Castello il giorno della sommossa e la risposta di Strano avrebbe scatenato la violenza. Dette quelle parole sarebbe stato “preso come un sacco di patate per buttarlo fra gli scogli sotto il Castello ma l’intervento del medico De Mauro gli salvò la vita. A questo punto cominciò la distruzione”.
[3] Nella memoria di Belletti si dice che fu il 27 agosto il giorno della sommossa.
[4] P.Paino, Francesco De Mauro e gli altri nei Vespri di Lipari del ’26, in L. S: d’Austria, Le isole Eolie, vol. VIII, op. cit.(Archivio Storico Eoliano.it)
I sindaci diventano podestà
Una sanatoria per l'occupazione dei terreni alla Rocche Rosse
 Nel Consiglio dell’11 ottobre 1925 viene portato dal consigliere Giuseppe Ziino il problema dell’occupazione dei terreni alla Rocche Rosse. Si parte dalla denuncia che è in atto una occupazione abusiva a spese del demanio comunale, ma si arriva ad una proposta concreta. Siccome si tratta di un terreno arido ma di possibile edificazione egli propone che la si divida in lotti e la si assegni agli “indigeni che dimostrino di essere tali”, ai mutilati, orfani, vedove e decorati di guerra solo a fini edificatori, evitando che di essi si faccia speculazione. Ed il Consiglio delibera di dare mandato all’ing.Turchio di preparare una planimetria della contrada, di predisporre i lotti e di mettere come vincolo che le costruzioni devono essere realizzate entro due anni dall’assegnazione. Si stabilisce anche un canone enfiteutico annuo di lire 15 per lotto. Saranno escluse dalla concessione le aree di possibile scavo per presenza di pomice di valore commerciale e quelle in prossimità del mare che rimarranno per l’uso civico.
Nel Consiglio dell’11 ottobre 1925 viene portato dal consigliere Giuseppe Ziino il problema dell’occupazione dei terreni alla Rocche Rosse. Si parte dalla denuncia che è in atto una occupazione abusiva a spese del demanio comunale, ma si arriva ad una proposta concreta. Siccome si tratta di un terreno arido ma di possibile edificazione egli propone che la si divida in lotti e la si assegni agli “indigeni che dimostrino di essere tali”, ai mutilati, orfani, vedove e decorati di guerra solo a fini edificatori, evitando che di essi si faccia speculazione. Ed il Consiglio delibera di dare mandato all’ing.Turchio di preparare una planimetria della contrada, di predisporre i lotti e di mettere come vincolo che le costruzioni devono essere realizzate entro due anni dall’assegnazione. Si stabilisce anche un canone enfiteutico annuo di lire 15 per lotto. Saranno escluse dalla concessione le aree di possibile scavo per presenza di pomice di valore commerciale e quelle in prossimità del mare che rimarranno per l’uso civico.
In riferimento a questa iniziativa, nel 1951 l’avv. Giovanni Raffaele[1] scriverà, che l’istituto d'ufficio dal Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia verificò dal 1925 al 1929, “le occupazioni arbitrarie compiute da privati in danno del demanio comunale pomicifero di Lipari nelle contrade S. Gaetano e Grotta delle Mosche facenti parte della località Acquacalda, e nelle località Rocche Castagna, Porticello, Campobianco, Spiaggia Arena, Pietraliscia, Croce, Montepilato, Agliozzo, Rocche Rosse, Due Corna, Cavallo Arena, Serro Chiesuola, Valloni Acquacalda, Chiesa Vecchia di Acquacalda”. Ci furono diverse opposizioni contro gli atti della verifica da parte di chi era stato incluso “negli elenchi delle occupazioni non legittimabili del demanio comunale pomicifero di Lipari”. Con sentenza del commissario degli usi civici del 21 maggio 1932[2] si ordinava la reintegra “delle zone di demanio arbitrariamente occupate dai privati, facultando il Comune ad immettersene in possesso intra trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, condannando inoltre gli occupatori al pagamento dei frutti indebitamente percepiti e delle spese di giustizia e di verifica, rimandando a separata sede la liquidazione di tali spese e frutti”[3].
Grazie a questa iniziativa, saranno parecchi, i gruppi familiari che realizzeranno una abitazione e, sul finire del secolo l’amministrazione comunale opererà perché ai possessori di alloggi su terreni gravati da enfiteusi sia data la possibilità di divenire proprietari a pieno titolo. Ma la sentenza del commissario non riguardava solo i modesti “usurpatori” che avevano occupato un pezzo di terreno per farsi la propria abitazione familiare, ma anche grossi proprietari di terreni pomiciferi che avevano usurpato oppure avevano sconfinato, cioè non erano rimasti nei limiti della loro concessione originaria. E sarà proprio questo problema del reintegro dei terreni usurpati dai grossi proprietari, una delle ragioni alla base della riproposta autonomia di Canneto sul finire degli anni 40.
Per la reintegra dei terreni pomiciferi il commissario per gli usi civici inviava a Lipari per gli accertamenti l’ing. Lemmo che sarà autore di una mappa dei terreni pomiciferi, conosciuta come “mappa Lemmo”, che a lungo è stata utilizzata dagli uffici comunali come strumento di individuazione delle varie taglie.
Fra i proprietari veri che però avevano sconfinato c’era Gaetano Saltalamacchia di Acquacalda padre del Sindaco Salvatore Saltalamacchia. Per questa ragione il Sindaco dovette dimettersi e, malgrado una commissione di Lipari avesse fatto presente al prefetto Guerresi che sarebbe stato utile, anche al fine di una composizione della vertenza, nominare commissario prefettizio lo stesso Saltalamacchia, il prefetto non accettò la proposta. Invece sciolse il Consiglio giacché i suoi membri erano, chi più chi meno, imparentati con gli aventi causa, e nominò commissario l’avv. Gaetano Manganaro. Questi compare negli atti del Comune di Lipari a partire dal 24 marzo 1926.
Si propone una rotabile che faccia il giro dell'isola

Salvatore Saltalamacchia tornerà alla guida del Comune il 10 aprile 1927 quando viene nominato Podestà in virtù della legge 4 febbraio 1926 n. 227.
Con la legge del 4 febbraio 1926 n. 237, che fa parte delle cosiddette” leggi fascistissime”, venne istituito il podestà. Dal 21 aprile 1927 al 1945 gli organi democratici dei comuni furono soppressi e tutte le funzioni in precedenza svolte dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale furono trasferite ad un podestà, nominato con Regio decreto per cinque anni e in ogni momento revocabile.[4]
Sempre nella seduta dell’11 ottobre e per iniziativa del consigliere Ziino si approva un ordine del giorno che è una perorazione al governo fascista perché si doti l’isola di una rotabile che permetta la “circolazione intera dell’isola” collegando fra loro Lipari, Canneto, Acquacalda, Quattropani, Pianoconte e di nuovo Lipari ed in particolare il suo porto rifugio. E questo sia per esigenze legate allo sviluppo sociale e civile sia per lo sviluppo economico e commerciale. Questa richiesta diventa tanto più pressante osserva il Consiglio in quanto “il miglioramento encomiabile che sta avverarsi nei servizi marittimi dell’Arcipelago Eolio, apportato dal Governo, non sarebbe in sostanziale armonia con la deficienza di strade che non migliorano ma peggiorano le condizioni interne della principale fra le sette isole liparesi”.
Un sogno questo di una rotabile che percorra tutto il perimetro dell’isola che verrà concretizzata solo negli anni 70. Invece un altro sogno che finalmente viene a compimento è quello di avere la strada centrale di Lipari degna di un vero e proprio corso.
Il 13 aprile del 1925 il Consiglio deliberò l’allineamento fra la casa di Michele Antonucci con quella del dott. Gaetano Fenech eliminando così tutte le porzioni di fabbricato e di terreni eccedenti questa linea. Spariva così ‘u Strittu a Sena che da qualche tempo aveva assunto il nome di via Eolia ma tutti continuavano ad indicarlo col vecchio nome. Passarono sedici mesi dalla delibera ed ora Lipari aveva corso Vittorio Emanuele che da San Pietro correva diritto fino sopra il piano. Un corso con la sua brava pavimentazione a basole ed i marciapiedi con mattoni di cemento[5].
[1] Avv. G. Raffaele, Per l’integrità territoriale del Comune di Lipari. Memoria storico-giuridica, Lipari 1951.
[2] Pubblicata a stampa sul Bollettino degli Usi Civili, anno II, fascicolo V, maggio 1932 pagine 1889 a 1959)
[3] Avv. G. Raffaele, op. cit.
[4] Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà (secondo che la popolazione fosse inferiore o superiore a 100.000 abitanti), nominati dal Ministero dell'Interno. Il podestà era inoltre assistito da una consulta municipale, con funzioni consultive, composta da almeno 6 consultori, nominati dal prefetto.
[5] G. Iacololino, Strade che vai, memorie che trovi, op. cit. , pag. 162-163.(Archivio Storico Eoliano.it)
La polemica dimentica il dramma dei lavoratori nelle cave. La "liparosi"

Una "foto di gruppo" dei cavatori con tanti.bambini.
Le condizioni di lavoro nelle cave
In tutta questa controversia fra Comune e Vescovato non si parla mai di quali fossero le condizioni di lavoro nelle cave. Innanzitutto quanti erano sul finire dell'800 i lavoratori della pomice? Vueiller nel 1893 parla di 1500 lavoratori che abitavano nei borghi di Canneto ed Acquacalda. Douglas che compie una indagine per conto del Foreing Office nel 1895 parla di 1000 addetti di cui almeno 600 destinati all'attività estrattiva; Gastone Vueiller nel suo resoconto del viaggio ci lascia due testimonianze : una diretta ed una del comandante la nave che lo trasportava a Messina.
Nella testimonianza diretta fra l'altro si legge: “ Provvisto di un cestino, di un piccone e di una lampada... l'operaio esce di casa alle quattro del mattino e arriva, dopo un'ora e mezzo di cammino, all'antico cratere. Là comincia per lui l'ascesa molto faticosa sul pendio. Alla fine raggiunge il capo di grotta, che comanda una squadra che conta dieci o quindici lavoratori. Insieme scendono tre o quattrocento metri sotto terra attraverso un sentiero inclinato. Ma prima di arrivare a quella profondità dove oggi si trova la pomice, gli operai hanno dovuto scavare per quindici o venti giorni senza profitto il fianco della montagna per aprirsi un varco attraverso la sabbia bianca, fino alle viscere del suolo. Il metodo di scavo non è cambiato da un secolo. I lavori di sostegno sono sconosciuti, ci si fida di un terreno franoso, che ogni anno causa delle vittime”.
La testimonianza del comandante della nave: “ La vita di quei poveracci è spaventosa. Nel nord avete le miniere di carbone: la vita è dura per i lavoratori, è vero, ma almeno alcune società forniscono loro dei mezzi per lo sfruttamento della miniera e il trasporto del materiale. Ci sono compagnie che li assicurano e in caso di incidenti si da una pensione alle vedove, ai vecchi. L'operaio della pomice non ha niente; lavora quattordici o quindici ore al giorno guadagnando un franco o un franco e venticinque centesimi, non di più. Vive nel paese del vino e non conosce che acqua, a tavola non conosce la carne e campa soltanto di legumi e pane cotto un mese prima. Eppure non si è mai messo in sciopero. Dopo la sua faticosa giornata, scende al villaggio con 50 o 60 chili di pomice sulle spalle, attraverso i sentieri pericolosi che ha percorso al mattino. Arriva dal sensale e deposita il suo fardello ricevendo un acconto. Quando la pomice si è seccata viene pesata e l'operaio riscuote il prezzo convenuto. E' lì che lo aspetta il sensale, o piuttosto il suo aguzzino, che stabilisce il peso a proprio piacimento. Il povero disgraziato non può protestare, perché ha ricevuto un anticipo ed ha bisogno di quell'individuo il giorno dopo...” [1].
Douglas ci informa sul lavoro dei bambini nella cave[2]. Bambini di ambo i sessi erano inviati dai loro genitori al lavoro, con stipendi ridicoli, nella raccolta del pezzame, o nel trasporto sulle spalle delle pesanti ceste lungo la ripida discesa di Canneto, sotto un sole abbagliante, per due volte al giorno. Douglas ritiene che il lavoro di trasporto era molto più duro dello scavo in grotta ed aveva effetti fortemente dannosi soprattutto sullo sviluppo dei giovani ragazzi tra i 5 e i 14 anni quali sono quelli impiegati nelle cave[3].
Un’altra testimonianza è quella di Luigi Vittorio Bertarelli fondatore del Touring Club Italiano. Reduce di una visita all'arcipelago scriveva nel 1909 che le cave sono “profonde, caldissime all’interno…coltivate con metodi vecchi, industrialmente non lodevoli ed igienicamente perniciosi.. Dura vi è l’opera di estrazione, che si fa col piccone; durissimo il trasporto all’esterno, entro sacchi e recipienti di stuoie e di vimini, al quale sono adibiti anche ragazzi giovanissimi, evidentemente senza alcun rispetto della legge sul lavoro dei fanciulli. Producono abbastanza per tutta Europa ed anzi per esportarne oltre mare. Dei vapori sono sempre sotto carico a Canneto e ad Acquacalda dove in grandi molini, di cui vari appartengono ad una ditta tedesca, si opera una cernita di materiale ed in parte la sua macinazione in mezzo ad un pulviscolo folto, persistente che si diffonde a distanza come una nebbia intorno agli stabilimenti ed è visibile a più chilometri…”[4].
 |
 |
 |
 |
Quattro immagini di lavoratori della pomice. Le foto in alto mostrano le entrate delle gallerie dove si scavava. Più fortunati quelli che lavoravano all'aperto o sul nastro trasportatore o guidando le decovilles
Fra incidenti di lavoro e "liparosi"
Non meraviglia che in queste condizioni gli incidenti sul lavoro siano all’ordine del giorno. In Consiglio comunale giungono due petizioni di vedove che chiedono che venga loro condonato il pagamento del diritto di percezione dovuto dal loro congiunto. La prima è del 28 marzo 1899 ed è della moglie di Giovanni Portelli di Nicolò Antonino che “l’abisso inghiottì tanto immaturamente …, dopo quest’altra vittima del sudato lavoro, essa è rimasta sola a piangere sul capo dei suoi quattro orfanelli, di cui il quarto porta ancora in seno, ed il secondo è cretino”. La seconda è del13 marzo 1906 e riguarda Gaetano Villanti “rimasto vittima di una frana prodotta dal terremoto dell’8 settembre ultimo, lasciando la moglie con sei figli minori, in cattivissime condizioni economiche”[5] .Nel 1921 un medico di Canneto il dott. Giuseppe Di Perri comprende e denuncia che la polvere da pomice per l’alta percentuale di silice libera e silice combinata, provoca una forma di silicosi di particolare gravità e di polimorfa evoluzione, denominata liparosi.[6]. Il rischio coinvolge anche gli abitanti soprattutto quelli che esercitano privatamente la lavorazione dei prodotti. Finalmente nel 1943 dopo vari studi ed indagini la silicosi sarà riconosciuta tra le malattie professionali.

1. Questa tabella è stata realizzata assemblando i dati presenti in G. Arena, op. cit. e Carmelo Cavallaro – La pomice nell’isola di Lipari. Aspetti geografici economici e sociali. In Atlante.. Dello stesso autore si veda anche “Le risorse minerarie delle Isole Eolie nei processi di trasformazione economica”, “Annali della Facoltà di Economia e Commercio” dell'Università di Messina, n. 12, 1978.
[1] G.Vuillier, Escursione alle Eolie, Impressioni del presente e del passato, a cura del Centro studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani, Pungitopo editore.
[2] L’11 febbraio del 1996 un Regio Decreto il n. 3657 vietava l’impiego dei bambini sotto i 9 anni di età negli opifici, nelle cave e nelle miniere e di adibire al lavoro notturno quelli inferiori a 12 anni. Ma la legge escludeva le piccole industrie, l’artigianato, i lavori agricoli, il lavoro a domicilio che erano i settori che impiegavano i minori in massa. Solo il 19 giugno del 1902 ( legge n. 242) il Parlamento italiano emanò un altro provvedimento per i minori, nel quale si elevava il limite di assunzione a 12 anni, 13 e 14 per i lavori in miniera, a 15 i minori potevano fare tutti i lavori.
[3] Copia del rapporto è conservato presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, Raccolta Amalfi, v. G. La Greca, La storia della pomice di Lipari, vol. II, pag. 78.
[4] Giuseppe Iacolino, inedito, Quaderno XI.
[5] G. La Greca, op. cit. pp. 82-83.
[6] G. Di Perri, La silicosi nei lavoratori dell’industria della pomice di Canneto-Lipari, Lipari 1950; C. Cavallaro, La pomice dell’isola di Lipari: aspetti geografici, economici e sociali, in “Bollettino della società geografica Italiana”, anno 1979 n. 4-6. pp. 277-278
La vittoria del Comune in tutti i tre gradi
Aspettando la sentenza

Nel Consiglio Comunale del 24 luglio 1915 si parla del commercio della pomice bloccato a causa della guerra. “Non si può disconoscere – informa il Sindaco - che il nostro paese vive quasi esclusivamente col commercio della pietra pomice con l'estero. Questo commercio, in seguito alla dichiarazione di guerra dell'Italia, è stato completamente sospeso e quindi si sono chiusi i mulini e sono venute meno le entrate che davano al Paese una certa agiatezza”.
Nel Consiglio comunale del 25 aprile 1916 il cav. Franza chiede al Sindaco un aggiornamento sull'andamento della causa contro il Vescovo e il notaio Paino non si fa pregare. Questa è una causa – esordisce - molto grave e la più grave che si sia mai avuta. Infatti nel passato l'avversario ha chiesto sempre una certa somma di denaro o il preteso suo diritto su di una cosa determinata. Qui invece l'avversario chiede tutto ciò che costituisce l'esistenza del Comune, chiede il suo Demanio, il suo patrimonio ed è ovvio che non può esistere comune senza demanio, senza patrimonio. Quali sarebbero le conseguenze finanziarie non occorre molto per spiegarlo. E si noti che la pretesa del Vescovo oggi ha per oggetto Lipari anzi tutto l'arcipelago che diverrebbe un feudo della Mensa Vescovile. Quanto allo svolgimento procedurale della causa si può dire che si sono avute due fasi. Nella prima i differimenti si susseguirono ai differimenti; oggi abbiamo avuto un risveglio da parte dell'avversario e siamo entrati in un periodo di febbrile attività. La causa doveva essere discussa all'udienza del 4 corrente e malgrado le forti insistenze dell'avversario, essa fu rinviata al 9 maggio giusto gli accordi presi ed anche perché, dopo la presentazione di nuovi documenti da parte del Vescovo, occorreva che essi fossero esaminati. E' già pronta la memoria in risposta a quella dell'avversario. Memoria stesa dal prof. Emanuele Carnevale. Sono dolente di non potere distribuire ora ai consiglieri la memoria, perché, benché sollecitato da diversi giorni, il Procuratore legale del Comune di Messina non ha sin'ora inviate le copie a noi destinate. Fra giorni un illustre componente del consiglio di difesa, il prof. Salvioli si recherà a Messina per esaminare e studiare i nuovi documenti presentati dal Vescovo.
Il consigliere Palamara prega il Sindaco di volere partecipare alla seduta a Messina del 9 maggio e di consentire, mettendo a disposizione un mezzo locale, di partecipare anche a quei cittadini che lo volessero. Il consigliere Ferlazzo deplora che mentre il paese è impegnato a portare avanti il Risorgimento e la libertà ci sia chi voglia rigettarci nel feudalesimo. Il Consiglio vota all'unanimità di stanziare lire 800 per il vaporetto Unione che dovrà portare il Sindaco e la commissione a Messina e per le ulteriori spese.
Il 3 luglio tutta la seduta del Consiglio verte sulla causa col Vescovo e sulla posizione assunta dal Procuratore del Re che non è intervenuto a difesa del demanio pomicifero ma, assumendo la rappresentanza del Regio Patronato, si è unito all'attore ( il Vescovo) e ne ha fatto sua l'istanza e la tesi fondamentale, dichiarando di operare così in seguito ad ordine del Ministro della Giustizia. Quest'azione del Regio Governo è, si fa notare da parte del Sindaco, in contraddizione con quella da questo sempre svolta di riconoscimento, disciplina e tutela del demanio pomicifero: riconoscimento da ultimo proclamato anche dalle legge del 5 gennaio 1908. Perciò il Consiglio delibera di elevare una rispettosa ma viva rimostranza al Governo per quanto è avvenuto all'udienza del Tribunale di Messina del 10 maggio scorso; di manifestare, ora che la causa è in decisione, la sua piena serena fiducia nella giustizia del Tribunale, di cui ossequiosamente attende la sentenza.
La vittoria del Comune

E la sentenza giunge il 23 luglio dopo che la prima sezione del tribunale civile e penale di Messina ha escusso la causa nella udienza dell'11 maggio e la discussione è continuata animatissima nei giorni 12 e 13. La sentenza è favorevole al Comune.
Anche se si tratta di una sentenza ancora di primo grado comunque rappresenta un ottimo risultato e Sindaco ed amministratori possono trarre un respiro di sollievo. Ma non è tempo di speculazioni e rivincite politiche. Il 24 maggio l’Italia aveva dichiarato guerra all’Austria e molti giovani dalle Eolie erano partiti per le armi ed altri si preparavano a partire. Inoltre le condizioni economiche della popolazione erano sempre più gravi.
Emanuele Carnevale non rinuncia però a cogliere pubblicamente il significato di una vittoria che ritiene in gran parte, ed a ragione, sua. Il 3 settembre 1916 attraverso un manifesto rivolto ai cittadini di Lipari, esulta per l'esito e rivendica il suo ruolo di estremo difensore dei diritti civili. Scriverà nelle sue memorie :”Io ne cominciai lo studio nel 1911, e principiò per me da allora una ben dura fatica, durata senza tregua sino al novembre del 1920: una fiera lotta che mi dette infine la grande soddisfazione del trionfo, ma seminò la mia strada di amarezze e di dolori, fra cui non ultimo, la mancata gratitudine del mio paese, da me salvato da grandissima iattura... Avvocato d'una delle parti, fui dall'altra selvaggiamente aggredito, in fogli volanti e memorie difensionali, con attacchi velenosi e triviali; e non mi fece scudo la calda e decisa solidarietà di coloro per i quali io subivo questi attacchi. Scrissi sei o sette memorie a sostegno degli assunti del Comune, e soltanto in alcune collaborarono due dei colleghi di difesa, ma sempre in minor grado; e del resto posso per la verità affermare che tutti gli accennati assunti furono pensati, sviluppati ed illustrati da me...Passarono dei mesi prima che essi si decidessero ad accettare il mio sistema difensivo, al quale opponevano dubbiezze e riserve che non mi persuadevano...Al momento della discussione orale in Tribunale e in corte d'Appello....dovetti sobbarcarmi ad una fatica che mi pareva superiore alle mie forze fisiche, non troppe, specie la seconda volta; ma Dio aiuta... Dovetti per più udienze sostenere quasi tutto il peso della causa, lottando contro valenti avversari...Dico quasi tutto il peso perché in Tribunale parlarono solo e brevemente i senatori Scialoia e Fadda su questioni limitate e secondarie, e poi partirono, lasciando a me tutta la sostanza della controversia; in Corte d'Appello non parlai che io, essendo completamente assente il numeroso collegio di difesa del Comune (Salandra, Scialoia, Fadda, Salvioli, Bruschettini), meno del valoroso penalista senatore Fulci, che aggiunse breve discorso ad illustrare ulteriormente alcune delle cose da me dette”[1].
La discussa sentenza della Cassazione

Carnevale lamenta di avere avuto anche poche soddisfazioni tangibili: mediocre compenso, grave fatica, e una sola volta, dopo la sentenza favorevole del 23 agosto 1916, un coro di voci popolari, si fece sentire sotto i balconi della sua villa al torrente di Santa Lucia. Vogliamo osservare come le parole di Carnevale lasciano intuire che quei dissensi e contrasti nel collegio di difesa - di cui si era parlato soprattutto nell’autunno del 1913 quando Vescovo e Sindaco si incontrano a Roma nell’ufficio dell’on. Ugo di Sant’Onofrio per verificare se c’erano le condizioni di una transizione - erano tutt’altro che false.
Quanto alla partecipazione popolare a dire il vero, osserva Iacolino,[2] l'adesione partecipativa dei liparesi ci fu, e si estrinsecò fervida, appassionata e clamorosa, ma solo nei primi anni quando la cosa aveva il fascino della novità e le cronache del processo rimbalzavano in mezzo a quello stato d'animo euforico che anche nelle Eolie, come in tutta Italia, era alimentato dal nazionalismo, dalla propaganda bellica per l'impresa di Libia e dall’individualismo anarchico praticato dal D'Annunzio e proclamato da Filippo Tommaso Marianetti.
La sentenza d’Appello giunge a conclusione delle udienze che vanno dal 10 al 19 agosto del 1918 ed infine il 10 gennaio 1921 giunge anche la sentenza favorevole della Corte di Cassazione.
“Per mons. Paino – commenta Iacolino – fu come un colpo di lancia infertogli a tradimento. Egli non se l'aspettava davvero quel verdetto tanto più che l'ultima fase del dibattimento doveva essere decisa da una sezione presieduta dal prof. Mariano D'Amelio il quale per il suo equilibrio e per la sua imparzialità ispirava la miglior fiducia. Ma all'ultimo momento comparve sullo scanno il prof. Sen. Lodovico Mortara, già ministro della Giustizia, notoriamente 'ebreo e massone'[3].Nell'animo di mons. Paino quel nome risuonò come il preludio di un fallimento totale e irreversibile”[4].
“Un decennio di studi (1911-1921) – osserva concludendo il suo saggio il prof. Marcello Saija – nel quale otto secoli vengono passati al vaglio della più sagace curiosità. Questo sforzo che ha impegnato valenti storici del diritto ed ha permesso, con un notevole carico finanziario per le parti in contesa,di raschiare archivi italiani e stranieri, attende ancora oggi di avere frutti maturi[5]”.(Archivio Storico Eoliano.it)
Transare o andare in giudizio?
Gli intransigenti si oppongono ad ogni mediazione
 Ora anche la situazione generale spinge per una mediazione e il Prefetto il 14 dicembre cerca di farlo capire al Sindaco, anzi gli mette per iscritto la richiesta da leggere in Consiglio Comunale.
Ora anche la situazione generale spinge per una mediazione e il Prefetto il 14 dicembre cerca di farlo capire al Sindaco, anzi gli mette per iscritto la richiesta da leggere in Consiglio Comunale.
Ma il partito intransigente è sulla difensiva. E’ riuscito già una volta a bloccare le manovre per un accordo ed è il momento per giocare d’anticipo prima del Consiglio comunale convocato per il 26 dicembre. Viene fatta circolare nel paese una lettera aperta al Sindaco
Così, quando si apre il Consiglio, il Sindaco è obbligato a partire proprio da questo fatto.
E' circolata - dice - una lettera aperta al Sindaco, a stampa, sulla vertenza Comune- Mensa vescovile, dove dietro i “si dice”, si avanzano delle insinuazioni. La lettera porta la firma dei Consiglieri comunali Palamara, Giacomo Maggiore, farmacista Salvatore Fenech, notaio Salvatore Scolarici e si chiede al Sindaco di rendere di pubblica ragione i motivi dei ripetuti incontri col Prefetto ed. in particolare, se fosse vero che questi aveva esercitato vere e proprie pressioni per transare la causa con la Mensa vescovile.
Il Sindaco smentisce di avere avuto, nel merito, delle imposizioni da parte del prefetto e che a questa discussione sarebbe intervenuto anche il vescovo. Nessun prefetto può imporre alcunché ad un Sindaco e le transazioni non le fa il Sindaco ma il Consiglio comunale. Comunque una lettera del prefetto Buganza scritta il 19 dicembre, è arrivata al Sindaco e questi ne dà lettura integrala. In essa, fra l'altro, si dice: “La Mensa Vescovile si batte pel conseguimento di un vantaggio, il comune si batte per la propria medesima esistenza. Soccombendo l'avversario la Mensa Vescovile rimane pressapoco quello che è, col solo danno delle spese; soccombendo il comune, il comune è finito. Ora, l'Amministrazione Comunale si è essa resa conto di questa formidabile situazione? Si assume che già da tempo il collegio di difesa opportunamente interpellato dal Municipio sulle probabilità della causa, non sia stato troppo esplicito ed abbia emesso un parere dubitativo. E' così? Se lo è, io penso che l'amministrazione debba ben ponderare quello che fa, come penso che nemmeno l'autorità tutoria debba rimanere indifferente di fronte ad un andamento di cose che può essere periglioso. Se non lo è, ed io auguro e spero che non lo sia, mi pare che dopo trascorso tanto tempo nel quale la causa non ha fatto un passo, l'amministrazione debba ad ogni modo mettersi in grado di sapere a che punto siamo e quali siano oggi, dopo tante ricerche di documenti e rinvii della causa, le probabilità che presenta. Inseguire supinamente le vicende forensi per avventura fino ad ora poco attive, mi pare incauto da parte dell'amministrazione comunale, la cui responsabilità non finisce con la nomina di un collegio di difesa. Io troverei pertanto non solamente prudente, ma doveroso che, profittando di questo periodo di sosta, il Comune invitasse il Collegio della difesa a riferire sullo stato della causa, sui presidi approntati per sostenerla, sulla probabilità che i patrocinatori illuminatissimi ai quali è affidata, prevedono. Questa, ripeto, non è una lite ordinaria; e non è semplicemente una lite grave; essa è per il Comune vitale, investendone la sua stessa esistenza. E quindi necessita che gli amministratori responsabili, sappiano come procede e presumibilmente come potrà finire.”.
A questo punto si apre la discussione. L’avv. Palamara anche a nome del notar Maggiore, notar Scolarici e del farmacista Fenech si dichiara soddisfatto nel sentire che l'amministrazione attiva difenderà ad oltranza i diritti del Comune, non è soddisfatto invece della risposta data a proposito dei “si dice” sugli avvenuti colloqui e pressioni vescovili. La risposta non è chiara. Che i “si dice” siano veri e che le pressioni vi siano state è dimostrato dalla lettera del Prefetto, nella quale si consiglia la transazione.
Il Sindaco ribadisce che non vi è stata nessuna pressione e nessun intervento di terzi ai colloqui.

Il Prefetto vuole la transazione
Palamara ribadisce che la lettera del Prefetto non rispetta la realtà dei fatti quando dice che gli avvocati hanno emesso dei dubbi sul buon diritto del Comune, ma offende il Consiglio e lede gli interessi e la dignità del paese. Propone che la seduta si sciolga in segno di protesta.
L'assessore Onofrio Paino parla della situazione internazionale e della lotta di libertà contro l'imperialismo austro-tedesco. “Tutto questo non commuove il Vescovo di Lipari, il quale va ramingo di porta in porta per chiedere ausilio e protezione per restaurare una delle antiche signorie in queste Isole Eolie, le quali al par di tutti gli altri italiani, altra Signoria non riconoscono, se non che quella che regna per grazia di Dio e volontà della nazione, quella cioè della gloriosa casa Sabauda. Lipari, malgrado i consigli del Prefetto che desidererebbe la transazione col Vescovo, non cederà un palmo delle sue terre a chicchessia”.

Il consigliere dott. De Mauro dice di non spiegarsi la lettera del Prefetto che contiene notizie che non potevano essergli date che dalla parte avversa al Comune. E' il Vescovo che insinua che vi è incertezza fra gli avvocati del Comune, mentre lui che ha partecipato all'ultima loro riunione sa che sono tutti convinti e compatti. Perchè il Prefetto si è fatto l'opinione solo sulla base delle informazioni del Vescovo e non ha chiesto ad altri come i consiglieri provinciali del comune?Il Vescovo continuerà con l'intrigo e con l'inganno per trarre dalla parte sua la pubblica opinione. La lettera odierna è provocata dall'intrigo del Vescovo che carpisce la buona fede del Prefetto. Anche Paino si unisce a Palamara nel chiedere di togliere la seduta.
Il consigliere Franza protesta sdegnosamente contro l'operato del Vescovo, il quale non ha lasciato mezzo intentato per ottenere una transazione che Consiglio e cittadinanza non vogliono a qualsiasi costo.
Il consigliere Ferlazzo informa che tutti i documenti a sostegno della tesi del Comune sono pronti da tempo e che i rinvii di discussione dipendono dalle convenienze ora dell'una ora dell'altra parte.
Il consiglio approva all'unanimità una mozione del consigliere Palamara che dichiara di togliere la seduta in segno di protesta perchè giudica lesiva della dignità del Consiglio la lettera del Prefetto.
La riunione del Consiglio e le nuove manifestazioni di piazza mettono la parola fine alle possibilità di accordo e mons. Paino ne prende atto: “Il Vescovo di Lipari – si legge in un breve comunicato – che lotta più per l'adempimento di un dovere che per il riconoscimento di un diritto, si era illuso che potesse il ragionamento produrre l'effetto salutare di far comprendere ad un popolo, sobillato da pochi, che le questioni di diritto non si discutono in piazza e che le grida incomposte della folla irresponsabile non possono né creare, né annullare diritti secolari. Egli è cittadino ma è anche Vescovo, e quando ha fatto il possibile per conciliare i suoi doveri contrapposti, la responsabilità di questa causa cade su chi l'ha voluta, chiudendo gli occhi alla luce meridiana che viene dai documenti della Mensa”.
In questo ultimo scorcio di causa circolano documenti e memorie e in tutti il motivo dominante non è più quello dell'autenticità e della veridicità dei documenti concessori, ma si sposta sulla natura dei titoli e su quale fosse la natura della concessione che davano e potevano dare i vescovi.(Archivio Storico Eoliano.it)

Si delinea il conflitto Vescovado - Comune
Il Vescovo chiama in giudizio il Sindaco

Il 29 aprile 1911 mons. Paino cita in giudizio il Comune di Lipari. Lo fa quando vede che la via della trattativa pacifica non è possibile ed intuisce che sulla questione si era ormai innescato un disegno politico Premurandosi di far sapere, con un foglio a stampa, il suo immutato convincimento a definire il contenzioso in via transattiva e a ritirare l'istanza in qualsiasi momento si fossero create le condizioni per l'accordo.
Nella chiamata in giudizio del Sindaco di Lipari al Tribunale di Messina il Vescovo vuole: “
1.Far dichiarare che nessun diritto sia di proprietà che di possesso, può il comune vantare sulle terre pomicifere esistenti nel territorio di Lipari nelle contrade: Pilato, Montepilato, Russo, Rocche Castagna, Grotta delle Mosche, Acqucalda, Foss Castagna, Serro, Rocche Rosse, Chirica, Altapecora, Serro della Chirica, Monte Bianco, Porticello e altre denominazioni, ed inibirgli di più rilasciare licenze per la escavazione della pomice.
2.Far dichiarare che questo diritto di scavazione, come di ogni altro di assoluto proprietario, compete allo istante, libero da ogni vincolo, per titolo certo ottenuto dai sovrani normanni nel secolo XI, confermato dagli stesi nel secolo successivo ed esercitato dalla Mensa nei secoli a seguire, salvo l'obbligo di corrispondere quelle tasse che possano essere dovute, e sono effettivamente pagate a norma di legge da tutti gli altri proprietari di terre pomicifere.
3.Far condannare il Comune di Lipari alla rifazione dei danni ed interessi da liquidarsi in separata sede per l'arbitrario esercizio di un diritto che non gli compete e che ha ostacolato l'esercizio dei diritti di proprietà dell'istante.
4.Far condannare il Comune di Lipari alle spese tutte del giudizio e competenze degli avvocati in causa, munendo l'emettenda sentenza di clausola esecutiva salvo ogni altro diritto od azione”[1].
La squadra di studiosi che il Vescovo schiera è di alto livello. Oltre al prof. Garufi di cui si è detto, vi sono il prof. Filomusi Guelfi e il prof. Francesco Scaduti.
Contro l’iniziativa del vescovo si costituisce il Comune di Lipari. Il 4 maggio 1911 il Consiglio comunale è chiamato a ratificare la delibera della Giunta “a stare in giudizio e nominare un collegio di difesa contro il Vescovo di Lipari”.Il collegio del Comune sarà composto oltre che dall'avv. Emanuele Carnevale, dall'avv. Ludovico Fulci, ordinario di diritto penale, incaricato di storia del diritto all'Università di Messina e deputato al Parlamento, dal prof. Giorgio Arcoleo, ordinario di diritto Costituzionale all'Università di Napoli e senatore del Regno, da Arnaldo Bruschettini, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Roma, da Carlo Fadda, ordinario di Diritto Romano nell'Università di Napoli e deputato al parlamento, da Giuseppe Savioli, storico del diritto ed autore di parecchi saggi in materia di decime ecclesiastiche, da Vittorio Scialoia. ordinario di Diritto romano all'Università di Roma, senatore e, fino a pochi mesi prima, ministro della Giustizia. Al Prefetto tutti questi nomi altisonanti sembrano troppi ma il Sindaco fa osservare che non si tratta di un giudizio di routine ma di una causa decisiva per il Comune.

La risposta del Comune: si costituisce in giudizio e avvia la polemica
Oltre a decidere di stare in giudizio ed a nominare il collegio di difesa, questo Consiglio dà il via ad una fase fortissima di polemiche con il vescovo che si protrarrà per oltre due anni fino a quando nell'agosto del 1913 Paino lascerà Lipari. La posizione non solo dei consiglieri democratici – tendenzialmente anticlericale - che rispecchiano la posizione massonica e laica, ma anche quella dei popolari è di sdegno morale per una strategia, quella del Vescovo, che appare loro anacronistica e viene giudicata tendente a restaurare il “dominio temporale”.
Onofrio Paino, nel suo intervento, afferma che “gli sanguina il cuore al solo pensare che un Vescovo nativo delle isole Eolie sia venuto per ostacolare il risorgimento economico di queste popolazioni” e comunque bisogna accettare il guanto di sfida che egli ha lancito e abbattere definitivamente un potere temporale ormai condannato dalle nazioni più civili del mondo. Il Consigliere Paternò pur dichiarandosi d'accorso sulla difesa dei diritti del Comune non lo è per la sfida contro il potere temporale. Non è di questo che è chiamato a discutere il consiglio A questo punto il pubblico in sala e fuori comincia a protestare tanto che il Paternò è costretto a interrompere il suo intervento. Il Consiglio approva la delibera con 18 voti a favore ed uno astenuto ( Paternò).
Non ci fu un'eco collettivo e universalizzato di odio nel confronto del Vescovo ma una polemica che si trascinò per tre anni dal 1011 al 1013 sulle strade e sulla carta stampata.. Non furono mai più di ottanta o cento i cittadini che improvvisarono manifestazioni pubbliche per le vie del paese con alla testa un drappello di borghesi, di massoni e di esponenti del Partito Democratico e del socialismo. In prima fila si notavano il farmacista Nunzio Esposito, il dott. Francesco De Mauro, il dott. Gaetano Fenech, l'ingegnere Gaetano Martinez, don Giuseppe Bonica, don Domenico Ziino, don Edoardo Bongiorno, don Giuseppe Tonelli e persino i sacerdoti don Emanuele Scolarici e don Emanuele Palmisano. Anzi lo Scolarici era solito portare lui la bandiera italiana e gridare con quanto fiato aveva in gola “Abbasso il Vescovo”.[2]
Quanto alla carta stampata il riferimento è ad un mensile, formata da due fogli, dal titolo “La voce della Patria. Cronaca mensile delle Isole Eolie” diretto da Giuseppe Favorito. A questo periodico ed ai foglietti volanti che alimentavano la polemica da parte laica si risposte da parte “cattolica” con due o tre pieghevoli propagandistici firmati “ da un gruppo del Clero”.
Nel mese di maggio esce un volantino a cura di questo gruppo denominato “Una parola serena” che faceva riferimento alle prime dimostrazioni di piazza e ricostruiva la posizione del vescovo con la spiegazione del motivo che l'avevano condotto a agire contro il Comune dopo aver tentato la via amichevole, e comunque sempre pronto a rivedere la posizione se ci fosse stato un cenno di attenzione e di distensione.
Verso giugno o luglio da parte laica si fa uscire un “foglio volante” intitolato “La libertà delle terre di Lipari”. Il suo autore , un certo B.T.; si difende su “La Voce della patria” dalle accuse di “veemenza” dicendo di avere una ferma convinzione “che Mons. Paino non è un ignorante, ma semplicemente un giovane pastore inesperto, consigliato e guidato da un essere le cui opere, diremo col poeta, non furono “mai leonine , ma di volpe”[3].
La polemica dilaga sui giornali e per le strade
Nel 1911 il collegio non era ancora entrato in funzione e il prof. Carnevale replica alla memoria del vescovo, utilizzando un parere del prof. Savioli e stampa un saggio intitolato “La libertà delle terre di Lipari ed il preteso dominio del Vescovo”[4]. Le linee d'attacco sono tre: il dubbio sull'esistenza dei diplomi normanni per cui le “prove” del Garufi sarebbero solo “indizi”; l'insufficienza sostanziale del diploma di conferma del 1134 – per cui l'inciso che fa riferimento alle isole potrebbe essere una interpolazione effettuata in epoche successive -che nonostante l'analisi del Garufi resta comunque inutilizzabile; la possibilità che il Constitutum, in assenza di esplicito riferimento, possa avere una fonte di legittimazione diversa da quella indicata dal Garufi o addirittura non averne alcuna. Detto questo in via principale, Carnevale in via subordinata sostiene che, pur ammettendo l'autenticità e veridicità dei titoli concessori, la natura dei poteri che venivano dati all'abate traeva origine non dalla proprietà della terra ma dal diritto concesso al signore di amministrare e di esercitare su di essa la giurisdizione. Si trattava insomma di una concessione di feudo (signoria politica) e non in allodio( in proprietà privata). Questo feudo, aggiunge Carnevale, finisce con l'intestazione della Capitania e della Castellania di Lipari a Antinolfo da Procida nel 1357 e a Federico Chiaramonte nel 1366 e se i vescovi continuano a fare concessioni enfiteutiche sino all'800 é per via dell'esercizio abusivo di un potere utilizzando la lontananza delle isole dai centri da cui promanava l'autorità sovrana. E comunque, in via subordinata, questo feudo non esiste più con la legge del 1812 che ha tolto di mezzo i poteri feudali.
Da questi presupposti si dipana tutta una polemica con battute acide soprattutto fra il Garufi ed il Carnevale. Quindi la polemica dilaga non solo per le strade, non solo sui fogli volanti d'attacco e sui giornaletti locali, ma anche sulle riviste di studio. Parleremo più avanti di questo clima di scontro che si crea nel paese. Qui basti qualche rapido accenno. La “Voce della Patria”, il giornaletto locale che incontreremo più avanti, saluta calorosamente ed enfaticamente il rientro a Lipari di Carnevale[5]: “Tu sei vero figlio, vero amico, sii benedetto!”mentre gli attacchi al vescovo, speso irriverenti ed oltraggiosi sono ormai all’ordine del giorno.
Mons. Paino lascia Lipari
Ed è in questo clima che un giorno, nel dicembre 1912, corse voce – ma forse era solo il parto dell'eccitazione del momento – che qualcuno avesse pensato ad assoldare un ex coatto che viveva ai margini della società, perchè procedesse all'eliminazione fisica del vescovo. Di concreto c'era solo il racconto dei familiari di mons. Paino che in una fredda serata, lasciando il palazzo dove avevano assistito il prelato, per far ritorno alle loro abitazioni, all'estremità del viale, nei pressi delle gibbie scorsero un individuo dall'atteggiamento sospetto che cercava di nascondersi dietro una siepe. Il giovane nipote del vescovo, anche lui di nome Angelo Paino, si avvicina e lo invita a venire allo scoperto. Lo riconosce e perquisendogli gli trovava addosso un coltello. Lo stesso nipote sporge denuncia al commissariato ma , arrestato l’ex coatto, non si arrivò ad alcuna incriminazione.
Forse non fu per questo fatto, forse intervennero altre considerazioni comunque in un canicolare pomeriggio di agosto del 1913 mons. Paino fu visto uscire dal palazzo tutto solo, con una valigia contenente effetti personali e carteggi vari, e dirigersi verso Marina Corta dove si appartò nella chiesetta del Purgatorio. Lì attese che arrivasse l'Adele, il vaporetto di linea, alle 15. Prese posto sulla barca del rollo e salì a bordo. Mons. Paino si diresse a Messina dove fu accolto dall'arcivescovo Mons. Arrigo che qualche anno dopo, alla fine del 1916, lo nominò suoi ausiliare pur restando Amministratore apostolico di Lipari.

Perchè questa partenza che da qualcuno fu interpretata come una fuga? Per restituire all'isola un po' di serenità giacchè la sua sola presenza non faceva che rinfocolare le passioni? Può essere, m forse lui stesso pensò che fuori da Lipari, in una realtà come Messina, avrebbe avuto maggiore libertà di movimento per seguire la vertenza e nell'esercitare le opportune pressioni diplomatiche su enti e personaggi da cui potesse sperare appoggi e mediazioni. Infatti solo qualche settimana dopo è a Roma per cercare di pervenire ad un accordo col Sindaco.
E’ tra settembre e ottobre del 1913 che a Roma nello studio dell'on. Ugo di Sant'Onofrio avviene un incontro a cui partecipa mons. Paino con alcuni suoi consulenti e il Sindaco di Lipari accompagnato da un consigliere provinciale e da due consiglieri comunali. All'incontro non era presente l'avv. Carnevale. Il vescovo consegnò nuove memorie e disse di rimettersi al giudizio degli avvocati del Comune. L’impressione è che nel collegio difensivo del Comune vi siano dei contrasti e forse le tesi sostenute dal prof. Carnevale non sono sempre condivise dagli altri membri. Certo il marchese Sant’Onofrio che si era fatto promotore dell’incontro dovette sostenere la tesi della possibilità di una mediazione e forse, poggiandosi sull’ascendente che aveva nei confronti degli amministratori eoliani - anche se il Sindaco da aprile non era più il cav. Giuseppe Franza ma il notaio Gaetano Paino, parente del prof. Carnevale - qualche ipotesi dovette farla. Se in quella sede non si definì alcun accordo però qualche spiraglio si dovette aprire.
Ai primi di gennaio gli avvocati del Comune fanno giungere al Sindaco un invito a partecipare ad una riunione del collegio di difesa convocata a Napoli per il primo febbraio con l'obiettivo di adottare importanti decisioni di strategia processuale in vista dell'udienza ormai prossima. Qualcosa deve essere avvenuto fra l’autunno e l’inverno a raffreddare le ipotesi di mediazioni se pure ne erano state fatte. Così nella Giunta del 30 gennaio si decide che non è il caso che intervengano amministratori in un incontro di luminari della scienza del diritto. Anzi nel deliberato di Giunta si rinnova piena fiducia all'avv. Carnevale ed agli altri membri del collegio, segno che Carnevale aveva ripreso pienamente il controllo della situazione.
Intanto a livello internazionale spirano venti di guerra che raffreddano le relazioni commerciali ed il 21 agosto 1914 , durante la discussione sul Bilancio il Sindaco osserva che siamo entrati in un periodo di crisi allarmante che ha determinato la soppressione totale del nostro commercio della pomice, l'unica fonte di ricchezza per noi. Il ristagno del commercio ha portato alla disoccupazione di operai e al Comune sono giunte varie domande di sussidio. Troppe, per poterle prendere in considerazione. Il Consiglio comunale l’1 settembre si interroga sul che fare. L’unica possibilità è dare il via a dei lavori pubblici che creerebbero occasione di nuovo lavoro. La proposta è quella di appaltare subito i lavori della rotabile Lipari- Canneto. La costruzione della rotabile rappresenterebbe un sollievo in questa direzione.
[1] Dall’atto di citazione del 29 aprile 1911, ripreso dal dispositivo della sentenza di primo grado, registrata in Messina l’11 settembre 1916, vo. 160, numero 261, foglio 97, in M.Saija,La seconda controversia liparitana, op. cit., pag.127.
[2] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno XI
[3] Il riferimento è a don Giovanni Paino esperto segretario della Curia detto Alazza per via che andava in giro sempre con un mantello che per l'andatura claudicante sembrava un'ala svolazzante
[4] E. Carnevale, La libertà delle terre di Lipari e il preteso dominio del Vescovo. Ragioni esposte in difesa del Comune, Stabilimento tipografico Carlo Nava, Siena 1911.
[5] Nel 1911 il prof. Emanuele Carnevale che viveva ormai stabilmente a Palermo dove insegnava torna a Lipari per distribuire la sua “memoria” a favore del Comune intitolata “La libertà delle terre di Lipari e il preteso dominio del Vescovo” che era stata stampata a Siena. A Lipari non aveva molta sintonia con la classe politica locale perché era ritenuto un radicale di estrema sinistra mentre al Comune la maggioranza era moderata. Nel 1919 il Carnevale sarà eletto vice presidente dell’Unione radicale di Palermo e poi presidente.(Archivio Storico Eoliano.it)
Mons. Paino fa una proposta di mediazione
Mons. Paino, un vescovo eoliano
 Quando il Parlamento approva la leggere n. 10 la sede vescovile di Lipari è vacante da più di due anni ed era stata retta da Amministratori apostolici. Dal 6 dicembre 1906 al 2 luglio 1907 da mons. Francesco Raiti[1] che era stato eletto vescovo di Lipari il 22 luglio 1903 e trasferito a Trapani il 6 dicembre 1906, dal 13 luglio 1907 al 13 luglio 1908 da mons. Audino[2] che era stato già vescovo di Lipari dal 1898 e poi era divenuto vescovo di Mazzara del Vallo e dal 13 luglio 1908 al 20 aprile 1909 dall’arcivescovo di Messina mons. Letterio D’Arrigo[3].
Quando il Parlamento approva la leggere n. 10 la sede vescovile di Lipari è vacante da più di due anni ed era stata retta da Amministratori apostolici. Dal 6 dicembre 1906 al 2 luglio 1907 da mons. Francesco Raiti[1] che era stato eletto vescovo di Lipari il 22 luglio 1903 e trasferito a Trapani il 6 dicembre 1906, dal 13 luglio 1907 al 13 luglio 1908 da mons. Audino[2] che era stato già vescovo di Lipari dal 1898 e poi era divenuto vescovo di Mazzara del Vallo e dal 13 luglio 1908 al 20 aprile 1909 dall’arcivescovo di Messina mons. Letterio D’Arrigo[3].
La nomina a vescovo di Lipari – che è del 12 luglio 1909 - raggiunge mons. Angelo Paino[4] mentre è a Santa Marina Salina, sua cittadina natale.Parleremo nel prossimo capitolo di questo importante personaggio della storia eoliana: qui ci interessa specificamente per la controversia sulla pomice. Il 9 agosto 1909 inizia il suo ministero e probabilmente già lavora ad una ipotesi di transazione. La soluzione a cui pensa parte dalla posizione classica della Chiesa di Lipari ma contiene alcuni tratti di novità. Le prospettive di crescita della produzione e commercializzazione della pomice, l'esistenza della legge n.10, la creazione di un consorzio che toglierebbe la concorrenza fra produttori locali – di cui si parla e che un clima di pacificazione favorirebbe - ,permetterebbero un sicuro sostentamento per tutti: per gli scavatori, per il Comune e , pensa, il nostro giovane vescovo, anche per la mensa. Anche se Paino ritiene che la Chiesa ne abbia diritto non pensa a rivendicare le decime perchè questo provocherebbe sterili conflittualità dannose per l'azione pastorale. Si concentra quindi sui terreni pomiciferi ed osserva che niente cambierebbe per i cavatori se in luogo di pagare un fitto al Comune lo pagassero alla mensa. Certo qualcosa cambierebbe per il Comune ma non tantissimo giacchè il Comune con la legge n. 10 i maggiori introiti li riceve dalla tassa per l'escavazione della pomice che grava sulle proprietà pubbliche come su quelle private. E tale tassa dovrebbe essere pagata anche alla Chiesta una volta riottenuta le proprietà delle terre pomicifere.
La proposta di mons. Paino per la pomice
Il Comune perderebbe solo gli introiti sulle concessioni, ma non tutti perchè, al fine di ricompensare queste perdite, il vescovo. pur deciso a rivendicare tutte le terre, sarebbe disposto a trattenerne solo un parte, lasciando l'altra nella disponibilità della municipalità. Una posizione questa, sulla quale il Paino rifletteva da tempo e, probabilmente, sugli aspetti storici e giuridici fin da 1907, quando rettore del seminario di Trapani aveva avuto modo di ascoltare una conferenza del prof. Carlo Alberto Garufi sulla storia dei monasteri greci e latini in Sicilia e quindi anche del Monastero di San Bartolomeo. Il docente di Paleografia latina e diplomatica dell'Università di Palermo, doveva aver riferito in quell'occasione di avere trovato, quattro anni prima, nell'Archivio Capitolare di Patti, un documento inedito, di tale importanza, da permettere il completamento del mosaico di conoscenze sul Monastero di Lipari: il Constitutum originario dell'Abate Ambrogio. E proprio il Constitutum era il nuovo documento che si aggiungeva a quelli di Ruggero, di Urbano II, di Ruggero II …sancendo il buon diritto della Chiesa di Lipari sui terreni delle isole.
Da qui, da queste potenziate premesse storiche e giuridiche, prendeva le mosse la proposta economica che il Paino aveva elaborata..
E nei primi mesi del 1910, è questa l'ipotesi che Mons. Paino spiega al Sindaco di Lipari, il cav. Franza, popolare e buon cattolico, in un incontro privato. “Raccoglierò documenti e ragioni – così il vescovo riassumerà qualche tempo dopo la sua posizione - che farò studiare e vagliare dai miei avvocati. Lo studio di questi avvocati presenterò al Comune, il quale lo sottoporrà agli avvocati suoi; e se questi, sia pure dopo un'amichevole discussione coi miei legali, troveranno infondata la pretesa, io vi chiederò scusa del disturbo e non se ne parlerà più, se invece si conosceranno i diritti della mensa, allora e solamente allora io dirò: questi diritti non li voglio fare valere tutti perché amo anch'io il mio paese, e non voglio che esso abbia per me iattura”[5].Egli ne vuole riconosciuta una parte e dice anche come intende spenderla : una parte andrà a vantaggio del Seminario e quindi del ginnasio aperto a tutti e non solo ai chierici; una parte al capitolo della cattedrale; una parte ai curati poveri; una parte per gli istituti di beneficenza ed “una tenue rendita infine sarà per la Mensa”.
 Sebbene la proposta avesse accolto il consenso dell'on. Ugo di Sant'Onofrio, trovò il Sindaco molto freddo alle posizioni del vescovo. Probabilmente sapeva che il partito dell'intransigenza a Lipari era fortissimo e non poteva spuntarla. E questo partito era capitanato dall'avv. Emanuele Carnevale, che era divenuto nel frattempo, docente alla cattedra di diritto e procedura penale dell'Università di Palermo. Carnevale era stato anche candidato come deputato nel collegio nelle elezioni del maggio 1909 ma nulla aveva potuto contro Ugo di Sant'Onofrio che l'aveva sconfitto con 1285 voti contro 322. Questo voleva solo dire che una sua contrapposizione con l’esponente popolare su questo terreno non poteva che favorirlo in prospettiva se avesse di nuovo voluto tentare l’avventura politica.
Sebbene la proposta avesse accolto il consenso dell'on. Ugo di Sant'Onofrio, trovò il Sindaco molto freddo alle posizioni del vescovo. Probabilmente sapeva che il partito dell'intransigenza a Lipari era fortissimo e non poteva spuntarla. E questo partito era capitanato dall'avv. Emanuele Carnevale, che era divenuto nel frattempo, docente alla cattedra di diritto e procedura penale dell'Università di Palermo. Carnevale era stato anche candidato come deputato nel collegio nelle elezioni del maggio 1909 ma nulla aveva potuto contro Ugo di Sant'Onofrio che l'aveva sconfitto con 1285 voti contro 322. Questo voleva solo dire che una sua contrapposizione con l’esponente popolare su questo terreno non poteva che favorirlo in prospettiva se avesse di nuovo voluto tentare l’avventura politica.
Marchese Ugo di Sant'Onofrio in tenuta militare
[1] Mons. Francesco M. Raiti nato a Linguaglossa in provincia di Catania il 7 febbraio del 1868. Divenuto monaco dell’ordine dei Carmelitani nel monastero di Malta, si laureò a Roma dove rimase ad insegnare filosofia e teologia nel Collegio Carmelitano di S. Alberto Magno. Viene eletto vescovo di Lipari il 22 giugno del 1903 ma giunge in diocesi fra il febbraio e il marzo del 1904. L’1 novembre 1905 approvava la costituzione dell’Istituto delle Suore Francescane dell’Immacolata concezione di Lipari. Entrò in conflitto con le Suore di Carità di Lipari che lo accusavano di favorire il nuovo istituto francescano a loro danno. Inoltre l’Amministrazione comunale lo minacciava di un’azione penale per non avere portato avanti la scalinata della Cattedrale iniziata dal suo predecessore. Per tutti questi motivi il vescovo chiese il trasferimento dalla diocesi e l’ottenne nella diocesi di Trapani rimanendo Amministratore apostolico di Lipari sino al 2 luglio 1907. Morì a Trapani l’1 maggio del 1932.
[2] Mons. Nicolò M.Audino nato a Vallelunga in provincia di Caltanissetta il 15 ottobre 1861. Laureato in teologia e diritto canonico all’Università Gregoriana di Roma. Venne nominato vescovo di Lipari il 28 novembre 1898. Prese possesso canonico della diocesi l’1 gennaio 1899 e fece solenne ingresso a Lipari il 15 marzo dello stesso anno. Nell’agosto del 1900 organizzò un grande pellegrinaggio a Roma degli eoliani per l’anno santo con oltre 150 persone di cui 50 religiosi.. Nei quattro anni della sua permanenza a Lipari espletò per ben tre volte la visita pastorale in tutte le borgate e frazioni dell’arcipelago. Venne trasferito a Mazzara del Vallo nel giugno del 1903 dove morì il 20 giugno 1033.
[3] Mons. Letterio D’Arrigo era nato a Messina il 15 novembre del 1849, Fu canonico teologo alla Cattedrale della sua città. Divenne arcivescovo di Messina il 25 marzo 1898. Rimasto illeso nel terremoto di Messina del 1908 si diede ad organizzare i soccorsi e quindi all’opera di rinascita civile e religiosa della città malgrado gli ostacoli della massoneria che non voleva che si ricostruissero le chiese preesistenti. Morì a Messina il 18 dicembre 1922.
[4] Mons. Angelo Paino, era nato a S.Marina Salina il 20 giugno del 1870. Si era laureato in teologia a Napoli ed in filosofia e diritto ecclesiastico civile a Roma presso l'Accademia di S. Tommaso. Aveva insegnato nei seminari. Nel novembre del 1898 fu chiamato dal vescovo di Anglona e Tursi in Calabria a ricoprire la responsabilità di rettore in seminario insegnandovi anche teologia . Verso il 1907 fu chiamato da mons. Raiti a Trapani per interessarsi della formazione morale dei chierici. L’anno dopo rifiutò la nomina a vicario generale dell’arcidiocesi di Messina che gli offriva mons. D’Arrigo per non tradire le aspettative del vescovo di Trapani. Eletto vescovo di Lipari il 20 aprile 1909 all’età di soli 39 anni, prese canonico possesso della diocesi il 22 agosto 1909. Nell'ottobre 1916, su richiesta dell'arcivescovo D'Arrigo, fu nominato, sub secreto, ausiliare di Messina, governando la sua diocesi di Lipari dal capoluogo. Il 10 gennaio 1921 fu eletto arcivescovo titolare di Antinoe e coadiutore con diritto di successione di mons. Letterio D'Arrigo Ramondini. Quindi, il 22 dicembre 1922, fu eletto vicario capitolare, il 10 febbraio 1923 la sua nomina ad Arcivescovo Metropolita di Messina e Archimandrita del SS. Salvatore fu confermata dalla Sede Apostolica e il 3 marzo dello stesso anno prese canonico possesso dell'Arcidiocesi di Messina.Fu assistente al Sacro Soglio e resse l'arcidiocesi sino al 7 marzo 1963, giorno in cui furono accolte le dimissioni presentate per l'età avanzata. Di conseguenza fu trasferito alla sede arcivescovile titolare di Serre di Macedonia. Decano dei vescovi del cattolicesimo, si spense nel Seminario Arcivescovile di Messina il 29 luglio 1967 all'età di 97 anni.
[5] Genuardi, Siciliano, Scaduto, Garufi, Il dominio del Vescovo nei terreni pomiciferi dell'isola di Lipari, Acireale 1913.(Archivio Storico Eoliano.it)
La "leggina" sulla pomice
Il problema del contrabbando

G.Vuillier, Calandra di Canneto
Nel frattempo il problema del contrabbando si era fatto sempre più spinoso e più scandaloso quando apparve evidente che in questi traffici erano coinvolti non solo operai ma anche alcuni proprietari e quindi persino consiglieri comunali ed alcuni assessori[1] tanto che si arrivò a dare la sfiducia , nel Consiglio del 26 agosto 1906, intrecciandosi il problema del contrabbando con l’inchiesta sulle guardie campestri, sulla base di un ordine del giorno presentato dal consigliere Carnevale con sedici voti contro dodici, all’amministrazione Faraci.[2]
Sulla vicenda del contrabbando furono promosse due inchieste ministeriali. Di grande interesse l’analisi che, di questo fenomeno fa, nella sua relazione l’ing. Moretti, dell’ufficio minerario di Caltanissetta.
“Il contrabbando – afferma il relatore – si esercita su vasta scala su tutta la regione pomicifera, essendo le piccole proprietà private frazionate qua e là in mezzo alle terre comunali. Più particolarmente però il contrabbando ha luogo per le cave della Castagna, internamente all’isola e per quelle di Campo Bianco ed Acquacalda alla marina, e tale contrabbando viene fatto dagli escavatori a danno del Comune per sottrarre i loro prodotti al pagamento attuale della tassa in vigore, con il favore di alcuni fra i più importanti proprietari specialmente ad Acquacalda. Malgrado tutti gli sforzi fatti dal Comune per eliminare tale contrabbando, finora non ottenne risultati pratici e lo dimostra il fatto che nel 1906 ben 6129 tonnellate di pomice prodotte nelle terre comunali sono sfuggite al pagamento della tassa. Infatti nel 1906 si produssero tonnellate 16.266 di pomice delle diverse qualità e risulta dai ruoli comunali della tassa di percezione attuale che solo tonnellate 6788 pagarono la detta tassa al Comune. Figurerebbero quindi come prodotte nelle cave private tonn. 16266- 6788= tonnellate 9487. Questa cifra è un assurdo. Ammessa anche la maggior ricchezza delle cave private perché meno sfruttate, la maggior facilità di escavazione e di trasporto per le loro migliori condizioni topografiche, pure è logico ritenere che una tale cifra esorbita oltre i limiti del possibile se si tiene conto del rispettivo numero di cave e degli operai impiegati nelle une e nell’altre.”
E qui il Moretti effettua un calcolo. Nel territorio del demanio operano attualmente 24 cave a cielo aperto e 100 (106) sotterranee, e in seguito a nuove constatazioni risulta che vi siano occupati circa 504 operai contro 11 cave a cielo aperto, 9 sotterranee e 140 operai delle proprietà private. Sulla base di semplici calcoli proporzionali dovrebbe risultare che la quantità prodotta nei terreni demaniali dovrebbe essere di 12 917 tonnellate contro 3349 dai terreni privati. “Ammettendo che per le migliori condizioni delle cave private la loro produzione sia stata rispettivamente a quelle comunali, del 10% in più le cifre di produzione su riportate sarebbero trasformate in tonnellate 3648 per le cave private e tonnellate 12582 per quelle comunali, cifre queste molto vicine al vero”.
Il risultato di questa dimostrazione è che su 12582 tonnellate prodotte nei terreni demaniali nel 1906, ben 6129, e cioè quasi la metà, rappresentano l’ammontare del contrabbando a danno del Comune.
Quanto alla localizzazione risulterebbe che il contrabbando maggiore si verificherebbe ad Acquacalda , Campobianco e Castagna. A Castanga ed Acquacalda le cave private sono vicine e confinanti con quelle demaniali da qui la facilità di contrabbandare. “I proprietari delle cave private di queste regioni sono quelli che maggiormente insorgono contro la tassa del dazio alla marina compresi quelli di Porticello (attigue alle ricche cave comunali di Campobianco) e ciò perché con l’applicazione della nuova tassa alla marina, cesserebbe per loro il provento attuale del contrabbando che esercitano e verrebbe definitivamente tolto il modo di poterlo praticare”.

G. Vuillier, donne che lavorano la pomice
La “leggina” sulla pomice
Gli anni che vanno dal 1902 al 1907 furono anni di grande instabilità politica. I sindaci - con l’esclusione dell’avv. Giuseppe Faraci che lo sarà sia nel 1902-1903 e poi per quasi due anni dal 22 febbraio 1904 al 30 dicembre 1906 - duravano pochi mesi ed al massimo un anno. E questo fino a quando verrà eletto il cav. don Giuseppe Franza, già maggiore dell'esercito.
L’approvazione di una leggina che rendesse obbligatoria la tassa sulla pomice e ne permettesse l’esazione all’imbarco, sembrava l’unica risposta valida per rimettere in piedi le tristi sorti del bilancio comunale, causa dell’alternarsi di Amministrazioni fragili. Nel Consiglio del 15 giugno 1904 il Sindaco avv. Giuseppe Faraci da conto di un incontro con l’on. Ugo di Sant’Onofrio, deputato del collegio, proprio sul problema del miglioramento del diritto di percezione della pomice.
Il secondo mandato di Faraci terminò nel dicembre del 1906, dopo le elezioni parziali del 22 luglio 1906 ed il cambio di maggioranza del Consiglio. A Lipari fu mandato ancora una volta un commissario nella persona del dott. Eugenio De Carlo. Intanto si costituì un “Comitato pro pomice” del quale facevano parte le più spiccate personalità dei due partiti, il democratico ed il popolare, fino ad allora profondamente divisi. Questo Comitato si batteva per un ritorno al regime in vigore sino al 1887 e cioè la percezione dei diritti alla partenza. Una commissione con a capo il dott. De Carlo andò a Roma per sostenere questa posizione col Governo. “Il Governo – riferì l’on.di Sant’Onofrio, in Parlamento - dopo un accurato esame della questione riconobbe trattarsi non di dazio di esportazione o consumo: ma di una vera e propria tassa di escavazione mineraria” e quindi, essendo immutata la legislazione in materia, rimaneva valido il sovrano rescritto del 1855. “E tale opinione veniva autorevolmente confermata dal Ministero delle Finanze, direzione generale delle gabelle, con nota del 12 aprile 1907”.
Sull’onda di questo chiarimento 484 elettori eoliani, fra i quali molti proprietari di cave, mandarono una petizione al Parlamento perché fosse regolamentata la situazione e l’on. Di sant’Onofrio, visto che esisteva un forte accordo a Lipari su una comune piattaforma, presentò una proposta di legge.
L'on.Di Sant'Onofrio ed mil cav. Franza
Particolarmente attivo nel Comitato e nei rapporti con l’on. di Sant’Onofrio era stato il cav. Giuseppe Franza, già maggiore dell’esercito e fratello del canonico Franza Ed il cav. Franza fu eletto sindaco, praticamente all’unanimità, il 16 luglio 1907. Agli anni dell'instabilità amministrativa seguono ora per Lipari anni particolarmente fecondi. Il Franza si rivelò un amministratore dotato di perizia e dedizione esemplari. Al Governo c'era Giolitti che cercava di andare al di là degli schieramenti politici e di mettersi direttamente in contatto con le esigenze popolari. Così furono continue le puntate che il Franza faceva a Messina e Roma per conferire con il Prefetto ed i titolari dei vari ministeri o con lo stesso presidente del Consiglio. E si racconta che fosse abbastanza insofferente delle etichette per cui non amava le lungaggini dell'anticamera. Una volta andando a trovare il Prefetto fu fermato da un uscire che gli disse con durezza:
“Dove va lei? Deve fare la fila, deve farsi annunziare ed aspettare di essere chiamato. Questa è la regola.” e lui rispose”Dite al signor Prefetto che c'è il Sindaco di Lipari e che Lipari è fuori regole”. La battuta piacque al Prefetto che fece capolino dal suo ufficio e subito lo ammise al colloquio.
Il cav. Franza e Lipari avevano però anche un efficace sostenitore nella persona dell'on. Ugo del Castillo marchese di Sant'Onofrio[3], del Partito Popolare, del collegio di Castroreale.
 Il marchese di Sant’Onofrio lo conoscevano tutti a Lipari perchè si faceva vedere spesso e non mancava mai di tenere un comizio alla vigilia delle consultazioni. Quelli del P.P.I. gli facevano trovare addobbato il vasto magazzino di falegnameria di don Giuseppe Casserà che era a metà della Salita di S.Giuseppe. Le sedie per il pubblico venivano prelevate dalla vicina chiesa.
Il marchese di Sant’Onofrio lo conoscevano tutti a Lipari perchè si faceva vedere spesso e non mancava mai di tenere un comizio alla vigilia delle consultazioni. Quelli del P.P.I. gli facevano trovare addobbato il vasto magazzino di falegnameria di don Giuseppe Casserà che era a metà della Salita di S.Giuseppe. Le sedie per il pubblico venivano prelevate dalla vicina chiesa.
L'onorevole era stato uno degli ideatori e operatori della campagna che aveva determinato l'elezione di Franza approfittando del ruolo di sottosegretario agli interni e facendo leva sul regio commissario avv. Eugenio De Carlo che gestì il comune di Lipari nei sei mesi che precedettero l'elezione.
Fu De Carlo che riuscì a convincere tutti che bisognava uscire dalla precarietà e che con l'approvazione della leggina sulla pomice che sarebbe arrivata da lì a poco una grande stagione era alle porte.
E la leggina arrivò il 5 gennaio 1908. Era la legge n. 10 dal titolo .”Sulla escavazione della pomice nel Comune di Lipari”. In realtà si trattava di una legge che con modificazioni e aggiunte veniva a confermare l'antico sovrano rescritto del 14 giugno 1855 riguardante il medesimo oggetto; un rescritto che, applicato saltuariamente e senza un serio impegno da parte della classe dirigente del paese, era “caduto nel volger degli anni in desuetudine”. Più specificatamente, la legge del 1908 che autorizzava il Comune ad emanare al più presto il regolamento applicativo, contemplava “una tassa di escavazione” sulle pomici provenienti dalle “cave situate in quell’isola” da riscuotersi “ sia in locali appositamente destinati sia al momento dell’imbarco “, e un così detto “diritto di esercizio o di licenza, da applicarsi mensilmente ad ogni singolo escavatore”. All’art. 3 la legge faceva obbligo al Comune di curare “che tutti gli operai occupati nelle cave e nel trasporto della pomice sino al mare, tanto per le cave di sua proprietà quanto per quelle di proprietà privata, siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro”.
Il regolamento fu approntato e pubblicato tempestivamente, il 21 luglio dello stesso anno e malgrado fosse chiaro e comprensibile a tutti, non mancarono , tra i cavatori, dissensi e avversioni, per cui nei primi anni il Comune ebbe serie difficoltà a far rispettare i suoi diritti. Comunque i proventi ammontarono a circa 100 mila annue e questo permise al Sindaco Franza di ridurre le tasse, di riportare in pareggio il bilancio e di far guadagnare a Lipari la fama di comune più ricco d'Italia.
La leggina ebbe una grande ripercussione a Lipari. Il tripudio per questa legge fu notevole e si fece a gara per ringraziare quelli che risultavano i massimi promotori della sospirata norma: Giovanni Gilitti, Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno, e l’on. Ugo di Sant’Onofrio. Il Consiglio comunale fu convocato il 19 gennaio con all’ordine del giorno “ onoranze a S.E.Giolitti ed all'on. Marchese Ugo di Sant'Onofrio”. Per i due fu decisa la cittadinanza onoraria, si redisse una pergamena di lode e si decise di dedicare loro una piazza ciascuno: quella di Marina Corta ex Marina S.Giovanni e ora Piazza del Commercio a Ugo di Sant’Onofrio e quella di sopra la Civita ora Piazza degli Studi al Giolitti. A Sant’Onofrio fu anche deciso di dedicargli un mezzo busto da collocare nella sala del Consiglio. Ma mentre il primo ebbe la sua piazza ma non il mezzo busto, per il secondo ci furono diverse vicissitudini. Infatti ci si era … dimenticati che già l’anno prima la piazza degli Studi era stata dedicata a Mazzini e così si pensò di intestare a Giolitti la piazza del Pozzo[4]. Ad Ugo di Sant’Onofrio, inoltre, furono dedicati, alla sua presenza, grandi festeggiamenti pubblici il 28 ottobre dello stesso anno.
L’escavazione della pomice andò avanti sino al 2007 quando cessò perché il Consiglio Comunale non rinnovò le concessioni che erano scadute nel 2001.(Archivio Storico Eoliano.it)
[1] Nella seduta del Consiglio del 9 marzo 1905 l’assessore Paternò accusa il consigliere Giuseppe Casaceli di essere il mandante di alcuni contravventori. Nel Consiglio comunale del 28 febbraio del 1906 è lo stesso assessore Paternò ad essere chiamato in causa. G. La Greca, op. cit., pp.61-66.
[2] G. La Greca, op.cit., pp.61-72.
[3] Ugo di Sant’Onofrio era nato a Baden Baden in Germania nel 1845 dove il padre, colpito da condanna per cospirazione contro il Borbone, si era rifugiato. Studiò a Torino dove si laureò in giurisprudenza, Superato un concorso al Ministero degli Affari Esteri, operò per quindici anni nella diplomazia. Quando nel marzo del 1878 Benedetto Cairoli divenne primo ministro, fu nominato suo segretario particolare ed ebbe parecchi importanti incarichi all’estero. Morto il padre che rappresentava alla Camera il collegio di Castroreale, fu chiamato a succedergli dal voto unanime degli elettori. Ricoprì ruoli di responsabilità in diverse commissioni parlamentari, nel 1900 fu Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici nel Ministero Saracco e nel 1903 Sottosegretario all’Interno nel ministero Giolitti.
[4] Ma questa denominazione avrà vita breve perché nel 1926 verrà chiamata piazza Mussolini poi, caduto il fascismo nel ’43, prima piazza Quattro novembre ed infine piazza Matteotti.
Il primo scontro Comune - Vescovo per la pomice
Il primo scontro con il vescovo

Lo sfruttamento delle terre pomicifere nel corso del secolo si andò sempre più intensificando , assumendo la piena fisionomia industriale solo a partire dal 1884[1].
Intanto l’esportazione della pomice aveva raggiunta la media annua di 5 mila tonnellate e questo anche per via dei nuovi sistemi di lavorazione e dell’introduzione dei motori a carbone impiantati dalla ditta Barthe e dalla società anonima Eolia Oltre che a Canneto ed Acquacalda esistevano due forni di essicazione a Lipari , uno al termine di via Santa Lucia con prospetto sul torrente el’altro in fondo al vicolo Ausonia.


Il Vescovo Natoli, a sinistra e il prof. Emanuele Carnevale a destra
Fu talmente florida, in quegli anni l’industria della pomice che, col ricavato della concessione – come si afferma nel Consiglio comunale del 4 aprile 1889 - si poteva provvedere ai bisogni del Comune “senza far gravare sulla popolazione imposta alcuna”. Questo spinse il Comune – con delibera del 4 aprile 1889 - a perseverare nella reintegra delle terre comunali usurpate. Il nuovo sindaco avv. Emanuele Carnevale[2] si intestò questa battaglia, nella quale trovò sostegno nel Prefetto e finalmente il 19 giugno 1891 arrivò l’ordinanza del regio commissario degli affari demaniali che respingeva l’eccezione dell’avv. Natoli La Rosa secondo il quale molte terre pomicifere erano proprietà della mensa vescovile. L’amministrazione successiva, quella del Sindaco avv. Onofrio Carnevale, dall’ottobre 1891 all’agosto 1895,la mise in esecuzione , così “fu delimitato il demanio pomicifero e si fecero oltre duecento esecuzioni” [3].
Di quella esperienza scrisse lo stesso Emanuele Carnevale: “Il Comune aveva un cospicuo demanio pomicifero, e in gran parte era stato usurpato: io lo rivendicai ricercando e raccogliendo per la prima volta i documenti del suo diritto e impegnando un’asprissima lotta con gli usurpatori: ottenni l’Ordinanza di reintegra nel giugno del 1891”[4].
Alle manovre di reintegra operate dal Comune si oppose energicamente il vescovo tramite l’avv. Antonino Natoli La Rosa. Scrive l’avv. Natoli che la volontà di spogliare il vescovo del suo patrimonio si manifestò prima nel 1890 e riguardava una parte dei giardini che circondavano l’episcopio, ad opera del Demanio dello Stato. Ma il ricorso al Ministero bloccò quella operazione. Dal 1891 in poi la Rappresentanza Municipale si era impossessata di estese tenute dell’Isola,”molte delle quali da qualche secolo e più furono dai Vescovi concedute in entiteusi. Per questi fondi gli utilisti espropriati, avendo spinto giudizio di rivendica contro il Municipio, minacciano di tradurre presso il Tribunale anche il Vescovo…per garantirli ed indennizzarli della patita evizione[5]” .”Fu nell’anno 1884 che i Municipalisti di Lipari cominciarono a spacciare che quelle terre pomiciose fossero proprietà demaniale del Comune istesso. L’audace menzogna faceva monopolizzare in mani cointeressate la lucrosa industria delle pomici a tutto danno dei proprietarii utilisti e dei poveri che i vescovi, originari proprietarii, avevano sempre favorito con le contrattuali concessioni delle terre. Quella bugiarda invenzione si rivestiva della officiale autenticità col contratto del 14 novembre 1884 col quale si dichiarava di locarsi al francese Barthe terre pomiciose di demanio Comunale: terre che il Comune non ha…Quale sia l’eco straziante di queste dolorose note si rivela da …Telegramma: Ministro Interni, Roma. Tormentati Liparesi 1000 privatamente riuniti lacrimando implorano Regio Governo liberarli tormentatore Municipio che rispogliali proprietà e tassali ferocemente. Lipari agosto 1891[6]”.
La tesi del vescovo era che l'Amministrazione comunale, sin dal 1890 si era inventata “gratuitamente” l'esistenza di un demanio comunale in numerose contrade di Lipari mentre in realtà essere erano della mensa vescovile che fondava il suo possesso – come si è detto - sulla donazione del Conte Ruggero all'Abate Ambrogio, il Breve di Urbano II del 1901, il diploma di Re Ruggero II del 1134, ecc.
“La pretesa demanialità di tale terre non può neanco sostenersi contro le attestazioni positive degli atti e contratti autentici, che loculentemente addimostrano, quelle terre non essere state mai proprietà del Comune , ma bensì di altrui. E oltre a tutto ciò, non può senza un'audacia dissennata, oggi ancor tuttavia ricantarsi una tale demanialità: quando delle asserzioni di proprietà Comunale dell'Ente Comune di Lipari, nel mentovato giudizio contro Barthe, cotanto lungamente ed accanitamente sostenuto, non potette giustificarsene alcuna. E il pretendente Comune non produsse verun atto probatorio della sua pretesa proprietà e possesso su quelle terre !!! La mancanza di quei titoli può dirsi oramai giuridicamente costatata: mentre dopo lunghe e ripetute diffide, e parecchi termini dilatori accordati tanto preso il Tribunale di prima istanza, che preso la superiore Corte d'Appello non fu mai possibile al Comune produrne[7]”.


Sulla scorta della pianta topografica predisposta – continuava l’avvocato della mensa vescovile nella presa di posizione contro la reintegra - si era avviata la reintegra con forme di esecuzione forzata di proprietà parecchie delle quali “erano state già concesse ad enfiteusi dalla Mensa vescovile di Lipari “. Era successo che questi possessori per enfiteusi vescovile si erano rifiutati di pagare in censo alla Mensa. Anzi, alcuni di questi, per quieto vivere, erano passati a riconoscere il Municipio come proprietario primitivo. Molti altri invece citarono nel corso del 1894 il Municipio di Lipari chiedendo il rilascio dei fondi, e minacciavano di trascinare in giudizio anche la Mensa vescovile. Così per evitare di essere citato in giudizio, l'avvocato del Vescovo aveva assunto gratuitamente la difesa di costoro.
All'indomani dell'Ordinanza il vescovo,luglio 1892, invitava al bonario componimento le migliaia di debitori del censo fisso. Ma siccome questi si erano rifiutati il vescovo faceva presente che non poteva più proseguire su questa strada.
Ancora nel 1895, il 28 febbraio, il vescovo Natoli inviava una nota al Ministero di Grazia, Giustizia e del Culto sollecitando il R. Economato dei Benefici Vacanti, ma questo ugualmente respingeva le tesi della mensa.
A questo punto le acque si calmano. Ancora mons. Audino che succederà a mons. Natoli, alla morte di questo, scriverà ai Sindaci di Lipari e di Salina per lamentare la triste situazione delle finanze della diocesi per via dei diritti negati in censi e decime ma questo non produrrà effetto alcuno. Una nuova contesa si aprirà con il vescovo Paino dopo che sarà varata la tanto attesa legge sulla pomice.
La questione dell’esazione del dazio sulla pomice
.
 Le risorse provenienti dall’escavazione della pomice rappresentavano oltre il cinquanta per cento del bilancio comunale e – venendo a mancare un affittuario monopolista – le entrate erano diminuite significativamente col risultato che l’ente ne risentiva. Per porvi rimedio era necessario ricorrere ad un adeguato corpo di guardie campestri ma il suo mantenimento si rivelava molto oneroso. Vi era anche il problema dei luoghi, montagnosi e di difficile raggiungimento, che non permettevano una efficace sorveglianza. In queste condizioni il contrabbando poteva prosperare. Nel 1891 si avviò la procedura per ottenere il decreto reale che autorizzasse il Comune – come d’altronde avveniva prima del contratto con l’Eolia basandosi sul rescritto sovrano del 25 giugno 1855 - a riscuotere il diritto di percezione sull’escavazione della pomice all’imbarco della stessa. Così infatti la sorveglianza diveniva più agevole concentrandosi sui luoghi di imbarco. Ma la richiesta del Comune, pur avendo ottenuto il parere favorevole del prefetto, non viene accettata dal governo.
Le risorse provenienti dall’escavazione della pomice rappresentavano oltre il cinquanta per cento del bilancio comunale e – venendo a mancare un affittuario monopolista – le entrate erano diminuite significativamente col risultato che l’ente ne risentiva. Per porvi rimedio era necessario ricorrere ad un adeguato corpo di guardie campestri ma il suo mantenimento si rivelava molto oneroso. Vi era anche il problema dei luoghi, montagnosi e di difficile raggiungimento, che non permettevano una efficace sorveglianza. In queste condizioni il contrabbando poteva prosperare. Nel 1891 si avviò la procedura per ottenere il decreto reale che autorizzasse il Comune – come d’altronde avveniva prima del contratto con l’Eolia basandosi sul rescritto sovrano del 25 giugno 1855 - a riscuotere il diritto di percezione sull’escavazione della pomice all’imbarco della stessa. Così infatti la sorveglianza diveniva più agevole concentrandosi sui luoghi di imbarco. Ma la richiesta del Comune, pur avendo ottenuto il parere favorevole del prefetto, non viene accettata dal governo.
Intanto il 23 dicembre del 1902 il Consiglio per cercare di fare quadrare un Bilancio che si trovava in difficoltà decide di aumentare il diritto di percezione sulla pietra pomice raddoppiandola. Contro questa decisione un centinaio di escavatori ricorrono al Prefetto asserendo che questa decisione li danneggia. In Consiglio il 7 febbraio 1903. si sviluppa una forte polemica fra i consiglieri Esposito e Faraci da una parte e Caserta dall’altra. Caserta che pure si era fatto promotore del raddoppio del diritto nella seduta del 23 dicembre ora, dice ,di essere stato tratto in inganno. La discussione si fa animata ed il pubblico entrato nella sala partecipa con grida e urla. Ad un certo punto viene decisa la chiusura della discussione togliendo la parola al Caserta ed esplode il caos. Furono rovesciate sedie e tavoli e corsero anche pugni, calci e colpi di bastone. Quando – a distanza di alcuni mesi, il 20 marzo – il Consiglio si riunirà nuovamente l’animosità non si era ancora esaurita.
Il comune torna alla carica sul tema della percezione dei diritti all’imbarco nel 1894 e vuole chiedere la riproposizione del rescritto sovrano. Ma fra le carte del Comune questo non si trova più. Non rimane altra strada che chiedere al Ministero delle finanze una “leggina” che autorizzi il “dazio d’uscita”.. Il Sindaco avv. Onofrio Carnevale – il 2 agosto - fa presente, in consiglio comunale, come, quando si applicava questa forma di esazione si percepivano dalle 80 mila alle 90 mila all’anno e non era necessario ricorrere, come è invece poi avvenuto, “alla sovraimposta comunale, all’aumento del dazio consumo sul vino e sulla carne e alla tassa fuocatico ( o imposta di famiglia), pesi cotesti che il paese sopporta appena”. Invece il dazio sulle pomici da riscuotere all’imbarco “grava sull’estero,nelle di cui piazze esse vengono esportate, e migliora le condizioni degli operai, i quali trovano così meglio retribuito il loro lavoro”.
Il 9 gennaio 1895 il Sindaco in Consiglio comunale riferisce la risposta negativa del Ministero delle finanze perché avrebbe per oggetto “una imposizione che è in aperto contrasto col sistema tributario in vigore per i Comuni, e perché costituirebbe un precedente che la tutela dovuta al commercio consigli di prevenire”.
E’ il consigliere avv. Emanuele Carnevale che indica due strade per riprendere con efficacia l’iniziativa. La prima è una verifica dell’attuale sistema di riscossione. E’ vero che il Consiglio ha provveduto alla nomina di un direttore che sovrintenda al sistema ma non ha dato grossi risultati.”Egli con ciò non intende dire che si sia fatto male, perché è certamente la cosa in sé stessa che offre molte spine e difficoltà, ma se mai si potesse usare un sistema più conducente egli ne sarebbe lieto”.La seconda è quella di insistere col Ministero perché ha l’impressione che la questione non sia stata studiata con attenzione “giacché non è l’imposizione di un dazio nel vero e stretto senso della parola che si domanda, ma una modalità di esazione di quel diritto di percezione legalmente riconosciuto e dovuto sull’escavazione della pomice nei demani comunali”.
Il "sovrano rescritto"
Nel Consiglio del 26 marzo 1895 si prende atto che il Comune ha richiesto ed ottenuto dall’Archivio di Stato di Palermo copia del “sovrano rescritto” e si delibera di inviarlo ai Ministri dell’Interno e dell’Agricoltura, industria e commercio per chiedere l’autorizzazione all’esazione all’imbarco delle pomici. Per diversi anni non si hanno riscontri del governo su questo piano. Comunque le delibere del Consiglio per l’esazione del dazio all’imbarco concorrerà alla formazione, come vedremo, della legge n. 10 del 1908.
Nel consiglio comunale del19 ottobre 1899 il consigliere Giovanni Carbone denuncia che i diritti di escavazione non rendono alla finanze comunali neanche la quinta parta di quello che dovrebbero - visto che l'esportazione supera i 150 mila quintali l'anno - e questo perchè la maggior parte della pomice sfugge alla verifica della Guardie Campestri.
Quello del funzionamento del sistema di riscossione non è problema nuovo. Più volte era venuto alla ribalta in Consiglio. Nel consiglio del 12 novembre del 1894 si era data notizia di aver licenziato quattro guardie campestri perché non svolgevano il servizio con regolarità e quindi lasciavano spazio al contrabbando. Si parla anche di affidare il servizio ad un esattore piuttosto che al tesoriere perché l’esattore può procedere alla riscossione forzata. A questo proposito un problema sorge su chi debba gravare l’agio dell’esattore: sui singoli cavatori o sul Comune? Viene alla fine chiarito e deciso che di esso si debba fare carico il Comune.

Ma quello delle guardie campestri doveva essere un problema spinoso. Nel consiglio del 5 settembre 1895 il nuovo Sindaco avv. Giuseppe La Rosa riferisce che il sistema di sorveglianza lascia molto a desiderare per mancanza di personale perché con quello esistente non si possono organizzare i turni notturni ed il contrabbando avviene soprattutto di notte e per questo servizio servono delle guardie scelte. Il problema è quello dell’età? E’ meglio spingere l’età fino ai quarant’anni per avere persone più responsabili e dotate di esperienza o invece contenerla al massimo ai trent’anni perché siano in grado di affrontare le fatiche di lunghe e escursioni in località impervie e scoscese? Nel 1899 il corpo era composto da un direttore, un caporale, un appuntato e quattordici guardie. Nel settembre del 1902 si comunica che la Giunta aveva provveduto al licenziamento dell’intero corpo per migliorare il servizio che lasciava molto a desiderare.
Nel corso del 1905 si procede alla modifica del regolamento organico delle guardie. Il corpo prevede due capo guardie, quattro guardie di prima classe e sei guardie di seconda classe. Ma fra il 1905 ed il 1906 scoppia una grave crisi che verrà risolta solo nel 1907. Vi è una inchiesta, vi sono varie dimissioni che – nel luglio del 1906 - sono accolte dalla giunta Faraci che indice un concorso per sostituire i dimissionari. Poi invece emette una delibera di conferma senza tener conto del bando e delle domande pervenute. La delibera di riconferma viene annullata dall’autorità tutoria. Il 9 settembre la Giunta procede allo scioglimento del corpo dando facoltà agli agenti di rimanere in servizio finché non si sarebbe provveduto ad una nuova sistemazione. Ma anche questa delibera viene bocciata ed il corpo rimane affidato a personale avventizio. Finalmente il 30 gennaio del 1907, dopo anni di caos e confusione, il regio commissario procede alla nuova sistemazione portando le guardie da dodici a quattordici, nominando due agenti provvisori, confermando nel servizio le guardie che non si erano dimesse nel luglio del 1906 mentre quelle che avevano date le dimissioni rimangono come avventizi.(Archivio Storico Eoliano.it)
[1] G. Arena, L’economia delle isole Eolie, op. cit., pag. 46.
[2] Emanuele Carnevale nasce a Lipari il 4 marzo 1861 dall’avv. Emanuele Carnevale Salpietro e da Giovanna Rossi. Si Laurea Messina nel 1884 e proprio negli anni universitari inizia a fare politica fra i democratici di Messina. Aderisce alla massoneria di Palazzo Giustiniani e sostiene nelle elezioni del 1882 la lista radicale. Tra il 1884 ed il 1891 dopo aver ricoperto la carica di presidente fondatore di una Società di mutuo Soccorso di Salina, diventa presidente della Società operaia di Mutuo soccorso di Lipari e nel novembre del 1889 diventa primo sindaco elettivo del Comune di Lipari e lo sarà fino all’ottobre 1891.
[3] O. Carnevale Rossi, Pro veritate, Lipari 1903, p.6.
[4] E.Carnevale, Miei ricordi di vita e di lavoro, palermo 1923, pp.43-44.
[5] A.Natoli La Rosa, Sul beneficio Vescovile di Lipari e le sue rivendiche. Note rischi arative, Messina 1896, pp. 11, 24 e 25.
[6] A.Natoli La Rosa, Studii politico-sociali, Palermo 1896, pp. 95,100.
[7] A.Natoli La Rosa, Il monopolio commerciale per la pomice nell’isola di Lipari, 1889, in G.La Graca, op.cit. ,vol II, pp.32-33.
La raccolta e lavorazione della pomice si riorganizza e industrializza
Verso l’industrializzazione della raccolta della pomice

Canneto ai primi dell'800
La pomice è stata la grande risorsa naturale che ha inciso nella storia dell'arcipelago soprattutto negli ultimi duecento anni[1]. A portarla agli onori delle cronache sono stati nell'800 due eventi: l'industrializzazione e la commercializzazione del prodotto che dimostrarono che questa pietra – dal punto di vista economico – non rappresentava solo una modesta integrazione per coloro che versavano in condizioni precarie ma poteva rappresentare una vera ricchezza per i privati e per le casse del comune; le nome che colpirono in particolare la chiesa liparese privandola di censi e di decime e la portarono a rivendicare i terreni demaniali per sopperire in qualche modo alle proprie esigenze.
Il primo accenno ad un commercio della pomice di Lipari è del 18 maggio 1276. Carlo d’Angiò autorizza il vescovo ad esportare e commerciare oltre allo zolfo ed all’allume anche la pomice (lapides”).Una chiesetta dedicata a San Cristoforo nasce a Canneto nel 1596 e secondo Iacolino questo è segno che la gente del luogo portava a spalla le ceste del pezzame. Sul finire del XVII secolo si dovettero avviare piccole attività di commercializzazione della pietra[2]e Dolomieu nel 1781 afferma che Lipari è “l’immenso magazzino che fornisce la pomice a tutta l’Europa” e sette anni dopo Spallanzani afferma che a Lipari “vengono bastimenti italiani, francesi e d’altre nazioni per caricare questa merce”[3].
La prima volta che si parla di concessione a proposito della pomice è nel 1813 quando Vito Nunziante chiede al governo borbonico delle terre demaniali ed il governo interpella il vescovo di Lipari perché specifichi, delle terre comunali, quali sono patrimoniali e quali demaniali. Il Nunziante torna alla carica l’8 maggio 1825 e il Decurionato municipale delibera di concedergli in esclusiva, per nove anni, di estrarre dai beni comunali “la materia vitrea” per impiantare una fabbrica di cristalli. Ma ancora una volta non si arrivò a nulla di concreto.
La prima volta che si pensa ad un dazio sulla pomice è il 29 aprile del 1835 e il Decurionato stabilisce che deve essere di grani 10 siciliani per ogni quintale di pietra pomice scavata. Le entrate previste sarebbero ammontate a 100 onze l’anno corrispondenti a circa 600 tonnellate di prodotto e dovevano servire per far fronte all’illuminazione notturna da organizzarsi nel Comune.[4]
La decisione del Comune si scontra prima con i privati che sono possessori dei terreno - o perché se ne sono appropriati e non intendono riconoscere la natura demaniale delle terre o perché li hanno ricevute in enfiteusi dal vescovo a cui pagano il censo – ma si scontra anche con la gente del popolo giacché le terre pomicifere erano considerate da sempre terre comuni, meta di cavatoli singoli e a gruppi, i quali prendevano ciò che potevano, alimentando, comunque, un discreto commercio di esportazione. Sistema che rimase in vigore per tutto l’800 e sino ai primi del 900. Infine si scontra anche col vescovo che si riteneva, fin dal tempo dei normanni, proprietario delle isole Eolie e quindi anche di questi terreni Così mons. Proto, fra il 1839 e il 1840, invia una “memoria” sulle decime all'Intendente magistrato aggiunto per protestare contro il sindaco Antonio Natoli ed alcuni possidenti liparesi che volevano sopprimere le decime sui prodotti della terra. Comunque il 24 giugno1855 il Comune di Lipari ottiene l’autorizzazione di imporre il dazio sulla pietra pomice all’imbarco grazie ad un “sovrano rescritto” e il 28 maggio del 1868 il Consiglio Comunale, su proposta dell’Amministrazione guidata dall’avv. Filippo Carnevale, approva il primo regolamento per il diritto di riscossione sulla pietra pomice che si estrae nelle cave di proprietà del Comune.
 |
 |
 |
 |
All’inizio, lo sfruttamento delle terre pomicifere era a carattere artigianale e la pomice veniva acquistata in conto proprio dagli stessi capitani dei velieri che provvedevano poi a rivenderla[5] nei vari porti dell’Italia e della Francia, solo nel 1880 assumerà una fisionomia industriale..

Il primo passo in questa direzione si ha quando giungono i rappresentanti di società straniere che prima si limitarono ad acquistare il prodotto, poi cominciarono a selezionarlo e lavorarlo nei mulini che fanno costruire a Lipari, Canneto, Porticello e ad Acquacalda.
Il precursore in questo campo è il francese monsieur Firmine Bacot de la Maison de commerce ‘Leonard Bacot’ specialiste en ponces chois, poudres, grain a Paris.[6]. Bacot il 2 settembre 1865 sposa a Pirrera Angelina Restuccia ed il 24 maggio 1867 rivolge una petizione al Sindaco per chiedere una porzione di demani comunali in contrada rocche Pirrera e la esenzione del dazio sulla polvere di pietra pomice che viene manufatta ed esportata all’estero. Il Consiglio Comunale respinge le due richieste . La prima perché i demani comunali o sono dati in enfiteusi o sono gravati da usi civici e quindi sono di libero accesso a tutti i cittadini e rappresentano una fonte di sostegno per numerose famiglie. La concessione quindi per molti liparesi rappresenterebbe un danno. Inoltre l’esenzione dal dazio danneggerebbe le entrate comunali.
La concessione in monopolio
E’ negli anni 80 che si pone il problema di affidare raccolta e commercializzazione della pomice ad un soggetto unico. Il 30 maggio del 1881 il Consiglio Comunale, sindaco Filippo De Pasquale, si riunisce per discutere una richiesta del signor Gabriele Barthe avanzata per mezzo della Prefettura. Si apre una lunga fase che si concluderà solo il 21 novembre del 1884 assegnando al richiedente “in locazione, a trattativa privata, per un ventennio, i demani comunali produttivi di pietra pomice”. In questi tre anni e mezzo che sono trascorsi dalla richiesta alla decisione del Consiglio verranno vagliati diversi problemi ed obiezioni e si dovrà tenere conto di richieste diverse da quella di Barthe. La prima obiezione che viene avanzata – e che si dimostrerà fondata tanto da mettere in crisi il contratto stipulato – riguarda lo stato dei terreni demaniali molti dei quali sono stati usurpati. L’obiezione è avanzata dall’apposita commissione consigliare costituita per vagliare l’offerta di Barthe. Si propone di sospendere la decisione “fino a che i demani comunali usurpati e principalmente quelli a terreni bianchi dove si trovano le pomici non saranno reintegrati”. Ma il richiedente torna alla carica visibilmente sostenuto dal Prefetto e così un paio di settimane dopo il Consiglio é richiamato a decidere. Questa volta il consesso si divide perché vi è chi teme il verificarsi di inconvenienti e giudica che sarebbe meglio andare avanti come si era fatto fino ad allora cioè dando in appalto la riscossione dei dazi e magari aumentandoli. Ma a maggioranza di sedici a dieci si decide di mettere all’asta la concessione. Problemi nascono però sulle condizioni del contratto. In particolare due. Il Barthe avrebbe voluto fare uso di mezzi meccanici e di macchinari, il Comune si oppose perché “andrebbe a nulla il lavoro di una gran quantità di gente addetta a questa lavorazione”e su questo punto il Comune la spunta. Non la spunta però su un’altra clausola che riguardava i mezzi autorizzati a eseguire il trasporto nei vari porti. Il Comune avrebbe voluto che fossero solo i “bastimenti della marina mercantile di Lipari” ma la norma viene respinta dalla deputazione provinciale di Messina la quale non accetta neanche la successiva mediazione di allargare l’ambito dei bastimenti autorizzati a quelli dell’intero Comune e non della sola isola e di prendere in considerazione, per le eccedenze, i bastimenti di Salina e “poi quelli dell’intero compartimento marittimo di Messina”. Ma oltre le condizioni un altro problema riguarda il bando e la selezione dei concorrenti. Barthe vorrebbe che si andasse a trattativa privata il Comune propende per la gara pubblica. Alla gara vengono presentate tre offerte .Oltre a Barthe vi è quella di Felice Neble e dei francesi Chamencin e compagni. Il Consiglio sceglie la terza offerta ma il Prefetto annulla la decisione. Probabilmente aveva raccolto la protesta di Barthe che lamentava che la sua offerta fosse stata resa pubblica.
Le trattative riprendono ai primi di marzo del 1884 e questa volta le proposte sono solo due: quella di Barthe e quella della Banca Siciliana di Messina. Si procede a trattativa privata ma il 18 luglio la Banca dichiara di non potere accettare tutte le modifiche fatte alle sue condizioni ed stava per avanzare una nuova proposta. Ma il consiglio a maggioranza di otto a sei, di fatto, chiuse la trattativa con la Banca Siciliana ed il 20 novembre tornò a riunirsi per approvare la concessione a Gabriele Barthe.
Il Comune con questo contratto si proponeva due obiettivi: garantire al comune entrate daziari costanti e consistenti; reintegrare con procedura indiretta il demanio pomicifero[7].
I diritti del Comune sulla pomice e quelli del Vescovo
Ma quello che alcuni temevano si verifica. Barthe constata che non può entrare in possesso di estese porzioni delle terre pomicifere. E così appena sei mesi dopo la firma del contratto ne denuncia l’impraticabilità. E proprio perché il Comune non riesce a provare la asserita demanialità, dopo due sentenze favorevoli del Tribunale, Barthe ottiene il 31 luglio del 1885 la risoluzione del contratto per via giudiziaria. Comunque il contenzioso fra Barthe e il Comune, per il pagamento dei danni e gli interessi, si trascinerà sino all’aprile del 1898 quando la causa si conclude in modo favorevole per il Comune.
Intanto il 12 febbraio del 1884 la Giunta municipale approva un nuovo “regolamento per la riscossione del diritto di percezione sulla pietra pomice che si estrae dalle cave dei demani comunali” dopo quello del 1868. L’efficacia del rescritto sovrano del 1855, confermata dai regolamenti, continuò ininterrottamente e senza opposizione da parte dell’Autorità Tutoria fino a tutto il 1887, cioè sino al momento in cui il Comune diede in locazione alla “Eolia” i propri demani pomiciferi.
Due anni dopo il fallimento dell’esperienza Barthe e dopo due aste pubbliche andate deserte l’1 maggio 1886 giunse al Comune la richiesta del signor Giuseppe Lanzi di concessione procedendo a trattativa privata. Il Consiglio comunale cominciò a discutere del nuovo contratto mentre, strada facendo si viene precisando la fisionomia del nuovo richiedente. Il 5 maggio 1887 il sindaco Ferdinando Pajno informa che il Lanzi aveva agito in nome e per mandato del sig. Giovanni Rodriquez fu Leopoldo; il medesimo giorno della sottoscrizione del contratto di locazione, e cioè il 25 gennaio 1888, si costituisce la “Società Eolia” in nome e por conto della quale ha agito il Rodriquez.
Il nuovo contratto[8] concede in locazione, per due anni con possibilità di rinnovi biennali fino al termine massimo del 1905, con un canone annuo di lire 92 mila e cauzione di lire 85 mila, tutti i terreni demaniali produttivi di pietra pomice che il municipio possiede e di cui è in godimento – che vengono elencati con nome delle contrade in cui si trovano - col diritto di scavare nelle cave esistenti ed in altre che vorrà aprire senza limitazione alcuna. Il Comune ed i residenti possono fare uso della qualità detta “alessandrina”, del lapillo e della “stacquatura”, che si trova sulle spiagge, ed anche dei bastardoni purché questo materiale venga adoperato esclusivamente nei fabbricati del territorio comunale.
L’art. 3 del contratto precisa, come era stato fatto anche nel contratto con Barthe, che la concessione riguarda il sottosuolo e non la superficie che rimane nella disponibilità del Comune e che può concedere in enfiteusi. All’art. 8 si chiarisce che “ il concessionario non potrà adibire per l’escavazione della pietra pomice che solo lavoratori ed operai del Comune di Lipari escluso ogni mezzo meccanico di macchine” . I lavoratori ammessi allo scavo della pomice dovranno essere in possesso di un permesso scritto rilasciato dal Comune e dovranno cedere al concessionario tutte le qualità di pomice che scavano. Gli operai non possono scavare più di 50 mila quintali all’anno di pomice salvo che non sia il concessionario a farne richiesta. L’eventuale eccedenza verrà conteggiata nella quota dell’anno successivo.
Questi i passaggi che ci sembrano più significati. Rimane il fatto della generica indicazione dei terreni demaniali e questa sarà ancora una volta fonte di contrasto e causa del fallimento anche di questa esperienza.
Inoltre i lavoratori erano privi di un contratto collettivo di lavoro e ricevevano una retribuzione molto bassa[9]. Ed è anche per questo che fin dall’inizio molti di essi rifiutano di munirsi del permesso di lavoro continuando a scavare per loro conto e vendendola a commercianti-mediatori che esistevano malgrado il monopolio concesso all’Eolia. Infatti, oltre ai lavoratori, l’altra categoria che veniva colpita dal contratto monopolistico erano i commercianti ed i mediatori di pomice che dovevano ridurre il loro giro d’affari perché l’Eolia trattava direttamente con gli importatori nazionali ed esteri[10]. Quindi erano diversi gli eoliani che non erano soddisfatti da questa soluzione e infatti diversi cittadini faranno ricorso contro il contratto patrocinati, per lo più, dall’avv. Antonino Natoli La Rosa, fratello del vescovo Natoli[11].
E fu proprio respingendo uno di questi ricorsi che il Consiglio di Stato diede parere favorevole circa la validità del Decreto reale del 5 gennaio 1889 con cui si riconosce al Comune il diritto di concedere in locazione le terre pomifere demaniali.
La gestione della società Eolia
I primi due anni di attività dell’Eolia, dal 1888 al 1890, furono positivi e le sue azioni inizialmente quotate a 250 lire ciascuna passarono a 450 e si vendettero non solo in Italia ma fino a New York. Poi cominciarono i contrasti perché la società tardava a pagare le quote dell’affitto alla scadenza continuando a evidenziare il fatto che non solo continuava l’escavazione abusiva di molti lavoratori in barba al monopolio ma che non sempre, si riusciva a fare valere, nei confronti di questi il contratto sottoscritto soprattutto per l’incertezza dei confini demaniali. Il primo scontro arriva il 25 maggio 1890 con il rifiuto della società di pagare la rata bimestrale ma, il 3 settembre la giunta ed il 10 il Consiglio, approvano un atto di transazione nel quale si decide di consegnare i terreni liberi demaniali incolti ( con qualche incertezza nei confini), i terreni demaniali che erano usurpati ma per i quali ormai vi erano i verbali di conciliazione approvati dal regio commissario e l’impegno di consegnare gli altri terreni demaniali, già usurpati, per i quali vi erano i verbali di conciliazione ma non ancora la firma del commissario.
Il fatto nuovo che dovette spingere l’Eolia alla transazione fu questo procedimento in corso che portava ad accertare il demanio comunale togliendo alibi agli abusivi.
Ma le controversie con gli operai continuavano ed il Pretore non sempre, in base ai documenti esistenti, riusciva a fare chiarezza. L’Eolia riprese così a protestare col Sindaco con due lettere del marzo 1891 e poco dopo sospese il pagamento del bimestre. Questa volta non c’era materia per nessuna transazione e si andò verso la risoluzione del contratto che venne dichiarato dalla Corte d’Appello con sentenza del 22-29 dicembre 1892. La sua vita era stata di appena quattro anni.
Chiuso il contratto con la Eolia il Comune rientra nel possesso dei giacimenti ed affida l’estrazione della pomice agli operai residenti pagandoli due lire per ogni quintale, affidandoli al controllo di nove vigili e di un capoguardia[12].
La vicenda ha uno strascico in relazione allo svincolo della cauzione che l’Eolia aveva prestato al Comune. Sul finire del 1899 questa non era stata riscossa e in Consiglio comunale ci si interroga sui motivi. Nella seduta consiliare del 12 gennaio 1900 il consigliere Giovanni Caserta, appartenente all’opposizione, lancia l’accusa: la ragione sta nell’esistenza di un forte conflitto d’interessi giacché facevano parte della società Eolia, De Pasquale e Giuseppe La Rosa eredi a titolo universale dello zio avv. Rosario Rodriquez ed allo stesso tempo amministratori comunali e consiglieri comunali. Per questo l’amministrazione non si era costituita.
Comunque la lunga diatriba col curatore fallimentare dell’Eolia si concluderà nel 1903 e nell’agosto di quell’anno il Consiglio Comunale approva la ripartizione della cauzione dell’Eolia destinandola oltre a coprire il deficit del bilancio del 1903 e al pagamento degli onorari degli avvocati, al finanziamento di due opere pubbliche:il completamento del palazzo degli Uffici e la costruzione di serbatoi di acqua potabile.
Intanto un'altra richiesta di concessione in monopolio avanzata dai signori Pietro Scouffos, console greco in Messina, Francesco M. Navone, vice console francese in Messina e avv. Edmondo Catania di Messina, arriva in Consiglio comunale il 14 luglio 1893. Di essa se ne discute per circa un anno ma non arrivò a formalizzarsi. E’ interessante notare che una parte significativa della discussione riguardò, dopo i fallimenti di Barthe e dell’Eolia, i terreni che potevano essere dati in concessione. L’avv. Emanuele Carnevale, intervenendo su questo tema sostenne che “la locazione dei demani comunali pomiciferi di Lipari, abbia a procedere per i terreni incolti, che sono stati sempre nel libero posseso del Comune, e per la consegna dei quali avvi il verbale relativo redatto dall’ing. Placido Catania ed inseriti nel contratto di transazione fatto tra il Comune e la società “L’Eolia” presso il notar Faraci in data del 3 settembre 1890, e per i terreni già regolarmente e definitivamente reintegrati. Per determinare questi con precisione, egli dice che occorre di attenersi strettamente all’ordinanza emessa dal signor Prefetto, quale commissario per gli affari demaniali, in data del 19 giugno 1891, ed a tutti gli atti di reintegra, in base e in virtù dei quali nessuna contestazione esiste e potrà esistere intorno al godimento dei terreni reintegrati, tra i quali bisogna includere quelli per cui seguirono le conciliazioni, con i patti e le obbligazioni ivi ammesse, e che riportarono l’approvazione dell’Autorità amministrativa e la sanzione sovrana”.
La richiesta di Haan
Non migliore esito avrà la richiesta di Theodor Haan di Dresda del 5 aprile 1903 che chiede anch’esso il diritto di escavazione in monopolio per vent’anni sui terreni del demanio comunale. La richiesta si arena quando il consigliere Giovanni Caserta pubblica su “La Sentinella “ di Messina un ampio dossier contro questo progetto supportato da una lettera che lo stesso Teodoro Haan scrive a possibili soci cofinanziatori affermando che l’affare che viene a proporre “ avrà un profitto netto del 20 per cento” e questo attraverso una forte riduzione delle spese di trasporto e di imballaggio che saranno svolte direttamente e non più attraverso intermediari locali. Aggiunge che è ormai “ proprietario di tutte le miniere, incluse quelle del Comune di Lipari, legatosi con un contratto, per 20 anni, per consegnare a me l’intero prodotto delle sue miniere”. E vanta il sicuro consenso del Comune – malgrado ancora il Consiglio non abbia preso alcuna decisione – grazie all’assistenza” di quattro persone interamente padrone della situazione e di procuratori degni di fiducia da cui ho avuto i documenti”.
L’informazione suscita clamore e più delle pagine e pagine del Caserta sono le righe di Haan a tacitare ogni voce di consenso dell’iniziativa, soprattutto in Consiglio comunale. Nessuno infatti vuole essere accusato di essere una di quelle “quattro o cinque persone interamente padrone della situazione”. Inoltre la lettera faceva intendere che i danneggiati non sarebbero stati solo gli operai cavaioli ma anche i bottai che costruiscono casse e barili e gli armatori dei vaporetti che fino ad allora avevano trasportato la pomice . Questi ultimi, visto la crisi dei prodotti della vite per via della fillossera, facevano ormai affidamento soprattutto sul trasporto della pomice. Anzi era stato grazie a questa prospettiva che diversi armatori liparesi, a cominciare dal comandante Francesco La Cava, avevano potuto riconvertire il loro naviglio passando appunto dalla vela al vapore.[13]
Haan e compagni continuarono la loro attività di industriali pomiciferi sfruttando solo le aree private che avevano già acquisito. E gli affari prosperarono tanto che nel 1909 presero in affitto un mulino per 12 anni. All’inizio del conflitto fu fatto un inventario dell’azienda è risultò una consistenza attiva di oltre 415 mila lire. Nell’aprile del 1915, col precipitare delle relazioni dell’Italia con l’impero austro germanico, Haan chiuse la lavorazione e licenziò il personale. La gestione dell’azienda venne assunta dal procuratore Filippo De Pasquale. La ditta Haan continuò i rapporti con Lipari come distributrice della pomice in Germania, almeno sino agli anni ’70[14].(Archivio Storico Eoliano.it)
[1] I riferimenti per questo capitolo sono tratti – quando non riferito diversamente - da G.Iacolino, indedito cit., quaderni X e XI; G. Arena, L’economia delle isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina 1982; M.Saija, La seconda controversia liparitana, in “Dal ‘constitutum’ alle ‘controversie liparitane’, Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano,n.2, Messina 1998; G. La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dagli albori alle concessioni monopolistiche, Milazzo 2002; G.La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dalla controversia con il vescovo Natoli all’avvio della legge sulla pomice, Lipari 2008; G. La Greca, La storia della pomice di Lipari. Volume III. Dal tentativo Haan alla legge del 1908, Lipari 2009.
[2] G.Iacolino, nota n. 32 a P.Campis, op.cit., pag. 465.
[3] G.La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dagli albori alle concessioni monopolistiche, Milazzo 2003, pag.34.D.du Dolomieu, Viaggio alle Isole Lipari, Edizioni del Centro Studi Eoliano; L.Spallanzani, Destinazione Eolie (1788), Lipari 1993.
[4] G. Arena, op.cit., pag. 47.
[5] Ancora nel 1958 qualche anziano di Canneto ricordava questa prassi che comunque dovette andare avanti, parallelamente, anche quando l’attività fu industrializzata.
[6] A.Natoli La Rosa, Prospetto descrittivo delle Isole Eolie, Palermo 1900, p.3. anche G.Arena , op.cit., pp 47-50.
[7] G.Arena, op. cit. pag. 47.
[8] Il test del contratto come i riferimenti ai Consigli comunali in G. La Greca, La storia della pomice di Lipari. Dagli albori alle concessioni monopolistiche, op.cit. pp.124-125.
[9] Lire 1 a quintale per pomici frantumi e lire 9 per le pomici grosse.
[10] G.Arena, op. cit., pag. 48.
[11] A.Natoli La Rosa, Studii Politico-sociali”, op. cit.
[12] L.S. d’ Austria, Le Isole Lipari, Volume VIII. Parte Generale. Praga 1894.
[13] M. Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit., pag.180.
[14] G. La Greca, La storia della pomice di Lipari, Vol.III. Dal tentativo Haan alla legge del 1908, Lipari 2009, pp.43-60.
Mons. Arata, un grande vescovo santo
La paziente intransigenza di mons. Arata
 Le antiche porte di Palermo
Le antiche porte di Palermo
Tensioni con il Tribunale della Real Monarchia dovette sperimentarle anche mons. Francesco Arata[1], malgrado i propositi con cui era giunto a Lipari nel gennaio del 1664. Il suo fermo intento era quello di liberare la diocesi dalla presenza del commissario del Tribunale della Real Monarchia di Palermo ma agendo con tatto e diplomazia e senza lasciarsi sviare da altri problemi. Invece improvvisamente, ad un anno dal suo arrivo, si trovò nel bel mezzo della mischia con il governatore delle isole e capitano d’arme. Una contesa partita da un problema eminentemente giuridico e cioè se l’istituto del “privilegio del foro” – che permetteva al vescovo di far giudicare dal tribunale ecclesiastico di sua competenza gli ecclesiastici ed i familiari di Curia – che era stato abrogato nel 1635 dal re di Spagna, si applicava ugualmente a Lipari visto che la diocesi – già prima di quel tempo - dipendeva direttamente dalla Santa Sede[2]. Ma la vicenda degenera in un conflitto col capitano d’arme che viene scomunicato dal vescovo e col commissario del Tribunale della Real Monarchia. Inoltre mons. Arata deve anche trascorrere tre mesi nella prigione di Palermo dove lo rinchiude, nella primavera del 1667, il viceré. Il vescovo non si dà per sconfitto ed approfitta di questi mesi per avere un chiarimento, a conclusione del quale torna a Lipari con la promessa che sarebbe stato allontanato il capitano d’arme e rimosso il commissario. Ma se viene mantenuta, “a stento[3]” , la prima promessa la seconda viene dilazionata nel tempo fino a quando nel 1668 non scoppia un altro caso. Anche qui il commissario impugna una sentenza del vescovo ed il vescovo lo minaccia di scomunica. A questo punto il commissario si dimette e chiede di riconciliarsi col vescovo. Il Tribunale di Palermo non nominò un successore ma il nuovo viceré volle incontrare, come aveva richiesto il suo predecessore il vescovo. Mons. Arata accettò prontamente e annunciò alla S.Sede che chiedeva una dispensa dalla residenza di sei mesi, mettendo in conto che anche questo viceré , come il predecessore, avrebbe approfittato di averlo a Palermo per segregarlo in carcere. Invece questa volta si trattò di un confronto in piena libertà dove ognuno espresse le sue ragioni ma il vescovo rimase fermo sulle sue posizioni e se ne tornò a Lipari di fatto vittorioso anche se non volle ammettere che di una vittoria si era trattato.
Mons. Arata deve nominare il vicario di Messina
Non purtroppo una vittoria definitiva perché scoppia un altro caso, sempre per l’applicazione del “privilegio del foro”, probabilmente nel 1675 o poco prima perché di esso mons. Arata parla in una relazione , appunto del 1675, alla Sacra Congregazione del Concilio. Il caso riguarda il capo dei gendarmi della Curia vescovile che da dieci mesi è in carcere per un alterco col giudice del Tribunale laico. Il vescovo scomunica il giudice e questo si appella al Tribunale della Monarchia. Il vescovo resiste all’ingiunzione di trasmettere ad essa gli atti del procedimento per l’appello e viene convocato alla corte del viceré che allora risiedeva a Milazzo. Dopo due ore di rimostranze che mons. Arata dovette subire improvvisamente il suo interlocutore fu colto da un terribile mal di testa che non accennava a placarsi nemmeno dopo giorni, e così se ne dovette tornare a Palermo.
Ma il caso più clamoroso doveva accadere l’anno successivo, in seguito alla morte dell’arcivescovo di Messina che avvenne il 22 marzo 1676. In quel tempo Messina si era ribellata agli spagnoli ed era temporaneamente occupata dai francesi. Nell’attesa che fosse designato il nuovo arcivescovo il capitolo nominò il vicario nella persona del canonico Benedetto Dini, ma la decisione non piacque al Tribunale della Real Monarchia.
Messina, si eccepì, anche se occupata dai francesi appartiene al regno di Spagna ed al regno di Spagna appartiene gran parte del territorio diocesano. Inoltre si fece appello ad uno dei canoni del Concilio Tridentino che stabiliva che in una diocesi metropolitana con sede vicaria, la nomina del vicario spettava al vescovo della diocesi suffraganea più antica. Cioè, in questo caso, il vescovo di Lipari. Questi, che si trovava in quel periodo a Palermo, acconsentì e nominò un ecclesiastico messinese di sua conoscenza, don Francesco Tanzi che, saputo della nomina, fuggì da Messina e si stabilì a Milazzo per esercitare, libero dal controllo francese, la sua funzione. E così Messina ebbe due vicari, il Dini e il Tanzi. Il primo che esercitava sulla città e sulla parte della diocesi sotto il controllo francese, e l’altro sulla parte della diocesi sotto il controllo spagnolo.
La decisione di mons. Arata di nominare lui il vicario non piacque alla S. Congregazione del Concilio che temeva insidiata la dipendenza diretta della diocesi di Lipari dalla Santa Sede ed il rischio del suo rientro nell’alveo della Legazia Apostolica. Mons. Arata , saputo di queste critiche, cercò di spiegare ai membri della S. Congregazione i motivi del suo comportamento e come, consultando l’archivio diocesano, si era potuto rendere conto che i suoi predecessori per più di sessant’ anni, senza interruzione, avevano accettato di essere suffraganei della sede Metropolitana di Messina. Comunque, conclude assicurando, che è pronto a rimettersi alle loro decisioni.[4].
Prima che la lettera arrivi alla Congregazione questa ha già disposto. Valeva – si conferma - il decreto di Urbano VIII del 1627 che dichiarava esente la chiese di Lipari da qualsiasi dipendenza che non fosse quella della S. Sede quindi l’Arata veniva invitato ad annullare il suo atto, mentre il Tanzi, che non doveva tenere in alcun conto la designazione del vescovo di Lipari doveva comunque rimanere nella carica di vicario generale perché a questo incarico veniva destinato direttamente dalla Congregazione.
Un braccio di ferro fra Roma e Palermo sulla pelle del vescovo
Il vescovo di Lipari ubbidì prontamente e lo comunicò a Roma per dimostrare la sua buona fede. Il Tanzi invece non potè accogliere la disposizione della S. Sede perché viveva in regime di Legazia Apostolica e non poteva accettare ordini superiori che non passassero o fossero approvati dal Tribunale della Monarchia. Inoltre se si applicava il Concilio di Trento, una volta esclusa la diocesi di Lipari il diritto-dovere della nomina passava alle altre diocesi suffraganee che erano Cefalù e Patti e non alla S. Sede.
Ma la S. Congregazione non si dà per vinta. Rimbrotta aspramente il vescovo di Lipari accusandolo “di essersi comportato da spergiuro con determinata volontà e di avere, in piena consapevolezza, contrastato ad un preciso decreto della S.Sede”[5]; e riguardo al Tanzi coglie al volo la circostanza che un suo membro, il card. Ludovico Emanuele Fernandez de Portocarrero era stato designato dalla corte di Madrid a governare l’isola per chiedergli di avallare la nomina della S.Congregazione alla cui decisione lui stesso aveva concorso.
 Il Cardinale Portocarrero
Il Cardinale Portocarrero
Questa mossa metteva in imbarazzo il cardinale Portocarrero che si vide nel mezzo di un conflitto di interesse e non potè fare altro che passare la lettera al giudice del Tribunale della Regia Monarchia. Il giudice – comprendendo benissimo che la richiesta della S. Congregazione minava l’istituto della Legazia Apostolica – respinse la richiesta e censurò l’operato del vescovo di Lipari.
Per circa un anno le cose andarono avanti nella confusione. Il Tanzi continuò ad operare come vicario in base alla nomina del vescovo di Lipari per il Tribunale della Regia Monarchia ed in base alla propria designazione per la S. Sede. La diocesi di Lipari rimase suffraganea di Messina per il Tribunale ed invece soggetta unicamente alla S. Sede per la S. Congregazione. E il povero vescovo di Lipari? Rimaneva nelle ambasce e aspettava chiarimenti da Roma che non arrivavano.
Questa era la situazione quando nel maggio del 1678, in ordine ad una causa della vendita di un podere di Salina avvenuta 35 anni prima, ci si appella all’arcivescovo di Messina e questo richiede gli atti alla curia di Lipari. Che fare? Il vescovo scrive all’arcivescovo esprimendogli tutto il proprio imbarazzo, gli chiede di aver pazienza e di attendere, perché spera in un chiarimento da parte della S. Congregazione del Concilio[6]. Ma Roma taceva malgrado le sollecitazioni ed intanto si aveva sentore che a Palermo la situazione andava aggravandosi perché l’arcivescovo di Messina non aveva mantenuto il silenzio dopo la lettera di Mons. Arata, ma aveva informato il viceré che aveva informato il re.
Il 17 ottobre del 1678 la consulta dei ministri di Stato emette una sentenza che riafferma la suffraganeità della diocesi di Lipari rispetto a Messina e si suggerisce al vicerè di convocare a Palermo il vescovo di Lipari per dar conto della sua condotta presente e passata.
E mons. Arata parte per Palermo alla fine di giugno del 1679 ed a Palermo vi rimarrà per circa un anno, fino al giugno del 1680, trascorso in incontri e interrogatori e per lo più in stato di detenzione con lo scopo di farlo desistere dalla posizione di ritenersi dipendente solo da Roma. Durante questo periodo più volte scrive alla S. Congregazione chiedendo lumi su come comportarsi ma senza ricevere sostegno ed appoggio alcuno. Al vicerè il povero vescovo continua a rispondere che lui aveva cercato di adeguarsi alla volontà del re e di comportarsi come suffraganeo del metropolitano di Messina ma questa condotta non mi fu più possibile tenerla per un esplicito intervento del papa. “Quel che avrei dovuto fare me lo suggerisca, di grazia, Eccellentissimo Viceré, la Sua ben nota e decantata pietà e saggezza. Avrei potuto io, in tutta coscienza, avrei potuto io, in tutta coscienza, non ubbidire ad un così esplicito ordine del Sommo Pontefice che è l’immediato ed unico superiore dei Vescovi?... se ad un suddito vengono impartiti da due Superiori diversi ordini contrastanti fra loro, ben si sa che tutti i Teologi suggeriscono che è doveroso obbedire a quel superiore che è di grado più elevato, e non all’altro”.[7]
Mentre a Palermo mons. Arata si mostrava risoluto sulla sua posizione, a Roma l’ambasciatore di Spagna aveva aperto estenuanti quanto inutili trattative con la curia giacchè il papa era più risoluto di Mons. Arata. Intanto a Messina si raccoglievano documenti e testimonianze per testimoniare quanto la suffraganeità di Lipari fosse antica e costante. Tutto però dimostrava che la questione andava per le lunghe per cui sul finire dell’inverno del 1680 il vicerè chiede al re il permesso di potere rimandare a Lipari l’Arata che si era dimostrato un soggetto troppo difficile da trattare e per di più la diocesi lamentava la mancanza del suo vescovo.
Così, probabilmente, nel giugno dello stesso anno mons. Arata tornava alla sua sede. Intanto nel marzo del 1678 era stato nominato il nuovo arcivescovo e quindi il problema della nomina del vicario si era risolta di per sé. Rimaneva il problema della dipendenza della chiesa di Lipari. Questa si risolvette in qualche modo il 9 febbraio del 1691 quando, morto mons. Arata, venne nominato vescovo di Lipari mons. Gaetano Castillo[8] ed il papa, nella bolla di nomina, ribadì l’esenzione della chiesa di Lipari da ogni sudditanza esclusa quella con Roma. Ed essendo questa bolla stata sottoposta dal nuovo vescovo all’exequatur del governo siciliano la questione veniva risolta con una vittoria piena della Santa Sede[9].
Gli anni ’70 non sono solo quelli, come abbiamo visto, del braccio di ferro fra Roma e Palermo giocata sulla pelle di mons. Arata ma sono anche anni di carestia e di guerre che investono le Eolie come la Sicilia ed altre realtà del Mediterraneo.
Carestia allora significava crudamente mancanza di pane. La raccolta del 1671 era stata poverissima. I contadini protestavano con i proprietari terrieri accusandoli di vendere ai cittadini tutto il grano prodotto per ricavare maggiori guadagni e abbandonavano le campagne affollando le città sperando di trovare qui il benessere. In realtà trovavano miseria e morte. Nel corso del 1672 a Palermo morirono di fame oltre cinquantamila persone, a Messina ventimila, quindicimila a Catania e Siracusa[10]. I messinesi armarono cinque vascelli e con essi cominciarono a dare la caccia alle navi cariche di mercanzie che attraversavano lo Stretto o veleggiavano nelle vicinanze[11]. E siccome questa pratica si era diffusa nelle zone costiere, il viceré intervenne per dichiararla inammissibile, chiedendo la punizione dei magistrati che li avevano avallato ed ordinando la restituzione dei grani derubati. Ma era tutto inutile perché la situazione, in particolare nel messinese, era ogni giorno di più fuori controllo[12] .
Il "miracolo" del Vascelluzzo
E a Lipari? La situazione non era certo migliore che altrove. E’ proprio in questa circostanza il vescovo Arata, che già si era fatto apprezzare per il suo spirito di carità verso i poveri, “faceva distribuire ai bisognosi ogni mattina alla porta del suo Palazzo – annota il Campis[13] -o leumi cotti o riso, e non in scarsa misura”.Ma malgrado l’impegno del vescovo la situazione andava precipitando fino a quando, nella prima decade di febbraio del 1672, erano terminate le scorte di grano e non si aveva speranza che ne potesse arrivare dalla Sicilia perché per parecchi giorni di seguito vi erano furiose tempeste che non permettevano a nessun vascello di accostarsi.
 Il Vascelluzzo
Il Vascelluzzo
Il 13 febbraio era la ricorrenza dell’arrivo a Lipari delle spoglie di S.Bartolomeo e la gente, come sempre nelle situazioni di pericolo, si affidava al patrono aumentando le invocazioni e le preghiere. Ed è proprio il 12 febbraio, vigilia della ricorrenza, si vide apparire all’improvviso dinnanzi all’isola “una gran nave, la quale, quantunque combattuta da ogni parte dalli venti infuriati e flagellata dall’onde, non però cedeva punto allo sdegno degli elementi”[14]. Il Campis descrive come il comandante cercasse in tutti i modi di indirizzare il vascello verso Milazzo o una spiaggia della costa tirrenica, ma inutilmente. Il vento consentì una sola manovra, quella di approdare nel porto di Lipari. Qui si scopre che era una tartana francese, denominata S. Bartolomeo, carica di frumento, diretta a Messina. E quando si seppe che Bartolomeo era anche il nome del proprietario, subito si gridò al miracolo e comprato tutto il grano, “si rimediò alle communi miserie per qualche tempo”[15].
E si tratta, questo del vascello pieno di grano, del miracolo più popolare fra gli eoliani assieme a quello dell’arrivo delle reliquie del Santo. A memoria di esso nel 1930 i liparesi fecero realizzare il cosiddetto “vascelluzzo” in oro ed argento, un reliquiario che conserva un lembo di pelle del Santo[16].
Ma non sono solo la carestia e la miseria a travagliare in questi anni la vita degli eoliani, vi sono i navigli dei saraceni che rifanno la loro comparsa, ma soprattutto ricompaiono nei nostri mari le navi da guerra, che per qualche tempo, non si erano più viste e le isole tornano ad essere teatro di scontri.
Il motivo per cui gli scontri navali riprendono a verificarsi nel basso tirreno è legato in particolare alle vicende di Messina. Qui la carestia ha dato origine a forti sommosse popolari[17] e ad una sorta di guerra civile che ha portato Messina a scacciare gli spagnoli e a chiedere l’appoggio dei Francesi ed a dichiararsi indipendente dalla Spagna ( 1674-1678).
Tutto questo per i liparesi – che si mantennero fedeli al re di Spagna con in testa i loro giurati ed il loro vescovo - voleva dire maggiori restrizioni nelle navigazioni giacchè c’era il pericolo di imbattersi in navigli francesi. Per il popolo voleva dire anche lavoro straordinario e gratuito nelle opere di difesa, requisizione ed ammasso nei magazzini del Castello del poco grano che i contadini conservavano per le emergenze. Una squadra francese piuttosto consistente operava nei mari delle Eolie nel febbraio del 1675 . Lo scontro con gli spagnoli avvenne tra Panarea e Stromboli e la vittoria arrise ai francesi tanto che il comandante della flotta, sbarcato a Messina, si dichiarò viceré di Sicilia. Un altro scontro, questa volta fra francesi e gli olandesi venuti a dare man forte agli spagnoli e dall’esito dubbio, si ebbe a largo di Alicudi l’8 gennaio del 1676. Dopo lo scontro entrambi i contendenti vennero a sostare nelle baie di Lipari tenendosi a rispettosa distanza. Si studiarono per due giorni con qualche scaramuccia, poi i francesi si mossero verso Messina mentre gli olandesi buttarono le ancore a Milazzo. Dopo le operazioni navali si spostarono sulle coste della Sicilia orientale.
Gli scontri finirono nel 1678 con la pace di Nimega e la Spagna riebbe indietro Messina e gli altri territori occupati in Sicilia[18].
 Messina, antica fortezza
Messina, antica fortezza
Un grande e santo vescovo
La carità di mons. Arata verso i poveri non si limitò solo al periodo della carestia ma fu un carattere distintivo di tutto il suo ministero[19]. E visto che gli introiti della Mensa non erano più abbondanti come un tempo, giacchè la carestia e la limitatezza dei commerci aveva ridotto le entrate a 3 mila scudi l’anno mentre la popolazione era arrivata a 5.500 abitanti – di cui tre mila nella città alta – e da questi introiti bisognava decurtare diverse somme[20] fra cui quelle per l’ospedale dell’Annunciata che si trovava al Castello, vi rimediava con le sue risorse personali e con i contributi dei benefattori[21] che continuamente sollecitava. Per recuperare le risorse per i poveri mons. Arata arrivò a vendere i materassi e le coperte del suo letto. Il Campis racconta che “tutte le limosine che distribuiva voleva passassero per mano non sua, ma d’altri. Anzi mai esso tenne denaro sopra di sé, e richiesto un giorno da persona confidente perché così praticasse, rispose: ?Se io vedessi con i miei occhi il denaro, che sa se io me l’affetionassi e mi paresse più duro il darlo come devo. L’argento e l’oro rubbano i cuori per menzo dell’occhio, onde per guardarci da essi non dobbiam guardarli”[22].
La sua attività caritativa aveva ottenuto dei buoni successi se poteva scrivere nel 1665 – naturalmente prima della carestia - che “in mezzo a questo piccolo gregge non c’è una sola pecorella alla quale manchino gli alimenti per il suo quotidiano sostentamento”.[23]
Ma la carità non era l’unico valore all’attenzione del vescovo Arata, aveva anche – ed è forse il suo tratto più interessante – una concezione dell’evangelizzazione che modernamente si sposava con la promozione umana. Anch’egli, come i suoi predecessori, si rende conto che la religiosità degli eoliani é molto carente, fortemente inquinata da una ignoranza – a cominciare dal non sapere leggere e scrivere, peculiarità che non era solo del popolo ma anche della classe media e dei ceti privilegiati[24] - che li portava a viverla intrisa di superstizione e paganesimo.. Ma, al contrario di essi, non si limita a condannare queste deviazioni ma andava alle sue cause. E le cause stavano nel clero secolare e nei religiosi che non erano meno ignoranti del popolo che era loro affidato. I primi perché la loro formazione era approssimativa e abborracciata[25], i secondi perché come scriverà lo stesso vescovo in una relazione “ad Limina” del 19 gennaio 1668 – “qui per lo più vengono inviati come a luogo di confino e al fine di far penitenza taluni frati che si allontanano dalla disciplina religiosa e sono rilassati nello spirito” per cui “con la loro condotta essi fanno più male che bene, e che con la loro licenziosità e dissolutezza danno occasione a fatti scandalosi”[26].
Per i frati chiede ed ottiene la collaborazione dei superiori. Ed infatti, già nel 1672, in una lettera alla S. Congregazione del Concilio riferisce che la situazione è del tutto mutata sia per quanto riguarda i cappuccini sia per i minori osservanti. Per quanto riguarda, invece, il clero secolare e il popolo mette in campo una strategia ad ampio raggio. Fa venire da fuori sette sacerdoti che dovranno collaborare nella sua opera pastorale a cominciare dal vicario generale; tenta di portare a Lipari – ma l’operazione non va in porto - i frati Scolopi, specializzati nella promozione della cultura popolare, ed arriva ad offrire loro il convento sulla Civita dei minori osservanti; promuove un Sinodo diocesano per il 1666 con l’obiettivo di verificare lo stato disciplinare della sua chiesa;[27] istituisce in Lipari di un parroco stabile perpetuo che svolga con continuità la cura d’anime senza essere distolto- come accade per il vescovo – da attività di governo; invita puntualmente predicatori gesuiti a parlare in Cattedrale ed a tenere “i quaresimali”[28]; infine, ma sicuramente l’iniziativa più importante, promuove l’apertura di una “scuola di grammatica”, gratuita ed aperta a tutti, ai chierici che volevano prepararsi al sacerdozio ma anche i ragazzi poveri che volevano darsi una cultura di base. In questa scuola si dovevano insegnare “la grammatica ed i rudimenti della fede”[29].
 La “scuola di grammatica” promossa da mons. Arata sarà il primo strumento di istruzione pubblica delle Eolie. Proprio in quegli anni Lipari apriva due biblioteche – sempre sovvenzionate dal vescovo - una presso il monastero dei Minori Osservanti ed una presso i Cappuccini mentre lo stesso vescovo, presso il suo palazzo, aveva un’altra buona dotazione di libri.
La “scuola di grammatica” promossa da mons. Arata sarà il primo strumento di istruzione pubblica delle Eolie. Proprio in quegli anni Lipari apriva due biblioteche – sempre sovvenzionate dal vescovo - una presso il monastero dei Minori Osservanti ed una presso i Cappuccini mentre lo stesso vescovo, presso il suo palazzo, aveva un’altra buona dotazione di libri.
Col tempo anche le forme di espressività religiosa durante le processioni si erano purificate e non vi erano più le manifestazioni esagitate che tanto negativamente avevano colpito mons. Vidal.
Si era fortemente affezionato a Lipari Mons. Arata e quando, morto l’arcivescovo di Catania, il 27 settembre 1686, lo stesso Carlo II lo proporrà per governare quella diocesi, egli rifiutò per non abbandonare quella che Dio gli aveva “data per sposa” [30]. Ci si è chiesti se quello del re fosse un riconoscimento per un prelato che nella difficile vicenda della ribellione di Messina si era mantenuto fedele alla monarchia spagnola oppure un ennesimo tentativo di riaprire in qualche modo la vicenda dell’autonomia della diocesi liparese liberandosi di un vescovo irriducibile dalla consegna avuta dal papa. Ma se veramente questo proposito stava in cima ai pensieri della Spagna non si sarebbe dovuta prestare più attenzione alla bolla di nomina del suo successore quando fu sottoposta all’exequatur?
Comunque passarono meno di quattro anni ed il 25 maggio 1690 mons. Arata morì compiendo l’ultimo atto di umiltà della sua vita. Chiedendo, cioè, - come racconta il Campis – di essere sepolto nella Cattedrale, ai piedi dei gradini dell’entrata , dalla parte interna della chiesa, in modo da “esser calpestato da tutti quelli che entrassero”[31]
[1] Dopo i problemi vissuti da mons. Gentile la Santa Sede tornò a promuovere su Lipari vescovi siciliani capaci di trovare un modus vivendi con la Real Monarchia siciliana e la scelta cadde su mons. Francesco Arata, appartenente ad una influente famiglia di Palermo. Venne nominato vescovo di Lipari il 13 agosto del 1663 e giunse a Lipari nel gennaio del 1664 con il fermo proposito di tenersi lontano da ogni competizione.
[2] La vicenda la si ritrova nei documenti dell’Archivio Segreto del Vaticano, Sacra Congreg. Concilio R., cass. 456°, ff.147 e 147v e anche i G. La Rosa,op.cit., vol.I , pag. 205 e ss.. Si veda G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno IID, pag.57 b1,2,c
[3] ASV,SCCR, Cass.456 A f.178v.
[4] Archivio Segreto Vaticano, SCCR, Cass. 456°, ff.173-173v. La lettera del vescovo Arata è del 10 aprile 1677.
[5] G.Oliva, op.cit. doc.IV, p.36.
[6] La documentazione in ASV, SCCR, Csss. 456°, ff.300-300v.
[7] Lettera del 10 novembre 1679 in ASV, SCCR, Cass.456°, ,f.330.
[8] Mons. Gaetano Castillo, nato a Termini Imerese, teatino, eletto vescovo di Lipari l’8 gennaio 1691all’età di trentatrè anni. Morirà il 22 marzo del 1694 cadendo da una scaletta sul tetto del Palazzo Vescovile.
.[9] Iacolino ritiene che l’accettazione dell’autonomia di Lipari da Messina non sia stato un atto voluto del Tribunale di Palermo ma piuttosto una disattenzione giacchè l’arcivescovo di Messina continuò a ritenere la diocesi di Lipari sua suffraganea ed a chiamare all’appello il vescovo di Lipari il 14 agosto, la vigilia dell’Assunta. Naturalmente questi risultava assente e veniva puntualmente multato ma la multa non veniva mai riscossa. (G:Iacolino, manoscritto, cit. Quaderno IID, pag. 72 a,b.). Comunque dopo il successo del 1691 la Curia romana continuerà a ribadire l’autonomia di Lipari da Messina fino al 1826 quando tornò a considerare i vescovi di Lipari suffraganei di Messina anche se ormai si trattava di un atto formale. La suffraganeità viene definitivamente meno quando nel 1976 la diocesi di Lipari verrà incorporata nell’Arcidiocesi di Messina.(Archivio Storico Eoliano.it)
[10] S.Greco, Messina Medioevale e moderna. Dai Normanni ai Borboni, Messina 1998, pag. 285.
[11] Idem, pag. 283.
[12] G.E. Di Blasi, Storia cronologica de’Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, Palermo 1974, vol.III, pag.243-245.
[13] É.Campis, op.cit., pag.338.
[14] Idem, pag. 339.
[15] Idem, p.340.
[16] Quello dell’arrivo miracoloso di vascelli carichi di grano nei porti di città o paesi marinari in quei giorni della grande carestia, non furono rari. Un simile caso, imputato ad un miracolo della Beata Vergine, successe anche a Messina negli stessi giorni ed anche a Messina si fece un vascello d’oro per ricordare l’evento. V. F.Pergolizzi, “Quel famigerato viceré della Sicilia”, in Gazzetta del Sud, 1 aprile 1992. Certo la coincidenza degli arrivi miracolosi e della denuncia dei furti di nave non può non insospettire. Inoltre, al di là del fatto specifico, c’è da chiedersi quanto i liparesi che avevano la fama di sapersi destreggiare nel campo della pirateria marittima fossero rimasti inoperosi in una situazione così confusa e drammatica. Su questi dubbi si veda anche G.Iacolino “E’ arrivato un vascello carico di…” in Gente alle Eolie, Lipari 1994, pp.207-210.
[17] Uno degli episodi che fu all’origine delle sommosse messinesi riguarda un argentiere Giuseppe Martines la cui moglie aveva da poco partorito e lui andava alla ricerca di un pane. Ma in Sicilia, per decreto del viceré, al popolo non poteva esser venduto pane fresco (che invece era privilegio solo dei baroni), ma quello del giorno precedente perché si era convinti – vista la carestia - che dovendo mangiare pane duro se ne limitasse il consumo. Il Martines a cui era stato rifiutato un pane si vide sfilare sotto gli occhi una cesta di quello appena sfornato destinato ai nobili. Infuriato picchiò il garzone e rubò un pane. Sul posto si raccolse una piccola folla che cominciò ad inveire contro il Senato. Accorsero altra gente ed anche alcuni nobili e nel tafferuglio che seguì il Maertines ferì un nobile e si dette alla fuga. L’episodio mette in evidenza il dualismo che si andava formando in città: i nobili e il senato da una parte denominati Malvizzi ed il popolo dall’altra denominati Merli. E siccome con questi si schierò lo stradigoto, i Merli furono intesi come filo spagnoli e i Malvizzi invece come fauturi dell’indipendenza dagli spagnoli. Nell’estate del 1674 i Malvizzi fecero strage di popolani, scacciarono lo stradigoto e fecero allontanare a cannonate il viceré che voleva entrare in porto. Era l’avvio dell’indipendenza della Spagna e per garantirla i messinesi si appellarono ai francesi e furono ben felici di intervenire con le loro navi. Essi fecero la comparsa nei nostri mari il 28 settembre del 1674. (S.Greco, Messina mediovale e moderna, op.cit,. pp.283-300.
[18] Dura fu la vendetta degli spagnoli contro Messina che uscì da questa esperienza distrutta: il Palazzo municipale venne abbattuto e le macerie cosparse di sale; il senato elettivo fu abolito; l’Università e la Zecca chiuse; le campane del Duomo vennero fuse e se ne ricavò una statua equestre raffigurante re Carlo II che schiacciava l’idra della rivoluzione; l’Archivio distrutto e disperso; i cittadini più compromessi fuggirono e la città si ridusse a quasi la metà con non più di 50 mila abitanti.
[19] Campis racconta che fra l’altro il vescovo tutti i giorni aveva un povero a pranzo come commensale ed alla fine del pasto, che condivideva con lui, gli dava anche una elemosina in denaro. I poveri diventavano più d’uno nelle solennità.
[20] Ricordiamo che a carico della Mensa oltre all’ospedale vi erano le spese correnti della Cattedrale; gli stipendi per i cappellani, i canonici, i procuratori legali e gli impiegati delle corti vescovili; le pensioni annuali per i porporati romani; le guardie per mare e sulle alture (Stromboli, Alicudi, Monte Guardia); l’integrazione dei legati per le fanciulle povere da marito, ecc.
[21] Fra questi benefattori il più generoso e assiduo fu Bartolo Russo “il quale quotidianamente lo provedeva di quanto vi fu bisogno sino all’ultimo de’ di lui giorni”(Campis).
[22] P.Campis, pag. 340-341.
[23] ASV, Cass.456 A f. 163.
[24] Vi erano “cerusici” che per rilasciare un certificato di malattia dovevano ricorrere al notaio che sotto il referto faceva apporre un segno di croce attestando che questo apparteneva al “professionista”(G. Iacolino, manoscritto cit. Quaderno IID, pag. 58).
[25] Se un giovane voleva farsi prete chiedeva l’autorizzazione al vescovo che gli indicava alcuni sacerdoti anziani che davano un po’ di rudimenti per una decina d’anni. Di tanto in tanto venivano sottoposti a degli esami e quando erano ritenuti idonei ricevevano gli ordini sacri.
[26] ASV,SCCR,Cass. 456°, ff.179v-180.
[27] E’ singolare che all’annuncio del Sinodo le autorità laiche ed il popolo si appellano al viceré ed al Tribunale della Monarchia ritenendolo “contro il bene comune”. Per fortuna il vicerè e i Tribunale furono di tutt’altro avviso e stigmatizzarono le autorità locali per avere “osato iterferire nella sfera ecclesiastica” (ASV,SCCR, Cass, 456A, f. 177).
[28] La preparazione alla Pasqua durante i quaranta giorni della quaresima.
[29] G. La Rosa, op.cit., Vol.I, pp 211-216.
[30] G.La Rosa, op.cit., Vol.I, pag.220.
[31] P.Campis, op.cit., pag. 344.
Il vescovato di Lipari sempre al centro di tensioni
La pratica dello "spoglio" ridesta il conflitto
 Innocenzo X
Innocenzo X
Se durante il vescovato di mons. Giuseppe Candido la tensione pubblica fra il vescovo e le autorità di governo sembra assopirsi essa riprende di nuovo fuoco improvvisamente – segno che la situazione era tutt’altro che tranquillizzata – con il suo successore che era anche suo cugino, mons. Agostino Candido[1]. A dar fuoco alla miccia è la decisione della Nunziatura Apostolica di Napoli di praticare lo “spoglio” in seguito alla morte del predecessore sospettando il lascito di un ingente capitale liquido. Il capitale non si trova ma scoppia un conflitto che si allarga a macchia d’olio chiamando in causa prima il vescovo, che pure aveva tentato di tenersi in disparte, poi i giurati e quindi anche i referenti esterni a cominciare dal viceré di Sicilia sollecitato dai giurati che avevano preso le parti del vescovo, e del Nunzio di Napoli che inviò un suo rappresentante il quale si appellò al capitano d’arme. Infine la vicenda viene portata per ben due volte alla Santa Sede, la prima dal vescovo che era stato sospeso da un procuratore del Nunzio di Napoli, la seconda dai suoi avversari che avevano accusato Mons. Candito di avere ceduto alla Real Monarchia di Sicilia mettendo in discussione il diritto del Pontefice. Ed è nel corso di questo viaggio, dopo aver chiarita la situazione col papa, che mons. Candido muore, nel luglio del 1650, colpito dalle febbri delle paludi romane[2].
Alla fine lo “spoglio” si fece malgrado il nuovo vescovo, mons. Geraci, avesse preso posizione contraria. Questi però seppe trarre insegnamento dalla vicenda e curò, durante il suo governo, di depositare periodicamente presso il banco del Vaticano – garantendone la disponibilità per la chiesa liparese – le somme eccedenti della sua amministrazione.[3]
Comunque la chiesa liparese – al di là di momentanei chiarimenti - continuò a vivere in un intreccio di tensioni e di ambiguità fra Santa Sede, Nunziatura Apostolica di Napoli e Tribunale della Regia Monarchia di Palermo. E che a queste tensioni contribuivano anche gli uffici vaticani lo mette in risalto la lettera che il 19 dicembre 1650 – in occasione della nomina del nuovo vescovo mons. Benedetto Geraci[4] – a nome del papa Innocenzo X veniva inviata all’arcivescovo di Messina. In essa si ripristinava il suo ruolo di metropolita nei confronti del vescovo di Lipari, in aperta contraddizione di quanto aveva disposto Urbano VIII nel 1627 e quindi si ridava fiato alle mire di Palermo di interferire nella diocesi di Lipari. Comunque quest’atto, qualunque ne sia stata la ragione e la causa, rimarrà isolato e la S.Congregazione del Concilio, in futuro, farà sempre riferimento alla bolla di Urbano VIII.[5].
E fu proprio mons. Geraci che sperimentò direttamente come fra la prepotenza della Real Monarchia e le ambiguità e la lontananza della Santa Sede, spazio al vescovo per difendere l’autonomia della sua diocesi ne rimaneva ben poca. Così dovette piegare la testa sulla vicenda dello “spoglio”, ma in qualche modo dovette subire – malgrado le riconferme formali del vaticano della particolare condizione della diocesi nei confronti del regno di Sicilia - anche l’ingerenza del Tribunale della Real Monarchia che nominò un suo commissario a Lipari, ed infine ebbe partita persa nella difesa del “diritto d’asilo” che cercò di far rispettare nelle chiese della sua diocesi ma ricevendo i rimbrotti del viceré[6].
Ma qual è la rendita annua della Mensa vescovile?
 Prima di partire per Roma per effettuare la sua visita “ad Limina”, fissata per i primi mesi del 1660, Mons. Geraci scrive una sua relazione alla Sacra Congregazione del Concilio[7] dove fa il punto sulla situazione economica e finanziaria della diocesi. Egli sostiene che i proventi annui della mensa sono di circa 3 mila ducati di moneta d’argento siciliana quindi ben 1.500 in meno degli introiti dichiarati da mons. Candido. Se poi si pensa che da questi 3000 bisogna sottrarne 1.500 per le pensioni romane[8] e rimanevano da pagare gli stipendi ai due collettori delle decime, i contributi per il mantenimento delle guardie diurne e notturne della Città e delle isole, le elemosine da erogare ai poveri della città alta – dove risiedevano 3 mila abitanti - che erano molti, e a quelli del borgo – che contava 2 mila anime – che erano ancora di più, si poteva capire che le risorse a disposizione del vescovo fossero veramente poche e da qui le lamentele per non potere riparare la cattedrale che mostrava segni di decadimento.
Prima di partire per Roma per effettuare la sua visita “ad Limina”, fissata per i primi mesi del 1660, Mons. Geraci scrive una sua relazione alla Sacra Congregazione del Concilio[7] dove fa il punto sulla situazione economica e finanziaria della diocesi. Egli sostiene che i proventi annui della mensa sono di circa 3 mila ducati di moneta d’argento siciliana quindi ben 1.500 in meno degli introiti dichiarati da mons. Candido. Se poi si pensa che da questi 3000 bisogna sottrarne 1.500 per le pensioni romane[8] e rimanevano da pagare gli stipendi ai due collettori delle decime, i contributi per il mantenimento delle guardie diurne e notturne della Città e delle isole, le elemosine da erogare ai poveri della città alta – dove risiedevano 3 mila abitanti - che erano molti, e a quelli del borgo – che contava 2 mila anime – che erano ancora di più, si poteva capire che le risorse a disposizione del vescovo fossero veramente poche e da qui le lamentele per non potere riparare la cattedrale che mostrava segni di decadimento.
Ma se questo si diceva nella relazione, la realtà doveva essere ben diversa perché risulta che egli avesse messo da parte ben quattordicimila scudi d’oro con i quali intendeva creare un fondo per costituire a Lipari un “monte di Pietà per beneficio delli Popoli di questa Città”. E contava proprio di approfittare della vista “ad limina” per versarlo in una qualche banca romana. E non ne aveva parlato nella relazione perché reso edotto delle travesìe subite al suo insediamento non voleva che questa somma finisse nello “spoglio[9]”.
Purtroppo il viaggio per Roma fu avventuroso e durò un paio di mesi passando per tempeste spaventose. A Roma, qualche mese dopo il vescovo morì e dei quattordicimila scudi d’oro, che era riuscito a salvare dalla tempesta, non si riuscì a sapere che fine avessero fatti[10].
Basiluzzo fa parte delle Eolie?
 L'isolotto di Basiluzzo
L'isolotto di Basiluzzo
Comunque che il vescovo avesse messo da parte una somma cospicua si doveva essere diffusa la voce perché subito , questa volta, partì l’operazione di “spoglio” avallata dal nuovo vescovo, mons. Adamo Gentile[11], che era un napoletano. Ma delle somme sperate non si trovò nulla e si dette sfogo ad una caccia alle streghe con incriminazione di furto ed arresto nei confronti di un povero prete e quindi reazioni delle autorità civili e quindi del viceré di Palermo che mal sopportavano l’accondiscendenza del vescovo allo “spoglio”[12]. Il vescovato di Lipari rimaneva così al centro di tensioni e turbolenze. Anzi mons. Gentile nel poco tempo che fu alla guida della diocesi, riuscì ad unificare contro di sé giurati, governatore, nobili e capitolo della Cattedrale. Sull’onda della vicenda dello “spoglio” l’attenzione del vescovo fu attratta dal cercare di capire dove erano andati a finire i 4.600 scudi annui che dovevano avanzare, fatte tutte le detrazioni, visto che la Mensa percepiva ben 6.600 scudi e non 3.000 come asseriva il suo predecessore. E quindi il prelato era divenuto sospettoso di tutti e pronto a entrare in lite con chi scopriva evadere i censi e le decime. In particolare la sua attenzione si appuntò sui possessori di terreni di Basiluzzo, ricchi borghesi ed ecclesiastici che vivevano a Lipari e nulla pagavano alla diocesi. Il vescovo li diffidò e costoro ricorsero al Tribunale della Regia Monarchia. Ed il tribunale candidamente sentenziò che Basiluzzo non faceva parte del lascito di Ruggero Normanno perché nell’elenco delle isole da questo fatto nel documento, Basiluzzo non compariva. Era chiaramente un dispetto fatto al vescovo liparese giacchè era naturale che Basiluzzo non fosse presente nell’elenco visto che era considerato poco più di uno scoglio e quindi nelle pertinenze di Panarea[13].
[1] Mons. Agostino Candido divenne vescovo il 12 giugno del 1645. E’ sotto il suo governo che ufficialmente tornano i cappuccini a Lipari (anche se probabilmente la decisione era già stata presa l’anno precedente) e si stabiliscono dove ora c’è il cimitero comunale ottenendo il terreno per il convento dal vicario episcopale don Benedetto Gualtieri.
[2] La narrazione puntuale di questo conflitto si trova in G. La Rosa, Pyrologia Topistorigrafica dell’Isole di Lipari, Lipari 1997, Primo volume, pp 186 – 191.
[3] G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno IIC, pag. 43.
[4] Mons. Benedetto Geraci venne nominato vescovo di Lipari il 19 dicembre 1650 e morì a Roma , dove era andato in visita ad limina il 13 agosto 1660.
[5] La lettera di Innocenzo X all’arcivescovo di Messina in G.Oliva, Le contese giurisdizionali della Chiesa liparese nei sec. XVII e XVIII, Messina 1905, doc. III, pag.36. In G.Iacolino, manoscritto cit, Quaderno II C, pag 42g,h.i.
[6] Sull’indipendenza della Diocesi si veda G. Oliva, op.cit., pp.97-98 e G. Iacolino, manoscritto cit., pag.43, a, b..Per quanto riguarda il diritto d’asilo si veda G.La Rosa, op.cit. vol.II, pag.110-111. Migliore successo ebbe invece mons. Geraci nel promuovere iniziative devozionali come la nomina di Sant’Agatone a copatrono della diocesi e la Vergine Immacolata a patrona universale delle Eolie. Fece anche consacrare la Chiesa Cattedrale anche se non mancava chi sosteneva che questa fosse già stata consacrata quando fu rimessa in piedi dopo la ruina. Il 28 maggio del 1651 emise un severo “Editto per le magàre” rivelando come i liparesi mischiassero nella loro pietà la devozione dei santi con pratiche di esorcismo e di stregoneria.
[7] Relazione di Mons. Geraci alla S,Congregazione del Concilio del 1659, in Archivio Segreto del Vaticano. Cass. 456 A, ff.133-135,
[8] A carico della diocesi di Lipari che era ritenuta una delle più ricche della Sicilia ogni anno, da oltre un secolo, pendeva l’obbligo di rimettere alla Santa Sede sotto la voce “pensionamento” o stipendio per un paio di cardinali millecinquecento o duemila scudi.
[9] Su queste vicende si vedano i documenti in Archivio Vescovile Lipari, Civili,9. G.Iacolino, Manoscritto cit., pagg. 46 b3,c,d.
[10] G. Iacolino, Gente alle Eolie, Lipari 1994, p.160; G. Iacolino, manoscritto cit.,pag. 46d,47,47°.Mons. Geraci a Roma andava ad abitare presso un amico medico, Terenzio Tornatore, e fu questi che si incaricò delle esequie e su cui si appuntarono molti sospetti per la perdita degli scudi d’oro.
[11] Mons. Adamo Gentile, di Caserta, nominato il 15 novembre del 1660, giunge a Li pari nel maggio del 1661 muore 18 mesi dopo la sua elezione.
[12] G.La Rosa, op.cit., vol.I97-203, vol. II pag. 113-114.
[13] G.La Rosa, op.cit., vol I pag.203, vol.II pag.115-116. La polemica con i canonici si sviluppò a partire dalla richiesta di questi di aumentare la loro prebenda e di regolarizzare il servizio in Cattedrale che lasciava molto a desiderare specie nei confronti delle chiese conventuali. Si discusse anche come reperire i fondi visto che la Cattedrale pretendeva anche lavori di restauro e si arrivò così col parlare degli introiti della Mensa e qui scoppiò il dissidio. I canonici scrivono due lunghe lettre di reclamo – una al viceré e una al Tribunale della Regia Monarchia – dove fra l’altro si accusava il presule di non curarsi del culto divino e del bene spirituale della diocesi e di lasciar deperire la Cattedrale. La risposta del vicerè, comunicata al vescovo e a lui giunta il 7 giugno del 1662, è una dura reprimenda soprattutto per la condizione della cattedrale. Il vescovo – letto il dispaccio – “divenne una vipera che si avventava contro chiunque se li parava d’innanzi, di modo che, non potendo sfogare la sua còlera, se la volle pigliare contro il nostro Glorioso Protettore Apostolo S.Bartolomeo” ed abolì la festa del 17 giugno che scadeva pochi giorni dopo. Ci si immagini la reazione della cittadinanza a cominciare dai giurati. Così quando a metà di novembre mons. Gentile si ammalò e, nel giro di pochi giorni, il 28 novembre morì a solo quarantaquattro anni di età, il giudizio popolare non potè non attribuire questa ad una punizione del Santo.(Archivio Storico Eoliano.it)
Un vescovo diplomatico in un mare di maldicenze
Mons Candido un vescovo che sa destreggiarsi
Per evitare gli eccessi di mons. Caccamo, nella scelta del successore la Santa Sede si muove con molta prudenza e preferisce puntare su un siciliano di Siracusa che però aveva studiato e risiedeva a Roma presso il papa - era maestro del Sacro Palazzo Apostolico - di cui spesso condivideva la mensa. Quindi un uomo di tutta fiducia per cercare di portare in porto l’obiettivo che ha in mente la Santa Sede, rendere la diocesi di Lipari autonoma, dipendente unicamente da Roma e potere da lì sferrare l’attacco alla Legazia Apostolica, ma operando in questa prospettiva con grande prudenza senza perdersi in scontri personali e di sapore locale come era accaduto al Caccamo. Era questi mons. Giuseppe Candido che il 29 novembre del 1627, quando è nominato vescovo di Lipari, ha appena trantacinque anni. Il nuovo vescovo arriva a Lipari con due bolle in tasca: quella di nomina che prudentemente – anche lui come il suo predecessore – sottopone all’exequatur del viceré di Palermo ed un’altra, del dicembre 1627, che doveva tenere segreta e conteneva la dichiarazione di Urbano VIII che la Chiesa di Lipari era immediatamente dipendente dalla Sede Apostolica e quindi libera da ogni autorità e giurisdizione compresa quella del metropolitano di Messina[1]. Segreta doveva essere la bolla per tutti ma non per l’Arcivescovo di Messina che ne era stato messo a conoscenza dallo stesso pontefice. Purtroppo dopo circa un anno anche questa bolla diventa pubblica in seguito ad un incidente. Un soldato, colpito da scomunica da parte del vescovo, ricorre in appello e la causa viene inoltrata a Messina ma l’Arcivescovo, con riferimento alla bolla, si dichiara incompetente. La notizia scatena non poche polemiche. Il re ed i loro funzionari si sentono colpiti nelle loro prerogative giacchè a questo punto tutte le cause giudicate dal Vescovo in appello devono andare direttamente a Roma Ma protestano anche i liparesi per cui questa scelta provocava “tanti dispendij e lungarìe” per cui mandano a Madrid un loro incaricato, designato dai giurati, don Tommaso Policastro a perorare la loro causa[2]. Ma le proteste del re e l’impegno dell’ambasciatore spagnolo non ebbero alcun effetto e con due rescritti del 9 novembre 1631 e del 21 dicembre 1635 la Sacra Congregazione confemava che “Liparensem Episcopum Sedi Apostolicae subiectun”.
Quindi al povero vescovo veniva lasciata una difficile incombenza, quella di rimanere fermo sul principio e nell’ubbidienza alla Santa Sede ma al tempo stesso sapersi muovere con prudenza e diplomazia. E dovette farlo molto bene mons. Candido da ottenere, allo stesso tempo, lode ed approvazione dalla Real Corte e dal papa[3].
Comunque se riesce a destreggiarsi bene con i militari e le autorità di Palermo e di Lipari, Mons. Candido non riesce ad evitare il vezzo - che era un po’ generalizzato, ma nelle isole trovava maggior diffusione forse a causa dell’isolamento e della limitatezza dell’ambiente che finiva con l’enfatizzare luci ed ombre e spesso le ombre più delle luci – della maldicenza e della denigrazione affidata ad una lettera. Mons. Candido fu preso di mira da un gruppo di professionisti e comunque di gente in vista della città che, a partire dal 1639, cominciarono a divulgare sul suo conto critiche e calunnie portandole a conoscenza del viceré e poi anche a Roma alla Sacra Congregazione del Concilio. Fra le altre accuse vi era quella di aver utilizzato a proprio vantaggio il lascito di Mons Vidal, di cui abbiamo detto, per regalare ogni anno il vestiario a persone bisognose dell’uno o della’altro sesso avendo ecceduto nel protagonismo sia pretendendo che o poveri andassero a farsi misurare i vestiti in Palazzo vescovile in sua presenza, sia che poi – una volta ultimati- andassero a ritirarli dalle sue mani mentre se ne stava sulla sedia gestatoria. Una prassi che i delatori giudicavano la causa per cui “molte persone vergognose e meritevoli, essendo di famiglie onorate e bennate, lassano di piglare il detto legato per non comparire pubblicamente e pigliare detta elemosina”[4].
A tutte le accuse il Candido risponde serenamente e puntualmente, ma oltre a lui lo fanno ben venticinque canonici liparesi con una dichiarazione del 15 aprile 1642 che più che una difesa è una attestazione di affetto e di stima per il loro vescovo. E certamente non aveva bisogno di essere difeso a Roma dove era conosciuto e stimato tanto che quando il 15 settembre 1644 viene eletto papa il prefetto della S.Congregazione del Concilio il card. Giambattista Pamphili col nome di Innocenzo X non meraviglia che questi volle mons. Candido a suo fianco a Roma e lo nominò governatore della città[5].
Durante il suo governo che durò dal 1627 al 1644 mons. Candido si distinse per aver ulteriormente migliorato le entrate della diocesi che dai 3 mila scudi del 1626 arrivarono sino a 4.500 scudi. E fu proprio grazie a queste entrate che riuscì – malgrado le dicerìe dei detrattori - a finanziare diverse opere a cominciare dalla Cattedrale dove, per prima cosa, provvide a ricollocare il soglio vescovile all’interno del coro dove era prima dell’intervento di mons. Caccamo. Ma non si limitò certamente a questo: “La Chiesa cattedrale che era vecchia e brutta e che minacciava di andare in pezzi, è stata da me consolidata, interamente biancheggiata, fornita di finestre di vetro e arricchita di nuove cappelle[6]”. E fra l’altro si deve a lui la creazione della cappella del battistero con un artistico fonte battesimale.
Gli anni della carestia e dei tumulti
In quegli anni Lipari era cresciuta e contava complessivamente 5 mila abitanti di cui settecento risiedevano permanentemente nel borgo. Questo numero però aumentava di molto durante l’estate quando la gente abbandonava la città alta perché vi faceva troppo caldo e cercava refrigerio in ville e casalini fuori dalle mura. C’era quindi bisogno che si costituisse “una filiale sacramentale” della cattedrale anche perché le porte della città alta chiudevano al tramonto e diveniva impossibile accedervi. Così fu scelta la chiesetta di San Giuseppe di cui fu iniziato l’ampliamento e dove , dal 1929 in poi, si poterono celebrare tutti i sacramenti escluso i battesimi.
Il buon andamento delle finanze della diocesi certamente dovette influire positivamente anche sulle vocazioni perché se nel 1610 i preti, compreso i canonici, erano 28, con 3 diaconi, un suddiacono e 12 chierici, nel 1642 erano divenuti 44 con 4 diaconi , 3 suddiaconi e 17 chierici ed ogni anno vi erano lasciti per la celebrazione di più di 7 mila messe quasi tutte da farsi in Cattedrale, cioè una media di ben venti messe al giorno e si può quindi capire come mai il vescovo si lamentasse che “il solenne sacrificio della Messa viene celebrato precipitosamente, disordinatamente e con grandissimo scandalo”[7].
Comunque non erano tempi facili quelli per i liparesi in genere perché non era raro che nelle isole venissero a mancare le derrate alimentari. Il grande terrore oltre ai pirati era quello della peste. Bastava che si diffondesse la voce che in qualche parte del Mediterraneo fosse scoppiata una pestilenza perché i porti dei regni di Napoli e di Sicilia si chiudessero all’approdo alle navi che non offrivano garanzie. I commerci si bloccavano e con i commerci non circolavano più i grani che era la derrata alimentale fondamentale. Che voleva dire offrire garanzie? Le navi dovevano munirsi di certificati rilasciati dagli ammiragliati che attestavano lo stato di sanità della nave e dei paesi da cui provenivano. Ma non sempre questi certificati erano accettati come attendibili nei porti di arrivo.
I LIparesi contro Masaniello e fedeli alla monarchia


A sinistra, i tumulti a Napoli capeggiati da Tommaso Aniello. A destra, Masaniello arringa la folla
Nel 1647 a causa di una ostinata siccità che provocò mancanza di frumento, si ebbero tumulti e ribellione a Napoli e Palermo con richieste che assunsero un significato politico perché chiedevano l'abolizione della gabelle e la partecipazione del popolo alle municipalità. I rivoltosi di Palermo e di Napoli – questi ultimi guidati da un certo Tommaso Aiello meglio conosciuto come Masaniello - si collegarono fra di loro e si scambiavano informazioni tramite navigli che passavano per le Eolie. L’obiettivo dei rivoltosi palermitani era quello di liberare la Sicilia dal dominio spagnolo e proclamare la repubblica. In questa occasione i liparesi rimasero fedeli alla monarchia spagnola e riuscirono diverse volte a bloccare questi collegamenti trasmettendo i messaggi dei rivoltosi ai Vicerè di Napoli e della Sicilia. Fra l’altro i navigli liparesi catturarono una feluca che da Napoli si dirigeva a Palermo con la quale i ribelli di Napoli segnalavano di fermare sei vascelli carichi di grano per evitare che cadessero nelle mani degli spagnoli che avevano bloccato il porto di Napoli.
Don Giovanni d’Austria, figlio del re Filippo IV che comandava l’armata navale spagnola inviò al capitano d’arme ed ai giurati di Lipari il 26 ottobre 1647 una lettera di plauso.
La carestia continuò per parecchio tempo, fino al 1648, e don Giovanni d’Austria assunse la carica di viceré di Sicilia. Se ne avvantaggiarono i liparesi che il 12 maggio del 1649 ottennero la diminuzione della tassa del censo.(Archivio Storico Eoliano.it)
[1] Ughelli, Italia sacra, tomo I, foglio 784, in L. Zagami, op.cit., pag. 242.
[2] G. Oliva, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparese, Messina 1905, doc.I, pag. 33. G. Iacolino, manoscritto cit, pag.38b.; L. Zagami, op.cit., pag, 242-3.
[3] G. Iacolino, manoscritto cit., pag. 38c.
[4] La documentazione di questa vicenda comprendente le lettere dei delatori e le risposte del vescovo e la lunga nota dei canonici a sostegno del vescovo, si trovano in Archivio Segreto Vaticano, Sacra Congr. Cons. Relat., Carp. Liparen., 456°, ff.99 e ss.; G.. Iacolino. manoscritto cit., pag. 40 g-o.
[5] Purtroppo Mons. Candido morì il 9 dicembre del 1644 a Roma dove si era trasferito da poche settimane affrontando in autunno il viaggio per mare che poco sopportava tanto che negli ultimi sedici anni non si era mai mosso da Lipari nemmeno per le visite “ad limina” al papa che i vescovi devono fare ogni tre anni.
[6] Arch.Segreto del Vaticano, Cass. 456 A, f. 93v), G. Iacolino, manoscritto. Cit., pag. 39 b.
[7] Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456°, ff. 54v e53. G. Iacolino, manoscritto. Cit., pag. 39.
La devozione alla Madonna del Terzito
La madonna del Terzito
 Nel periodo in cui Mons. Caccamo era vescovo di Lipari, il 23 luglio del 1622, a Salina, quell’Alfonso Mercorella che abbiamo già conosciuto, mentre era impegnato a disboscare il pianoro che collega Malfa a Leni per poter mettere i terreni a coltura, giunto ai piedi del Monte dei Porri sente un misterioso suono di campanella che si ripete tre volte e che lo porta a scoprire il rudere di un’antichissima chiesetta che risaliva al VII secolo, dedicata, come abbiamo già visto, alla Vergine Maria[1].
Nel periodo in cui Mons. Caccamo era vescovo di Lipari, il 23 luglio del 1622, a Salina, quell’Alfonso Mercorella che abbiamo già conosciuto, mentre era impegnato a disboscare il pianoro che collega Malfa a Leni per poter mettere i terreni a coltura, giunto ai piedi del Monte dei Porri sente un misterioso suono di campanella che si ripete tre volte e che lo porta a scoprire il rudere di un’antichissima chiesetta che risaliva al VII secolo, dedicata, come abbiamo già visto, alla Vergine Maria[1].
Col tempo la fantasia popolare amplificò questo fatto del ritrovamento dei ruderi e si disse che il Mercorella non avrebbe solo sentito il campanello ma anche visto “una bellissima Donna vestita di color azolo, con un velo bianco sul capo, e con un campanello nella mano destra, che fissamente lo mirava”, si parlò di una lampada che rimase accesa per ben tredici anni senza che le fosse somministrato olio, di un giovane cieco dalla nascita che facendo visita al santuario acquistò la vista[2]. Lo stesso Campis, parlando dell’episodio, fa propria un’altra voce nata dalla fantasia popolare, che il Marcorella insieme ai ruderi avrebbe trovato anche un vecchissimo quadro della Vergine che fu fatto a pezzi dalla devozione popolare “trasportata da eccessivo affetto” per farne reliquie[3]e, rifacendosi al Campis, la versione del ritrovamento dell’immagine, è riportata nella lapide che nel 1901 fu posta nel vestibolo del Santuario. .
In realtà, come fa notare Giuseppe Iacolino, Rocco Pirri[4] che scrive prima del Campis, nel 1640 dice chiaramente che fu nel VII secolo che “per divina ispirazione, fu trovata la celebre immagine di Maria”, e ciò apparirebbe da antichissimo documenti che si conservano presso alcuni cittadini di Lipari appassionati di antichità.
Più che ad un miracolo si pensa a valorizzare i terreni
 E’ un fatto che nell’immediato non dovette fare molto scalpore questo episodio del Terzito riproposto dal Mercorella nel 1622 visto che mons. Caccamo non ne parla nei suoi scritti, né si soffermano su questo episodio altri storici della chiesa liparese[5]. Il Mercorella, che come abbiamo visto era impegnato a titolo proprio ed anche per conto del vescovo, nella valorizzazione di quei terreni fu il promotore della ricostruzione della chiesa[6] . Era quello il tempo, dopo il concilio tridentino, di un forte rilancio e sviluppo della devozione per i santi ed in particolare la devozione mariana. In Sicilia culti legati ad apparizioni o eventi miracolosi si sviluppavano a Tindari, Caltagirone, Capo d’Orlando, Palermo. Nella stessa Lipari erano arrivati i culti della Madonna di Loreto a Quattropani, del Nome di Maria a Pirrera, dell’Assunta a Serra. E col tempo anche la madonna di Tindari si impose all’attenzione ed alla devozione degli eoliani.
E’ un fatto che nell’immediato non dovette fare molto scalpore questo episodio del Terzito riproposto dal Mercorella nel 1622 visto che mons. Caccamo non ne parla nei suoi scritti, né si soffermano su questo episodio altri storici della chiesa liparese[5]. Il Mercorella, che come abbiamo visto era impegnato a titolo proprio ed anche per conto del vescovo, nella valorizzazione di quei terreni fu il promotore della ricostruzione della chiesa[6] . Era quello il tempo, dopo il concilio tridentino, di un forte rilancio e sviluppo della devozione per i santi ed in particolare la devozione mariana. In Sicilia culti legati ad apparizioni o eventi miracolosi si sviluppavano a Tindari, Caltagirone, Capo d’Orlando, Palermo. Nella stessa Lipari erano arrivati i culti della Madonna di Loreto a Quattropani, del Nome di Maria a Pirrera, dell’Assunta a Serra. E col tempo anche la madonna di Tindari si impose all’attenzione ed alla devozione degli eoliani.
[1] Quella del 1622 viene intesa come la terza ricostruzione del Santuario. La prima cappellina risale al V secolo quando un santo monaco eremita, anche per contrastare il culto di Demetra che continuava a sopravvivere fra i contadini che lavoravano a Salina ed in particolare in quel fertilissimo pianoro, volle edificare questo punto di richiamo religioso e dipinse o disegnò anche una immagine della vergine. La cappellina andò in rovina e venne ricostruita nel VII secolo e fu allora che venne riscoperta l’immagine della madonna che il monaco aveva dipinta.
[2] Alcuni di questi episodi ed altri ancora sono raccolti in fascicoletti devozionali circolati nel secolo scorso come “Breve storia del Santuario della Madonna del Terzito che si venera a Val di Chiesa (Salina), a cura del Cappellano Curato Sac. D. Francesco Costa, Messina 1924.
[3] P.Campis, op.cit., pp 66-67.
[4] R.Pirri, Sicilia Sacra, Liparensis Ecclesiae Notitia VIII, p.951.
[5] Iacolino fa notare che all’episodio del 1622 non danno alcun risalto né il Pirri, né La Rosa, né Rodriquez. In “La Chiesa Cattredrale…, manoscritto cit. Quaderno IIB, pp.33-39.
[6] Su dove ricostruire la chiesa, se nel luogo indicato dal Mercorella o a quota più bassa, sul ciglio del sentiero che percorreva il fondovalle come voleva qualcun altro che affermava di avere trovato lì i veri ruderi della antica chiesetta, ci fu a suo tempo discussione ma prevalse la tesi del Mercorella, mentre il suo contestatore fece erigere una edicola nel luogo da lui indicato ( G.Iacolino, op,cit., pag. 34).(Archivio Storico Eoliano.it)
Il vescovo che uccise il capitano d'arme
Mons. Caccamo, un vescovo prevenuto

Lo scranno (come appare oggi) che scatenò le ire di Mons. Caccamo
Che la ragione di scegliere come successore di mons. Vidal un domenicano di Palermo, teologo e consultore dell’Inquisizione, segnalato alla S.Sede dal viceré di Sicilia don Francesco di Castro che lo conosceva e lo stimava perché confessore della suocera, fosse quella di stemperare il clima e di andare su una personalità gradita al regno di Palermo, è più che probabile. Ed infatti il primo atto del nuovo vescovo fu proprio un atto di deferenza verso il viceré sottoponendo la bolla della sua nomina alla visione del Tribunale della Regia Monarchia che concesse l’exequatur cioè il gradimento. Nominato il 2 aprile del 1618 il Caccamo prede possesso della diocesi tramite un suo procuratore, Alfonso Mercorella, mentre giunge a Lipari solo in estate.
Che non fosse venuto a sedare gli animi ed promuovere la pace lo si comprese subito dal suo primo atto. La prima cosa che vide entrando in cattedrale – tre giorni dopo il suo arrivo - fu lo scanno delle autorità laiche, spazioso e imponente, che attirava gioco forza l’attenzione dei fedeli mentre il soglio vescovile era relegato dentro il recinto del coro. E così immediatamente decide di dare lo sfratto ai giurati e al capitano d’arme, “ruppìo pezzi pezzi detta seggia”, e colloca al posto del loro scranno “una seggia altissima di sei scaloni per sedere lo stesso Vescovo”[1].
Comunque nei giorni seguenti, venuto a più miti consigli, mons. Caccamo fa ricostruire il seggio giuratorio ma colloca, di fronte a questo, un proprio seggio anch’esso di legno creando in una chiesa che aveva allora solo la navata centrale una strozzatura che intralciava le funzioni.
Questo atteggiamento risentito nei confronti delle autorità dell’isola che ebbe sfogo contro lo scranno in Cattedrale probabilmente fu originato dal fatto che trovò il Palazzo Vescovile per gran parte inabitabile e per l’altra parte occupato da uffici del municipio e dai soldati per cui era stato costretto a prendere alloggio nel casalino fuori città “con evidente pericolo di cadere in mano ai privati”, come egli stesso ebbe a scrivere.[2] .
 Il vecchio Palazzo Vescovile oggi sede del Museo Archeologico
Il vecchio Palazzo Vescovile oggi sede del Museo Archeologico
Comunque che nell’animo di mons.Caccamo non ci fosse solo un risentimento nei confronti delle autorità locali ma la convinzione profonda che a lui toccasse combattere una santa battaglia contro le ingerenze dei laici e la riaffermazione della preminenza del vescovo sulla città e le isole, lo si vide dagli atti conseguenti a cominciare dai tentativi –non riusciti – di sganciarsi dalla suffraganeità verso l’Arcidiocesi di Messina. Trovata sbarrata questa strada anche per l’intervento del viceré, l’azione del vescovo si concentrò nel resistere alle richieste della Regia Monarchia a cominciare dal rifiutarsi di trasmettere gli atti dei processi tenuti a Lipari[3] perché si potessero celebrare, presso il Tribunale di Palermo, i giudizi d’appello. In questa resistenza la Corte di Lipari trovò alleata la Corte arcivescovile di Messina che o non dava corso al processo di revisione o si muoveva con lentezza eccessiva, tanto che il governo di Sicilia col consenso del re decise di inviare a Lipari quello che oggi si chiamerebbe un “ispettore”, cioè un delegato dal giudice della Monarchia, l’abate Rocco Pirri, dottore in teologia e diritto, che nel 1647 sarebbe divenuto famoso pubblicando “Sicilia Sacra”, la storia della chiesa nella regione.
L'ispezione del Pirri
Il Pirri arriva a Lipari con una lettera delegatoria e per giorni e giorni - anche grazie all’assenza del vescovo che si trovava a Roma - può operare nella Curia, interrogare persone, eliminare editti e carte che contenevano anatemi contro l’istituto della Regia Monarchia. Certamente incontrò anche il Capitano d’arme a cui raccomandò che nelle isole si rispettassero gli ordini della regia Monarchia e del suo tribunale.
Non sembra però che il risultato di questa ispezione abbia influito sul comportamento di mons. Caccamo che continuerà a restare fermo nella sua posizione intransigente sull’immunità e’indipendenza della sua diocesi. Aumenterà però la vigilanza dei Capitani d’arme nei confronti del Prelato e questo renderà i rapporti ancora più esasperati.
 Una nedaglia dedicata all'abate Rocco Pirri.
Una nedaglia dedicata all'abate Rocco Pirri.
Intanto il vescovo pensa anche alle finanze della diocesi e parte col rivendicare il diritto del vescovo ad autorizzare chi vuole andare nelle isole per coltivarle, cacciare, prelevare frutti e legna e ricordando che al vescovo spetta, in tutte le isole, una imposta chiamata “laudemio” - dal latino laudare cioè approvare –consistente in una percentuale sui trasferimenti che avvengono da una persona all’altra. Una particolare attenzione il vescovo dedica all’isola di Salina per valorizzare circa metà del territorio a ridosso del Monte delle Felci, verso ponente, che dovrà essere disboscato e destinato a colture redditizie attraverso contratti di enfiteusi. E’ nella redazione di questi contratti che emerge, come testimone di molti di essi, un personaggio, Alfonso Mercorella, che abbiamo incontrato come procuratore del vescovo nel suo insediamento a Lipari e che diventerà uno dei più facoltosi possidenti di Salina.
Il vescovo si scontra con i possidenti
Nel procedere in questa operazione dei nuovi contratti di enfiteusi il vescovo si imbatté in numerose persone che risultavano senza titolo nel possesso del terreno e non pagavano il censo alla chiesa e siccome egli partiva dal presupposto che Salina, come tutte le isole, fosse di proprietà della chiesa ritenne che si trattasse di abusivi e intimò loro l’esibizione dei documenti pena l’esproprio. La decisione scatenò forti proteste e molti di questi proprietari veri o presunti, quasi tutti residenti a Lipari, ricorsero avanzando due obiezioni: i titoli non esistono perché con la “ruina” sono andati persi o negli incendi o nella deportazione inoltre se il vescovo rivendica la proprietà di tutte le isole come mai allora di Lipari possiede solo alcuni terreni e la gran parte hanno invece dei proprietari? Per questo si chiede di fare a Roma delle verifica negli uffici degli “spogli” per trovare qualche inventario antico e comunque verificare cosa percepivano di censo i vescovi prima della “ruina”[4].
Il ricorso contiene inoltre tutta una serie di notizie - alcune forse veritiere ma diverse probabilmente esagerate o false perché contraddittorie - sull’operato del vescovo col chiaro intento di metterlo in cattiva luce come persona avida, poco attenta al bene delle anime, che trascura i luoghi di culto.
Non si hanno riscontri sull’esito di questa protesta in ordine ai terreni di Salina ma il fatto è che Caccamo continuò a stipulare contratti aumentando il numero dei residenti e triplicando le entrate della Mensa.
Ed è grazie a queste entrate che egli può mettere mano al casale di Lipari che ormai è divenuta la sua sede, restaurandola ed ampliandola, promuovere lavori nella Cattedrale e procede all’erezione o ampliamenti di chiese ed oratori nella stessa isola di Salina.
La colonizzazione di Salina scatena un conflitto fra i poteri locali
 Ma proprio la colonizzazione di Salina diventa causa di attrito del vescovo col capitano d’arme Pedro Jurato, tipo borioso ed esibizionista, che voleva intromettersi nel progetto di valorizzazione forse per perseguire qualche utile personale. Il fatto è che le pretese del capitano dovettero farsi molto insistenti tanto che Caccamo perse la pazienza e si rivolse al viceré che intervenne ordinando al capitano di “non molestare li beni della Chiesa”[5] Cosa che Pedro Jurato non dovette accettare di buon grado e così la tensione fra il vescovo e i militari aumentò e questo anche quando cambiò il capitano d’arme e a don Pedro Jurato successe don Pedro Manpasso.
Ma proprio la colonizzazione di Salina diventa causa di attrito del vescovo col capitano d’arme Pedro Jurato, tipo borioso ed esibizionista, che voleva intromettersi nel progetto di valorizzazione forse per perseguire qualche utile personale. Il fatto è che le pretese del capitano dovettero farsi molto insistenti tanto che Caccamo perse la pazienza e si rivolse al viceré che intervenne ordinando al capitano di “non molestare li beni della Chiesa”[5] Cosa che Pedro Jurato non dovette accettare di buon grado e così la tensione fra il vescovo e i militari aumentò e questo anche quando cambiò il capitano d’arme e a don Pedro Jurato successe don Pedro Manpasso.
Si sviluppano così una serie di episodi che trasformano l’animosità in fatti incresciosi dove, pur nel contrasto delle diverse versioni, è possibile comprendere che si fronteggiano l’arroganza e la prepotenza del capitano d’arme e della guarnigione militare da una parte e la superbia ostinata - a cui si aggiungeva un temperamento impulsivo che arrivava fino alla perdita di controllo sui propri comportamenti - di un vescovo che si riteneva il signore a cui doveva essere riconosciuto il “diretto Dominio e Patroneggio delle isole” e bollava come “figlioli de iniquità[6]”coloro che abusavano del patrimonio terriero della diocesi e non versavano né censi né decime.
Ed è proprio nell’estate del 1623 che si verificano una serie di fatti dove entrano in conflitto le competenze di due autorità, il vescovo e il capitano d’arme, in campo giudiziario ma che finiscono coll’essere così sproporzionati e spropositati che si possono spiegare solo con i particolari temperamenti dei due personaggi. Il capitano d’arme, don Pedro Manpasso - per perseguire dei servi del vescovato, in un crescendo di reazioni e controreazioni - arriva a mettere in stato d’assedio la città alta impedendo di fatto a Mons. Caccamo di abbandonarla per tornare alla sua abitazione, minacciando di arrestare ecclesiastici e laici che lo accompagnavano.. Il vescovo di fronte alla violazione delle proprie competenze e ad azioni che giudica gravissime sopraffazioni, reagisce non soltanto con la scomunica ma col vietare agli ecclesiastici di confessare e di assolvere i militari, persino in “articulo mortis” e privando il cappellano del presidio della possibilità di amministrare i sacramenti[7] .
Indubbiamente questi episodi si ritorcono in modo particolare contro il vescovo che è sempre più isolato e inviso non solo ai militari ma anche ai nobili ed alle autorità civili, e gli uni e gli altri, inviano “informative” al re ed al papa. E le proteste dovettero andare a buon fine perché il papa Urbano VIII lo richiamò a Roma. Mons. Caccamo che negli ultimi tempi era divenuto sempre più permaloso ed irascibile reagì malamente a quest’ordine e ritenendo che la responsabilità del suo allontanamento fosse soprattutto del capitano d’arme, lo fece convocare ed al culmine di una violenta discussione lo colpì con un coltello ferendolo mortalmente[8]. A Roma il papa lo fece confinare in carcere dove morì il 9 agosto del 1627.
[1] Da un esposto di liparesi al Santo Padre, in Arch. Vesc. Di Lipari, Carp. Civili 7. il documento che contiene altre lamentele ha per titolo “Li pretendentij del Vescovo Caccamo contro questa Città de Lipare”. La versione del vescovo è in Archivio Segreto Vaticano, Relazione di mons. Caccamo del 1631 circa, Cass. 456 A, f. 46v; in G. Iacolino, La Chiesa Cattedrale, manoscritto cit., Quaderno IIB pag. 37 d,e,f.
[2] ASV; Relazione di mons. Caccamo, cit. A proposito del Palazzo vescovile a fianco alla Cattedrale al tempo del vescovo Vidal il Campis scrive che era “ridotto il tutto in frantume di fabrica non abitabile, sol poche stanze restano ad uso del Prelato, e queste esposte nell’estate al caldo intollerabile”(op.cit, p.324). Probabilmente erano quelle poche stanze che negli unici mesi di assenza del vescovo, erano state occupate dai funzionari del municipio e dalle guardie.
[3] Fra gli atti processuali di quegli anni che la Corte vescovile di Lipari si rifiutava di trasmettere a Palermo per l’appello vi era il ricorso contro la scomunica inflitta dal vescovo a Giovanni Maria Israeli che aveva avuto la colpa di avere preso le parti del proprio fratello, il prete don Tommaso, mentre veniva arrestato nella Cattedrale per ordine dello stesso vescovo giacchè, don Tommaso, subcollettore del legato pontificio di Napoli , aveva avuto l’ardire di richiedere 2000 scudi da devolvere al Nunzio e alla camera Apostolica per lo”spoglio” successivo alla morte di mons. Vidal. Era, quello dello spoglio, una antichissima consuetudine per cui i vescovi non potevano disporre, per testamento, del superfluo dei loro redditi beneficiali. Questo superfluo, all’atto della morte del presule, doveva essere individuato e quindi devoluto alla Camera Apostolica. A chi spettava questo compito? In Sicilia, eccetto Lipari fino a prima dell’unione, era il viceré o il giudice della monarchia di Palermo che, per mezzo di suoi emissari, compiva questa operazione per conto della Santa Sede mentre nelle diocesi dipendenti dal viceré di Napoli era il legato pontificio di Napoli che mandava funzionari di sua fiducia. Anche se i beni andavano sempre alla Santa Sede l’importanza di chi materialmente compiva l’operazione stava nel fatto che a questi – e quindi allo Stato per cui operava ed a tutta una catena di funzionari - andava un largo margine di utile. E non si trattava di utili di poco conto perché quando ( si trattava di un diritto non sempre esercitato) lo “spoglio” veniva fatto esso era così meticoloso e fiscale che prosciugava i fondi delle mense vescovili.
Quindi si trattava di una operazione che in loco non veniva vista di buon occhio e suscitava sempre molte critiche e rancori sia da parte del clero locale che del vescovo di nuova nomina che la vivevano come una aggressione alle proprie risorse. E siccome, per l’esecuzione di questo istituto, Lipari continuò a dipendere da Napoli e il legato pontificio di Napoli, per questo “spoglio” aveva nominato come suo delegato, sub collettore si diceva, un prete liparese, don Tommaso Israeli. Su di lui si scatenò l’ira del vescovo che fu arrestato, maltrattato e sbattuto in un “damuso obscuro”appena finita la messa cantata con ancora indosso tutti i paramenti. Parimenti l’arresto ma con sequestro di beni e scomunica toccò a Giovanni Maria che aveva cercato di difendere il fratello protestandone l’ innocenza. (Archivio Vescovile di Lipari, Esposto di Giovanni Maria Israeli carp. 7 civili. In G:Iacolino, La Chiesa Cattedrale, manoscritto cit. Quaderno IIB, pag.13).
[4] Archivio Vescovile di Lipari, Carp. Civili 7; v. G.. Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, Quaderno IIB, manoscritto, cit. pp 21-23.
[5] L.Genuardi e L.Siciliano, Il Dominio del Vescovo nei terreni pomici feri dell’isola di Lipari, Acireale 1912,p.81, in G.Iacolino, manoscritto cit., pag. 27.
[6] Archivio.Vesc. di Lipari,Editto del 1624, Carp. Civili 7.
[7] In quella estate del 1623 dovettero verificarsi due diversi episodi che fecero scoppiare il conflitto di interessi fra il vescovo ed il capitano d’arme. Il primo, sul finire dell’estate, in cui un isolano invasato aggredisce prima degli ecclesiastici e poi il capitano d’arme. In quale prigione doveva essere rinchiuso questo soggetto? Nelle carceri del vescovo o in quelle del presidio militare? Qui la relazione al re di un tale Gilberto funzionario di Milazzo parla di una reazione inconsulta del vescovo che in abiti pontificali e accompagnato dai canonici con i paramenti della messa scomunicò il capitano e andò in processione per la città alta “con atti e con parole ingiuriose maltrattò il detto Capitano”.Sempre secondo Gilberto il Capitano avrebbe scongiurato il vescovo in ginocchio di evitare lo scandalo ma il vescovo in sovrappiù, tolse alla guarnigione la possibilità di accedere ai sacramenti. Relazione di Gilberto di Milazzo al re del 6 settembre 1623.( Archivio Generale di Simanca, Legajo 1895, n.23. in G. Iacolino, La Chiesa cattedrale, manoscritto cit., pag. 40). Non mettiamo in dubbio che ci sia stato anche questo episodio, ma i documenti che si conservano nel vescovato di Lipari si riferiscono ad un episodio accaduto il 27 luglio sempre del 1623 il cui abnorme appare soprattutto il comportamento del capitano d’arme. A scatenare il conflitto sarebbe una partenza dei servi del vescovato da Lipari, per degli acquisti in Sicilia, senza “licenza ‘uscita” contando sulla consuetudine che i famigli del vescovo ne erano esentati. Il capitano giudica la trasgressione gravissima e persegue uno dei due servi fino dentro la Cattedrale violando il diritto d’asilo che vigeva per i luoghi sacri. E’ a questo punto che Mons. Caccamo vuole fare valere la sua autorità scatenando reazioni durissime e impensabili fino a isolare il vescovo, gli ecclesiastici ed i famigli in cattedrale e negli alloggi dissestati del Palazzo Vescovile. Infatti il capitano ordinerà ai suoi soldati di guardia che se il vescovo voleva andar via era libero di farlo ma preti e servi sarebbero stati arrestati ed inviati a Palermo in catene. A questa dichiarazione, il vescovo che vestito dei paramenti, in processione con il clero e i servi era giunto al posto di guardia grida ad alta voce “ Siatemi testimonij che lo Capitan d’arme mi tiene carcerato con i miei creati et clero dentro la Città et non mi lassa andare al mio palazzo fuori Città” . E fatto dietro front se ne tornò processionalmente alla Cattedrale.( La documentazione di questo episodio con ben 14 testimonianze si trova nell’Archivio Vescovile di Lipari, Processi criminali, busta n. 3,1, carp. 33, f. 408 e ss). Con ogni probabilità, il divieto di prestare i sacramenti alla guarnigione, dovette avvenire dopo questo episodio che non sappiamo se sia giunto e come a conoscenza del re del papa.(Archivio Storico Eoliano.it)
[8] L. Zagami, op.cit., pag. 241-2.
Il nodo della Legazia Apostolica
Lipari nella Legazia Apostolica
 Uno degli obiettivi del re Filippo III nell’aggregare le Eolie alla Sicilia distaccandole dal regno di Napoli – abbiamo detto - era quello di ricondurle nell’alveo della Legazia Apostolica di cui godeva il regno di Sicilia.
Uno degli obiettivi del re Filippo III nell’aggregare le Eolie alla Sicilia distaccandole dal regno di Napoli – abbiamo detto - era quello di ricondurle nell’alveo della Legazia Apostolica di cui godeva il regno di Sicilia.
Era la Legazia Apostolica un istituto che risaliva a papa Urbano II ed alla bolla Quia propter prudentiam tuam del 5 luglio 1098. In essa si diceva: “Noi non stabiliremo, nel territorio di vostra pertinenza, alcun legato della Chiesa di Roma senza il volere ed il consiglio vostro. Che anzi tutte le cose che Noi intendiamo fare tramite un legato vogliamo che siano fatte dalla vostra opera come vice legati quando dal Nostro lato le commetteremo a voi per la prosperità delle Chiese che sono sotto la vostra potestà, ad onore di San Pietro e della Santa sua Sede Apostolica alla quale sino ad ora tu hai fedelmente obbedito e che, nelle sue occorrenze, hai aiutato con valore e fedeltà”. E questo per ringraziare Ruggero di aver sottratto l'isola agli arabi e di averla restituita al culto della Chiesa di Roma. Il problema era che lo stesso Urbano II , qualche anno prima, con bolla del 3 giugno 1091 aveva concesso all’Abate Ambrogio la piena potestà sulle Eolie affermando che queste sarebbero dipese direttamente dalla Santa Sede.
Con l'andar degli anni i sovrani di Sicilia, anche di diversa dinastia, accresceranno a loro vantaggio i contenuti e l'efficacia della bolla e, ad un certo momento, si autodefiniranno legati apostolici mentre la Santa Sede farà di tutto per restringerne i termini e frenarne gli abusi, fino a definire falsa la bolla di Urbano II che invece era sostanzialmente vera.
Il concetto di Legazia Apostolica si affermerà con maggior consapevolezza tra i secoli XIV e XV e assumerà forme più decise di invadenza a cominciare dal Cinquecento. Per tutto il corso del 1600 e 1700 la diocesi di Lipari, dai pontefici dichiarata “immediatamente soggetta alla Santa Sede” diverrà il terreno di scontro tra i sovrani di Sicilia e la Santa Sede. Sarò' allora, con inizio nel 1711, che esploderà la famosa “controversia Liparitana”, di cui parleremo più avanti.
Filippo III di Spagna
La Chiesa sulla difensiva
Per ora, nel 1610, siamo ai prolegomeni. Se Filippo III pensa quindi di ricondurre le Eolie sotto la sua piena autorità, politica e religiosa, il papa Paolo V non solo è deciso ad opporvisi ma probabilmente pensa di utilizzare le Eolie come un grimaldello per scardinare questo istituto e, in questo disegno la diocesi di Lipari doveva essere quella in cui il potere del papa si esercitava in maniera piena e senza nessuna remora. Quindi niente applicazione della Legazia Apostolica ma anche niente più subordinazione di Lipari alla sede metropolitana di Messina che fino ad allora era stata sempre riconosciuta dai vescovi liparesi anche quando Lipari faceva parte del reame di Napoli[1].
 Comincia così una corrispondenza fra il cardinale Gallo a nome del papa ed il vescovo di Lipari in cui si raccomanda a mons.Vidal di non permettere che “per causa di detta unione venga fatta alcuna novità intorno alle Cose Ecclesiastiche così in materia di Giurisditione come di Collatione di Beneficij o qualsivoglia altra cosa, ma , pretendendosi qualche Innovatione, faccia che si ricorra prima a Sua Beatitudine a cui deve spettare sopra di ciò la totale diliberazione” [2]. La prima lettera della Santa Sede è del 6 maggio cioè ci si muove per tempo prima della formalizzazione dell’incorporazione che avverrà il 30 maggio.
Comincia così una corrispondenza fra il cardinale Gallo a nome del papa ed il vescovo di Lipari in cui si raccomanda a mons.Vidal di non permettere che “per causa di detta unione venga fatta alcuna novità intorno alle Cose Ecclesiastiche così in materia di Giurisditione come di Collatione di Beneficij o qualsivoglia altra cosa, ma , pretendendosi qualche Innovatione, faccia che si ricorra prima a Sua Beatitudine a cui deve spettare sopra di ciò la totale diliberazione” [2]. La prima lettera della Santa Sede è del 6 maggio cioè ci si muove per tempo prima della formalizzazione dell’incorporazione che avverrà il 30 maggio.
Non sono passati che pochi giorni da questa data che viene preteso dai Ministri del regno di introdurre nella diocesi di Lipari il Sant’Uffizio dipendente dall’Inquisizione spagnola come era d’uso in Sicilia. E così il 16 aprile del 1611 il Cardinale Gallo a nome del papa riscrive a Mons. Vidal raccomandandogli di non permettere assolutamente questa intromissione. Se i ministri palermitani dovessero insistere il vescovo mostri pure la lettera scritta a nome del papa e comunque non si faccia alcuna innovazione senza prima trattare col pontefice. Mons. Vidal è convinto e determinato in questa resistenza e lo fa opponendosi energicamente “non senza – dirà il suo successore mons. Caccamo – gravissimo percolo della sua vita”[3]. I regi ministri minacciarono allora e continueranno a farlo in seguito “la destituzione dalla dignità episcopale e la soppressione della Sede –Cattedrale”[4].
Papa Paolo V
Il vescovo di Lipari, per antica consuetudine proprio perché si riteneva il proprietario delle isole e dipendeva direttamente da Roma, godeva di specialissime immunità e prerogative ed era esente dai tributi imposti dallo Stato. Questa situazione, proprio negli ambienti politici ed amministrativi di Palermo, era mal tollerata mentre lo stesso vescovo non era ben visto perché giudicato inaffidabile ed un evasore di fatto, e quindi, appena possibile, osteggiato.
Le tensioni fra le confraternite
Queste tensioni, alcune anche di scarso rilievo ed effimere, si riflettevano nel microcosmo eoliano facendone un vero e proprio covo di vipere. Prima la guarnigione militare e poi anche le autorità civili e la nobiltà terriera e armatoriale, che mal subivano il pagamento dei censi e delle decime, cominciarono a percepire la figura del vescovo con fastidio e insofferenza, fino, qualche volta, a sfociare in gesti di aperta ostilità, a cui facevano riscontro reazioni durissime col solito ricorso a severissime scomuniche.
E non deve destare meraviglia se proprio la cerimonie religiose divennero il terreno più proficuo in cui questi sentimenti e queste tensioni presero a manifestarsi. Così da una parte i militari ed i nobili fecero della confraternita dell’Addolorata - che aveva sede nella chiesetta che si chiamava allora della Soledad, nel luogo dove sorge ora la chiesa dell’Addolorata – il loro luogo di incontro e tendevano a manifestare con cerimonie sfarzose il loro potere contrapponendosi a quelle che il vescovo officiava in Cattedrale. In particolare le cerimonie della Settimana Santa diventarono occasione di confronto e di competizione tanto da costringere il vescovo ad intervenire per porre un freno. Per tutta risposta la confraternita si adoperò perché la loro chiesa forse promossa a Cappella di Regio patronato con cappellano indipendente dal vescovo e sottoposto direttamente alla Legazia Apostolica di Palermo. Fu quello il momento di una ricca fioritura di confraternite molte sorte in contrapposizione a quella dell’Addolorata ed in solidarietà col vescovo come la confraternita[5] del S. Crocifisso o dei SS.Sette Dolori che si radunava ogni venerdì nella cappella della Concezione in Cattedrale mentre, sempre in Cattedrale, venne eretto un altare detto dei SS.Sette Dolori.
Anche le situazioni più banali divennero occasione di conflitto e di scontro come l’uso del “chiomazzo”, un cuscino ricamato che metteva il vescovo sotto le ginocchia durante le celebrazioni, divenne occasione di contesa col capitano d’arme che se n’era fatto fare uno simile; oppure il colore del drappo sullo scranno del municipio in Cattedrale che i girati vollero rosso paonazzo mentre il vescovo riteneva che questo colore fosse distintivo degli abiti dei prelati; o la consuetudine che i pubblici ufficiali, nelle feste solenni, accompagnassero il vescovo dalla soglia del palazzo vescovile alla Cattedrale e viceversa, alla fine delle funzioni, che divenne occasione di dispetti e quindi di processi che si imbastivano dinnanzi al Tribunale civile del vescovo[6]. Beghe paesane, frizioni locali che però si inserivano e acquisivano spessore nel più grande conflitto che si andava approfondendo quello cioè dello schierarsi con Palermo o con Roma, con lo Stato o con i vescovo.
la sofferenza di mons. Vidal
Questa situazione di tensione e di contrasti doveva essere subìta con sofferenza da un vescovo come Vidal che, come abbiamo visto, proprio in nome della buona convivenza aveva esentato dai tributi alla chiesa i nove decimi dei possessori dei terreni in enfiteusi ed aveva donato al Municipio diversi beni. Così a partire dal 1613, sentendosi logorato e con una piaga nella gamba che lo inficiava negli spostamenti, pur avendo solo 66 anni, declinò di andare a Roma per la consueta visita “ad limina” e cominciò a pensare alla propria morte. Fece costruire il suo sepolcro che volle in Cattedrale interrompendo l’antica tradizione di seppellire i vescovi nell’ipogeo che si apriva sotto il coro[7] ma soprattutto, uomo sensibile ai problemi della povera gente, volle creare, il 19 giugno del 1617, un fondo perpetuo che permettesse, con i proventi ricavati, ogni anno di dotare di un corredo di vestiario una trentina di persone: dodici uomini al 24 di agosto, festa ufficiale di S. Bartolomeo, e un certo numero di donne al 13 febbraio, ricorrenza, secondo la tradizione, dell’arrivo della cassa di S.Bartolomeo a Lipari, giorno che era comunemente detto della “festa della cascia”. Infine, nella festa del 17 giugno – anche questa dedicata a S.Bartolomeo - dovevano essere consegnate onze 10 “in sussidio di maritaggio d’una povera zitella”[8].
Mons. Vidal moriva il 17 settembre del 1617 a settanti anni di età, colpito da apoplessia. Oltre che, come abbiamo visto, dotato di abilità diplomatica, ed attento alle esigenze della comunità a cominciare dai più poveri, fu anche un vescovo di grande sensibilità pastorale. Indefesso nel somministrare i sacramenti “ si faceva udire frequentemente – ci informa il Campis – predicando nelle Chiese, o , nel conffessionario, ascoltando, consolando et istruendo i penitenti, oltre il tacito esortare che facevano le sue virtù delle quali era a meraviglia dotato” [9].
[1] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, manoscritto citato, pag. 33°. Il rapporto di “suffrageneità” di una diocesi ad un’altra si esprimeva soprattutto nella funzione di corte d’appello che il vescovo metropolita esercitava nei processi ecclesiastici ed anche in alcuni gesti formali di riconoscimento di questa dipendenza durante particolari funzioni religiose come il 15 agosto a Messina, in occasione della festività della Madonna della Lettera, patrona della città, quando nel corso della funzione solenne i vescovi di Lipari, Patti e Cefalù dovevano rispondere alla chiamata del vescovo di Messina pena la commissione di una multa che il più delle volte però non si faceva pagare.
[2] Archivio Vescovile di Lipari – Carpetta Civili 7 “Documenti ritrovati nell’Archivio della Chiesa di Lipari…” in G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, manoscritto cit., pag. 33°1. Lettera del 7 maggio 1610.
[3] Relazione di mons. A. Caccamo alla S.Congregazione del Concilio, del 1621 circa, in Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 A,f.46.
[4] Idem.
[5] Sulla storia delle confraternite nelle Eolie vedi G.Iacolino, Confraternite e Pie Associazioni laiche nell’Arcipelago delle Lipari, Lipari 2005.
[6] Su tutti questi avvenimenti si veda G.Iacolino, L Chiesa Catttedrale..,, manoscritto citato pag.33-34; vedi anche Archivio vescovile di Lipari, criminale, anni 1622 e ss.
[7] Nell’ipogeo mons. Vidal stabilì invece che si deponessero i cadaveri dei canonici capitolari, opportunamente essiccati e poi rivestiti dei loro abiti di cerimonia, ciascuno collocato in una propria nicchia verticale, in posizione eretta. Le nicchie non superavano la quindicina. Un minuscolo locale adiacente era destinato ad essiccatoio e colatoio. Vi era uno speciale sistema di trattamento dei cadaveri. Ventiquattr’ore dopo il decesso, il cadavere, senz’altra preparazione, veniva chiuso nel colatoio, adagiato sul coricatoio a grata. L’ingresso veniva poi murato perfettamente con malta per schiudersi allo scadere di almeno un anno. Alla riapertura del colatoio, essendo prosciugato il cadavere, questo veniva rivestito con gli abita da cerimonia. L’aria non lo distruggeva, né c’era più da temere alcuna nociva influenza sulla pubblica igiene. G.. Iacolino, La Chiesa cattedrale…, manoscritto cit., pag. 32b; per il sistema di trattamento dei cadaveri v. una lettera del 9 ottobre 1881, indirizzata al Sig, Soprintendente dell’Ufficio del patrimonio e Beneficenza, n. 5791, pubblicata ida Pierre Thomas in G. De Maupassant, Viaggio in Sicilia, Palermo 1977, pag. 45, in nota.
[8] Archivio Stato Vaticano, Cassetta 456 A, ff.41v-42v. Atto del notaio Alfonso Ferrazzano. G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…., op.cit.pag. 32 e,f ,g. Questa pratica alimentata dal fondo istituito da mons. Vidal era ancora operante nel 1841.
[9] P.Campis, op.cit., pag. 317-318. Stranamente il Campis afferma che mons. Vidal morì ad 82 anni di età (pag. 324), e sulla sua scia l’informazione viene ripresa da altri storici. Ma è lo stesso mons. Vidal che il 3 gennaio del 1613 scrivendo a un dignitario della curia pontificia per scusarsi che le condizioni di salute non gli permettono di andare a Roma per la visita “ad limina” per cui manda al suo posto il canonico La Noara, suo procuratore, afferma di avere, a quella data, 66 anni.(Archivio Storico Eoliano.it)
Popolazione, economia e tributi
I conti con il vescovo e con lo Stato
La chiesa era a Lipari proprietaria di gran parte delle terre e di molti immobili e questo creava molte tensioni con gli enfiteuti di più antica data che mal sopportavano di dover pagare i censi alla Mensa vescovile sia con il municipio che, dopo la “ruina”, si era appropriato di alcuni fabbricati compreso una parte del Palazzo Vescovile e la casa del Tocco, che era la sede dei giurati, e non voleva restituirli. Così il 14 aprile del 1610 Mons.Vidal, con atto pubblico, esentò dai tributi ecclesiastici la maggior parte dei proprietari delle terre coltivate di Lipari e rinunciò a favore dell’autorità civile a gran parte degli edifici occupati. E questo “per vivere la città con il suo Prelato, ed i Prelato con il suo gregge, in pace come si conviene”. Rimanevano al vescovo il possesso di oltre un decimo dei terreni agricoli dell’isola fra cui, nei pressi della città, l’area che andava dai piedi del Castello sin oltre l’attuale corso Vittorio Emanuele che era allora una sorta di torrente intransitabile nelle giornate piovose e delimitata ai lati dal Vallone del Ponte e da via XXIV maggio che veniva chiamata Calata del Castello. Quest’area, che rappresenta il centro storico odierno, comprendeva orti e vigneti con una ventina di pozzi di acqua salmastra. Nella parte meridionale vi erano delle piccole abitazioni che rappresentavano la periferia di Sopra la Terra per il resto vi erano terreni dati a coltura punteggiati qua e la da rustici “casalini”che,via via, saranno oggetto di cessioni censuarie ai privati permettendo così l’espansione del Borgo e contravvenendo alle disposizioni dell’autorità spagnole.
Oltre il torrente, dove ora c’è il corso Vittorio Emanuele, vi era, sempre di proprietà del vescovo, una grande vigna che era stata rinnovata verso il 1595 dove proprio mons. Vidal fece sorgere “un casalino di villa” quello che ora è il palazzo vescovile. La costruzione era sobria e consisteva in due vani terreni con sopra due o tre stanze munite di baglio e pergolato ad essa si accedeva per un viottolo che collegava il casalino con il torrente che era allora corso Vittorio Emanuele[1].
Già nel 1608 il vescovo aveva condonato, a favore dell’Università, alcune terre boschive del Castellaro con alcune modeste condizioni.
Le Eolie nel Regno di Sicilia
Intanto il 30 maggio del 1610 le Eolie vengono rincorporate nel Regno di Sicilia staccandosi dal regno di Napoli a cui erano appartenute fin dal 1548. Si trattava di una antica aspirazione dei liparesi che vedevano in questo passaggio sia un possibile incremento dei loro traffici, sia il beneficio di avere una capitale più vicina importante ai fini delle pratiche amministrative e giudiziarie. E per questo si era speso, mettendo in campo le sue virtù diplomatiche., il vescovo Vidal con numerosi viaggi fatti a Napoli e Messina.
Ma se questi erano gli obiettivi dei liparesi e del loro vescovo per cui avevano chiesto l’incorporazione alla Sicilia, fra quelli del re Filippo III ve ne erano almeno altre due: tenere meglio sotto controllo questi isolani fra cui vi era chi si dedicava alla pirateria e ricondurre la Chiesa di Lipari nell’ambito della Legazia Apostolica di Sicilia.
Ed è proprio questo passaggio amministrativo a far scattare l’”operazione reveli”[2] cioè il censimento delle persone e dei beni che aveva come finalità quella di stabilire la base impositiva per il pagamento dei tributi. La cosa non fu presa bene dagli abitanti perchè questo obbligo amministrativo contrastava palesemente con i privilegi di cui essi godevano da vario tempo ed anche la gente che si era riversata a Lipari dopo il “sacco” l'aveva fatto a patto di dover godere, tra l'altro, dell'esenzione dalle imposte statali. Da qui l’inizio di una dura contestazione per fare valere i privilegi contro una burocrazia palermitana che li riteneva tacitamente abrogati.
“I Liparoti comunque – osserva Arena - non poterono sottrarsi all'ordine che veniva da Palermo, ordine che il loro vescovo ribadiva con proprio bando e doveva far rispettare. Sicché l'operazione riveli si portò a compimento in tempi brevissimi e nel rispetto delle formalità stabilite”[3]. Essi non ebbero seguito perché il Tribunale del Real Patrimonio, riconoscendo i diritti acquisiti. scongiurò che essi potessero avere effetti fiscali per cui le carte del censimento andarono a finire direttamente nell’archivio del Tribunale.
Le proprietà del Vescovo e quelle del Comune
Innanzitutto i riveli ci dicono che i residenti a Lipari sono 1281 maschi e 1103 femmine quindi, in totale 2.384. Vi sono inoltre 256 persone del presidio militare fra soldati e famiglie e 38 schiavi. In totale 2.678 di cui 86 sono ecclesiastici[4] mentre 40 residenti risultano temporaneamente assenti. L’età media dei maschi residenti è di 22 anni visto l’alto numero di bambini sotto i nove anni (383) mentre i fuochi familiari sono 576 con un’ampiezza media delle famiglie di 4,05.
I rilevi permettono di ricavare informazioni non solo riguardo alla popolazione, ma anche all'economia. In ordine alle proprietà dai “riveli” risulta che l'Università possedeva “la casa del Tocco”, sede del Municipio( gravata di censo enfiteutico da corrispondere al vescovo), due case adibite a deposito di armi e munizioni, un magazzino adibito a deposito di grano, terreno di 18 salme circa in località Castellaro e molti altri terreni boscosi ed incolti in diverse parti dell'isola che non davano nessun reddito perchè erano a disposizione dei cittadini per raccogliere legna da ardere e pascolare il bestiame.
La Chiesa possedeva vari fabbricati ( chiese, palazzo vescovile e qualche casetta) dentro la città e aveva la piena proprietà in molte contrade di Lipari ( Acquacalda, Annunziata-Chiusa, Canneto-Calandra, Capistello-San Nicola, Caravezza, Castagna, Monte Pelato, Pianoconte, Pianogreca-Ficuzza, Pirrera, Sant'Angelo, Salvatore,ecc.) e la proprietà praticamente di tutte le isole minori.
Vi erano in quella data anche un Monte di Pietà ed un Ospedale, entrambi amministrati dalla Chiesa ed una Confraternita di San Nicola proprietaria di un terreno in località Valle de Imbroga. L'Ospedale aveva diversi lotti di terreno ceduti in enfiteusi (Annunziata, Barisana, Collo, Cappello, Cugni, Ponte, S. Caterina, S. Lucia, S. Margherita...).
Una proprietà immobiliare diffusa fra i privati
Quanto ai privati bisogna osservare che c'era a Lipari una proprietà immobiliare piuttosto diffusa anche se va osservato che c'era chi possedeva una casa, mezza casa, un terzo di casa e chi possedeva più case; c'era chi possedeva un pezzo di terreno improduttivo e chi possedeva diversi terreni redditizi. Comunque senz'altro notevole era il numero di coloro che godevano di redditi non di lavoro. Tuttavia se si considera che per il vitto di una persona abbisognava una somma all'incirca pari a 12 onze d'oro l'anno, e che questa spesa aumentava adeguatamente secondo che si trattasse di famiglie di 2,3 o più componenti e se contemporaneamente si tiene presente che su un totale di 577 rivelanti abitanti a Lipari, solo 62 ( il 15,94%) avevano una rendita annua netta superiore a 12 onze, 62 (10,74%) una rendita annua superiore a 18 onze, 31( 5,37%) una rendita superiore a 30 onze e solo 16 ( 2,77%) andavano oltre le 40 onze di rendita netta annua, di certo non si può pensare che fossero molte le famiglie liparesi che potevano vivere esclusivamente di rendita.
Bisogna quindi capire che cosa offriva l'agricoltura, la pesca, il commercio, ecc. La poca disponibilità di acqua per l'irrigazione condizionava fortemente l'agricoltura eoliana del primo seicento. Di fatto a Lipari, alle poche colture orticole si contrapponevano massicciamente il fico, il cappero, le terre coltivate a grano e altri cereali, e soprattutto la vite. C'erano poi alcuni canneti, qualche gelso e, sparsi qua e là, vari altri alberi da frutto.
Niente i riveli ci dicono sugli animali da cortile, quanto agli altri tipi, nell'isola c'erano 169 asini, 92 bovini, 1632 caprini, 38 muli, 12 cavalli e 1 maiale. Perciò la carne, il latte, il formaggio e persino le pelli, non mancavano. Di mulini ce n'erano 27 per cui si può ricavare che la farina si produceva sul posto sia macinando il grano locale che quello importato.
La flotta si componeva di 4 barchette (gozzi), 3 speronare( bastimenti con 2 o 3 alberi a vele latine e capienza di 20-30 tonnellate) e 4 feluche ( bastimenti con 1-2 alberi inclinati a vele latine e capienza di 30-50 t.). Diffuse erano le imbarcazioni in comproprietà.
Notevole doveva essere il commercio nell'isola e quello con piazze siciliane e calabresi ( Messina, Milazzo, Palermo, Ficarra, Tropea, Militello, Monteleone) o estere. Si commerciava grano, olio, vino, uva passa, capperi, fichi secchi, formaggio, spezie, pani. La presenza a Lipari di alcuni possidenti genovesi lascia capire che i rapporti si spingessero oltre il Tirrreno.
Nonostante il forte sviluppo delle attività economiche c'erano a Lipari persone che per vari motivi ( infermità, vecchiaia, ecc.) non erano in grado di procurarsi nemmeno un piccolo reddito di lavoro su cui contare. Ai bisognosi comunque non mancavano né l'aiuto della Chiesa, né quello dei privati, sicché non è nemmeno immaginabile che la condizione dei poveri a Lipari fosse identica a quella dei mendicanti presenti in quasi tutte le parti d'Europa.
Le entrate della chiesa e l'attività caritativa
Varia era l'attività che la Chiesa svolgeva a favore delle persone bisognose. Essa si estendeva dalle sovvenzioni alle concessioni di aree fabbricabili, dalla concessione di piccoli lotti di terre coltivabile, alle elemosine, dalla formazione della dote per le giovani povere che andavano in spose alla tutela dei minori ( il Campis informa che a Lipari la Chiesa amministrava anche un brefotrofio), e riusciva ad evitare forti disagi.
“ Se è vero – commenta Giuseppe Arena – che i vescovi di Lipari, male interpretando le concessioni normanne del 1088 e del 1134, pretesero per lungo tempo di essere proprietari delle Isole Eolie, è anche vero che con la distribuzione di terre in enfiteusi o altra forma crearono una grossa massa di piccoli coltivatori e proprietari, che altrimenti non ci sarebbe mai stata; se è vero che gli stessi vescovi incassarono per lungo tempo censi che in termini di diritto loro non spettavano, è anche incontrovertibile che quasi tutto il denaro da essi percepito venne riversato nelle Eolie, per costruzioni e a sostegno del Seminario, del Monte di Pietà, dell'Ospedale, dei poveri, degli orfanelli, ecc. E quindi, se sul piano giuridico non si può dire che l’Università di Lipari non sia stata privata per tanto tempo di molta parte del suo demanio, sul piano del realismo più crudo sembra proprio che la storia debba riconoscere che ciò fu più un bene che un male per le Eolie, tanto per i risultati diretti quanto per quelli indiretti”[5].
Sempre nella seconda metà del 600 il vescovo procedette a far disboscare vaste zone dell'arcipelago aumentando così i posti di lavoro e permettendo una distribuzione più razionale della popolazione nelle isole e la messa a coltura di molte terre. Queste terre procuravano al vescovo nuove entrate perchè venivano date in enfiteusi o in affitto dietro il pagamento di censi e decime. Di queste terre certo non ne beneficiò il popolo minuto ma le famiglie benestanti, gli ecclesiastici, loro parenti e comunque coloro che avevano delle risorse, classi sociali che nel tempo cominciarono a lamentarsi sempre più per questi balzelli che dovevano pagare[6].
Ma malgrado le lamentele per i censi e per le decime, le incursioni dei pirati lungo tutto il corso del secolo, la vita economica dell'arcipelago andò migliorando al riparo, com'era, dalle rivolte e dalle guerre. Erano in molti a darsi all'attività della pesca, alla caccia dei conigli, delle quaglie e delle tortore all'allevamento del bestiame e soprattutto di capre che circolavano libere nelle terre comuni e qualche volta sconfinando e danneggiavano i poderi coltivati.
Si raccoglieva e si esportava in Toscana, Campania, a Marsiglia anche la pomice: circa 500 tonnellate l'anno. Per molte di queste attività – pesca, caccia, allevamento , raccolta della pomice – i liparesi qualche volta riuscivano ad eludere le gabelle e la gente poteva arrotondare i propri redditi. Ancora nel corso della seconda metà di questo secolo un'altra fonte di entrata fu rappresentata, come abbiamo visto, dalla lotta ai pirati turchi che una volta catturati venivano venduti come schiavi, per esempio a Trapani dove si svolgevano libere vendite all'asta.8Archivio Storico Eoliano.it)
[1] Un primo ampliamento il casalino lo ebbe nel 1620 a cura del vescovo Candido, un altro intervento ci fu nel 1725 il vescovo Platamone che diede alla costruzione un aspetto più decoroso, ma fu il vescovo Attanasio che tra il 1845 e il 1856 diede al Palazzo l’aspetto che oggi conserva. Tra il 1911 e il 1928 il Palazzo rimase disabitato e andò degradandosi. Fu mons. Re che nel 1928 mise in atto un generale restauro del fabbricato. Nel 1965 Mons. Nicolosi mise in vendita quasi per intero la vigna venendo incontro al desiderio dell’Amministrazione comunale di tracciare nuove strade ed acquisire terreni per l’espansione urbana.( G.Iacolino, La chiesa cattedrale.., manoscritto cit., pag. 31 e,f,g.
[2] G. Arena “Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610 “Analisi, elaborazione statistica e sintesi dei riveli di Lipari conservati nell’Archivio di Stato di Palermo, Messina 1992, pag.7 e ss.
[3] G.Arena, op.cit., pag. 10.
[4] Fra cui 1 vescovo, 12 canonici, 16 preti semplici, 18 fra diaconi, subdiaconi e chierici, 8 frati, 18 monache professe e 13 terziarie francescane
[5] G.A.M. Arena, Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610, op.cit.,pag.75.
[6] G. A.M. Arena, L’Economia delle isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina, 1982, pp20-21.
La cura d’anime e il lento ripopolamento del territorio
Morale della gente e involuzione religiosa
Abbiamo segnalato che nel periodo che precede la “ruina”, per la maggior parte i vescovi venivano eletti e consacrati ma non raggiungevano la diocesi per cui quello di vescovo di Lipari era di fatto divenuto un titolo onorifico e si governava tramite un proprio vicario. Così aveva fatto il vescovo Ubaldo Ferratino ed anche i suoi tre predecessori. Quanto ai successori[1] – visto che per lo più erano siciliani - può darsi che abbiano deciso di vivere nell’isola e si sa che sotto il loro governo avvenne, come vedremo, l’apertura di chiesette e cappelle[2], ma se per loro iniziativa o su insistenza della gente questo non sapremmo dire, comunque, quello che è certo, è che non dovettero avere molta cura pastorale della Diocesi se, chi verrà dopo, troverà una situazione molto deteriorata. Questi successori, non solo si impegneranno a riportare a Lipari i frati cappuccini, come farà mons. Paolo Bellardito che probabilmente dovette giudicare insufficiente l’opera dei preti secolari, o metteranno mano alla ricostruzione del capitolo come fecero mons. Martino d’Acugna[3] - che fu il prelato che ricondusse , come abbiamo visto, in Cattedrale la reliquia del dito di S.Bartolomeo – e mons. Giovanni Gonzales da Mendoza[4], ma ciò che più dovette preoccupare questi vescovi a cominciare da Mons. Bellardito – di cui il Campis ci dice che governò la Chiesa di Lipari “con somma pietà e zelo come dimostrano le ordinazioni e costituzioni da lui fatte per la riforma dei costumi”[5] - era proprio la situazione morale della gente e lo stato di involuzione a cui era giunta la pietà religiosa.
E’ un editto di Mons. Antonio Vidal - che succederà nel 1598 a mons. Gonzales de Mendoza – che apre uno squarcio sul tipo di religiosità che era divenuta abituale fra le donne dell’isola. L’editto è del 16 giungo 1609, quindi ben dieci anni dall’insediamento di questo vescovo[6], e indubbiamente parla di situazioni che doveva conoscere molto bene e di pratiche che risultano ostiche ad estirparsi. Mons. Vidal, si richiama ai tre predecessori mons. Bellardito, mons. D’Acugna e mons. di Mendoza che come lui ogni anno, sotto pena di scomunica ed altre pene, avevano proibito alle donne di Lipari in occasione della morte di un loro congiunto o nelle ricorrenze di questa, di lasciarsi andare a pianti, grida, urli, balli disordinati ed altri comportamenti scomposti “all’usanza di barbari”.[7] Lo stesso editto denuncia poi che nelle solennità e durante le processioni, ancora le donne, si fanno notare con pianti “ad alti voci parendo volersela pigliare con nostro Signore Dio”.E visto che la minaccia di scomunica, da sola, non raggiunge alcun effetto, il vescovo annuncia che la disubbidienza verrà anche multata col pagamento di tre onze a ciascuna persona da devolvere ad opere pie[8].
Ma la trasformazione delle processioni e dei funerali in sceneggiate intollerabili – che tanto scandalizzavano e irritavano presuli di grande cultura religiosa e di ampie visioni cosmopolite - era solo la superficie di un disordine morale più profondo e così. con fogli che faceva affiggere sulla porta della Cattedrale, il vescovo Vidal bollava il concubinato, il meretricio, le magarìe, le invocazioni diaboliche,ecc[9]. Ed è perché preoccupato della cura d’anime che quando nel 1599 andarono via i Cappuccini[10], mons. Vidal, d’accordo con i giurati, fece venire dalla Calabria i Minori osservanti assegnando ad essi la chiesa ed il convento dei Cappuccini che era, come abbiamo detto, sulla Civita. I frati osservanti prendono consegna dei locali nell’aprile del 1600 ed il mese dopo viene stipulato l’atto notarile.
Il ripoipolamento delle campagne
E non era solo la situazione morale e religiosa che lasciava a desiderare a Lipari ma anche quella delle condizioni igieniche soprattutto in una realtà così ristretta come era il Castello. Erano poche le case che avevano una latrina o un pozzo nero per cui rifiuti di ogni genere, solidi e liquidi, gli avanzi dei cibi misti ad escrementi ed orina, si riversavano per le strade e persino “a lato la chiesa cattedrale, altre chiese et palazzo vescovale”[11]. Il vescovo lamentava Vidal , oltre a questo, lamentava che nella città e a fianco alle chiese si tenevano gli “animali attaccati” e ci si servisse dei tetti delle chiese per stendervi il grano ad asciugare “et altri servicj indicenti farsi in lochi sacri”.
I giurati nelle loro ordinanze si limitavano a chiedere che il sabato e nelle vigilie delle feste comandate, ogni famiglia provvedesse a pulire di fronte alla soglia delle loro abitazioni mentre si raccomandava che i rifiuti non si buttassero per strada, né dagli spalti che davano sul Borgo, ma da quelli del lato del mare. E se la situazione morale, religiosa e umana di Lipari appariva ai vescovi così critica ancora di più doveva sembrare quella delle contrade dell’isola principale e delle isole minori.
Dopo la “ruina” per alcuni anni la popolazione visse concentrata nella città alta e nel borgo e nelle contrade si andava solo, come nelle isole, a lavorare la terra ed infatti l’attenzione alla realizzazione di chiesette e cappelle rimane qui circoscritta. Ma col passare degli anni, lentamente riprendono a formarsi anche nella campagne delle piccole comunità. Ed il nascere di chiesette e cappelle fuori di Lipari è un segnale della creazione di nuovi insediamenti anche per lo stimolo dei deliberati del Concilio di Trento,. Così mentre il vescovo Lanza (1554-1564) porta a compimento la costruzione delle chiese nella città alta; il suo successore mons. Giustiniani (1564-1571) si spinge Sopra la terra e nel 1569 fa costruire la chiesa di S. Anna. Ma è mons. Cavalieri ( 1571-1580) che va fuori dal borgo di Lipari e fa riparare l’antica chiesa dell’Annunziata, poi quella di S. Margherita e quindi quella della Serra dedicata all’Assunta. Mons. Bellardito (1580-1585) ricostruisce e amplia l’antica chiesa di S. Nicola e ne realizza una alla Cicirata dedicata all’Assunta. Fa costruire nel 1583 una edicola rifugio su monte S.Angelo dedicandola a S. Michele Arcangelo ma sicuramente si tratta di un richiamo devozionale piuttosto che un luogo di culto al servizio di una comunità. Mons. d’Acugna realizza una cappella dedicata a S.Giorgio sulla sponda sinistra del Vallone del Ponte, la chiesa a Quattropani dedicata a Maria SS.di Loreto, quella a Pirrera al SS Nome di Maria, a S.Salvatore , a S.Leonardo, a Pianoconte nel 1593 la chiesina dedicata a Santa Croce dinnanzi alla nuova chiesa.
A questo punto dobbiamo affermare che oltre a chi vive nella città alta e nel borgo ci sono almeno una decina e più di piccoli nuclei abitati nelle campagne e nelle contrade che si spingono fino a Quattropani e la Cicirata ma a nord dell’isola non vanno oltre Pirrera. Tutta la zona al di là di Monte Rosa fino ad Acquacalda, probabilmente perché giudicata poco fertile e troppo scoscesa anche per la presenza dei giacimenti di pomice, di forre e profondi calanchi, è come se non esistesse.
Il difficile ripopolamento della zona nord di Lipari
Ci penserà il vescovo Gonzales de Mendoza (1593-1598), un vescovo che amava le sfide e l’avventura dato che finirà la sua esistenza in America, a cercare di forzare questa sorta di confino. Così pensò innanzitutto a quella gente che era andata a vivere a Canneto dentro - per dedicarsi allo scavo della pomice che cominciava ad essere adoperata nell’edilizia anche in Sicilia - edificando la chiesetta di S.Vincenzo Ferreri, quindi fece costruire una cappelletta a Pignataro dove una volta c’era la lanterna dedicandola a S. Giacomo Maggiore, quindi punta su Canneto in quella che allora si chiamava la baia della Calandra e, nel bel mezzo di questa baia, edifica una cappella dedicata a S.Cristoforo forse un incoraggiamento a chi scavare la pomice a raccogliersi in comunità e non vivere dispersi e nascosti fra le montagne per paura dei pirati. Comunque dovette passare molto tempo perché questo avvenisse se Lazzaro Spallanzani nel 1788 dice che a Canneto sono edificati “rari tuguri, dove vivono a stento pochi Isolani[12]”
Ad Acquacalda, sul finire del 500, non vi era ancora nessun insediamento perché era una realtà troppo lontana, isolata ed indifesa. Vi erano un paio di persone che coltivavano un po’ di terra e forse scavavano anche la pomice nei pressi della Castagna ma si guardavano bene dal pernottarvi per timore dei pirati turchi. Comunque col riprendere della vita a Salina anche Acquacalda riceve maggiore attenzione prima come luogo di sosta ma già ai primi del 600 sul timpone di San Gaetano dovettero sorgere una decina di “tuguri” e magari una piccola cappella dedicata proprio a S.Gaetano[13].
Il ripopolamento delle isole minori
Ufficialmente le isole minori dovevano essere disabitate e incolte per non offrire punti di appoggio ai pirati turchi o a navigli nemici visto che le guerre non mancavano, malgrado ciò abusivamente tutte le isole, di fatto, erano abitate: non molti a Salina, alcune decine a Stromboli e Panarea, un po’ di più a Filicudi. Alcuni erano venuti da Lipari, altri dal continente spesso fin dalla fine del secolo precedente. Se gli abitanti di Lipari ponevano diversi problemi di morale lassa e di religiosità deviata, nelle isole, che vivevano, nell’abbandono totale dove la violenza per sopravvivere era esperienza quotidiana, questi problemi non erano certo minori. Dovevano vivere in capanne di frasche coltivando pezzi di terra detenuti illegalmente perché di proprietà della Mensa vescovile , in condizioni miserevoli se non subumane, con relazioni improntate all’ individualismo ed alla sopraffazione ed una religiosità fortemente intrisa di pratiche superstiziose. Il loro isolamento fu per decenni quasi assoluto salvo le puntate che stagionalmente vi facevano pescatori e contadini di Lipari che riuscivano ad ottenere – dietro il rilascio, come abbiamo visto, di una tangente in natura - la “licenza d’uscita” dal capitano d’arme. Contadini che andavano nelle isole per raccogliere uve passe e malvasia, fichi e capperi barattandoli magari dai residenti in cambio di mercanzie di cui i locali erano completamente sprovvisti.
Ai divieti del comandante, a cominciare dal 1603 fino al 1917, si aggiunsero quelli di Mons, Vidal che proibì di andare nelle isole “senza licenza in scriptis di esso Monsignore” pena la scomunica. Una ordinanza affissa e proclamata ogni anno il giovedì santo nella chiesa Cattedrale durante la messa solenne[14]. Ma l’attenzione del vescovo per le isole non era solo connessa all’esigenza di fare rispettare il pagamento delle decime ma anche di procedere al recupero della gente sia alla vita organizzata sia alla fede ed alla morale cattolica. E questo a cominciare da Salina dove, proprio agli inizi del 600, si avvertivano chiari e manifesti segni di risveglio di vita e di attività agricola. Rari insediamenti stabili di pastori e contadini mezzadri dovevano esserci nelle zone interne e un certo numero di produttori di sale avevano fissato la loro dimora nel tratto costiero tra Lingua e Santa Marina. E come pensa a questo recupero mons. Vidal? Creando dei luoghi di culto dove la gente possa raccogliersi per pregare, accostarsi ai sacramenti ma anche ascoltare qualche insegnamento morale e religioso. Così, nel 1602, abbiamo il primo oratorio in una zona elevata della baia di Arenella, la Rinella di oggi, dedicata a S.Gaetano dove viveva un gruppo di boscaioli e contadini le cui abitazioni si assiepavano nel primo tratto del Vallone boscoso ; due anni appresso, nel 1605 sul fertile pianoro di Capo dove fra rigogliosi vigneti e alberi di fichi insieme a povere abitazioni, per la gran parte capanne, viene costruita la primitiva cappella in onore di S.Anna e della Natività di Maria ; nel 1612 sorge una chiesetta anche a Lingua, in località piuttosto discosta dal mare, intitolata a S. Bartolomeo al servizio di gente che si adattava alla pesca ed all’agricoltura, alla produzione di sale e al lavoro di carpenteria per piccole imbarcazioni; quindi ne 1622 dedicato alla vergine S.Marina. venne recuperata ed ampliata una antica struttura nella zona che prende il nome dalla chiesa dove dei contadini si dedicavano al trasporto a Lipari di derrate alimentari.
Il ripopolamento di Salina
Al ripopolamento di Salina, secondo Iacolino, concorsero in maniera significativa, un qualche gruppo di coloni proveniente dall’area di influenza veneta ed in particolare dalle isole Cicladi, Nasso, Scio, Cipro e Creta. Da terre cioè dove si producevano, in particolare, uve da tavola e da vino. Fra queste vi era una isoletta che si chiamava Monembasìa dove confluivano moltissimi vini dell’area e prima di prendere la strada dell’Europa, venivano ulteriormente curati e miscelati. Questi vini, a cominciare dal quattrocento, presero il nome dell’isoletta e si chiamarono “malvasie”. Quando a cominciare dal 1540 le isole caddero in mano dei Turchi e col tempo entrò in crisi anche Venezia come potenza marinara, cominciò la trasmigrazione dei coloni in varie regioni d’Italia fra cui la Sicilia. Ed anche nelle Eolie e principalmente a Salina a cominciare dal 1561 giunsero gruppi di questi portandosi i vitigni che avevano selezionato con tanta cura e trapiantandoli da noi[15] assieme alla loro esperienza di viticoltori. Fra questi immigrati probabilmente doveva esservi anche gente che aveva avuto a Cipro esperienze di saline e rimisero a cultura la piccola salina di Lingua. Ed è per questo che sul finire del 500 con riferimento all’isola non si parlò più di Didime ma di Salina che era già in uso nel XII secolo.
Sicuramente, continua Iacolino, si deve a questi coloni veneti l’introduzione a Salina del culto di Santa Marina . Una santa che nel 1512 era divenuta conpatrona di Venezia[16].
Una piccolissima cappella nel 1615 il vescovo Vidal la fa erigere anche a Stromboli e la dedica a S.Vincenzo Ferreri ma sarà una costruzione che deperirà presto perché l’isola era poco frequentata e spesso insidiata dai pirati turchi.
[1] Il Campis ( op.cit., pp.307-317) mette in risalto alcune contraddizioni fra due fonti entrambe solitamente bene informate: l’abate Ughelli che si rifà agli atti concistoriali e l’abate Pirri che, come abbiamo visto e stato anche a Lipari per documentarsi. L’Ughelli pone come successore di Ferratine, Annibale Spadafora , di Messina che rimarrà vescovo di Lipari fino alla sua morte e cioè per un anno dal 1553 al 1554; gli succede Filippo Lancia o Lanza, di Catania, dal 13 aprile 1554 al 1564; poi Antonio Giustiniani da Chio dal 12 maggio 1564 al 1571 che era già stato arcivescovo di Naxos ed aveva dato un significativo contributo teologico al Concilio di Trento; alla sua morte gli succede Pietro Cancellieri dal 3 ottobre 1571 alla sua morte nel 1580; gli succede Paolo Bellardito di Lentini dal 17 ottobre 1580 al 1585 quando rinunciò; quindi Martino d’Acugna da Siviglia dal 21 dicembre 1585 al 1593 e quindi Giovanni Gonzales da Mendoza, spagnolo dal 1593 al 1595; gli succede nel 1593 Alfonso Vidal anche lui spagnolo. Il Pirri disconosce questa successione e al Ferratino nel 1584 fa succedere un certo Giovanni, il quinto vescovo liparese con questo nome, dei minori osservanti che avrebbe portato a conclusione la fabbrica della Cattedrale ed avrebbe fatto venire dalla Sicilia i frati cappuccini affidando loro il convento che era stato dei frati osservanti sulla Civita. Sempre secondo il Pirri Giovanni V morì nel 1584 e fu sepolto in Cattedrale presso l’altare del SS.Sacramento. Il Pirri salta Spadafora, Lancia, Giustiniani e Cancellieri e fa succedere a Giovanni V, Bellardito ma non il 1580 bensì il 1584 per cui questo vescovo avrebbe governato solo un anno. Dopo di che la chiesa di Lipari sarebbe rimasta vacante sette o otto anni perché non nomina nemmeno il d’Acugna. Ma al di là delle contraddizioni fra la versione dell’Ughelli e del Pirri, dei quattro vescovi che seguirono il Ferratino sappiamo poco . Sicuramente risedettero a Lipari Mons. Bellardito e il d’Acugna . Anche a Lipari venne ad abitare Gonzales da Mendoza ma vi rimase solo due anni dopo di che nominò suo vicario l’arcidiacono e se ne partì per l’ America dove gli fu assegnata la diocesi di Chiapas nel Messico.
[2] Vedi G. Iacolino, Acquacalda di Lipari. Il territorio, la comunità umana, la chiesa, Lipari 2003, pp. 25-28.
[3] Martino d’Acugna, carmelitano come S.Teresa d’Avila e S:Giovanni della Croce dei quali era contemporaneo, predicatore,autore di un trattato su De arte Divini Amoris,e quindi studioso del misticismo.
[4] Giovanni Gonzales da Mendoza, agostiniano, aveva vissuto a lungo nel Messico e poi probabilmente andò anche in estremo oriente giacchè pubblicò una Historia de las cosas màs notables, ritos y costumbres del gran Reino de la China con allegato un Itinerario del Nuovo Mundo. Più tardi pubblicò anche Informe à Felipe II sobre la conservacion de las Indias e entrò a far parte dell’Accademia di Spagna.
[5] P. Campis, op. cit., pag.311.
[6] Mons. Alfonso Vidal viene nominato il 23 novembre 1599 ma raggiungerà Lipari solo il 20 aprile dell’anno successivo perché preferì passare a Roma l’inverno.
[7] “..ballari, triscare o alzarsi alla dritta, raffugnarsi o xipparsi li capelli o battersi in qualsivoglia parte del corpo, reputare o far reputare, sbattere la persona o fare strepito con porte o fenestre o far gesto di donna poco saggia gridando e saltando all’usanza dei barbari”.
[8] G.Iacolino, La Chiesa cattedrale di Lipari sotto il titolo di S.Bartolomeo, manoscritto citato, quaderno IIA, pag. 27-29.
[9] Idem, 27
[10] Il Convento dei Cappuccini di Lipari fu fondato nel 1584 ed edificato “tutto a lamia e damuso in quadro secondo il modello allora moderno innante la porta dell’entrata nella città, in buon sito e sopra l’antiche muraglie del palazzo del re Liparo”come è scritto nel manoscritto di P. Bonaventura Seminara da Troina, Libro primo, op.cit. pag. 140-141. Fu chiuso nel 1599 su iniziativa di un frate visitatore con la motivazione che i frati avevano violato la “regula della santa Poverà”.( Manoscritto di P.Bonaventura, op.cit., libro III). Iacolino, analizzando l’inventario dei beni lasciati dai Cappuccini nel monastero, afferma di avere individuato in che cosa consisteva questa violazione della regola: i frati si erano dati al commercio dell’uva passa. Infatti fra la roba trovata ci erano “trenta tri barilotti” che contenevano tredici cantàra ( un cantàro oscillava dagli 80 ai 100kg) e dieci rotoli uva passa, cioè oltre una tonnellata di merce pregiata. Inoltre nel monastero furono trovati anche sei archibugi con sei fiaschette per la polvere da sparo, una difesa contro eventuali assalti notturni da parte dei pirati visto che il convento si ergeva, allora, su una zona isolata a ridosso dell’approdo. (G. Iacolino, manoscritto, op.cit., pag. 30l).
[11] Archivio vescovile, Visita di Mons. D.Giovanni Mendozza, dal 1593 al 1626, f. 300; in G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale…, manoscritto cit, pag. 32°.
[12] L.Spallanzani, Destinazione Eolie, Lipari 1993, pag. 214; G.Iacolino, Acquacalda di Lipari, op.cit., pag.33.
[13] G.Iacolino, Acquacalda di Lipari, op.cit., pp.33-38.
[14] L.Genuardi e L. Siciliano, Il Dominio del Vescovo nei terreni pomici feri dell’Isola di Lipari, Acireale 1912, pg. 83, nn. 8 e 10 dove è riportato l’atto di Notar Verderami Voi del 1623. In manoscritto di G.Iacolino, La cattedrale…, op.cit., pag. 29 b.
[15] Si ricordi che nel 1564 viene trasferito a Lipari il vescovo Antonio Giustiniani, di famiglia genovese, che era nato a Scio ed era stato vescovo di Nasso.
[16] Queste informazioni sono ricavate dal manoscritto di G.Iacolino, La chiesa cattedrale…, op.cit., pag. 29f-i2. Sempre dallo stesso manoscritto – che si rifà, per lo più, all’Archivio Vescovile – derivano le notizie che seguono.(Archivio Storico Eoliano.it)
La pratica della pirateria e il commercio degli schiavi

La battaghlia di Lepanto diede un duro colpo alla piratertia ma non la debellò.
Una pirateria legalizzata
Già da alcuni accenni si evidenzia il fatto che, col tempo, va diminuendo la paura del “turco alla marina” aumenta invece la capacità predatoria dei liparesi sino a diventare essi stessi mercanti di schiavi.
La pirateria era considerata una vera e propria attività nel 400 e nel 500. E mentre in altre parti del mondo si va distinguendo fra corsari e pirati - i primi autorizzati e legalizzati, i secondi dei veri e propri banditi senza regole e senza vincoli - in Sicilia tutti erano pirati anche se quelli patentati si dicevano affidati ad pyraticam exercendam”[1]. La legalizzazione di questa attività nasceva dal fatto che il re con le sue navi non riusciva a difendere territorio e popolazione dalle incursioni che, quando si realizzavano ad opera dei pirati, erano caratterizzate da scorribande senza avvisaglia alcuna e richiedevano un continuo stato di allerta. Per questo già nel 1446 il re Alfonso aveva concesso ai siciliani facoltà di difendersi e persino “manu armata offendere” quando si imbattevano in navi che li aggredivano[2]. Il problema più dibattuto non era quello dell’esercizio di questa pratica come professione ma la divisione del bottino che i privati reclamavano tutto per intero sottolineando i rischi che correvano e il servizio che recavano al regno, mentre gli Ammiragliati, che rilasciavano le patenti, ne rivendicavano un parte[3]. Nel tempo si va affermando il concetto - formalizzato in una presa di posizione del Parlamento siciliano nel 1523 – che, visto il servizio reso alla comunità, nessun compenso dovesse spettare alla Regia Corte ed all’Ammiragliato ma il bottino doveva essere “di quelli che li pigliranno” se questo avveniva per mare. Nel caso invece che l’imbarcazione venisse catturata mentre si dirigeva verso terra doveva essere diviso a metà con coloro che erano a terra.
Una professione quella, della pirateria , molto lucrosa - soprattutto perché era collegata direttamente al commercio degli schivi - a cui non sdegnavano di prendere parte anche i vicerè, i loro familiari e funzionari governativi in un intreccio di ruoli pubblici e speculazioni private. “Le carte notarili di piazze come Trapani, Messina, Siracusa, […] ci hanno lasciato memoria interessante di contratti di società finalizzate all’esercizio della pirateria. Si trattava infatti di un’attività come un’altra , per la quale i notai fissavano in atti pubblici le condizioni e i patti a cui i soci dovevano sottostare[4]”.
Il commercio degli schiavi
 L’aspetto economico più rilevante e quindi lo scopo principale dell’attività di pirateria era costituito dal lucro ottenuto dalla vendita degli schiavi catturati. Un commercio per trovare braccia per il lavoro ma anche un commercio per riscattare chi era caduto in cattività. Il riscatto era infatti l’obiettivo della pirateria barbaresca mentre invece era più raro il riscatto per i mori caduti in cattività .
L’aspetto economico più rilevante e quindi lo scopo principale dell’attività di pirateria era costituito dal lucro ottenuto dalla vendita degli schiavi catturati. Un commercio per trovare braccia per il lavoro ma anche un commercio per riscattare chi era caduto in cattività. Il riscatto era infatti l’obiettivo della pirateria barbaresca mentre invece era più raro il riscatto per i mori caduti in cattività .
Abbiamo parlato delle condizioni in cui i deportati da Lipari fecero il viaggio verso oriente nel 1544. Possiamo dire, in genere, che i viaggi dei pirati che commerciavano in schiavi non doveva essere una crociera anche se c’era una bella differenza fra le condizioni di viaggio dei mercanti, dei proprietari degli schiavi e quello degli stessi schiavi costretti in catene, ferri e cippi giacchè il pericolo che potessero fuggire durante il viaggio era elevato e, in tal caso, né il locatore né tantomeno i proprietari degli schiavi, erano tenuti a pagare il nolo[5].
Come abbiamo avuto modo di accennare la pirateria si praticava anche da parte dei liparesi autorizzata e abusiva.
Nell’estate del 1571, prima della battaglia di Lepanto, fra Vulcano e Lipari si svolge l’assalto ad una fusta turca da parte di due galee genovesi che si contendono il bottino del naviglio mentre l’equipaggio turco che si era dato alla fuga per l’isola viene scovato dai liparesi che, ucciso un turco, ne fanno prigionieri altri undici e li consegnano ai genovesi ricevendo in pagamento cinquecento zecchini d’oro. In quell’occasione vengono liberati diversi schiavi cristiani che si trovavano nella stiva della nave turca incatenati[6].
I corsari berberi
Due documenti del fine secolo parlano invece di contadini eoliani che a Stromboli, Panarea e anche a Lipari sulla marina di San Nicolò, l’attuale Marina Lunga, vengono rapiti da equipaggi barbareschi e deportati in terre lontane[7]
Pietro Campis ci informa che intorno al 1580 continuano i corsari berberi ad imperversare nel mare di Lipari impedendo la navigazione e persino facendo incursione nei campi rubando i frutti della terra e facendo schiavi quanti vi ci trovavano. Per reagire a questi fatti alcuni liparesi - Bartolomeo Carnovale, Nicolao Altiri e Francesco Di Franco - armarono due brigantini ed una galeotta e si misero a contrastare i turchi impedendo loro altre scorrerie ed anche liberando una gran quantità di schiavi che si trovavano sui loro navigli. Poi, presa la mano, i nostri liparesi decisero di spingersi a levante esercitando loro la pirateria e tornando a casa con “prede considerabili e numerose turbe di Turchi in catene”[8]. Lo stesso Bartolo Carnovale nel 1584 chiede che gli vengano restituiti 17 turchi che gli erano stati requisiti dall’autorità dell’isola[9] mentre, sempre nel 1584, i liparesi si lamentano che viene loro impedito di recarsi a vendere al mercato degli schiavi i turchi catturati[10].

I turchi residenti a Lipari e chi tornava dalla schiavitù
Diversi turchi vivevano anche a Lipari e non erano poche le famiglie borghesi che fra i loro schiavi non contassero anche un moro ed una mora. Erano tempi quelli in cui la discriminazione razziale e religiosa esisteva in maniera sensibile. Nel 1664 il vescovo di Lipari, che era mons. Francesco Arata – un pastore, come vedremo, dotato di grande pietà e carità -fece affiggere alle porte della cattedrale un editto che ribadiva alcune norme comportamentali fra i cristiani e “li turchi mori et altri infideli” a cominciare dal fatto che, per distinguersi, quest’ultimi dovessero portare “il cerro di capelli in testa” pena dieci anni di galera e nella stessa pena sarebbero incorsi se fossero stati trovati in case di meretrici o avessero avuto rapporti con donne cristiane. Quest’ultime, a discrezione del vescovo, sarebbero state condannate invece o al carcere o alla frusta. Inoltre schiavi infedeli e schiavi cristiani dovevano pernottare in stanze separate e non dovevano mangiare insieme, “particolarmente in tempo in cui venghino proibiti i latticinij”. Per evitare “ogni occasione di male che potrebbe succedere” i cristiani non devono abitare con gli infedeli, né andare ai loro conviti, né invitarli ai propri, né mangiare insieme a casa propria o altrui, né possono ricevere da loro alcun medicamento e nemmeno andare da loro per curarsi delle infermità, né abbiano con loro cose in comune “ma, quanto far si può, da tutto lor commercio e pratica si astenghino”[11].
Un atteggiamento discriminatorio e vessatorio veniva tenuto anche nei confronti di chi tornava o fuggiva dalla schiavitù fino a quando non si accertava che era rimasto cristiano o che volesse sinceramente riconciliarsi con la Chiesa. E’ il caso di un tedesco fatto schiavo dai turchi e fuggito – nell’ottobre del 1583 - durante una sosta a Salina della nave dove era messo ai remi. Da Salina, dopo ventidue giorni di latitanza, riesce ad avere un passaggio per Lipari e si consegna alle autorità. E qui comincia un nuovo calvario del poveretto che viene messo in carcere in attesa che il vescovo accerti – sulla base di testimonianze – la sua vera identità, se era fuggito di sua volontà o se era un “turcho nato”, se avesse rinnegato la sua fede e in questo caso se lo avesse fatto di propria volontà o se costretto. Fortuna volle che qualche mese dopo, nel marzo del 1584, a Vulcano venne catturato un vascello marocchino dove, nell’equipaggio, vi erano persone che l’avevano conosciuto o avevano sentito parlare di lui e della sua fuga a Salina. Tutto a posto? Purtroppo non ancora. Il malcapitato doveva subire l’iter della “sollenne riconciliazione con la Chiesa”, una dura cerimonia penitenziale[12].
I vescovi pretendono le decime sugli schiavi
Ma l’attenzione dei vescovi e della curia alla liberazione degli schiavi non era sempre solo dettata da motivi religiosi per quanto rigidi ed inumani, ma anche da interessi materiali e cioè la decima sugli schiavi che spesso veniva reclamata sotto pena di scomunica. Infatti il 17 ottobre 1580 di scomunica viene colpito Bartolomeo Carnavale perché “degli schiavi liparesi da lui presi non aveva pagato la decima[13]”.
Le cose cominciano a cambiare il 20 luglio 1612 quando il vicerè di Sicilia dichiarerà che i liparesi per le loro azioni di pirateria autorizzata nulla dovranno dare al re ed all’Ammiraglio. I vescovi oppongono a questa decisione un “distinguo”, la norma non può valere anche per i turchi che venivano presi a terra perché, essendo essi gli unici ed assoluti proprietari delle isole, come si doveva la decima per i frutti del suolo così era per i prigionieri fatti a terra. Ma ai primi di ottobre del 1693 di quell’anno, proprio ad Alicudi, si ha un episodio di una certa importanza che porta alla liberazione di ventidue cristiani ed alla cattura di centocinquanta infedeli di cui tre agguantati sull’isola. Il vescovo rivendica per questi le decime dietro minaccia di scomunica. Gli armatori si oppongono e si va dinanzi al Tribunale della Regia Monarchia che li assolve dalla scomunica sentenziando che le decime non erano dovute perché le nostre sono “Isole che non producono turchi”[14].
La pirateria dei liparesi continuò ancora per qualche tempo. C’è un documento del napoletano del 1710 che parla dei “liparoti che infestano questo mare impedendo il commercio[15]” e proprio nel primo scorcio del 700 il nome dei liparesi era temuto sulle coste fra Reggio Calabria e il Golfo di Gaeta mentre gli isolotti di Ventotene, Palmarola e Zannone era loro zona di operazione dove sequestravano e poi chiedevano il riscatto di barcaioli del luogo usciti per la pesca. Poveri che derubavano altri poveri e giustamente Iacolino parla di “briganti marini di mezza tacca”[16].
I costi per la sicurezza
Col passare degli anni dalla “ruina”, abbiamo visto, la paura dei turchi va diminuendo. Ed anche se di tanto in tanto compaiono nelle nostre acque vascelli barbareschi la gente di Lipari comincia a lamentarsi del costo della sicurezza e chiede che vengano ridotte le incombenze e le spese. Si comincia nel 1633 quando i giurati di Lipari protestano col viceré e la spuntano, perché il Capitano d’armi ha ordinato che le guardie che si era soliti fare, ogni notte, con pattuglie di nove persone, nel periodo estivo da agosto ad ottobre nella marina di San Giovanni, nella spiaggia di Portinente e “in un posto ditto Gattarelli” siano estese per tutto l’anno e siano a carico delle persone che abitano nel borgo[17].Nel 1635 una lettera del vicerè ridimensiona le spese per le guardie e la difesa cominciando dalla “guardia del Monte”, per la barca di guardia all’isola di Vulcano, e per le guardie nell’isola di Salina, Stromboli e Filicudi. Un anno dopo i giurati riescono a liberare l’ università del costo del “capitan d’arme pratico ed esperto alla guerra”– onze otto al mese – che veniva inviato nell’isola per cinque mesi nella prospettiva di una guerra. Nel 1657 una nuova protesta per essere esentati dalla spesa di 40 onze al mese per la paga delle guardie ritenendo che la vigilanza contro i corsari e le imbarcazioni nemiche può essere fatta dalla gente che va al pascolo[18].
Non deve meravigliare questa richiesta dei liparesi di ridurre i costi per la sicurezza giacchè sulle mercanzie dei pescatori, dei contadini e dei commercianti già pesavano le decime ed i censi della Mensa vescovile. E se si aggiungevano le angherie del capitano d’armi e dei soldati si comprende che il peso dei prelievi diveniva insopportabile.(Archivio Storico Eoliano.it)
Potete scaricare il file in formato power point de:
La «ruina» del Barbarossa di di Michele Giacomantonio
[1] A. Italia, La Sicilia feudale, Milano 1940, pag. 363; R. Cancila, Corsa e pirateria nella Sicilia della prima età moderna, op.cit. pag, 363.
[2] F. Testa, Capituli Rengi Siciliae, Palermo 1741, p.352, v. R. Cancila, op.cit., pag. 364.
[3] R. Cancila, op.cit., pag. 256.
[4] Idem, pag. 369.
[5] Idemm, pag, 373-4.
[6] G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit., pp. 207-209.
[7] Idem, 209 e 218-9.
[8] P.Campis, op.cit., pag. 312.
[9] Libro delle Corrie, f. 4v e 5.
[10] Idem, f.6.
[11] Archiovio vescovile di Lipari, Editto generale di Mons. Francesco Arata, carp. 16.Civili, in G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit., pag. 210-211.
[12] Anche per questa vicenda i documenti originali si trovano nell’Archivio Vescovile di Lipari, Civile, carp. 2 e riprotati in G. Iacolino, op.cit., pp2111-213 e 222-226.
[13] G.Iacolino, idem pag. 214.
[14] Sulla vicenda si veda P. Campis, op.cit., pag. 58-60; G.Iacolino,op.cit., pag.213-214, 226-229; Archivio Vescovile, Carpetta Criminali 12.
[15] Si tratta di un documento del Banco di Santa Maria del popolo del 27 maggio del 1710 ora in Archivio del Banco di Napoli, cit. da G: Iacolino, op.cit., pag.215, 219.
[16] G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit.,pag. 215-216
[17] A.Raffa, op.cit., pag. 101.
[18] Idem, pag. 102.
La difficile ripresa
Un ripopolamento alla "Far West"

All’indomani del sacco, Lipari riprende lentamente la sua vita. Ha due grossi problemi da affrontare: il ripopolamento e la ricostruzione e cioè riparazione del castello e espansione della città.
Il re – che, come abbiamo visto, è stato pronto nella risposta anche su sollecitazione del marchese di Terranova - manda, di concerto col viceré di Napoli, il Comandante Consalvo de Armella , che si fermerà a Lipari dieci anni dal 1544 al 1554. Il comandante avrà ”ampla potestate et autoritate di far quello che li piacesse circa la rehabitazione di deta cità[1]”.
Già nel 1545 giunge anche una guarnigione spagnola – che nel 1544 è di cinquanta uomini ma al censimento del 1610 conterà, nell’insieme, comprese le famiglie, più di 250 persone - che risiederà stabilmente al Castello. Inoltre il Viceré di Napoli, il 21 gennaio del 1546, per aiutare il ripopolamento dell’isola, confermava, a nome del re, a chi fosse andato ad abitare a Lipari i privilegi, le grazie le franchigie e le immunità che in passato erano state concesse all’isola e questo favorì l’immigrazione dalla Sicilia, dalla Calabria e anche da diverse città italiane[2].Di più fu garantito anche il non luogo a procedere per chi aveva conti in sospeso con la giustizia[3].
Si tratta di un chiaro contributo ad un ripopolamento realizzato senza andare troppo per il sottile e quindi a una sorta di Far West, come è stato detto. Un notevole flusso migratorio quindi si concentra su Lipari per far fronte al vuoto creato dalla deportazione. Il movimento vorticoso durò circa un secolo e mezzo e attrasse genti dalle località più vicine, ma anche da territori più lontani. Nel 1693 Pietro Campis afferma che gli abitanti erano giunti a circa diecimila e “alla giornata si va sempre accrescendo”[4].
Le fonti liparesi danno molte informazioni sulla “qualità” degli immigrati. Molti sono mascalzoni, molti fuggono da situazioni tragiche, ma c’è anche gente intraprendente che spera in una promozione sociale.
“Lipari all'indomani del sacco e dello svuotamento si presenta come una terra delle opportunità, ma non soltanto da chi fugge da condizioni di non sufficiente garanzia di sopravvivenza, come pure è facilmente presumibile nella Sicilia del 500. Spesso si tratta di singoli o di famiglie che , cercando fortuna altrove e avendo una “preparazione” emigrano definitivamente a Lipari, dove trovano spazio per la qualificazione del loro mestiere”[5]. Così ai superstiti, via via si aggiunsero famiglie siciliane, calabresi, campane e la colonia di spagnoli rappresentata dai militari e dai loro familiari e che spesso crea dei problemi di conflitto con le autorità ed i comuni cittadini[6]. Molti di questi si sposano con eoliane ed una volta terminato il servizio rimangono nell’isola dando origine a quei cognomi chiaramente spagnoli che ritroviamo ancora oggi[7]
Ripopolamento forte ma non stravolgente
Il primo censimento compiuto dopo la “ruina”, come vedremo nel 1610, dice che gli abitanti residenti nelle Eolie, compresi gli ecclesiastici, sono 2384. Sono passati sessantacinque anni dalla grande tragedia e quindi hanno fatto a tempo a nascere i figli dei figli, e gli “oriundi”, cioè persone che o erano di Lipari o avevano anche un genitore che lo era, assommavano a 1200. “Nel ripopolamento di Lipari, dopo il sacco del 1544, vi fu, quindi, - commenta Angelo Raffa[8] - un profondo rinnovamento di stirpi, ma esso si innestò su un ceppo principale indigeno, che costituisce ancora elemento forte di continuità con la storia demografica isolana”. Il ripopolamento, quindi, fu forte ma non stravolgente.
I lavori per riparare e potenziare il castello cominciarono nel 1547 ma durarono a lungo anche se il grosso fu realizzato in due anni su progetto di Iacopo Malerba e la direzione dei lavori di Giovanni Andrea di Ferrara. Nel 1634 non erano ancora ultimati, tanto che il vicerè di Palermo, chiede al nuovo direttore dei lavori, Vincenzo Tudeschi, di ultimarli con urgenza perché la struttura minaccia di rovinare “per aversi differito tanto tempo a dar principio a ditta fortificazione”[9].
Abbiamo detto che una delle prime cose che Carlo V decise e che il capitano Gonzalo de Armella realizzò, insieme alla riparazione delle mura, fu quello fu di “spianare tutto il borgo cosiché le mura potessero dominare scopertamente la campagna[10]”. E questo perché non era solo considerato insicuro e pericoloso per abitarvi ma rappresentava anche un pericolo perché si poteva dare riparo ad eventuali attaccanti, come era avvenuto per il Barbarossa. Ma dove mandare ad abitare la gente di Lipari? Probabilmente per i primissimi tempi, fin quando la popolazione fu sotto i duemila abitanti, la questione non si pose, ma via via che l’opera di ripopolamento andava avanti non era pensabile che tutti potessero risiedere dentro le mura del castello. Ha inizio così un braccio di ferro fra le disposizioni delle autorità regie ed i comportamenti della gente spesso col beneplacito delle autorità cittadine. Da una parte si continua a ribadire il divieto - “non ardisca ne presuma piantare vite, ne fabbricare in modo alcuno in lo burgo in fronte la chiesa di S.to Petro in contro allo spontone né in altra parte intorno alla muraglia di questa città”[11] - e dall’altro lo si contravviene. E non giovano nemmeno le sanzioni che vengono poste come nel 1606 “sotto pena, per i nobili, di cinque anni di esilio dall’Isola e onze cinquanta da pagarsi per la regia fabrica, e, per i non nobili, sei anni al remo sulle galere” [12], o nel 1647 quando si vuole privare - chi abita fuori della mura - del diritto di voto e dei privilegi[13] o di nuovo si ribadisce, nel 1687, il pagamento di 50 onze di multa a chi vi abita senza permesso[14]. Così nel censimento del 1653 su 4480 abitanti ben 2406 abitavano “nel burgo e nelle marine”[15]. Nel 1653 però apprendiamo che nel borgo operano sei mulini e se ne autorizzano altri quattro, mentre alle due botteghe di alimentari se ne aggiungono altre due [16]. Eppure nel 1685 prima e nel 1687 ancora, il conte di Santisteban esprime grande meraviglia e chiede come sia possibile che. “senza espresso ordine nostro” , sorgano fuori dalle mura tante costruzioni[17]. Segno questo che qualche volta le autorità locali – come si è accennato - si mostravano comprensive. Daltronde come avrebbero dovuto fare i liparesi? Nel 1634 tramite i giurati avevano ripescato l’antico progetto di costruire sulla Civita, giudicato luogo più atto e sicuro da abitare, ed i giurati avevano inviato una supplica al duca di Alcalà.[18] Il consenso è ottenuto ma questo non blocca le costruzioni nella marina di San Giovanni che finisce col rappresentare il collegamento fra la Maddalena ed il quartiere di S.Pietro. Infatti proprio in quello stesso anno i giurati chiedono l’autorizzazione al duca di usare del patrimonio civico per completare il terrapieno del bastione che porta questo nome[19].
Abbiamo detto dell’attenzione del papa e del vescovo Baldo Ferratino – che pur continuava a vivere a Roma - per la riedificazione delle chiese subito dopo la “ruina” ed infatti già a partire dal 1545 vengono costruite le chiese di San Giuseppe, di San Pietro, delle Anime Purganti a Marina Corta ed iniziano i lavori per la Cattedrale che fu completata negli anni successivi. Si mise mano anche alla ricostruzione del palazzo vescovile a fianco alla Cattedrale. Il Campis osserva che la Cattedrale – grazie alla vigilanza e sollecitudine del vescovo - “ è riuscita più nobile che prima fosse, imperciò che quel tempio non è [più] coperto di tavole, ma d’una bellissima volta”[20]. E se i francescani che avevano avuto in custodia la chiesa di San Bartolomeo alla Maddalena vanno via subito dopo il sacco[21], dopo qualche anno, nel 1584, arriveranno i cappuccini che daranno inizio alla costruzione del convento e della chiesa di S. Francesco sulla Civita e cioè all’attuale Municipio ed a quella che oggi si chiama chiesa di S. Antonio[22].
Il riconoscimento e l’applicazione dei privilegi
Carlo V ed il viceré di Napoli, come abbiamo visto, avevano riconfermato tutti gli antichi privilegi oltre alle norme per ripopolare la città, ma questa direttiva doveva essere disattesa molto spesso dal comandante della città e dai suoi funzionari, perché i liparesi nel 1574 sono costretti a esprimere una protesta molto forte dichiarando che se la loro richiesta dovesse continuare ad essere ignorata si troveranno costretti a “disabitar dita città” [23]. Ma ancora nel 1598 deve intervenire il conte di Miranda per ordinare al capitano che si rispettino i privilegi e le consuetudini[24].
Non si tratta solo di rispetto dei privilegi, il fatto è che la guarnigione vuole le tangenti per consentire ai liparesi quello che è loro diritto. Come nel caso dei permessi per recarsi nelle isole minori a lavorare. Queste infatti erano ufficialmente disabitate e tali si voleva che rimanessero sia per pericolo degli agguati della pirateria turca, sia, in caso di guerra, temendo la presenza di vascelli nemici e sia per evitare il contagio dalle ricorrenti pestilenze. Così il Capitan d’armi e governatore di Lipari era tenuto ad impedirvi, in genere, l’accesso. Ai lavoratori in proprio o per conto terzi, escluse le donne e gli uomini sotto i 18 anni e sopra i 60, soleva rilasciarsi un permesso d’uscita a tempo determinato, cioè per la durata dei lavori stagionali. Ma ottenere il regolare permesso d’uscita non era cosa facile, giacché il Governatore ed i suoi ufficiali frapponevano una infinità di ostacoli, a meno che il richiedente non accondiscendesse a pagare una sostanziosa tangente in natura[25].
Conflitti con la guarnigione del Castello
Ancora, nel 1588 i liparesi si lamentano che il Capitano della città non permette loro di pescare di notte né nella loro isola né in quelle vicine a meno che non diano a lui una parte del pescato e cioè la quota di un pescatore: un grande danno. Il 12 dicembre 1588 il Conte di Miranda accoglie la petizione ed ordina al Capitano di non molestare i liparesi che possono andare a pescare di giorno e di notte senza dovergli dare niente. Invece i pescatori dovranno versare ai giurati un carlino per ogni barile di pescato che dovrà servire a pagare le guardie che fanno il servizio di controllo intorno all’isola[26].
Lo stesso problema lo pongono altri tipi di pescatori che non vanno in cerca di pesci ma di schiavi. Anche i padroni di barche che volevano uscire in mare a fare una retata o andare in Sicilia a vendere gli infedeli che gli era capitato di far schiavi, lamentano di dover pagare grosse tangenti occulte.
 E’ superfluo dire che per tutti questi arbitri e abusi i liparoti si lagnarono più volte con le autorità superiori – generalmente il vicerè di Napoli e di Palermo, - ma con esito non sempre favorevole.
E’ superfluo dire che per tutti questi arbitri e abusi i liparoti si lagnarono più volte con le autorità superiori – generalmente il vicerè di Napoli e di Palermo, - ma con esito non sempre favorevole.
Esito favorevole invece ha la petizione che nel 1595 i liparesi rivolgono al re Filippo II perché i loro privilegi siano applicati anche nei rapporti commerciali con la Sicilia[27]. Così anche nel 1618 lo stesso re conferma il diritto dei padroni di barche di tenere per se tutta la preda di schiavi senza dovere niente al regio fisco[28].
[1] G.Retifo, “Un drammatico sradicamento e un convulso ripopolamento. Lipari dopo il 1544” in Atlante dei beni etno-antropologici eoliani, Messina 1955., pag.48.
[2] P.Campis, op.cit., pag. 307-8.
[3] Idem, pag. 48.
[4] P.Campis, op.cit., pag. 308. G.Restifo, op.cit. pag. 52.
[5] Idem, pag. 53.
[6] Idem, pag. 49. F. Vergara, Società e giustizia nelle Isole Eolie (sec. XVI-XVIII). I processi penali della Curia Vescovile di Lipari, Soveria Mannelli, 1994, pag. 16. G.Restifo, op.cit., pag. 53.
[7] I Rodriquez, i Lopes, i De Losa, i Mirabito, ecc.
[8] A, Raffa, op.cit., pag. 103
[9] A. Raffa, op. cit. , pag. 100.
[10] Lettera di Baldassar Calderon del 30 ottobre 1606 nel Libro delle Corrie, ff. 12-12v anche in G. Iacolino, I turchi…, op.cit., pag. 198-201. Il Calderon dice che nel 1594 il vescovo Mendoza aveva dato in affitto alcune parti del borgo per fabbricarvi o coltivare ma l’anno successivo il Capitano don Basco de Peralta “emanò un bando secondo il quale nessuna persona osasse fabbricare o piantare alberi, sia piccoli che grandi, in detto borgo senza ordine di sua Eccellenza, sotto pena di cinquanta onze”.
[11] Libro delle corrie, 1606,f.12 v.
[12] Idem.
[13] Libro rosso, foglio 172 v. in A.Raffa, op.cit. pag. 99.
[14] Idem, foglio 311 r:.
[15] Idem, f.186,v.
[16] Idem, f.221 r, 222r, 258 r ev.
[17] Idem, f. 311 r.
[18] Idem, f.106 r e v.
[19] Idem, f..107 v.
[20] P.Campis, op.cit., pag.308.
[21] Nel 1559 viene venduto all’asta il loro convento alla Maddalena e lo comperano Gioannello Mercurella e la moglie Pina. “La chiesa francescana di S.Bartolomeo alla Maddalena, benché assai malconcia a seguito dell’incendio turchesco, restò adibita al culto finché non fu abbattuta. Al suo posto – e a semplice titolo di ricordo -, i fedeli liparoti del ‘600 vollero erigere qualla cappellina quadrata, con campanile, che ancora sussiste. E’ interessante sapere che al decadimento della quattrocentesca chiesa di S. Bartolomeo ebbero un qualche interesse i vescovi i quali mal tolleravano che la devozione al Santo Protettore non fosse interamente accentrata nella Cattedrale. Tant’è che essi, i vescovi, nelle vicinanze della chiesa francescana favorirono l’erezione di un nuovo sacello dedicato a S.Giuseppe.” ( G.Iacolino, I turchi alla marina, op.cit., p.197-198.
[22] Il manoscritto di P.Bonaventura da Troina (+1704) ( a cura di Giuseppe Lipari).Libro I, Messina 1999, pag. 140. I cappuccini lasciano Lipari nel 1599 e nelle loro strutture verranno ad insediarsi, verso il 1600 i Minori. I cappuccini torneranno ancora una volta a Lipari nel 1650 e costruiranno convento e chiesa nella zona attuale del cimitero. G.Iacolino. I turchi alla marina, op.cit., pag. 194-198.(Archivio Storico Eoliano.it)
[23] Libro delle Corrie, f.1 e 1v.
[24] Libro delle Corrie, 16 gennaio 1589, f.3 v.
[25] G.Iacolino, manoscritto, La chiesa cattedrale di Lipari sotto il titolo di S.Bartolomeo, Quaderno II A.
[26] Libro delle corrie, foglio 2 v..
[27] P.Campis, op.cit., pag. 316.
[28] Libro rosso, f. 228 r; A. Raffa, op.cit., pag. 104.
La riedificazione di Lipari dopo la “ruina”
L'attenzione dell'imperatore e del Papa


L'imperatore Carlo V e il Papa Paolo III
La “ruina” di Lipari, abbiamo detto, colpì notevolmente la mente, il cuore, la fantasia della cristianità di allora e Carlo V ed il Papa Paolo III fecero a gara per cercare di riedificare Lipari e di ripopolarla. Carlo V era stato sensibilizzato sulla situazione anche da una lettera, come abbiamo visto, del marchese di Terranova dell’8 settembre 1544 che temeva che un’isola strategicamente così importante, sia per il regno di Napoli che per il regno di Sicilia, se fosse rimasta disabitata avrebbe rappresentato una “gran commodità de’ corsali[1]”. Per questo concesse ai Liparesi ampi privilegi, immunità ed esenzioni. Inviò anche una colonia di tecnici e di maestranze con il compito di restaurare il Castello e di renderlo più forte di prima munendolo di nuovi bastioni e di muraglie inespugnabili e fece demolire le case del Borgo[2]. Il Papa pensò alla riedificazione delle chiese ed il 28 novembre del 1544 non solo elevò il vescovo di Lipari, Ubaldo Ferratino, a Nunzio Apostolico, che era scampato alla deportazione perché viveva a Roma, ma lo investì di ampia autorità compreso quella di concedere indulgenze a coloro che con elargizioni avessero concorso alla riedificazione delle chiese distrutte. Contemporaneamente il Papa ordinava all'Arcivescovo di Messina di obbligare con censure e scomuniche coloro che possedevano volumi, documenti e altri oggetti appartenuti all'Archivio Vescovile di Lipari ed alle Chiese della città, usurpati durante la “ruina”, di restituirli[3].

Paolo III benedice Carlo V
Purtroppo questo “appello” non ebbe grande successo, tanto è vero che il 1544 rimane ancora oggi come il tempo di una grande cesura dopo quella dell’833. Non esistono praticamente documenti di Lipari che parlano delle vicende delle isole prima di quella data. Per il periodo normanno la documentazione è recuperata soprattutto dagli archivi di Palermo, Roma e Patti. Le consuetudini ed i privilegi sono stati ricostituiti dopo la “ruina” attingendo dagli archivi di Palermo e Napoli. Qualche altro documento è possibile rintracciarlo negli archivi di tutto il mondo. Migliore successo ebbe invece, come vedremo, l'opera di ricostruzione.
Intanto malgrado gli impegni di Carlo V e del papa di riportare le Eolie alla normalità, queste erano fatto spesso oggetto delle mire dei pirati saraceni. La fama infatti del sacco del Barbarossa aveva attirato l'attenzione di emuli. Si distinse fra gli altri il corsaro Dragut che era stato uno dei luogotenenti del Barbarossa e che alle nostre isole doveva essersi, in qualche modo affezionato. Varie volte Dragut operò nelle Eolie tanto che un quartiere di Panarea è rimasto intestato a suo nome.
L'autodifesa dei Liparesi
Dobbiamo dire che nel corso degli anni i liparesi andarono facendosi per mare più abili e agguerriti tanto da non avere più paura dei pirati ma anzi prendendo ad affrontarli direttamente.
“Il nome di Lipari – commenta Zagami – tornò , come nei tempi antichi, ad essere temuto sul mare e ben presto i Turchi cominciarono ad astenersi dall'avvicinarsi alle isole Eolie ed a farsi vedere nel mare del Tirreno”[4].


A sinistra don Giovanni d'Austria e a destra una scena della battaglia di Lepanto
Comunque anche l'epoca dei pirati barbareschi volgeva al termine. Nel 1565, nel tentativo di occupare Malta, Dragut trovò la morte. Ancora qualche anno e il 7 ottobre 1571 una grande armata navale organizzata da Stati cristiani al comando di don Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V, si scontrava nel golfo di Lepanto con l'armata navale turca e dopo un'aspra battaglia riportò la vittoria che doveva distruggere per sempre la potenza marinara ottomana.
[1] Archivo Generale de Simancas, op. cit., legajo 1116, n.30). Fra l’altro il Terranova che si era recato a Lipari con un ingegnere oltre a suggerire al re di aggregare le Eolie al viceregno di Sicilia (“si fossero state unite a questo [ di Sicilia] Regno, per la vicinità se le haveria possuto fre migliore provisione..”), consiglia di realizzare tutto intorno alla rocca una cinta muraria continua e interrotta ed erigere dal lato mare tre torri di buona fattura, collegate da trincee con casematte correnti da torre a torre.(Archivio storico eoliano.it)
[2] P.Campis, op.cit.,pag. 306.
[3] P.Campis, op.cit., pag. 307.
[4] L. Zagami, op.cit., pag. 233; P. Campis, op.cit., pag.312.
Documento: Relazione del marchese di Terranova, presidente del Regno di Sicilia, all’imperatore Carlo V
(Il documento viene pubblicato per gentile concessione del prof. Giuseppe Iacolino ed è tratto dal suo libro “Le Isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite”, vol. IV, in corso di preparazione. Il Marchese di Terranova visitò le Eolie subito dopo la "ruina").
Con la caduta di Lipari. La deportazione di tante creature e la selvaggia distruzione della città, il viceré di Napoli don Pedro de Toledo accusava l’ennesima gravissima umiliazione che veniva ad aggiungersi all’amara consapevolezza del suo stato di impotenza. Meno umiliato ma più preoccupato ed inquieto era il presidente del Regno di Sicilia don Giovanni di Aragona e Tagliavia, marchese di Terranova. Questi, mentre il Barbarossa si andava avvicinando al basso Tirreno, temendo brutte sorprese nelle coste del triangolo peloritano, si era trasferito a Messina nel cui canale di lì a poco sarebbe apparsa la grande flotta nemica.
Da Messina il marchese di Terranova ebbe agio di seguire le manovre e gli spostamenti dell’armata e di venire informato di nuove scorrerie dei turchi nell’entroterra calabro. Di quei frenetici giorni egli inviò al re di Spagna e imperatore Carlo V una lunga e circostanziata relazione della quale amiamo riportare i passi che riguardano la nostra storia:
Lettera del 19 luglio 1544
“Sacra Cesarea et Catholica Maestà, Havendo per altre mie scritto a V.M.tà quanto è occorso, per questa sarà avvisata come l’armata turchesca, doppo la presa de Lipari essendo intrata in Faro et giunta alla Cattona, fecero intendere volere intertenerse per far riscatto delle anime prese, et che andasse chi volesse che li davano salvo condotto, dove hanno accordati molti et riscattato buon numero tanto de’ Liparotti come de Ischia. La matina di XIIIJ del presente [mese di luglio]in Callabria posero in terra da 600 turchi et corsero tra terra otto o dieci miglia, et presero da ottocento anime et ne amazzaro da mille et cinquicento…
Per relatione di alcuni d’essa armata, quello [che]se intende sarà con la presente il summario per informatione di V.M.tà; Lipari è de importanza per essere luoco forte et porto tanto vicino a questi doi Regni [di Sicilia e di Napoli], et si non si habita, sarà gran commodità de’ corsali; del che si ne causerà gran disturbo alla negociacione oltre che non potranno stare in tutta la costa di qua [cioè da Messina] a Palermo, né in la costa di Callabria, et molto più importa a questo Regno per essere piùvicina et al passo del tratto di questa Città a Palermo et delle navi che vengono di ponente. Queste Isole…,si fossero state unite a questo Regno, per la vicinità se le haveria possuto fare migliore previsione…
A XVJ del presente [mese di luglio]fu preso dalle guardie uno di Talamone venuto qui per riscattare di quelli del Sanese, il quale veniva dall’armata, et le ritrovarono un plico de lettere dal Priore di Capua che andavano a Roma; et quelle apperte, vi sonno trovate lettere di Polin per il Re di Francia et per lo Ambasciatore suo a Roma, et altri le quali con questa mando a V. M.tà…La matina seguente si partirono le quaranta galere et le navi; heri, che furon XVIIJ, si partì Barbarossa con il resto dell’armata costeggiando Callabria al camino di Levante. Questa mattina è partito Giannettino seguendo il camino dell’armata. Si son fatti riscatti di alcune anime di quelli de Ischia e di quelli de Lipari. Forse poche….”.
(NOTA – Archivio Generale de Simancas, Legajo 1116, n.38)
Ai primi di settembre il presidente del Regno, unitamente alla sua corte, ritornò a Palermo, e si servì di alcune galee della religione, di quelle, cioè, che erano in dotazione a certe comunità francescane dedite a procurare il riscatto di cristiani caduti in schiavitù. Durante il viaggio, il Terranova volle eseguire sopralluoghi a Milazzo, a Lipari e a Patti. A rigore, non sarebbe spettato a lui visitare Lipari che era una dipendenza del viceregno di Napoli; ma decise di venirci ugualmente a motivo della rilevanza strategica dell’arcipelago nei riguardi anche della costa settentrionale della Sicilia, oltre che di quella occidentale di Calabria. Di ciò che osservò, delle disposizioni che diede e dei suggerimenti che propose il marchese di Terranova spedì a Carlo V una breve relazione che è dell’8 settembre 1544. In essa si sostiene che Città Alta di Lipari, benché avesse una muraglia tutta di ‘pietra e terra’ e per giunta discontinua, non poteva cadere in potere del nemico anche quando questo la avesse ‘battuta’ con l’artiglieria per un mese intero. E’ vero, scrive il Terranova, che il Barbarossa ‘più facile l’haveria preso per altra parte’ cioè dal lato di tramontana, che per varie ragioni avrebbe potuto offrire agli assedianti un notevolissimo vantaggio. Sennonché l’ammiraglio preferì non spostare le artiglierie; era sicuro, del resto, che prima o poi i Liparoti, stretti dalla fame e dalla sete, avrebbero ceduto. Queste constatazioni furono per il Terranova una ‘làstima’, un motivo di rammarico e di rabbia. Il suo suggerimento? Eccolo: far condurre una cinta muraria continua e ininterrotta ed erigere sul lato mare tre alte torri, e di buona fattura, collegate da ‘traverse’ o robusti baluardi correnti tra torre e torre. Qui il documento:
Lettera 8 settembre 1544.
“Sacra Cesarea et Catholica Maestà,
Da Messina scrissi a V.M.tà dandole ragione di quanto era occorso et convenia al servitio di V. M.tà, così de ché partiva con questa Regia Coete per qua…
Havendomi ocorso la commodità delle Galere della religione,con quelle partettj [per]Melazzo dove reconoscettj il bisogno e lassai ordine che s’attendesse a continuar quella fabrica et fortification come parse essere bisogno. Dilà me parse [bene],con la comodità delle Galere, voler vedere Lipari portando con me l’ingegniero Ferramolino. Et intanto in quelle Isole la notte trovammo una galeotta de’ Turchi, la qual présimo. La mattina dopo sbarchai in Lipari dove mai ero stato. Per un conto mi parse [giusto] veddere quel luogho per darne raggione a V.M.tà; dall’altra parte [da Tramontana]me parse gran làstima veddere un sì bel luogo di quella fortezza; e con tutta la batteria che fecero, si bene havessero un mese battuto, non haveriano possuto fare effetto nessuno: tal che,si se havesseno volsuti defendere per quella parte non si posseva pigliare, perché restava la batteria alta due picche, et dalla parte de dentro tenéa una trencera fatta che le donne bastavano defendere; per l’altra parte [da Mezzogiorno]saria stata manco forte et più facile l’haveria preso. Mi parse veddere che Barbarossa sempre pensò che se rendessero: per questo non volle allargasse con l’artellaria da dove disbargò. Viddj quella fortezza di dentro e di fuore, la quale de sito è assai forte, però non tiene nessuno traverso né muraglia che vaglia, perché tutta è di pietra et terra. Fici misurare quello che circonda, lo qual è, per la parte de terra, canne duecento, per la parte del mare canne centocinquanta che fan tricento cinquanta canne in tutto. Vi bisognaria tre Torrioni; per far traverse bisogneria di nuovo murare tutte le mura; lo quale, e fatto il conto per Ferramolin et altri per lacommodità dela pietra che vi è a tratto con venticinque millia scudi se farria quella fortification complitamente e tal che sarrìa inespugnabile. La importanza di quel luogho per l’uno e l’altro Regno – e più per questo che per gli altri – V. M.tà l’haverà inteso, e de adesso sene sente travaglio de’ corsali, ultra che vi è un porto di cento galere che dicono Vulcano, un miglio discosto XXV millia scudj. M’ha parso [bene] darne particular raggione a V.M.tà.
Da Lipari venni a Patti sì per veddere e dare ordine che quella terra se reparasse, perché con star Lipari dis’habitato, sempre vi sono corsali; quella terra essendo vicina, stariano quelle gente con periculo; trovo che con poco se reparirà, che se assecureranno de corraìe, dove ho lassato don Antonio Brancciforte per capitan d’arme perché attenda con la più prestezza a ditta reparacione; per lo che quella terra prontamente ho fatto che dia scudi dui millia; si mancan, sarà puoco cosa. Vuolsi veddere il danno che recevettero, e trovo che fu poca cosa. Nel che culparo essi per non s’havere governato come li fu ordinato per me si como da poi le fe defendere, che se le escusào che non revettero danno nissuno.
Il Vescovo di Patti me ha fatto instantia che dovesse informarmi deli danni[che]lui e sua Ecclesia hanno ricevuto per l’Armata che fu in quello mare, e trovo che in tutto il danno ricevuto con cento scudi se restora tutto, perché non fecero altro danno che ali Organi della Ecclesia. Il danno fu quello poco ad alcunipovere genti che li brusciaron da sissanta case di poca importanza…”.
(NOTA- Archivio General de Simancas, Legajo 1116, n°38).Archivio storico eoliano.it
Alcuni interrogativi sulla vicenda: quanti erano gli abitanti? Quanti i deportati? Ci fu tradimento e da parte chi?
Ipotesi sui deportati
Partito il Barbarossa lascia dietro di sé devastazione, morte e le rovine ancora fumanti della città alta. Una serie di domande “difficili” che ci si pone è cercare di valutare quanti abitanti avesse Lipari prima della “ruina”, quanti furono i deportati, quanto furono quelli sfuggiti alla deportazione ed alla morte e - nascosti e dispersi per le campagne - rimangono per qualche tempo timorosi di riaffacciarsi in città per visitare i ruderi dei monumenti e delle case e piangere sui morti, quanti erano, infine, quelli che tornarono dopo la tragedia o perché erano fuggiti prima dell’arrivo dei turchi trasferendosi a Milazzo o in altre città della costa, o perché tornarono dalla deportazione, qualcuno subito, qualcuno dopo molti anni .
Cominciamo dai deportati per i quali esistono, come abbiamo visto, alcune cifre anche se fra loro un po’ discordanti. Maurando parla di 10 mila fra quelli che erano entro le mura e quelli che furono scovati( 1000) nelle campagne. Di novemila cittadini parla De Simone, di ottomila il Campis. La cronaca cappuccina conferma Maurando e dice che furono catturate da nove a diecimila persone.
Giuseppe Restifo[1] ritiene esagerate le cifre fornite dai testimoni dell’epoca, giacché come è tipico nelle catastrofi i resoconti dei testimoni tendono ad enfatizzare. A suo avviso Lipari poteva contare allora, al massimo, 4660 persone compreso quelle che moriranno nello scontro e quelle che riusciranno a fuggire. Ma questo conto si basa soprattutto sulle notizie che da il Campis – e che anche noi abbiamo riportato – dell'organizzazione della città in quartieri con comandanti e milizie volontarie. Infatti il Campis dice che la città fortificata fu divisa in sei quartieri e ad ognuno di questi furono assegnati due comandanti e centosessanta uomini in armi. In tutto 960 uomini abili al combattimento e cioè, secondo la norma del tempo, fra i 18 ed i 60 anni. Se si prende come base, suggerisce Restifo, il censimento del 1610, questa classe rappresenterebbe il 41,2% della popolazione maschile totale. La totalità dell’universo maschile a Lipari nel 1544 sarebbe stato cioè di 2330 maschi. Sempre basandosi sul censimento del 1610 siccome i maschi rappresentano il 53% della popolazione totale, la popolazione di Lipari sarebbe stata di 4396 abitanti; tutt’al più 4660 se si vogliono riportare le donne al 50% della popolazione totale. Ecco come Restifo ricava la sua cifra.
Pur apprezzando il ragionamento proposto vorremmo forse osservare che i dati del Campis si riferiscono alla situazione nella città alla vigilia dell’arrivo del Barbarossa e riguardavano gli abitanti abituali del castello. Ma quando il pericolo diventò incombente e si delinearono all’orizzonte le navi saracene, allora si dovette verificare una corsa dal borgo e dalle campagne a cercare rifugio nella rocca fortificata. Quanti furono queste persone che si rifugiarono nelle case di amici e parenti o si accamparono nella cattedrale ed in ogni buco o magazzino, o anche all’aperto visto che era luglio e quindi il clima favorevole? Non lo sapremo mai, ma non è impensabile che il numero raddoppiasse rispetto agli abitanti che abitualmente risiedevano al castello.
Quanti nativi scamparono alla "ruina"?
Un secondo problema è quanti furono i deportati riscattati prima della partenza decisiva per Costantinopoli. Nella tappa che la nave fece a Messina o a Catona in Calabria, come dice il Maurando, ci furono sicuramente alcuni riscattati a cominciare dal Camagna e dai suoi famigliari. Ma quanti furono? La versione del Campis che sostiene che il Barbarossa fosse ben contendo di liberarsi da parte del suo carico a prezzo conveniente perché temeva che il sovraffollamento poteva provocare ribellioni e difficoltà nel viaggio, si scontra contro quella di p.Bonaventura che invece parla di trattative che non sono andate a buon fine perché mentre i messinesi temporeggiavano perché speravano che Ariadeno venisse a più miti consigli, questo levò le tende e parti. Il francese Maurando sa che le trattative erano aperte ma non sa come andarono a finire perché le navi di Francesco I partirono prima di quelle turche. Comunque si dovette trattare al massimo di poche centinaia non certo di migliaia.
La maggior parte dei prigionieri navigarono verso Costantinopoli., affrontando un viaggio carico di sofferenze non minori di quelle patite sino ad allora. “Condizioni inumane” le definisce Angelo Raffa[2] quelle che dovettero affrontare. L’affollamento e le conseguenti condizioni igieniche e forse anche la mancanza di un vitto adeguato provocarono molte malattie e molte morti[3]. Una testimonianza resa da Bartholo Boe - che era fra i deportati e poi riuscì a riscattarsi - dice che degli schiavi presi a Lipari ed in altri luoghi, durante il viaggio, ne sono morti assai e soprattutto ragazzi per “li mali patimenti” tanto che il Barbarossa arrivato a Lepanto ordinò che si vendessero subito quelli malati, fra cui c’era appunto Boe che venne riscattato per 20 ducati da alcuni liparoti rinnegati che lì si trovavano[4].
Ancora, quanti furono i liparesi che rimasero sull’isola nascosti e che erano scampati al sacco? Il Presidente del Regno di Sicilia don Giovanni d'Aragona marchese di Terranova, ai primi di settembre dello stesso 1544, tornando a Palermo, volle eseguire sopralluoghi a Milazzo, Lipari e Patti. Visitò anche Lipari sebbene non avesse competenza su questo territorio giacchè le isole dipendevano dal vice regno di Napoli. Anche se erano passati cinquanta giorni dall'11 luglio la trovò completamente disabitata salvo una galeotta dei Turchi che lì stazionava e che subito fecero prigioniera. Non parlò di case distrutte – come fece per Patti - perché probabilmente lo erano tutte e si soffermò a dare indicazioni per il restauro della cinta muraria[5].
Quindi i sopravvissuti, ancora a cinquanta giorni, dai fatti si guardavano bene dal mettersi in mostra visto che la zona continuava ad essere battuta da navigli saraceni. Comunque doveva trattarsi di poche centinaia visto che gli uomini del Barbarossa prima di partire avevano battuto meticolosamente l’isola - per due giorni, secondo De Simone, per otto giorni secondo, p.Bonaventura - proprio alla loro ricerca.
Col tempo però Lipari riprese ad essere abitata. Chi si era rifugiato in campagna tornò nella città se non nel borgo, tornarono anche a Lipari chi era fuggito prima dell’arrivo dei saraceni a Milazzo e sulla costa siciliana, chi era stato riscattato a Messina o a Catona. Crediamo che siano stati, in tutto, un 700-800 persone, certo meno di un migliaio. Via via nel tempo tornò anche qualche deportato che si era riscattato o a Lepanto, come abbiamo detto, o a Costantinopoli[6]. A questo nucleo storico di liparesi si aggiungono altri immigrati che vengono a ripopolare l’isola.
“A Lipari, dopo il sacco del 1544 e per tutta la seconda metà del '500. - osserva Giuseppe Restifo – si crea una sorta di Far West compensatore; giungono molti immigrati attratti dai privilegi accordati dall'Università, dalle esenzioni fiscali e penali, dalle opportunità che l'economia delle Isole Eolie può offrire”[7].
L’ipotesi del tradimento
L’interrogativo più intrigante che all’epoca si posero i contemporanei e non solo a Lipari o in Sicilia, fu il sospetto del tradimento. Abbiamo già visto come molti sospetti si puntarono su Jacopo Camagna e come questi subisse anche un processo dal quale uscì assolto. Ma il vicerè di Napoli, don Pedro de Toledo dichiara che si sa chi sono i colpevoli della resa di Lipari per cui comanda che si incarcerino e venga data una punizione esemplare. Giannettino Doria riferendosi alle trattative fra Ariadeno e maggior enti di Lipari parla di cinque successivi incontri, prima con delegazioni di quattro cittadini, poi di due ( Comito e Camagna?). Dalle sue parole si capisce che la responsabilità dell'andamento della trattativa e della resa finale non fu di uno solo ma collettiva, dei notabili, che dopo l'ultimo abboccamento con l'assediante diedero ad intendere che c’era una possibilità di salvezza per tutti. Su questa base si sarebbe formato il consenso generale alla resa.
Fra coloro che si sono occupati della vicenda, due storici che probabilmente attinsero alle stesse fonti – il Campis ed il Pirri – sembrano giungere a conclusioni diverse. Decisamente innocentista il Campis, mentre il Pirri, ricapitolando i tre capi di accusa nei confronti di Jacopo Camagna - l’amicizia con il Barbarossa, gli abboccamenti reiterati e senza osservatori col nemico, l’esenzione che aveva ottenuta per se e i suoi parenti – sembra avallare il dubbio.
Chi era il Camagna? Sicuramente una delle persone più facoltose ed in vista della Lipari del tempo[8]. Proprietario terriero giacchè ancora nel XVII secolo vi era una piana ,nella zona di Balestrieri e Munciarda, che si chiamava “contrada di Camagna” ed anche armatore e navigatore con diverse imbarcazioni che operavano su un buon tratto di Marina lunga che si chiamava appunto “Plaia di Camagna”. I suoi commerci lo portavano spesso lontano da Lipari fino nelle terre più lontane, come Costantinopoli, dove pure, come abbiamo visto, arrivavano i prodotti delle Eolie. Nulla di strano che in questi viaggi sia venuto spesso a contatto con Ariadeno che appunto a Costantinopoli aveva residenza e probabilmente era anche stato suo cliente. Col Barbarossa aveva acquisito una certa familiarità, né conosceva la furbizia, la spietatezza ma anche l’attenzione a concludere dei buoni affari. Così quando a Lipari si seppe che sarebbe arrivata l’armata del Barbarossa, non è improbabile che Jacopo abbia parlato di lui agli altri maggiorenti nelle giornate e serate di apprensione e lunghe discussioni in cui Lipari si apprestava allo scontro.
Un sospettato: Jacopo Camagna
“Lo conosco bene – avrà detto -, l’ho incontrato diverse volte, ho fatto diversi affari con lui. E’ un uomo duro e risoluto ma anche una persona con cui si può parlare. Non è un mostro, ve l’assicuro. Anzi, per molti versi è anche una persona gioviale”.
Questo avrà detto Jacopo. Non certo che era suo amico. E probabilmente perché lo conosceva e quindi poteva essere avvantaggiato nella trattativa è stato scelto dal Capitano Governatore e dai giurati, nella fase più drammatica, la sera del 9 luglio, nel momento più cruciale, quando la delegazione che aveva trattato fino ad allora gettò la spugna perché l’interlocutore non mostrava spiragli di umana comprensione. Così lo andarono a trovare sulla sua postazione quella che dalla Porta Falsa andava sino a Santa Maria delle Grazie, i bastioni più esposti ai colpi di cannone. Ed era lì malgrado avesse una brutta sciatica che lo tormentava. Dice infatti il Campis: “Era il Camagna gentiluomo di molta stima appresso tutti e, come già avanzato in età, haveva buona pratica delle cose e prudenza nel maneggio degli affari. Lo pregarono tutti l’Officiali e tutto il popolo d’addossarsi la cura di ridurre Barbarossa a qualche ragionevole conventione… Di mala voglia abracciò il Camagna l’assunto inpostoli, sì per le sue indisposizioni come pur anco per dover trattare un negotio che nella riuscita non poteva mai essere approvato egualmente da tutti, non essendovi cosa di magiore difficoltà e meno accertata che pretendere di sodisfare al populo”[9]Ma, alla fine acconsentì.
Durante la trattativa, a sentire il Campis, è Ariadeno che fa la proposta di esentare dalla schiavitù venti famiglie, “il che sempre ho praticato in prendere alcuna terra per forza” . Camagna e Comito rilanciano e cercano di ampliare l’offerta e Barbarossa sembra accettare. Ma è ancora un’offerta limitata, selettiva, che riguardava circa 200 persone.
L’idea che tramuta la conoscenza di Camagna col Barbarossa in amicizia, supponendo addirittura una complicità a danno dei concittadini, sarà maturata nella mente di molti liparesi a cominciare dal 10 luglio quando Jacopo torna con questa proposta che non può non scontentare i più. Ed infatti la reazione è quella che si aspettava. “Et infuriati proruppevano in gravi doglianze et improperi contro quelli che havevano trattato con Barbarossa, ma singolarmente contro Japoco Camagna” . Perciò questi si chiude in casa e rifiuta di tornare a parlamentare. Ci andrà invece il Comito che torna dicendo di aver strappato al Barbarossa la promessa che esenterà tutti purchè ognuno paghi venti scudi. Quindi gli abboccamenti del Camagna col Babarossa, a dire del Campis, non furono reiterati, ma uno solo e insieme al Comito. Quello che c’è da chiedersi invece e se andò veramente il Comito al secondo incontro col Barbarossa. Il Campis è dubbioso ed infatti dice: “andò o finse d’andare”. Comunque la gente gli crede e si calma.
Diverso è il racconto del Maurando. Il francese segue il racconto del Campis sino all’accordo con il Camarga ed il Comito che riassume così:”li Liparoti darebero la cità con tutto quello che sarebe dentro, salvo 70 case, le qualle sarebbero salve con tuti li homini et done, puti e putine, et tutta la roba che sarebe trovato dentro”. Respinto l’accordo dai cittadini, questi mandarono altri ambasciatori che proposero la “resa a discrezione” cioè la resa senza condizioni, mettendosi nelle mani del conquistatore. Certo i liparesi vengono messi tutti sullo stesso piano ma, in questa versione, non c’è alcuna promessa di esenzione dalla schiavitù né per poche famiglie, né tantomeno per tutti.
Uno dei punti più controversi della “ruina” è proprio questo, su che cosa si sarebbe formato il consenso alla resa e se a questo proposito alla gente fu detto proprio tutto o qualcosa fu nascosta. Vediamo di ricapitolare. Il Campis chiude con l’assicurazione del Comito che Barbarossa farebbe salve oltre le 26 famiglie, più 50 uomini con le mogli, più gli eccleasiastici e gli ultra sessantenni - che già aveva concesso al Camagna - anche tutti coloro che avrebbero pagato 20 scudi; il Maurando sostiene invece che l’ultimo accordo sarebbe stato la resa a discrezione; De Simone è sulla posizione del Campis solo che invece di 26 famiglie più cinquanta, parla di 60 casate; il Pirri parla di resa della città lasciando andare 60 cittadini con le loro robe; infine p. Bonaventura parla di tradimento del Camagna che avrebbe aperto le porte al nemico in cambio della salvezza per se i suoi parenti e la sua roba.
La responsabilità colletiva dei notabili
Angelo Raffa[10], invece, che ha avuto modo di consultare l’Archivio di Simancas[11]. fa sua la versione dell’accordo che fornisce Giannettino Doria e che da la responsabilità del tradimento, non ad uno solo, ma ai notabili che dopo l’ultimo abboccamento con l’assediante fecero credere al popolo che tutti si sarebbero salvati grazie al patrimonio delle 26 famiglie più ricche che avrebbe rappresentato il riscatto per tutti. Come si vede una versione dell’accordo inedita che non emerge affatto dai racconti che abbiamo analizzato.
Il giorno dopo, cioè l’11 di luglio, il Barbarossa – che certamente ha in mente solo la vendetta per l’umiliazione subita di un assedio che assolutamente non aveva messo in conto - finge di muoversi nella direzione dell’esenzione per le sole famiglie benestanti trasferendo i mobili di queste nella casa del Camagna. In realtà mette al sicuro il bottino più ricco, che farà trasferire dopo sulle galee, prima di dare il via libera al saccheggio. A questo punto getta la maschera e dà il via libera ai suoi uomini per saccheggiare, distruggere, incendiare. Egli sa che non potrà fare arrivare a Costantinopoli tutte quelle ottomila persone, ma deve sanare il suo orgoglio colpito. E non ha pietà per nessuno, nemmeno per il Camagna che permetterà che sia riscattato ma solo a Messina insieme ad altri eoliani vecchi ed inabili al lavoro. Jacopo con la moglie Minichella torneranno ad abitare a Lipari dove moriranno, il primo probabilmente nel 1563, la seconda nel 1581[12].
Ci fu tradimento? Quello che è certo – osserva Raffa – è che alcuni cittadini furono subito riscattati, altri lo furono in seguito, moltissimi non tornarono mai più. Ciò significa che la promessa fatta dai notabili ai concittadini non venne mantenuta. “ Il vero tradimento consistette – scrive Raffa – nel far credere l'incredibile agli ingenui popolani, nel garantirsi la salvezza presente con la promessa a tutti d'una salvezza futura”[13]. Quindi avrebbe ragione Giannettino Doria mentre la dichiarazione di don Pedro da Toledo sembra avere piuttosto il senso di un alibi per chi avrebbe dovuto difendere l’isola e non fece nulla perché era stato deciso che l’isola dovesse essere una vittima sacrificale. Per cui parla di tradimento per distogliere l’attenzione dalle responsabilità politiche del governo ma lascerà nel vago i colpevoli[14].
[1] G.Restivo, Un drammatico sradicamento e un convulse ripopolamento. Lipari dopo il 1544, in Atlante dei beni etno-antropologici eoliani, (a cura di Sergio Todesco ) , Messina 1955, pag. 46-59.
[2] A.Raffa, op.cit., pag.93.
[3] “ Si dice che fu così numerosa la massa delle persone d’ogni ceto, che stavano sulla flotta, che , lungo il percorso della navigazione diretta a Costantinopoli, parecchie salme di prigionieri, stremati dalla fame, dalla sete e dall’afflizione ( fittamente stipati com’erano nel fondo delle navi in mezzo ai loro stessi escrementi) quasi ogni ora venivano gettati in mare.”Paolo Govio nel suo Historiarum sui temporis, libri XLV, che giungono fino al 1547, nell’ultimo libro parla della caduta di Lipari (pp.585-6). In G. Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Vol. IV, in corso di preparazione. Govio parla nella sua Historia di settemila deportati ed attribuisce il tradimento ad un certo Nicolò, “uno dei cittadini di spicco e uomo pavido” di cui lo stesso Campis afferma che di questo nome “non c’è mentione”(op.cit., pag. 306).
[4] A. Raffa, op.cit., pag. 105 nota n. 16.
[5] Archivio General de Simancas, Legajo 1116, n.38. Informazione fornitaci dal prof. Giuseppe Iacolino proveniente dal IV volume delle “Isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite”, ancora in corso di preparazione. Comunque, visto il ritardo delle pubblicazione, il prof. Iacolino ha consentito a pubblicare, su questo sito, nella Documentazione del capitolo, un estratto della relazione riguardante le Eolie e dintorni (v. Documentazione),
[6] L.Zagami, op.cit., riprende un episodio ricordato da Girolamo Di Marzo-Ferro in una nota della storia di Maurolico, Storia di Sicilia, 1849, lib. VI, pag. 360 e riferito al 1545. Un bastimento viaggiando da Scio ( l’isola di Chios ( ?) dinnanzi alla Turchia) verso Messina fu spinta dalla tempesta su una spiaggia delle Puglie. Oltre a tessuti preziosi questo naviglio aveva a bordo 250 passeggeri fra liparesi e calabresi che avevano riscattato la loro libertà e tornavano in patria. A causa del naufragio se ne salvarono solo cinquanta. Sempre a proposito di liparesi tornati dalla prigionia in oriente Giuseppe Restifo ( op.cit.pag. 46-47) parla di alcuni casi ricavati dalla documentazione di Processi civili conservati nell’Archivio Vescovile di Lipari ( vol. I).
[7] G.Restifo, op.cit., pag. 47.
[8] In un elenco delle “famiglie cospicue de’ Gentiluomini di Lipari” che vi erano prima della “ruina” che Giuseppe La Rosa dice di avere letto fra le carte di Cristoforo Cesareo e pubblica nel suo “Pyrologia Topostorigrafica dell’Isole di Lipari”, a cura di Alfredo Adornato, vol. II, pp19-20, Iacopo Camagna è al secondo posto subito dopo “la nobilissima famiglia de Franco”. L’elenco cita 32 famiglie e parecchie di queste sono divise in due o tre rami. Il manoscritto, come dice lo stesso La Rosa, non fa menzione alcuna delle famiglie dei popolani.
[9] P.Campis, op.cit., pag. 301.
[10] Op. cit., pag. 94.
[11] (Lettere al Viceré di Napoli, in Archivo General de Samancas, Papeles de Estado, Corrispondenci y negociacion de Napoles, Virreynato, E- 135/57)
[12] E’ una ipotesi che fa Giuseppe Iacolino nel manoscritto del libro sulla “ruina” non ancora pubblicato, di cui abbiamo fatto cenno, basandosi sui due testamenti. Dalla “Visitatio totus Diocesis Liparensis” del vescovo Francesco Arata, del 1685, Archivio Curia Vescovile di Lipari, foglio 59 v.
[13] A.Raffa, op.cit., pag.93-94 Il Campis infatti chiude con l’assicurazione del Comito che Barbarossa farebbe salve oltre le 26 famiglie, più 50 uomini con le mogli, più gli ecclesiastici e gli ultra sessantenni ( che già aveva concesso al Camagna) anche tutti coloro che avrebbero pagato 20 scudi; il Maurando sostiene invece che l’ultimo accordo sarebbe stato la resa a discrezione; De Simone è sulla posizione del Campis solo che invece di 26 famiglie più cinquanta, parla di 60 casate; il Pirri parla di resa della città lasciando andare 60 cittadini con le loro robe; infine p. Bonaventura parla di tradimento del Camagna che avrebbe aperto le porte al nemico in cambio della salvezza per se i suoi parenti e la sua roba.
[14] Una valutazione delle accuse di tradimento che ripercorrono molte delle nostre osservazioni la compie Giuseppe Iacolino nel suo manoscritto non ancora pubblicato e cioè il già citato quarto libro dell’opera “Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite”.(Archivio storico eoliano.it)
Gli undici giorni di passione di Lipari.
Le fonti della "ruina"

Schizzo di Marina corta del Maurando fatto durante l'attacco del Barbarossa
Sugli undici giorni in cui durò l'attacco a Lipari, prima della sua caduta, abbiamo diverse versioni. Innanzitutto quella di Pietro Campis ed è probabilmente la più importante perché se è vero che egli scrisse il suo Disegno Historico nel 1694, per quanto riguarda la storia della “ruina” utilizzò, come lui stesso dice[1], “un manoscritto di quei tempi conservato appresso Giovanni Cesario Gentiluomo di essa città”e quindi le informazioni che egli riporta non solo sono di un contemporaneo ma di uno che doveva aver vissuto la tragica vicenda dall’interno. In secondo luogo il racconto di Geronimo Maurando che abbiamo già citato e che partecipò alla “ruina” dalla parte di Ariadeno in quanto era cappellano di una galea del re francese Francesco I , anche lui testimonio diretto, partecipe della vicenda ma sullo schieramento opposto. Quindi il poemetto epico di Giovanni Andrea De Simone composto all'indomani della “ruina[2]”, un contemporaneo di Messina[3] che apprese della “ruina” forse da testimoni diretti ma che a questa non ebbe parte . C'è inoltre una “Relazione della fondazione del 26° convento dei P.P. Cappuccini che è quello di Lipari”, un manoscritto, forse del 1683, di frate Bonaventura da Troina che si trova nell'Archivio del Convento dei Cappuccini di Messina che contiene sui fatti una memoria raccolta sul finire del 600, “per relazione dei suoi antecessori” [4].
 Comunque grazie a questi documenti è possibile tracciare il racconto comparato dal 30 giugno, che era un lunedì, fino al 17 luglio[5].
Comunque grazie a questi documenti è possibile tracciare il racconto comparato dal 30 giugno, che era un lunedì, fino al 17 luglio[5].
Il Maurando, oltre a parlarci dello scontro ci dà alcune interessanti informazioni sulle Eolie. Innanzitutto ci parla di Lipari. Questa isola di Lipari – dice - è assai grande, abitata, ed è sede episcopale. La città è fortissima e i borghi grandi. A mio giudizio, prima di essere distrutta dai Turchi, vi erano tra la città e i borghi duemila case.
Di Lipari ci fornisce uno schizzo con in primo piano la rocca del Castello, il borgo della marina di San Giovanni, la piccola altura di Sopra la Terra e della Maddalena dove spicca la Chiesa ed il Convento di San Bartolomeo, una costruzione con un alto campanile. Sul disegno la scritta “Lipari è facta cusì”.
Una stampa con i galeoni di Barnarossa
Di Salina dice che vi sono “bellissime vigne. Non di uva per far vino, ma solo da far zibibi; dove se ne fa una grandissima quantità, ed i mercanti ne portano fino a Costantinopoli” confermando quanto abbiamo detto a proposito dello sfruttamento delle nostre miniere e delle nostre terre collegati con traffici commerciali in tutto il Mediterraneo. Di Stromboli afferma che era la casa di Eolo;” dal fumo che esce dal cratere i paesi delle isole vicine capiscono quali saranno i venti dei prossimi tre giorni; e per questo Eolo è dai poeti detto Dio dei venti” .

Lo schizzo di Maurando che raffigura Stromboli
Infine parla più a lungo di Vulcano dove ha fatto una escursione conclusasi con una scalata al cratere. Vulcano è disabitata e assai grande. “Prima era divisa in due isole, Vulcano e Vulcanello. Al presente sono un'isola perché l'abbondante cenere uscita dalla bocca del cratere ha chiuso il passaggio bloccando il braccio di mare che divideva le due isole e così si è realizzato un bel porto...” Si tratta di una notizia importante, osserva Angelo Raffa, perché alcuni naturalisti hanno sostenuto che questo fenomeno si fosse verificato solo con l’eruzione del 1550.[6]
“Mi è stato riferito da certi Liparoti ,- racconta ancora il prete francese - che delle volte questo monte di Vulcano buttò fuoco in modo così forte ed orribile che arrivò nell'isola di Lipari incendiando un bosco e insidiando col fuoco persino la città che si sentì in gran pericolo. Così tutte le donne di Lipari fecero un voto: che se Dio le avesse guardate da questo pericolo, non avrebbero mai più bevuto vino e sarebbero andate sempre a piedi nudi. E ottenuta la grazia, le donne hanno osservato sempre il voto: non bevono vino e sempre vanno scalze”. Anche di Vulcano Maurando ci lascia uno schizzo nel quale si vedono Vulcano e Vulcanello.

Il disegno di Maurando di Vulcano.
Una descrizione colorita del “castello o città di Lipari” c’è fornita dalla memoria dei cappuccini. Questo castello situato “sopra una petra circondata di muri “ distanti da una parte all’altra “circa d’un tiro di muschetto piccolo” e complessivamnette ampia “due salmate e mezza o tre[7]”. Le strade erano anguste e strette come i nostri corridoi ed alcune addirittura più strette. Dalla parte del mare queste case erano alte “56 piche circa[8]”ed erano a strapiombo “di maniera che gettando alcuna cosa cade dentro al mare”. L’entrata era da una sola parte “et entrandovi bisogna passare per cinque porte, all’ultima delle quali vi è il presidio de’ soldati…”.
Il Campis prima di [9]iniziare il racconto delle giornate di scontro richiama alcuni antefatti. Il vicerè di Napoli ha notizia delle intenzioni di Ariadeno qualche tempo prima, forse addirittura diversi mesi e, informandone i Liparesi, tende a tranquillizzarli: le navi sono molte ma i soldati sono pochi (!?!). I Liparesi decidono di organizzarsi e mandano a Messina Bartolo Comito per procurarsi palle, polveri e micce. Qualcuno propone anche che si mandassero sulla terraferma le donne e i bambini e che a difesa della Città rimanessero i soli abili. Ma la proposta non ebbe seguito[10]. Prevalse l'idea che la gente avrebbe combattuto con più impegno se avesse difeso anche la propria famiglia oltre alla patria.

Pianta del Castello con la divisione in quartieri sotto il comando di due responsabili
Lunedì, 30 giugno
“L'ultimo del mese di giugno comparve a Lipari Ariadeno con 150 galere, alla qual vista si spopolò tutto quel borgo correndo a refugiarsi nella Città Murata colle loro robe” (Campis). Vengono mandati sulla più alta cima di Salina due osservatori, Bartolo Stanca ( Zanca?) e Polverino, i quali ritornati riferiscono alla gente riunita nella piazza della Matrice. I liparesi stringono il patto di solidarietà. Il Capitano disse:
“E’ bisogno chi fazamo prova!
Veniti tutti con l’armi in lin mano;
di iornu e notti nixuno si mova
di la moraglia con lo cori sano,
a tali che si dica per memoria
chi Lipari di Turchi happi vittoria”[12]
A sera l'avanguardia della flotta si vede dispiegata all'altezza di Capistello. Nel corso della notte sopraggiungono le altre navi (De Simone).
“Erano già arrivati i navilli nelli mari di Lipari e dicono le genti del presente, per relazione dei suoi antecessori, che dal Capo delle fiche, che è dell'isola chiamata della Salina, lontana da Lipari dodici miglia, si poteva viaggiare passando da un navilio all'altro per aversi messo et ordinati a filo quasi toccandosi l'un l'altro” (frate Bonaventura).
Martedì 1 luglio
Ariadeno fa sbarcare parte degli uomini e venti pezzi di artiglieria a Portinente. I Liparoti aprono il fuoco, e le galere turchesche, dopo che due restano sommerse, vanno a riparare dietro la punta di Capistello. Durante la notte però i Turchi riescono a mettere in terra, a Portinente l'artiglieria, e a piazzarla nei pressi del convento francescano e della chiesa di S. Bartolomeo alla Maddalena “dove il terreno restava alquanto più alto”. ( Campis[13]).
Dopo che due galere vengono colpite Ariadeno ordina il ritiro delle navi nella rada di San Giorgio, cioè a Portinente e colà fa eseguire dei riti divinatori che si rivelano non propizi. Il rais Dragut, dal canto suo, assicura la vittoria al Barbarossa e, avanzando in salita da San Giorgio, arriva a piazzare 17 pezzi di artiglieria nei pressi della chiesa francescana di San Bartolomeo. (De Simone).
“Il primo del mese di luglio, l'armata al far del giorno [a le doe hore di matina ] giunse tra l'isola di Lipari e di Vulcano, e qui, nel canale, diede fondo. [ e qui trovarono Sala Rais[14] che era giunto con 60 galere e le navi Conterina e Delphina ]...Giunto Sala Rais (capitano dell'avanguardia) all'isola di Lipari, subito discese in terra con le cinque insegne dei Turchi, e si diresse ai borghi della Città ma non vi trovò nessuno, perchè tutti i Liparoti si erano ritirati nel forte. Entrati nel borgo i turchi andarono ad assediare ed attaccare quelli del forte che difendendosi valentissimamente al primo assalto ammazzarono quaranta Turchi. Sentito Ariadeno ( il signor Bassan) da Sala Rais che i Liparoti erano entrati nel forte con animo di resistere e difendersi, la notte seguente fece discendere a terra tre grossi cannoni e colobrine, “in numero pese 16”, che furono piantate accanto al monastero, sul monticello all'inizio del borgo, di rimpetto al forte di Lipari. Piantata la l'artiglieria Ariadeno fece mettere in terra il suo “pavaglione” . Quella notte stessa discese Ariadeno e tutti i turchi che erano in numero di 5550. E appena scesi aprirono il fuoco contro il forte. Ne rimase ferito al ventre uno dei capi turchi.” (Maurando).
Mercoledì 2 luglio
Per alcuni giorni la città di Lipari viene sottoposta ad intenso bombardamento con “grandissimo danno delle muraglie”.(Campis).
 Don Giovanni d'Aragona
Don Giovanni d'Aragona
“Sono in terra sette o ottomila infedeli comandati da Draut. Si dà inizio ad una intensa carica di artiglieria. Vengono sparate non meno di trecento cannonate. I Liparoti rispondono al fuoco. Lo scambio dei colpi prosegue nel corso della notte e per altri giorni ancora. Sempre al due di luglio, martedì, al largo di Messina sopraggiunge Giannettino Doria con trenta galere. Le forze della città si mettono in allarme e si organizzano perché quelle navi sono credute barbaresche. Poi si tributano onori al Doria il quale si consulta col Presidente di Sicilia don Giovanni Aragona, marchese di Torrenova e, insieme con questi, parte per soccorrere Lipari. Ritenendo però di non essere in grado di affrontare l'armata di Ariadeno, i due si ritirano e dislocano i loro contingenti qua e là, lungo la fascia costiera, tra Capo Peloro e Patti, col proposito di impedire ai Turchi l'approvvigionamento di acqua alle fiumare. Milazzo è in agitazione, pronta a difendersi. A Messina si studia ancora di portare aiuto a Lipari, ma l'impresa appare rischiosa. Intanto sui colli San Rizzo gli osservatori recepiscono le segnalazioni di fumo e di fuoco che trasmette l'uomo di Monte Guardia di Lipari. Trenta galeotte turche, allontanatesi da Lipari, accostano ai lidi di Patti per fare rifornimento d'acqua. Sbarcano 400 uomini i quali operano devastazioni nell'abitato della marina. Si comporta da eroe il pattese Coletta Rosio con tre suoi congiunti. ( De Simone)
Il 2 di luglio, continuando l'assedio e la batteria dei Turchi contro quelli di Lipari, dalla città uscirono tre dei capi e vennero da Ariadeno per cercare di patteggiare. Avrebbero dato ad Ariadeno 15 mila ducati d'oro se l'armata se ne andasse via senza fare nessun male agli uomini e senza danneggiare i beni. Ariadeno rispose che sarebbe stato felice di salvare uomini e città ma voleva 30 mila ducati d'oro e 200 bambini e 200 bambine. Altrimenti non sarebbero partiti prima di avere conquistato la città e bruciato e distrutta l'isola. Avendo compreso i Liparoti che Ariadeno aveva più propositi di guerra che di pace, tornarono mesti in città a riferire quanto avevano appreso. Partiti gli ambasciatori Ariadeno fece continuare a tirare cannonate ed archibugiate contro la città (Maurando)
Giovedì 3 luglio
Al fine di scongiurare il peggio, i giurati di Lipari inviarono al Barbarossa quattro messaggeri, Ferrante Russo, Bartolo Comito, Lorenzo Proto e Bartolo Damiani. Barbarossa pretendeva centomila scudi per abbandonerebbe l'isola. I messaggeri ritornarono ed informarono i cittadini che li rinviarono ancora una volta dal grande ammiraglio per proporgli una più ragionevole cifra. Barbarossa però è irremovibile e continua a bombardare l'infelice città. Mentre i Liparoti rappezzano le falle che via via si vanno aprendo nelle muraglie, Barbarossa fa uscire da Capistello il grosso dell'armata e fa sbarcare il resto degli uomini e dell'artiglieria. Oramai i cannoni del Castello sono inutilizzabili e tacciono. Le mura restano “fracassate” in più settori.(Campis).
Barbarossa spedisce al Castello di Lipari due dei suoi cristiani rinnegati con l'incarico di invitare alcuni rappresentanti della città a portarsi a conferire con lui. I Liparoti mandano una delegazione composta da Lorenzo Proto,Comito e Mini (Minico) di Muni. Costoro offrirebbero 20 mila scudi che Barbarossa sprezzante rifiuta. Con altere parole Lorenzo Proto fa intendere al turco che la fortezza di Lipari è inespugnabile.
…”Nui semo dotati
di vettovaglia e bon’artelaria.
Semu più forti che non è Citati
in tuttu Imperio, e sia quali si sia.
Io vi consigliaria che vi ni andati
con vostro honuri per la vostra via,
cie quista fantasia che vui tiniti
con poco honuri vui la rexiriti.”[15]
Barbarossa ribatte con minacce e congeda i tre uomini i quali vanno a relazionare ai cittadini. Con più accanita determinazione riprende il martellamento dell'artiglieria nemica (De Simone).

Edizione francese del 1901 del libro del Maurando
Maurando unifica la cronaca dal 3 al 5 e dice che “mai cessarono i turchi di notte e di giorno di sparare cannonate e archibugiate contro la città e soprattutto contro i bastioni che si trovavano proprio di fronte al monastero dove stava l'artiglieria dei Turchi. Ma proprio la copertura dei bastioni oltre alla città, difendevano gli abitanti, che proprio al riparo dei bastioni i Liparoti sparavano sui Turchi e ne ammazzavano parecchi.
Dalla cronaca dei cappuccini apprendiamo che il bombardamento fatto dal Monastero non bastò ad aprire brecce utili ad un eventuale assalto delle truppe perchè i muri sono terapianati e “anco di questa parte segue la pietra soda”. Così Barbarossa ordinò che l'artiglieria si portasse ad altro posto, poco distante, dove oggi c'è la chiesa di San Pietro, e lì si fece spazio gettando alcuni muri per terra. Secondo il Barbarossa quindi la parte più debole delle mura e più facilmente espugnabile era quella occidentale.
Venerdì, sabato, domenica, lunedì 4-5-6- 7 luglio
A prima sera si verifica un'eclisse totale di luna. Tristi presagi. I bombardamenti proseguono pesantissimi nei giorni successivi. Il bastione meridionale della città crolla. Si hanno i primi corpo a corpo tra Liparoti e Turchi sul filo della breccia. Sulle abitazioni continua a cadere la pioggia dei proiettili. Gli ottomila assediati resistono oltre ogni umana possibilità. Di notte, calandosi per le scarpate, mettono in salvo alcuni bambini e donne.(De Simone).
Il giorno 5 le galere turche andarono per cercare acqua nell'isola di Salina. Il sesto del mese, continuando i Turchi ad attaccare e colpire la città di Lipari, quelli da dentro tirarono un colpo di cannone che ammazzò 18 Turchi e uno spagnolo rinnegato, ingegnere di Ariadeno, fu ferito in modo grave da un sasso alla testa . Il 7 si continuò tanto dai Turchi che dai Liparoti a sparare e tirare cannonate. La notte seguente, verso le tre, fuggirono 20 uomini dalla città e di questi ne furono presi 4, i quali condotti da Ariadeno dissero che se i turchi avessero continuato a sparare sulla città come facevano, la città si sarebbe arresa a discrezione, perchè i capi ed i governatori di questa erano fra loro divisi. Inteso ciò, Ariadeno fece mettere questi Liparoti alla catena e comandò di intensificare il tiro contro la città (Maurando)..
Martedì 8 luglio
Al fine di ottenere una tregua i Liparoti inviano allo stato maggiore nemico tre gentiluomini: Bartolo Comito, Lorenzo Proto e Jacopello Marazzita. Barbarossa rimane sordo ad ogni loro richiesta e dà ordine di continuare a fare fuoco contro la città. ( Campis).
L'8 si continuò a battere la città e sparare, e quelli da dentro a difendersi. E la notte seguente,verso le tre o le quattro, Giannettino Doria con 30 galere viene all'isola di Vulcano dalla parte di Milazzo. Ma saputo che le nostre galere (cioè del Barbarossa) lo andavano cercando, se ne fugge (Maurando).
Mercoledì, 9 luglio
“Per mitigari un tanto atroci mali” Bartolo Comito e Jacopo Camagna, senza prendere accordi con alcuno, si recano dal Barbarossa e lo supplicano di desistere dall'assedio. Il feroce turco respinge le loro preghiere. Gli oratori replicano che, affidandosi alla di lui clemenza, Lipari è disposta ad arrendersi. Barbarossa accenna a voler fare qualche concessione. A questo punto il Comito e il Camagna scongiurano il corsaro che conservi almeno sessanta casate liparesi ( ogni casata comprende più famiglie), delle quali gli presentano una lista. Chiedono inoltre che non vengano molestati uomini e donne di età superiore a 60 anni, il clero secolare e quello regolare, dandosi facoltà, a quanti lo volessero, di riscattarsi per 20 scudi a testa.
Rispusi Barbarussa:”Orsù, sia fattu
comu voliti.Resto per contenti”
Così senza scriptura né contrattu
Lipari fu venduto con le genti.
Poi a conclusioni di lu fatti
-comu di supra, e dico ciaramenti -,
lu Mércuri e li novi di Iugnettu
conclusu fu quistu dogliusu effettu.
Così conclude il poeta, Camagna i suoi concittadini, li “vendio senza denari”[16].
Lipari è ormai posta in ginocchio, tant'è che Milazzo non coglie più segnalazioni dall'isola. I due rientrano in città e riferiscono alla cerchia del loro parentado. Poi adunano il popolo in assemblea. Camagna sostiene che non c'è altra possibile alternativa al disastro totale se non quella già prospettata al Barbarossa .
Audendu quistu, assai si contentavano
Timendu di chiù peiu non aviri,
e multi respondendu replicavano
dicennu: “Megliu volimu moriri”.
Li donni tutti quanti lacrimavanu;
con li figlioli in brazzo, con sospiri,
dicianu:”O figli, quali crudu cori
vi darìa in manu di Turchi e di Mori?”[17].
Nell'animo delle donne affiorano funesti presentimenti. Rabbia negli uomini e pianto di fanciulli. Nel clima di generale smarrimento, Comito vorrebbe affrettarsi dal Barbarossa per ratificare gli accordi, ma cerca ancora di convincere il popolo che non è possibile trovare diversa soluzione. Le donne ritengono accettabili i patti, ma sono molti i cittadini i quali sostengono che arrendersi per paura è disonorevole. Le polemiche si vanno attenuando. Infine, quando la maggioranza appare concorde, Comito e Camagna tornano dal Barbarossa.(De Simone).
Mentre De Simone descrive lo strazio delle donne liparesi che pensano ai figli da consegnare ai turchi e ai mori, Maurando esalta il suo “signor Bausan” cioè il Barbarossa.
Il giorno nove si continua a combattere e sparare tanto da i Turchi che dai Liparoti. Ariadeno, non mai sazio di compiere opere di carità, nonostante che a porto d'Ercole avesse riscattato parecchi cristiani, a Vulcano riscattò un napoletano con la sua donna e un figliolo: ancora riscattò tre bambine da 12 fino a 14 anni e un bimbo di 4, e donò parecchi denari in elemosina a certi poveri cristiani per potersene tornare alla loro patria.(Maurando).
Giovedì, 10 luglio
La cronaca che Pietro Campis fa del giorno 10 praticamente ripercorre, grosso modo, il racconto che De Simone ha collocato nella giornata del 9 con alcune differenze sulla conclusione dell’accordo col Barbarossa.. Il capitano d'armi e i giurati di Lipari, constatando la situazione disperata del paese, decidono di inviare al Barbarossa, l'anziano Jacopo Camagna – uomo pieno di acciacchi, ma di “buona pratica delle cose e prudenza nel maneggio degli affari”, perchè insieme con Bartolo Comito, raggiunga un “qualche ragionevole conventione “ col nemico onde non “ restare tutti morti per mano de' Turchi”. Al tiranno il Camagna dichiara : “siamo pronti ad aprirvi le porte quando voi promettiate libertà a quanti siamo in quel piccolo recinto di mura”. Dal canto suo il Barbarossa pretende avere tutto e tutti . “Troppo tardi veniste – disse al Camagna – non è più tempo di clemenza. Dove apprendeste offerirmi quel che è già mio. Tutti sarete miei schiavi![18]”. Comunque – come ha sempre fatto, dice, nelle sue conquiste – “sarà atto di gran pietà se venti soli famiglie farò esenti dalla schiavitudine”. Il Camagna e il Comito scongiurano che le famiglie da salvare siano non 20, ma 26, più cinquanta uomini con le loro mogli, più tutti gli ecclesiastici secolari e regolari, e tutti i cittadini di età superiore ai 60 anni. Barbarossa acconsente, ma, benché insistentemente pregato, non cessa di martoriare la città con l'assiduo fuoco della sua artiglieria. Alla relazione del Camagna e del Comito i cittadini tumultuano e gridano al tradimento. Devono salvarsi tutti o nessuno, dicono. Si propone, pertanto, di rinviare i due oratori al grande capo per chiedergli che conceda ad ogni singolo cittadino la facoltà di riscattarsi per 20 scudi. Intanto il Camagna, perché è sospettato di voler salvare sé e i suoi parenti, e anche “ per scansare le furie della plebe”, si ritira in casa. Comito, invece, fattosi calare dalle mura ( o sceso attraverso la porta falsa), va ( o finge di andare) a compiere la nuova missione e torna affermando che il Barbarossa ha accettato il nuovo compromesso.( Campis).
Anche il manoscritto di padre Bonaventura riporta alcune righe che devono riferirsi a questo giorno. Righe che raccontano i fatti già descritti da De Simone e da Campis con più succinta crudezza, sposando esplicitamente la tesi del tradimento già adombrata da De Simone. “Vedendosi così crudelmente combattuti, giudicando non potendosi difendere per lungo tempo, uno dei principali della città gli [al Barbarossa] fece a sentire che, perdonando la vita a lui et a suoi parenti, et anco la roba, la mattina seguente gli darìa la chiave della città”. Il Barbarossa acconsente per evitare il rischio della lotta, considerando le perdite subite e giacché in fondo aveva poche speranze di conquistare la città visto “che gagliardamente si difendeva”.
Sempre si continuò a cannonare e sparare tanto dai Turchi che dai Liparoti.(Maurando).
Venerdì, 11 luglio.
 La piazzetta della Maddalena dove avviene l'incontro
La piazzetta della Maddalena dove avviene l'incontro
Con in testa il capitano d'armi, i giurati e gli esponenti del paese, tutto il popolo di Lipari – racconta il Campis - si porta ai piedi di Barbarossa il quale, sempre impenetrabile sotto la sua scorza di arroganza, sta seduto su di un tronetto improvvisato accanto alla Chiesa di San Bartolomeo alla Maddalena. Dopo di aver passato in rassegna uomini, donne e fanciulli, rinvia tutti nella città murata e ad un suo scrivano ordina di prender nota delle ventisei famiglie “delle più cospicue” che non devono essere molestate ( il Campis non fa più menzione delle altre cinquanta).Poi fa l'ingresso in città lo stesso Barbarossa seguito da un immenso stuolo di suoi uomini. Dichiara “franche” le ventisei famiglie, e i loro mobili fa, per cautela, trasportare nella casa del Camagna. Sotto questo suo apparente comportamento di correttezza, egli nasconde nell'intimo l'intenzione di “non perdonare ad alcuno”. Infatti dà ordine di iniziare il saccheggio e l'incendio.” …non solo spogliarono le case, ma a molte di esse posero il fuoco riducendole in mucchi di pietre. Non la perdonarono né pure alle Chiese incendiando la Chiesa di San Bartolomeo vicino a Porto di Gente et incenerendo il nobile Monastero ad esso unito dove soleva mantenersi un buon numero di religiosi di San Francesco dell’Osservanza…Di più messero anco il fuoco alla Chiesa Catredale eretta già con Regia magnificenza dal Conte Rugiero Normanno… tutta fabbricata di vive pietre di smisurata grandezza, che, nondimeno, molto patì dalle fiamme, le quali consumarono e ridussero in cenere tutto il gran suffitto di essa e quanto vi era di legname con danno assai considerabile, oltre l’abrugiamento di tante sacre pitture che rendevano non meno adorno che ricco quel tempio. E perché unito a quello si trovava l’archivio in cui tante pubbliche scritture si conservavano ad eterna memoria sì della Chiesa che della Città di Lipari, il tuto s’incenerì: perdita tanto deplorabile non potrà mai bastantemente piacersi per tutti i secoli d’avenire essendosi in tal modo smarrite memorie di gloria non ordinaria e consumati registri d’opere meravigliose”[19](Campis).
Barbarossa, con le sue numerosissime genti, entra nella città. I suoi intenti sono di distruzione e di morte. I turchi cominciano a saccheggiare le case, a cercar denari, a spogliar le donne, a dissigillare le sepolture nelle chiese e depredare vasi sacri. A spintoni trascinano le genti verso il mare. Scene di strazio. Seduto alle porte della città, Barbarossa assiste alla miserevole sfilata dei prigionieri e si stupisce del gran numero. Altre scene di strazio. Eseguiti i conteggi e la selezione, Barbarossa fa avvisare tutti alle galere. Sono novemila individui. Altre scene di dolore e di crudeltà. Avviene l'imbarco.
“ A l’undici lu misi di Giugnettu
di Venneri fu tuttu quantu quistu,
lu iorno quando con tanto rispettu
per redimiri a nui fu mortu Cristu,
per cui lu Suli, ch’era chiaru e nettu,
si persi havendu tali murtu vistu.
Di tali iornu fu vintu e pigliatu
Lipari afflittu, persu e ruinatu”[20]
( De Simone).
L'11 luglio, facendo Ariadeno più presto del solito tirare le cannonate contro la città di Lipari, alle 8 del mattino, uscirono quattro liparoti responsabili della città ed andarono per trattare. I Liparoti avrebbero data la città con tutto quello che essa possedeva, salvo 70 case, le quali sarebbero state salve con tutti gli uomini e le donne, i bimbi e le bimbe, e tutta la roba de contenevano. Trovato l'accordo gli ambasciatori ritornarono in città e raccontarono al popolo che cosa si era deciso. Il popolo subito si levò ad una voce, e chiese altri ambasciatori proponendo : o tutti liberi o tutti schiavi. Mandati altri ambasciatori essi proposero la resa a discrezione e Ariadeno di buona voglia l'accettò. Così si potè conoscere di quanto male è occasione la differenza e la divisione tra i cittadini. Non solo questa maledetta divisione e parzialità civile è stata la causa della distruzione della città di Roma che era “domina e signora di tutto il mondo” al tempo di Giulio Cesare, di Augusto e di altri Imperatori, ma anche della distruzione tutta l'Italia, e ora di questa povera città di Lipari. Se dentro quella città ci fossero stati 200 soldati insieme con i cittadini non l'armata che noi eravamo, ma il doppio, non ce l'avrebbe fatta a prenderla nemmeno in sei mesi. Perché la città è posta sopra un balzo di rocce tutte intorno così alte come il castello di Antibes dalla parte del mare. E nonostante che per il sito sia fortissima, era anche circondata di bellissimi muri e fortissimi robusti cinque bastioni fatti di pietre e calcina (“et fortissimi beroardi sive bastioni fatti di prede et calsina”).
La resa di Lipari
Arresa che fu la città di Lipari, dopo tante cannonate che queste mura avevano subito, quelli che dentro la città avevano cercato di entrare vi erano riusciti con grande difficoltà perchè restava ancora alta la breccia da cui passare – l'altessa di una bona pica e mezza” - e bisognava salire uno per uno a gattoni e con difficoltà (“et era forsa montar ad uno ad uno in quattro piedi e con difficultà”). La presa di questa fortissima città ha creato ammirazione in tutta la Cristianità ma probabilmente Lipari è caduta per i suoi peccati. “ e il giusto Idio scorrosatto (scoraggiato) manda questi flagelli ne la Chiesia proprio Babilonica, non Cristiana, vindicandose dei soy inimici per li soy innemici” . E dico questo, per come mi è stato riferito da un Marsigliese che abitava a Lipari e lì si era maritato, la cui moglie fu presa quando la città si arrese, “questi Liparoti erano deditissimi al peccato sodomitico, in tanto che se avveseno visto uno bello giovene, per aver piacer del giovene, era[no] contenti che lui usasse con le loro done, era presente il marito”.
Preso che ebbe Ariadeno i Liparoti e la loro città a sua discrezione, fece cessare i bombardamenti e comandò che tutti quelli che erano dentro uscissero e venissero fuori di fronte a lui che stava seduto nel borgo presso la città. E per fare uscire i Liparoti e anche per evitare che i Turchi non cominciassero il saccheggio mandò quattro guardie. Tutti i Liparoti che furono trovati dentro la città furono menati da sua Signoria, e tutti li faceva passare dinnanzi a sé individuando gli uomini e le donne invalidi, e il resto, uomini e donne, bimbe e bimbe, mandò schivi sulle navi e le galere. Certo, il vedere tanti poveri cristiani e maggiormente tanti bimbi e bimbe procurava una grandissima pietà.
Fra le altre crudeltà praticate dai turchi la più grave fu quella accaduta nella chiesa episcopale di Lipari. Qui furono trovati un certo numero di uomini e donne vecchissimi ( a mio giudizio avevano più di cento anni), questi presi, furono subito spogliati e squartati vivi, e questo per prendere il fegato. Chiesi perché usassero una così grande crudeltà a questi poveretti e mi risposero che quel fegato aveva grandi virtù. Usciti fuori da Lipari tutti i cristiani e distribuiti fra le navi e le galere, fu caricata sulle galere anche tutta l'artiglieria trovata. E subito fu messa a sacco e fuoco la misera città e questo avvenne alle quattro dopo mezzo giorno dello stesso giorno. Quindi Ariadeno comandò di fare confluire tutte le galere turche al porto di Lipari mentre le nostre navi ( quelle dei francesi) dovevano tenersi alquanto distanti. Perchè avesse fatto questo, non lo sapemmo. Venuta tutta l'armata al porto di Lipari, Ariadeno si imbarcò con tutta l'artiglieria.
In un'altra parte del suo scritto Maurando parla di Iacopo Camagna e lo definisce “mal Cittadino” perché “ essendo padrone di una nave, e trafficato avendo con salvacondotti, più volte in Levante e in Barbaria, era conosciuto e amico del Barbarossa”.
La versione di p. Bonaventura sul giorno della resa inizia affermando che “la mattina seguente della promessa fece quel traditor della patria trovar le porte aperte. Vi entrò il tiranno incrudelito, la saccheggiò, con dar fuoco ad alcune parti, e fra gl’altre al vescovato, dove si vedono oggi le pietre sopra dell’Archivio liquefatte a modo di vetro squagliato”. Barbarossa, continua p. Bonaventura, fece prigioniera tutta la gente e cioè da nove a dieci mila persone visto che allora Lipari contava sedici o diciasettemila abitanti, Tra gli altri fece anche prigioniero “il traditore con tutti i suoi, e questa fu la paga e premio della promessa e del tradimento”.
Sabato e domenica, 12 e 13 luglio
L'incendio perdura in questo e nei giorni seguenti. I mobili che stavano ammucchiati nella casa del Camagna vengono caricati sulle galere. Alla stessa casa del Camagna si appicca il fuoco. Furono ottomila i cittadini condotti schiavi. ( Campis).
Le giornate del 12 e del 13, sabato e domenica, i Turchi le impiegano a razziare le campagne dell'isola. Catturano varia gente fuggitiva e tutto il bestiame possibile.(De Simone).
Il giorno 12 continuando il fuoco nella città, il resto dei Turchi con tutti i bagagli si imbarcarono. Il 13, continuando il fuoco, fu fatto riscatto di certi cristiani, che erano stati presi all'isola di Ischia. Il numero dei turchi scesi a terra per combattere ed assediare la città di Lipari erano cinque mila (5550). L'artiglieria era formata da tre cannoni e 16 pezzi di colobrine grosse di bronzo . L'artiglieria presa dentro Lipari fu un cannone rinforzato, una “mezana”, due “esmeriglj”, tre pezzi che gettavano palle di ferro. I turchi morti nell'assedio furono 343; i Liparoti 160 fra feriti e morti. 9000 furono le presone dei due sessi, prese schiave, senza contare quelli che “messo il fogo ali quatro canti de Lipari, furono trovati ascosi dentro le sotterranee caverne”. Quindi 10 mila in tutto. I Turchi hanno tirato contro il forte di Lipari 2800 colpi di cannone. Chi avesse avuto l'animo più crudele della tigre, vedendo pianti, gemiti, singhiozzi dei poveri Liparitani che abbandonavano la loro città per essere condotti schiavi, il padre guardando il figlio, la madre la figliola, non avrebbe potuto contenere i propri occhi dall'abbondante pianto, mentre quei cani parevano lupi rapaci in mezzo a timide pecorelle. Il 13 l'armata parte da Lipari e va in Sicilia per cercare acqua nel capo di Mortelle...( Maurando).
Anche p. Bonaventura parla dei giorni seguenti. Il Barbarossa – dice il cappuccino – si trattenne altri otto giorni per cercare i liparesi che si trovavano per l’isola nascosti e non si erano rifugiati nella città. Ma senza successo perché questi non si arresero per la fame, come Ariadeno pensava, ma preferirono nutrirsi di erbe e del poco pane che avevano conservato.
.
14 luglio, lunedì
(Campis non dà la successione dei giorni): L'armata turchesca lascia Lipari e giunge nei pressi di Messina, dove alcuni Liparoti prigionieri, tramite gli amici messinesi, trattano il loro riscatto. Barbarossa è ben felice di liberarsi di tanta merce scomoda a prezzi di convenienza. Anche il Camagna si riscatta. Trattenuto in Messina per essere giudicato dall'accusa di tradimento, è assolto. Dopo qualche mese rientra a Lipari. (Campis).
Al mattino i Turchi fanno vela alla volta di Messina. Colà Giannettino Doria attende l'opportunità di potersi scontrare col temibile avversario, ma Barbarossa, sospettando eventuali agguati da parte del Doria, si stringe alle coste di Calabria. A Messina si sta sulle difensive. A tarda sera le navi turche appaiono ancorate, lontano, nell'area dello Stretto. Le ciurme di trenta galeotte, composte di cristiani rinnegati, saltano in terra presso Fiumara di Muro, frugano per i boschi e su per le colline e braccano la popolazione fuggitiva. Fanno così una retata di 2000 prigionieri (De Simone).
Martedì, mercoledì, giovedì, 15- 17 luglio.
Alle prime ore del mattino i giurati di Messina spediscono al Barbarossa un messaggero autorizzato ad avviare trattative di riscatto a favore dei Liparoti prigionieri. Barbarossa si dichiara disposto a cederli escludendo, però, le donne e gli uomini validi. Il messo, che vorrebbe contrattare a vantaggio di tutti, in blocco e senza eccezioni, fa ritorno alla base. I giurati sperano che il tiranno si trattenga ancora per qualche giorno sì da poterlo convertire a più miti consigli. Invece Barbarossa fa ripartire alla volta del Levante un primo contingente dell'armata che porta il triste carico umano non senza prima aver fatto sbarcare alcuni Liparoti di rango, i vecchi e gli inabili. Alle prime luci del giorno seguente, 18 luglio, venerdì, salpa anche lui. “Partito. Che dio li pozza profundari!”. ( De Simone)
Maurando narra che il 16 e 17 luglio i Turchi fecero il baratto dei cristiani presi a Lipari nel porto di Catona in Calabria. I Messinesi venuti presentarono 15 mila ducati per tutti i cristiani presi in Lipari, e Ariadeno oltre i 15 mila domandò per il riscatto 8 mila quintali di biscotto. Il prete però non sa come la trattativa fu conclusa perché il mattino seguente la squadra francese partì.
La cronaca cappuccina parla di una trattativa solo sulla base dell'offerta di “rinfresco” ( rifornimento di viveri). Barbarossa avrebbe risposto che “gli darebbe le cose sacre ed ecclesiastiche e le presone vecchie e decrepite”. Dopo due giorni, non mutando le offerte dell'ammiraglio turco, la trattativa “ non ebbe effetto”. I poveri Liparoti andarono in Turchia e Ariadeno per il rinfresco ottenuto regalò a Messina, fra le altre cose, la campana grande di Lipari. Quella che oggi è nel castello di Rocca Guelfonia.
[1] P.C. Campis, op.cit., pag. 306.
[2] G.Iacolino, I turchi alla marina di Lipari, 1544, Lipari, 1985.
[3] G.Iacolino. I turchi…, op.cit. pp 75-84.
[4] “Il manoscritto di P. Bonaventura da Troina (+1704)” trascritto dal prof. Giuseppe Lipari, Libro III, Messina 1999. Alcune pagine alla vicenda dedica anche R.Pirri in Sicilia Sacra, Panormi, 1733, vol.II, Notitia Octava Ecclesiae Liparensis , riportate in G.Iacolino, I turchi…, op.cit., pp- 69-74. Il Pirro non aggiunge quasi nulla alle notizie che abbiamo sulla vicenda, salvo confermare quanto riportato dal Maurando che le accuse che alcuni fecero ricadere sul Camagna si basavano sul fatto che egli era amico del Barbarossa, che aveva avuto abboccamenti con il nemico reiterati e senza testimoni, quindi l’esenzione accordata (ma non mantenuta) a lui, parenti amici e proprietà. Il Pirri fu a Lipari intono al 1630 e raccolse le memorie degli anziani e probabilmente ebbe mondo di conoscere lo stesso manoscritto al quale , nel 1694, attinse anche Campis.
[5] Una comparazione fra il racconto del Campis e quello di Se Simone è fatta da G.Iacolino,. I turchi alla marina, op.cit.,pp. 39-47, a cui abbiamo largamente e liberamente attinto.
[6] A. Raffa, op.cit., pag. 97.
[7] M.C. Cannella , “Le unità di misure locali e il sistema metrico decimale nella scuola elementare”, Tesi di laurea dell’Università degli studi di Palermo, Facoltà di scienze della formazione, anno accademico 2004-2005, pag. 62 e ss..Il valore della salma cambiava da località a località della stessa Sicilia.
[8] La pica era un’altra unità di misura del tempo derivante dalla lancia di guerra, probabilmente intono al metro o poco più.
[9] P. Bonaventura da Troina, manoscritto, op.cit.
[10] Secondo P. Bonaventura sarebbe stato il vicerè di Napoli a dare l’ordine “che mandassero le donne, figlioli e figliole a Milazo”, ordine che fu eseguito solo in parte.
[11] P. Campis, op. cit.,pag. 159-160.
[12] G.Iacolino, op.cit., pag. 99.
[13] Campis, op.cit., pag.298-299
[14] Si tratta di Chanchelubin, uno dei capitani di Barbarossa.
[15] G. Iacolino, I turchi…., op.cit., pag. 118.
[16] G. Iacolino, I turchi…, op.cit., p.147.
[17] Idem, pag. 152. La più parte dei cittadini approva l’operato del Camagna e del Comito, altri invece preferiscono morire combattendo.
[18] P.Campis, op.cit., pag.302.
[19] P. Campis, op.cit., pag. 304-305.
[20] G. Iacolino, I turchi---, op.cit., pag.170.(Archivio storico eoliano.it)
Le premesse della “ruina”.
La lotta fra Carlo V e Francesco I

Il Castello è stato il centro dello scontro fra liparesi e turchi
Nell’aprile del 1503,le disfatte francesi in Puglia permettono alla Spagna di completare la riconquista del regno di Napoli. Il regno che fu dei Normanni viene ormai affidato a un viceré e integrato nell’impero di Carlo Quinto, titolare delle corone di Spagna e dell’impero romano germanico. Tale situazione viene definitivamente sancita dal trattato di Cateau-Cambrésis, il 3 aprile 1559 : un accordo tra Enrico II, re di Francia, e Filippo II di Spagna, pone fine alle pretese francesi in Italia.
Ma nel 1544, quando avviene la “ruina” di Lipari ad opera del Barbarossa con l’appoggio dei francesi, questo trattato è ancora lontano. La lotta fra Carlo V e Francesco I è ancora in corso e trasforma l'Europa intera in un grande campo di battaglia. In questo contesto – dopo vent'anni di scontri, battaglie, guerriglie – Francesco I, stimandosi inferiore di forze, stringe una alleanza con Solimano il Grande con cui già in passato erano intercorsi parziali intese e addirittura un trattato nel 1536. Per la Francia era in gioco infatti la sua stessa esistenza come stato indipendente e sovrano. Ormai da lungo tempo viveva accerchiata dalla Spagna e dai suoi alleati e stati satelliti. Quindi la scelta di andare a cercarsi gli alleati fuori dalla “cristianità” era un passo obbligato. Un passo obbligato ma molto delicato perché il Solimano era il capo degli “infedeli” ed in un momento in cui la Chiesa era travagliata dallo scisma dei luterani, si poteva rischiare di cadere in un ulteriore e più grave isolamento. Ed infatti nella letteratura dell'epoca si parlò di “empia alleanza”.
 Carlo V e Francesco I
Carlo V e Francesco I
Il lavoro di tessitura degli ambasciatori portarono alla definizione dell'azione comune. Si sarebbe messa in campo una flotta di 140 ( 142 ne conterà Maurando o Maurand, il prete francese aggregato alla spedizione, di cui parleremo) navi da battaglia accompagnate da numerose navi da trasporto. Questa flotta prese il mare da Costantinopoli il 17 aprile 1543 e dopo lunghe tappe in Egeo e nello Ionio, per imbarcare soldati e rifornimenti e per aggregare altre navi, raggiunse le rive italiane nel maggio 1544.
Angelo Raffa che ha studiato questa spedizione consultando anche gli archivi turchi osserva che “si trattava d'una delle più imponenti formazioni navali nell'intera storia del Mediterraneo”[1].
La flotta di Ariadeno il Barbarossa
Erano truppe – circa 23 mila fra marinai ed ufficiali esclusi i barbareschi,a cui si aggiungevano le truppe da sbarco , altri 7 mila uomini - al comando dei più alti ufficiali dell'esercito turco.
Il condottiero di questa incredibile flotta era Ariadeno il Barbarossa. Il suo vero nome era Khizr. Hayreddin da cui l'occidentale Ariadeno era un titolo arabo generale e generico che significava “Protettore della religione”. Barbarossa era un soprannome che aveva ereditato, insieme al sultanato di Algeri stato satellite dell'Impero Ottomano, dal fratello Oruc a cui era succeduto nel 1519. Il titolo ufficiale che gli riconosceva il Solimano non era però quello di Sultano o re, bensì di Beylerbey che significava governatore.
Ariadeno era stato un pirata in gioventù ma ormai da tempo si era lasciato alle spalle quel passato avventuroso e leggendario. Nel 1533 era divenuto grande ammiraglio ( Khapudan Pasha) di tutta la flotta imperiale facendo dell'impero turco la massima potenza marittima del Mediterraneo.

Una flotta di navi saracene

Sopra: fotta sarecena. Sotto : nave della flotta del Barbarossa disegnata da Maurando
Abbiamo detto che complessivamente la flotta ottomana mobilitò per questa missione oltre 30 mila uomini. Per il suo allestimento, fonti francesi parlano, di un esborso complessivo del Sultano di oltre 1.200.000 ducati. Somma ampiamente ripagata dal bottino. Si pensi che i prigionieri ridotti in schiavitù furono almeno 20 mila a cui vanno aggiunti preziosi, armi, denari, stoffe pregiate, oggetti d'arte sottratti dai luoghi attaccati. Moltissimi schiavi furono utilizzati come rematori nelle galee, ma molti furono venduti o riscattati ( soprattutto ecclesiastici e appartenenti a famiglie importanti e facoltose): le richieste per il riscatto erano fra 100 e 500 ducati. Di minor rilievo la squadra francese aggregata alla flotta. Si parla di cinque galere più una nave da trasporto. In realtà sotto il controllo diretto francese erano solo due galere, le altre tre rispondevano a Leone Strozzi, fuoriuscito fiorentino, cavaliere gerosolimitano, priore di Capua. Imbarcato sulla francese Réal agli ordini dell'Ammiraglio Antoine Escalin des Aimars, signore di Garde, detto Poulin o Polin, vi era Hieronimo Maurando ( Jerome Maurand), cappellano della nave, prete di Antiboul (Antibes) che redasse durante la navigazione ed il sacco di Lipari, un diario manoscritto che è giunto fino a noi[2].
Quindi quella flotta che terrorizzò per circa due anni tutto il Mediterraneo non era una flotta di pirati ma una vera armata militare formata in gran parte da ottomani, ma non solo. Lo erano in grande maggioranza, ma vi erano anche numerose imbarcazioni barbaresche, imbarcazioni pirate o corsare cioè ma inquadrate, per l'occasione, sotto un unico comando strategico; e vi era la presenza francese.

Ariadeno detto il Barbarossa
Il percorso della flotta ottomana
La flotta colpisce per prima la città di Reggio Calabria dal 20 al 23 maggio del 1543. Dopo Reggio la essa compì sbarchi quotidiani e furono numerose le incursioni nei regni di Napoli, di Sardegna, forse della Sicilia, sicuramente della Toscana. Dopo Reggio la flotta ebbe un primo contatto con le Eolie passando da Stromboli dove venne presa un'imbarcazione, il cui equipaggio fu in parte trucidato, in parte catturato e ridotto in schiavitù. Non vennero invece toccate le coste dello Stato della Chiesa.
Il 4 luglio i turchi passano dinnanzi a Nizza e si fermano a Marsiglia dove rimangono 15 giorni svolgendosi numerosi incontri fra i capi ottomani e nobili e dignitari francesi. Intanto Polin era andato a conferire con Francesco I e tornò comunicando la decisione del re. La flotta poteva occupare Nizza e svernare nella città francese di Tolone. L'assedio a Nizza ebbe inizio il 10 agosto e la città si arrese il 22 agosto. L'impegno era che gli abitanti restassero liberi e la città non venisse distrutta. Invece la città fu incendiata e gli episodi di violenza furono feroci e numerosi. Sebbene i francesi accusarono di questo i turchi vi sono testimonianze anche francesi che danno la responsabilità alle truppe di Francesco I. Il Castello comunque resistette e l'assedio fu tolto l'8 settembre quando si diffusero le notizie che dalla Lombardia e da Genova i stavano mobilitando truppe di terra e galee.
Per far posto agli ottomani Tolone fu sgomberata di tutti gli abitanti e la città assunse i connotati di un centro mussulmano con la trasformazione delle chiese in moschee e dei campanili in minareti. Da Tolone partì una squadra navale per Algeri carica delle prede fino a lì raccolte che non mancò, lungo la rotta, di attaccare porti ed isole.
Il viaggio di ritorno iniziò il 24 maggio 1544 dall'Isola di St. Marguerite di fronte a Cannes, e Francesco I dovette sborsare per convincere Ariadeno a salpare 800 mila scudi oltre ai viveri che i francesi avevano dovuto fornire durante la permanenza a Tolone.
Il viaggio dall'isola di St. Marguerite allo stretto di Messina durò 54 giorni durante i quali si susseguono continui attacchi a città, paesi, castelli, isole con distruzioni, incendi, eccidi, cattura di schiavi e bottino.
L'obiettivo strategico
Ma sarebbe un errore pensare che questi assalti non facessero parte di un piano programmato e che gli ottomani si abbandonassero all'aggressione istintiva e senza freni. Lo scopo di questi attacchi era quello di mettere in stato d'allarme le città, i porti e le isole dell'impero spagnolo nel Mediterraneo costringendo l'apparato spagnolo a mobilitarsi sulla difensiva e a frantumare le sue forze fra i vari obiettivi non avendo tempo e forze per pensare ad un attacco risolutivo al regno di Francia. A questa strategia contribuì lo stesso Solimano che mentre Ariadeno ed i francesi combattevano a Nizza guidava un possente esercito contro il regno di Ungheria mettendo in grave pericolo i possedimenti asburgici in Austria. Inoltre tutti questi attacchi e scontri obbligavano gli spagnoli a continui esborsi di denari per le ricostruzioni delle difese incidendo negativamente sul già disastrato bilancio. Non era negli obiettivi dei due alleati una loro espansione territoriale che li avrebbe messi in competizione e presto in conflitto, ma solo quello di indebolire l'avversario comune. Obiettivo che fu pienamente raggiunto.
La Spagna dovette decidere, per evitare un disastro economico e finanziario ancora più ampio, che avrebbe provocato il collasso definitivo dell'impero, di sacrificare alcune città e alcune isole non essenziali alla strategia della difesa. Fra queste ci fu Lipari. Le risorse difensive ed economiche spagnole si concentrarono nella salvaguardia dei luoghi essenziali dal punto di vista politico e militare per la tenuta complessiva dell'impero.
Lipari in cambio di Malta?

Leone Strozzi
In questo quadro c'è da chiedersi perchè Ariadeno non attaccasse Malta che pare fosse fra gli obiettivi prestabiliti della flotta. “Questa salvezza – scrive Angelo Raffa – ci è parsa connessa direttamente con la distruzione di Lipari. I documenti maltesi e fiorentini indicano con chiarezza questa ipotesi. La preoccupazione d'un eventuale attacco a Malta fu anzitutto di Leone Strozzi, vice comandante della squadra navale francese, che, a tal proposito scrisse al gran Maestro dell'ordine gerosolimitano dei cavalieri di San Giovanni, cui lui stesso apparteneva, e che era sovrano dell'isola di Malta. I Cavalieri, espulsi dall'antica sede di Rodi dai Turchi nel 1522, avevano ottenuto da Carlo V le basi di Tripoli e di Malta. In quest'isola erano giunti nel 1529 e quindici anni dopo mancavano ancora adeguate e definitive opere di fortificazione[3]”.
Per questo grande fu la preoccupazione per un attacco degli ottomani. Leone Strozzi mentre la flotta era fra Gaeta e Pozzuoli inviò segretamente a Malta un frate perchè desse assicurazioni al Gran Maestro che avrebbe fatto di tutto perché la flotta dirigesse altrove i suoi attacchi considerando che non avrebbe potuto dedicare molto tempo alle coste tirrene. Strozzi mette subito in atto in colloqui col Barbarossa questa strategia di convincimento verso altre mete. Nel caso estremo, promette, in cui non fosse riuscito nell'obiettivo avrebbe abbandonato la flotta e con le sue tre navi sarebbe andato in soccorso di Malta. Strozzi, forse con l'aiuto di Polin, riesce nel tentativo di convincere Ariadeno. Malta è salva, ma Lipari è condannata.
E che sia stato l'attacco a Lipari a salvare Malta lo rivelano stesse fonti maltesi che osservano come l'armata turca rimase dopo la presa di Lipari “ tanto esausta di munizioni, e tanto impedita e imbarazzata di robbe, e di schiavi; che rimase l'Armata sopradetta inhabile, à poter tentare per all'hora alcun altra impresa”[4].
Fra affari e miracoli
Prima di affrontare il tema dell’attacco a Lipari, dell’assedio e infine della devastazione, dobbiamo dare conto di alcuni episodi, i pochi che si sono tramandati, che riguardano le Eolie ed accaddero negli anni precedenti alla “ruina”. Il primo fatto è del 1530 ed è in relazione al sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi che avvenne nel 1527. Papa Clemente VII aveva bisogno di rilevanti risorse per ricostruire la città e pensò di attingere dalle mense vescovili e quindi anche dalla diocesi di Lipari. In particolare per Lipari si pensò di inasprire le decime abolendo, nel frattempo, il privilegio dell’esenzione totale di cui godevano proprietari terrieri a basso reddito, piccoli allevatori e modesti pescatori. Era un provvedimento particolarmente pesante e così si pensò di ricorrere alla Santa Sede ed il ricorso ebbe buon esito ed il 12 novembre del 1530 il papa scrisse ai liparesi confermando questo privilegio che risaliva “ab immemorabili tempore” e prevedeva l’esenzione totale dalla decima di quanti non riuscivano a ricavare dalle loro attività frutti, proventi e redditi non superiori al “valore annuo di sei ducati d’oro”[5].

Del 1533 è la notizia che il vescovo di Lipari, che però viveva a Roma dove era governatore, aveva dato in concessione ed enfiteusi perpetua tutte le cave di zolfo, vetriolo ed allume delle isole e, per questi prodotti, in particolare nell’isola di Vulcano. I beneficiari erano genovesi e forse anche veneti. Ed è questo il segno dell’attenzione e degli interessi che in quel periodo maturavano sulle Eolie da parte di commercianti che operavano su tutto lo scenario del Mediterraneo. Gente esperta dello sfruttamento del suolo e del sottosuolo che producevano e commerciavano. Infatti oltre ai prodotti minerari di Vulcano è in questo periodo che si parla di esportazione di passole e passoline - probabilmente soprattutto da Salina – fino a Costantinopoli.[6]
L’ultima notizia è del 1541 e riguarda uno dei tanti miracoli che gli eoliani attribuiscono al loro santo patrono. Era il 17 giugno ed un naviglio di forestieri con i marinai affetti di peste voleva a tutti i costi sbarcare nell’isola facendo leva su falsi attestati di “perfetta salute” degli imbarcati. Ma improvvisamente, sopra l’isola, comparve San Bartolomeo, “in aria cinto di sblendori con la sua destra armata di rilucente e ben affilato coltello, propria difesa di quell’Apostolo, adirato nel volto e sdegnato nella voce, e, fattosi visibile a tutti in aria sopra l’appestato vascello, scridò a quanti su quello si trovavano minacciando a quelli subita morte se altrove non volgevano subitamente la prora con allontanarsi da quelle Isole al suo patrocinio raccomandate dalla provvidenza Divina”[7].
I marinai si spaventarono e “con tutta prontezza vollero obbedire” senza però prima avere voluto informare i liparesi perché conoscessero la “vigilante sollecitudine” del loro patrono. Così una delegazione in barca si staccò dal vascello e raggiunto il porto, senza attraccarvi, narrò ad alta voce l’accaduto. Ed i liparesi fecero voto di celebrare in quel giorno, ogni anno, una solennissima festa in onore del Santo.
Papa Clemente VII
[1] A.Raffa, “La fine della Lipari medioevale” in Dal “Constitutum” alle “controversie liparitane”, Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano, 1998, pag.79.
[2] Jerome Maurand, La flotta di Barbarossa a Vulcano e Lipari nel 1544, Palermo, 1995. L’originale si trova nella Bibliothèque Inguimbertine di Carpantras e porta il titolo “Itinerario da Antibes a Costantinopoli del 1544”. Il volumetto pubblicato nel 1995 da Vittorio Giustolisi ne riproduce solo una parte ed in particolare i fogli 178-221 che furono esposti, per interessamento di A.Raffa, nella mostra che si tenne a Lipari dal 4 al 9 maggio 1995 alla Chiesa di S. Maria delle Grazie promossa dai quatto comuni eoliani in occasione delle celebrazioni del IX centenario del “Constitutum” dell’Abate Ambrogio. “La fondazione della ‘communitas’ eoliana”.
[3]A.Raffa, “La fine della lipari medioevale” , op.cit. , pag.89.
[4] A.Raffa, op.cit., pag.90
[5] G. Iacolino, op.cit., pag. 290-291; Archivio segreto Vaticano, Armadio XL,28,fogli 184-5.
[6] G. Iacolino, op.cit., pag. 292-293. L Genuardi e L. Siciliano, Il Dominio del Vescovo sui terreni pomici peri dell’Isola di Lipari, Acireale, 1912, p.82, n.5 nella nota 3 è detto che nell’Archivio di Stato di Roma fu ritrovato l’atto notarile del 1623.(Archivio storico eoliano.it)
[7] P. Campis, op.cit., pag 198-199.
L’apporto dei Cnidi non rafforza solo gli insediamenti ma permette anche, finalmente, di sperimentare le idee di libertà e organizzazione sociale che questa nuova gente porta nel cuore fin dall’abbandono delle loro terre in Asia minore. Inoltre una particolare organizzazione sociale si rende necessaria per amalgamare insieme gente che fin’ora si era dedicata solo all’agricoltura e gente invece che aveva vissuto sul mare e col mare. Nasce così una originale costituzione comunitaria che all’epoca, come vedremo, dovette fare scalpore[1].
Questa costituzione non riconosceva la proprietà privata; i cittadini erano divisi in due ordini rispettivamente cooperanti: quello dei marinai e quello dei terrestri. I primi difendevano la patria sul mare e provvedevano al sostentamento del popolo con i prodotti della pesca e, probabilmente, anche della pirateria: pirateria da contrasto e pirateria diretta; i secondi erano contadini, costruttori e pastori e lavoravano a loro volta per tutta la comunità. Le navi, i campi e ogni altra cosa erano di proprietà comune. Non si sentiva il bisogno di ricorrere al denaro perché gli scambi avvenivano sulla base della distribuzione dei prodotti e delle necessità. Per questo si cominciarono a coniare monete, più tardi, negli ultimi anni del V o agli inizi del IV secolo a.C per adoperarle negli scambi con altri popoli[2].
Abitazioni, navi e terra appartenevano alla comunità e tutte le decisioni relative a nuove costruzioni come all’utilizzo ed alla distribuzione delle terre venivano prese in assemblea. La preoccupazione delle incursioni piratesche doveva rimanere alta se per secoli solo Lipari fu popolata mentre nelle altre isole si andava, a turno, per coltivarle e per la raccolta dei prodotti, sempre scortati e protetti dai marinai. Quando poi, finalmente si decise di popolarle questo avvenne mantenendo comune la proprietà e sempre con la sorveglianza della marineria.
I villaggi che lì si costruirono rappresentarono gli osservatori di una rete costantemente attiva che teneva sotto controllo i movimenti di navigli che entravano nelle acque dell’arcipelago. Sulle vette delle varie isole vi erano delle torrette di avvistamento che permettevano di vigilare ampi tratti di mare e di segnalare alla flotta liparese, che veleggiava nelle acque attorno all’arcipelago, l’avvicinarsi di un qualunque bastimento di predoni. Questo permise ai liparesi di acquistare nel Tirreno una indiscussa superiorità navale, dovuta non solo alla continua pratica, ma anche alla posizione delle isole, che consentiva di sorvegliare qualunque traffico che si svolgeva sulla costa calabra e sulla costa sicula, da Milazzo a Cefalù. L'occupazione delle isole e la creazione di una efficace rete di sorveglianza sui mari fu alla base della capacità di contrasto con la pirateria etrusca ma, allo stesso tempo, fu con la sconfitta di questa – avvenuta nella battaglia di Cuma del 473 a.C. ad opera dei siracusani di cui i liparesi erano alleati - che fu possibile la piena utilizzazione delle nostre isole minori.
Infatti è da questa età che ha inizio uno sfruttamento più organico della salina di Lingua nell'isola di Salina che doveva essere iniziato fin dal VI secolo e nel IV secolo si può parlare di un centro stabilmente abitato se pur di ridottissime dimensioni dove ora vi è Santa Marina. Nel III secolo la popolazione dell'isola probabilmente toccò i trecento abitanti: per lo più lavoratori subordinati, schiavi, gente di fatica ma anche qualche piccolo proprietario, qualche mezzadro mentre i benestanti risiedevano a Lipari. E questo spiegherebbe il fatto che nell'isola scarseggiano sarcofagi funerari di quest'età. Questi abitanti oltre che nell'odierna Santa Marina vivevano nelle campagne nella spianata del Capo, nella valle fra le due montagne che unisce Rinella a Malfa[3].
Oltre a Lipari e Salina anche Stromboli doveva essere abitata come dimostra il ritrovamento negli scavi del 1980 di una necropoli greca a Ficogrande collocabile fra gli inizi del IV secolo e la metà del III a.C.. A Filicudi vi sono “testimonianze di abitazione stabile forse fin dalla fine del V o almeno dagli inizi del IV secolo a,C.”[4] Naturalmente si trattava di abitazioni collocate nell'attuale località del porto mentre bisognerà aspettare il II secolo a.C. perchè sorgessero abitazioni in zone agricole più lontane. Alla Calcara di Panarea abbiamo evidenti tracce di frequentazione, se non di vera e propria abitazione, dalla fine del IV secolo a.C. alla seconda metà del II secolo d.C.[5]. Comunque visto la peculiarità del sito è pensabile che si trattasse di un luogo di culto magari dedicato al dio Efesto.
I punti di forza di questa fase di sviluppo che va sotto il nome della Lipara cnida ( VI -III secolo a.C.) sono soprattutto tre:
1. La forte coesione dovuta all’originale assetto sociale che la nuova comunità si da.
2. La grande perizia nella navigazione e nel combattimento in mare che li porta presto a dominare nel Tirreno.
3. La ripresa dei commerci e dei rapporti con le popolazioni limitrofe grazie all’agricoltura, alla produzione dell’allume, all’utilizzo delle acque e del termalismo in genere.
Una superiorità sui mari del Tirreno
Interessante è questo aneddoto raccontato da Pausania[6] e che riguarda fatti accaduti nelle prime decadi del V secolo a.C. - probabilmente nell'ambito di un attacco per l'occupazione dell'isola - quando ancora la fama dei liparesi come navigatori e combattenti non si era affermata.
I liparesi avendo una volta avvistati numerosi navigli di pirati etruschi nelle loro acque, mandarono contro di essi cinque delle loro navi. I corsari, fiduciosi della loro capacità e forza, pur essendo di gran lunga superiori per numero di navi, non vollero attaccare in massa i navigli liparesi e, sicuri della vittoria, si opposero solo con un numero eguale di navi. La destrezza dei liparesi si rivelò in pieno ed essi, non solo resistettero all’urto di quella gente, la cui lunga pratica marinaresca li aveva circondati di un’aureola d’invincibilità, ma riuscirono ad impadronirsi dei vascelli loro opposti. I Tirreni cedettero che la vittoria dei liparesi fosse dovuta al caso e non al valore, e pertanto inviarono altre cinque navi meglio armate contro le cinque liparesi. Anche questa volta la vittoria arrise ai discendenti di Eolo e la nuova sconfitta esarcebò non poco i vecchi corsari i quali, armate altre cinque navi di gente particolarmente esperta nell’arte marinara, vollero ancora ritentare la prova della loro supremazia, facendo attaccare i navigli liparesi, vittoriosi già nei due precedenti combattimenti. Per la terza volta i liparesi uscirono vittoriosi dal duro confronto, aggiungendo così altre cinque navi alle dieci già catturate.
I pirati toscani, pure rammaricati per le perdite subite, non vollero attaccare con tutte le loro navi disponibili i vascelli avversari, stimando che poca gloria avrebbero avuta con lo sconfiggere dei navigli e della gente già provate e fiaccate in tre precedenti combattimenti. Ancora una volta essi preferirono dunque affrontarli con ugual forza e pertanto, preparati cinque legni con i migliori combattenti, affidarono ad essi il retaggio della loro vecchia supremazia. L’urto fu violento ma l’ardore dei liparesi ebbe anche questa volta ragione. I Toscani sorpresi dal valore di questi nuovi audaci del mare, che avevano combattuto e vinto in ben quattro prove, ricusarono ogni altro combattimento, preferendo allontanarsi e lasciare nelle mani degli avversari i venti vascelli catturati.
Grande fu la gioia degli abitanti di Lipari, quando videro tornare nel loro porto le loro cinque navi con a rimorchio ben venti navi catturate. Ricchi donativi furono, per quella strepitosa vittoria, offerti a ringraziamento dei liparesi ad Apollo in Delfi, nel cui tempio vennero pure depositati i venti stendardi delle navi etrusche catturate.
Ma la gioia dei liparesi fu di breve durata perchè durissima fu la reazione dei tirreni compreso un episodio di sacrificio umano che creò un grande sconcerto. Infatti, non si erano ancora spenti gli echi della grande vittoria, che gli etruschi, guidati da Velthur Spurinna, attaccano e conquistano Lipari e per rispettare un voto fatto a Febo ( Apollo), gli immolano il più forte dei liparesi, Teodoto. Ma anche la dominazione dei tirreni durò poco e dopo qualche anno i liparesi liberarono – forse con l'aiuto di Ierone di Siracusa - la loro isola (480-475 a.C.) dedicando al dio delfico una grande base marmorea con dedica. Ancora qualche tempo e gli Etruschi saranno definitivamente sconfitti a Cuma[7].
Un altro momento di coinvolgimento bellico Lipari lo dovette subire nel 427 a.C. nell'ambito della guerra tra Siracusa ed Atene che si concluse nel 424 con la pace di Gela. I liparesi erano schierati a fianco di Siracusa e per questo subirono diversi tentativi di occupazione fra i quali il più duro fu quello avvenuto sul finire del 427 da parte della flotta ateniese forte di 3400 uomini. Ma Lipari resistette – come anche in una successiva incursione nell'inverno del 426 - ed agli ateniesi non rimase che depredare le campagne.[8] Un altro scontro, sempre a causa dell'alleanza con Siracusa, Lipari lo subì nel 397 a.C. da parte dei cartaginesi che avevano dato inizio alla loro politica espansionistica. Questa volta la città soccombette ed i liparesi furono condannati a pagare 30 talenti ma ricuperarono la propria indipendenza una volta partita la flotta avversaria[9].
Mutamenti istituzionali e successo del “modello”
Intorno al IV secolo la costituzione comunitaria eoliana subì un mutamento, probabilmente dovuto alla maggior sicurezza e a un certo consolidamento delle strutture sociali. Si deliberò un affidamento ventennale di appezzamento dei terreni di Lipari alle famiglie di contadini. Ogni venti anni tutta la terra veniva di nuovo unificata e si procedeva ad una ulteriore suddivisione per il successivo ventennio per sorteggio.
Le isole minori restarono invece di dominio comune, prevalentemente adibite a pascolo, finché finirono anch’esse per essere lottizzate.
L’intento di sostenere il valore del distacco dal possesso era manifesto e dichiarato; ogni 20 anni, con feste e cerimonie rituali, tornava al popolo ciò che era del popolo. L’eccezionale fertilità e ricchezza dell’agricoltura eoliana testimonia che l’affidamento della terra veniva considerato come una sacra investitura e che ciascuno si faceva obbligo di ritornare i campi al popolo più fecondi di come li aveva ricevuti.
L’introduzione di queste regole, meno draconiane delle precedenti, dimostrano che si comincia a paventare, da parte dei capi dell’arcipelago, l’attaccamento alla proprietà privata fra la popolazione, sentimento che in precedenza non esisteva. Certo questo era dovuto al maggior benessere raggiunto dagli eoliani, alla sicurezza ormai consolidata dopo la vittoria sui pirati e certamente ai frequenti rapporti con popoli che non solo avevano l’istituto della proprietà privata, ma vantavano colossali fortune personali.
Lipari inoltre era divenuta un fiorente centro di scambio fra i più ricchi commercianti del Mediterraneo e dell’Egeo. Così nella prima metà del III secolo a.C. la rotazione ventennale della terra venne abolita e , in pratica, si istituzionalizzò la proprietà privata. Fu probabilmente in quel periodo ( o forse anche qualche decennio prima) che Lipari cominciò a coniare moneta. A dimostrazione che la moneta, almeno inizialmente, più che per i rapporti interni dovesse servire per i commerci con gli altri popoli ed in particolare con gli Etruschi verso i quali non vi era solo un rapporto di ostilità ma anche di interessi, sta il fatto che le monete di Lipari non furono coniate in argento come quelle delle altre colonie greche ma in bronzo e con un certo peso, simili cioè a quelle del sistema etrusco. Comunque con l'avvento della proprietà privata il “comunismo” di Lipari era finito. Esso era durato almeno trecento anni.
Questa costituzione della Lipara greca dovette colpire la fantasia dei contemporanei e forse influenzare le utopie sulla riforma dello stato che sbocciarono in quei tempi e nei secoli seguenti. Sembra che lo storico greco Evemero da Messina, di cui gran parte delle opere sono andate perdute, abbia scritto proprio su questa costituzione comunitaria delle Eolie. Addirittura si vuole che lo stesso Platone nella stesura della sua “La Repubblica” - scritta fra il 380 e il 360 a.C. - si sia ispirato all'esperienza liparese[10] contrapponendo alle classi dei marinai e dei contadini quella dei guerrieri e dei lavoratori e prevedendo la proprietà collettiva invece di quella privata..(Archivio storico eoliano.it)
[1] Noi la riprendiamo dalla ricerca fatta da Gin Racheli nel suo libro “Eolie di venti e di fuoco”. Riferimenti sono anche a Strasbone e soprattutto al bel saggio diTheodore Reinach, Le collettivisme des grecs de Lipari, in Revue des etudes Ggrecques”, 1890 , pgg 86-96.
[2] L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Il Castello di Lipari e il muso archeologico eoliano, Palermo, 1979, pag. 91.Ma potrebbe essere che la moneta di conio liparese faccia la sua comparsa solo nel III secolo.
[3] G. Iacolino, Raccontare Salina, op.cit. Pagg. 73 e ss.
[4] L.Bernabò Brea e M. Cavalier, Meligunis Lipara, vol.VI. Filicudi. Insediamenti dell'età del bronzo.Palermo, 1991.
[5] L.Berrnabò Brea e M.Cavalier, Meligunis Lipara, vol. III, Stazioni preistoriche delle isole Panarea, Salina e Stromboli, Palermo, 1968, pag. 9 e ss.
[6] Riportato da Zagami nel suo “Lipari e i suoi cinque millenni di storia”.
[7] A. Pagliara, Fonti per la storia dell'arcipelago eoliano in età greca, in Maligunis Lipara, Vol. VIII, Parte II, note pagg. 74-75.
[8] Tucidite, Vi,17 e III,115.
[9] Diodoro, XIV, 56.
[10] A. Raffa ha illustrato questa suggestiva ipotesi in una conferenza tenuta a Lipari nell'estate del 2008.



 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431