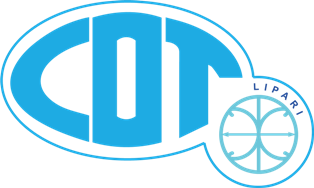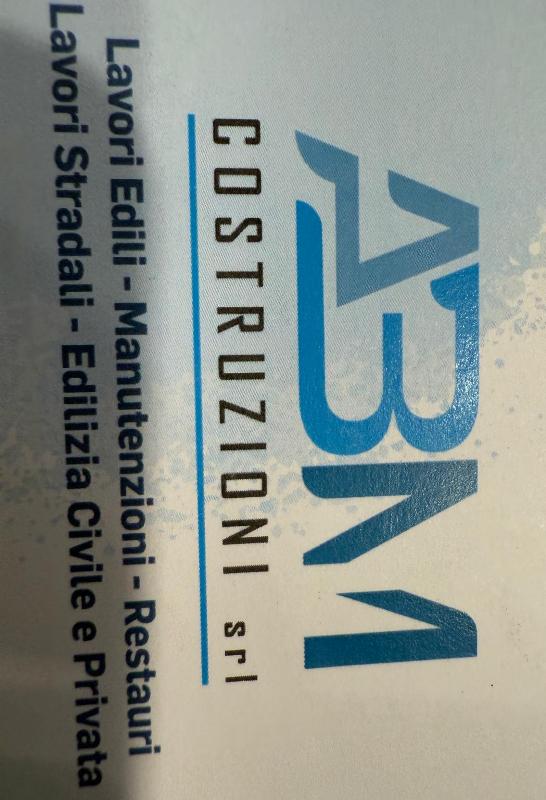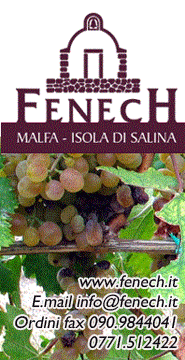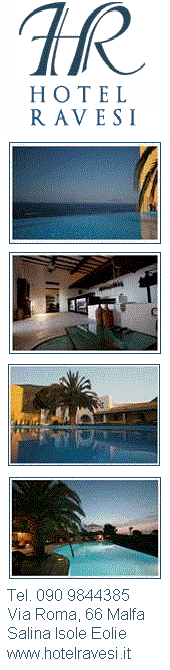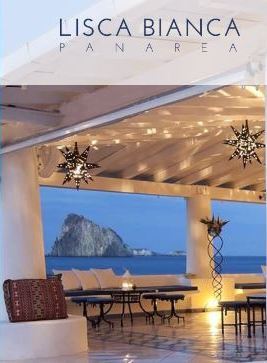di Michele Giacomantonio
di Michele Giacomantonio
Canneto vuole l'autonomia
I Cannetari sperano in una legge
Canneto nei primi decenni del '900
A metà del 1922 scoppia per il povero Sindaco Ferlazzo un fulmine a ciel sereno. Canneto vuole l’autonomia. Da tempo questa notizia serpeggiava fra la gente ma a Lipari la si considerava con scetticismo. Era un’idea velleitaria e balzana, si diceva, portata avanti da persone avventurose e fondata su presupposti sbagliati. Ma a Canneto ci si credeva veramente. Erano in molti a non essere soddisfatti di come il Comune amministrava l’isola e poi… c’era chi soffiava sul fuoco. Il piccolo borgo di cavatori dell’inizio dell’800 era diventata ormai una cittadina di duemila abitanti e si sentivano trascurati. Lipari si apprestava ad essere una cittadina con tre belle strade basolate, Canneto non ne aveva nemmeno una. Via era la via della marina e nient’altro. Dietro di questa le case si andavano assiepando disordinatamente. Si parlava di una via parallela che dovesse sorgere dietro la Chiesa di S. Cristoforo ma i discorsi rimanevano tali. La rotabile andava avanti a passo di lumaca e c’era chi accollava anche questo ai liparesi sostenendo che se ne disinteressavano.
Ai primi di luglio “l’idea balzana” approda al Parlamento. Una petizione con tante firme, non solo di Canneto ma anche di Lami, Acquacalda, Pirrera,, promossa, si dice da don Felice Sciarrone, uno dei leader del movimento dei lavoratori della pomice e attivista socialista,. era giunta sul tavolo di un deputato, l’on.Giuseppe Toscano, che l’aveva trasformata in disegno di legge per la costituzione a Comune autonomo della frazione di Canneto ed era riuscito a farla mettere in calendario per essere discussa alla Camera. Sciarrone era il promotore e quello che aveva rapporti con Roma ma con lui c’era tutta la classe dirigente di Canneto a cominciare dai sei consiglieri comunali della frazione : Vincenzo d’Ambra, Francesco Carbone, Antonino Portelli, Giovanni Ferlazzo Natoli, Giovanni Raffaele, Antonino Profilio.
Appena saputa la notizia il Sindaco convoca d’urgenza il Consiglio Comunale e l’11 luglio 1922 si tiene la seduta sul tema in prima convocazione.
Quando i consiglieri si ritrovano nella sede di Piazza Mazzini ci si accorge che mancano i consiglieri di Canneto. Una assenza deliberata? Se lo chiedono in molti quel giorno e la cosa sarà oggetto di polemica. I liparesi la prendono come un affronto, come la decisione di non volere nemmeno discutere della questione. I cannetari sosterranno di essere stati in qualche modo raggirati. Siccome venire da Canneto non era agevole, siccome quasi mai i Consigli si svolgevano in prima convocazione perché quasi sempre mancava il numero legale, si erano informati – Ferlazzo Natoli aveva telefonato all’assessore Saltalamacchia – ed avendo avuto rassicurazioni in questo senso se ne erano restati a casa.
Invece il Consiglio si svolge regolarmente e nessuno giustifica i consiglieri di Canneto. Il Sindaco entra subito nel merito del tema e afferma la sua convinzione che la separazione della frazione di Canneto sarebbe di gravità, sia per Lipari, quanto per lo stesso Canneto “ed ha sempre sperato che gli agitatori, nel momento di consapevolezza, comprendessero la gravità del danno. Il Comune mai nulla ha negato di ciò che è stato richiesto dalla rappresentanza della frazione la quale fino a pochi mesi fa ha collaborato nell’Amministrazione con la massima concordia. I servizi pubblici a Canneto sono identici a quelli di Lipari e procedono in eguale maniera. In ogni occasione, sia in Consiglio Comunale, sia in pubblici comizi, egli ha fatto caldissimo appello alla concordia”[1].

Calandra di Canneto
Intenso si sviluppa il dibattito. Scolarici dice che Canneto ha una numerosa rappresentanza in Consiglio e un assessore nell’Amministrazione, come fa a sostener di essere emarginata? Propone quindi una Commissione con poteri illimitati che si rechi a Roma per sostenere l’integrità del Comune e vanga a questo scopo stanziata una somma in Bilancio.
Palamara sostiene che le conseguenze di una separazione sarebbero gravi per entrambi. Come si applicherebbe la legge sulla pomice qualora fossero due i comuni che dovrebbero applicarla? Il pericolo è che la legge può divenire inapplicabile. De Mauro considera che il demanio pomicifero da il diritto di scavazione della pomice a tutti i naturali dell’isola ed ogni lavoratore ha diritto di sfruttare il demanio in ogni sua località senza distinzione di luogo. E questo perché le diverse esigenze commerciali e industriali esigono un lavoro fluttuante per ogni località del demanio in ragione della produttività di esso. E se per tale motivo non è possibile la divisione del demanio pomicifero, d’altro canto è necessario che tutti i lavoratori delle cave lo sfruttino con la maggiore armonia fra di loro.
La posizione contraria del Consiglio Comunale
Alla fine i diversi pareri confluiscono in un ordine del giorno predisposto, dall’avv. Casaceli, che viene votato all’unanimità.
“Il Consiglio, tenuta presente la presa in considerazione da parte della Camera dei deputati della proposta presentata dall’on. Giuseppe Toscano per la costituzione in Comune autonomo della borgata Canneto e annesse undici frazioni distaccandole dal Capoluogo di Lipari:
Ritenuto che è canone di diritto pubblico che deve essere di regola conservata l’unità dei Comuni. Che è regola la costituzione di grossi centri.
Che pertanto solo in via di eccezione è permessa l’erezione di borgata o frazione in Comune distinto quando si verifichi il caso di vera e assoluta necessità dimostrata.
Che è savio impedire l’accrescimento di piccoli Comuni.
Ritenuto che per motivi illegittimi e particolaristici è stata agitata in Canneto l’idea di autonomia;
Ritenuto che di nulla Canneto può lamentarsi, poiché ha avuto riguardi particolari in confronto alle altre frazioni ed ha servizi pubblici non comuni;
Ritenuto che è vicinissimo al Capoluogo ed è a questo allacciato da una rotabile in costruzione, da una mulattiera breve in ottime condizioni e da diverse linee marittime giornaliere;
Considerato che per il terreno pomicifero, posto nella parte nord dell’Isola di Lipari e che rappresenta l’unico cespite di entrata per la finanza del Comune, non è assolutamente possibile una separazione;
Ritenuto che nell’ipotesi malaugurata che si venisse alla separazione della borgata Canneto dal Comune si stabilirebbe un continuo e sanguinoso conflitto tra cittadini e cittadini, che hanno il diritto di esercitare gli usi civici sul demanio comunale pomicifero.
Ritenuto che venendo meno per conseguenza, l’attuale sorveglianza, per il godimento del demanio Comunale pomici fero, sarebbe inapplicabile la legge 5 gennaio 1908 n.10 spingendovi così nella più squallida miseria tutto il gruppo delle isole Eolie;
Ritenuto che il territorio di Canneto e delle pretese borgate, che ad essa figurano unite, si appartiene a grandissima parte a cittadini liparesi che vogliono l’integrità comunale.
Che a cittadini liparesi si appartiene pure ed in grandissima parte il territorio pomicifero privato; Ritenuto che le undici borgate non esistono come nuclei naturali di popolazione;
Che le medesime sono delle località di campagna dove si vegeta, ma non si vive, dove ci son piante e non uomini;
Ritenuto che la proposta costituzione di Canneto a Comune sarebbe di danno grave a Canneto e di danno non meno grave per Lipari e le altre frazioni dipendenti;
Ritenuto che un tale provvedimento sarebbe causa dissidio profondo, continuo e inconciliabile fra Comune e Comune;
Ritenuto che l’accoglimento della inconsulta richiesta di Canneto sarebbe un delitto gravissimo per Lipari e le Eolie e farebbe perdere ogni fiducia nelle Istituzioni e nei pubblici poteri.
Ritenuto che l’ordine pubblico è profondamente turbato e il turbamento si rende ancora più grave con effetti non prevedibili.
Per tali motivi ad unanimità di voti
Delibera
1)Opporsi alla separazione di cui nei considerando
2) Far voto al Governo del Re perché si degni provocare dalla Camera il rigetto della proposta di legge dell’on. Giuseppe Toscano;
3) Nominare una Commissione che si rechi subito a Roma per patrocinare la giusta causa dell’integrità Comunale;
4) Stanziare per la bisogna una adeguata somma in bilancio
5) Comunicare il presente ordine del giorno integralmente agli Onorevoli Ministri competenti, agli onorevoli deputarti della Circoscrizione”.
Il Presidente mette ai voti per alzata e seduta l’ordine del giorno presentato dal Consigliere avv. Casaceli che viene approvato all’unanimità. La Commissione da nominare sarà di nove membri e la votazione viene demandata ad una prossima seduta da tenersi il 15 luglio..

Canneto , " a praia":
Ed il 15 luglio finalmente sono presenti anche i consiglieri di Canneto, ed è subito polemica. Vincenzo D’Ambra e Francesco Carbone chiedono che venga letto il verbale della seduta precedente, Il Sindaco risponde che il verbale è stato già letto ed approvato alla fine della seduta precedente e siccome c’è un ordine del giorno da svolgere non si può perdere tempo con richieste dilatorie. Se si voleva conoscere cosa si era detto in consiglio il giorno 12 bisogna essere presenti allora o passare dalla segreteria successivamente per prenderne visione.
“Non eravamo presenti – ribatte il consigliere Carbone – perché l’assessore Saltalamacchia telefonò a Cannetto informando che il Consiglio non ci sarebbe stato”.
“Non è vero! – interviene Saltalamacchia – Io ho ricevuto una telefonata del consigliere Ferlazzo Natoli che voleva sapere se il Consiglio si sarebbe tenuto sicuramente. Io mi sono limitato a mio parere ed ho detto che essendo in prima convocazione difficilmente ci sarebbe stato il numero legale”.
La Camera non accoglie la richiesta
“Se fossimo stati presenti alla seduta scorsa – esordisce D’Ambra - avremmo aperto il nostro intervento al grido di viva Lipari e l’avremmo chiuso gridando viva Canneto. Se Canneto chiede oggi l’autonomia è perché si è vista trascurata”. Scorto poi in fondo all’aula il Tenente dei Reali Carabinieri, dice che non sa spiegarsene la presenza. Entrando quindi a discutere dell’ordine del giorno afferma che se si vuole mandare a Roma una Commissione che vada pure, ma non a spese del Comune ma a spese proprie.
Dopo D’Ambra parlano anche gli altri consiglieri di Canneto ed affermano che il dissidio sorto fra Lipari e Canneto è insanabile. Canneto manca dei pubblici servizi ed aspira ad un vivere più civile, a Lipari si sperpera il denaro del Comune. L’andata a Roma del Comitato pro integrità sia a spese dello medesimo, non potendo il bilancio del Comune sopportare tale spesa.
Il Sindaco ribatte che Canneto ha avuto le migliori cure ed è stata la preferita fra tutte le frazioni del Comune. Proprio nel momento più grave della Nazione e del Comune, quando scoppiò la guerra, Lipari non esitò ad appaltare i lavori della rotabile Lipari-Canneto, “i quali per più di metà sono stati eseguiti”. Le mancanze che ora si lamentano non esistevano solo pochi mesi fa quando i consiglieri di Canneto collaboravano col’Amministrazione. Così è stato per l’assessore Portelli che mai ha sollevato lamentele né nella passata amministrazione, né in questa.
“Come si fa ad accusare questa Amministrazione di sperperi – incalza - se è stata l’’Amministrazione della lesina? Chi volesse, prenda visione dei libri contabili. Dissidio insanabile? Non lo vedo proprio. Ho vissuto gran parte della mia vita a Canneto ed ancora ora vi passo un parte dell’anno. Credo di conoscere i sentimenti della gente di Canneto come conosco quelli di Lipari. Per questo posso dire che quando sarà sorpassato l’attuale eccitamento si tornerà a quella comunione di vita amministrativa che è nella generale aspirazione.
In questi giorni il Presidente dei Ministri Facta ha sentito il bisogno di chiamare a sé i deputati presentatori di progetti di legge per l’autonomia di Comuni per fare loro intendere tutto il grave danno che ne deriva da nuovi spezzettamenti di Comuni, esortandoli a meditare tutta la gravità finanziaria cui si va incontro.
Lipari che ha una storia millenaria e deve tutelare con tutte le sue forze l’integrità del Comune.”
“Tutte le volte – insorge Portelli - che in Giunta ho chiesto qualcosa a favore di Canneto mai è stata accolta”.
“E’ inesatto - ribatte il Sindaco - Una sola volta, Portelli ha fatto una proposta e riguardava lo stanziamento di una somma per la festa di S. Cristoforo. Io osservai che la Regia Commissione di controllo l’avrebbe cassata perché si trattava di una spesa facoltativa. Comunque fu approvata ugualmente e puntualmente la Commissione la cassò”.
A questo punto Portelli chiede che si dia lettura del verbale della seduta precedente ma il Sindaco lo richiama all’ordine del giorno della seduta odierna mentre quel verbale può leggerselo in segreteria. La discussione si arena su questo tema e il Sindaco accusa i consiglieri di Canneto di essere venuti in consiglio per fare ostruzionismo e tagliando ogni ulteriore possibilità di intervento dichiara che si procede alla votazione della Commissione. Nella votazione si astengono i consiglieri di Canneto che riprendono a protestare chiedendo che la commissione si rechi a Roma a proprie spese.

Ma questo punto si passa ad un altro punto all’ordine del giorno.
Nella seduta del 21 dicembre, il Sindaco di ritorno da una missione a Roma dove ha avuto diversi incontri . informa che “ha ragione di poter rassicurare il Consiglio che essa sarà trattata dal Governo con la massima benevolenza nei riguardi della integrità comunale” ed aggiunge che questo “è un argomento della più grande gravità che ha commosso e tenuto in sospeso gli animi di tutte le popolazioni del Comune.”.
Secondo l’avv. Giovanni Raffaele - che, su incarico del Comune, scriverà nel 1951 una memoria quando si riproporrà la vicenda sul finire degli anni 40 - la vicenda del 1922 che portò alla proposta di legge Toscano fu provocata “da elementi interessati” che avrebbero voluto “raddoppiare la tassa di escavazione sul lapillo, prevista dall'art. 1 della Legge 5 gennaio 1908 n. 10, e ciò al fine di impedire praticamente agli operai concessionari di cave l'escavazione del lapillo, mentre un'altra corrente, facente capo ai consiglieri comunali del capoluogo in contrapposto a parte dei consiglieri residenti ed aventi interessi in Canneto, era contraria a tale aumento”.
La vicenda non trovò accoglienza alla Camera e di essa non si parlò più, in quegli anni, in Consiglio comunale. Il tema verrà ripreso, sempre dagli stessi animatori, nel 1946 quando i cannetari verranno a Lipari per dimostrazioni a favore dell’autonomie e si faranno numerosi comizi sull’argomento. Ma anche questa volta, come vedremo, la mobilitazione non avrà successo.
Il Comune a rischio di collasso. Poi ripresa e rilancio
Un Comune al collasso

Case di pescatori a Marina lunga
Quando il cavaliere Ferlice Ferlazzo viene eletto Sindaco il 23 dicembre 1919 sa che ha di fronte a se un compito difficile: rimettere la macchina amministrativa in grado di funzionare in nove mesi, quanti ne restano per le elezioni amministrative.
“L’immane guerra con la rovina della finanza nazionale – dirà nel suo discorso programmatico - non ha risparmiato quella del nostro Comune e mentre prima florida dava ragione a ben sperare in una sollecita risoluzione dei diversi problemi cittadini, ora, dissestata come si è ridotta, fa tremare le vene dei polsi anche ai maggiori e provetti regitori, fa far disperare del domani. Prima della guerra eravamo riusciti ad accantonare parecchie centinaia di migliaia di lire per le opere pubbliche all’inizio delle quali con amorevoli e sollecite cure si era accinta la nostra precedente Amministrazione ma poi i mancati incassi della Tassa pomicifera determinati dal sempre diminuirsi delle esportazioni per effetto dello stato di guerra e l’accrescere degli oneri dovuti ai provvedimenti governativi per effetto della guerra stessa, aumenti di spese per rincari di materiali e di manodopera, creazione di nuovi uffici, caro vivere ed aumento di stipendi agli impiegati, ecc. dettero fondo alle economie accantonate, creando man mano il deficit per cui adesso la finanza comune è estremamente critica. La brevità data alla mia amministrazione non mi dà il tempo di espletare un programma qualsiasi e potrei essere dispensato dal fare una esposizione anche minima.”[1]
Ancora più preciso sarà il 14 aprile 1923 quando ricostruisce la vicenda degli sforzi fatti per uscire dalla crisi rispondendo all’inchiesta del Commissario prefettizio Cav. Francesco Bua.
“La guerra aveva inabissato la finanza comunale – spiegherà in una relazione che più che ai consiglieri è rivolta al Prefetto e al Governo - poiché l’unica tassa di entità, sulla quale poggiava tutto il bilancio del Comune, quella della pomice, da oltre 300 mila lire annue che era prima della guerra, si era ridotta a circa 80 mila lire, mentre le spese del Comune si erano triplicate ed anche quadruplicate. Né d’altra parte era stato possibile fronteggiare il forte deficit che man mano si era andato formando, con altre tasse locali , poiché la popolazione priva di ogni risorsa resisteva tenacemente con minaccia grave dell’ordine pubblico. Per le dimissioni del Sindaco il Prefetto affidò l’amministrazione del Comune ad un Commissario prefettizio nella persona dell’avv. Cincotta che nell’agosto venne sostituito dall’avv. Stagni Attilio, Commissario di Pubblica Sicurezza. Egli tenne l’amministrazione fino ai primi del 1920. L’Amministrazione dei due commissari prefettizi, succeduti al Sindaco Paino, non migliorò la situazione del Comune, né essi pensarono un sol momento, ad imporre le tasse, nemmeno tentarono di riscuotere quella sui cani, che pure era stata imposta dall’Amministrazione Paino, e ciò perché era grande la preoccupazione d’insurrezione della popolazione e di turbare l’ordine pubblico. D’altra parte non studiarono, né escogitarono alcun mezzo per poter fronteggiare la incombente situazione finanziaria che si avviava sempre più a gran passi verso la rovina. I pagamenti non si facevano più e i debiti del Comune si accumulavano spaventosamente, si era dunque in procinto di un vero e proprio stato di fallimento. E con gli altri numerosi creditori non si pagavano i debiti verso i medici condotti e la Cassa Provinciale per contributi scolastici[2]”.
Risanare il comune senza aumentare le tasse
Il motivo ridondante è che bisogna risanare il Comune senza aumentare le tasse. Lo dice Ferlazzo nel discorso del 23 dicembre 1919 e lo ripete con forza il 14 aprile 1923. Anzi nel 1923 c’è una motivazione in più, “il bolscevismo”. L’arrivo del fascismo aveva introdotto nel linguaggio abituale nuovi termini e nuovi nemici.
Le tasse non si potevano e non si possono aumentare per ragioni “di ordine pubblico, specie in quel tempo in cui il bolscevismo inquinava ed ammalava lo spirito Nazionale,”e più sommessamente si aggiunge “le quali del resto, in qualunque misura applicate, non potevano risolvere la situazione”.
“La disastrosa e allarmante situazione – incalza il Sindaco - impressionò fortemente la popolazione, la quale, non vedendo altra via di salvezza che nella ricostruzione di una amministrazione naturale che studiasse ed adottasse i provvedimenti più idonei e possibili nella grave contingenza senza però imposizione di tasse , reclamò energicamente e a gran voce che essa, senza ulteriore perdita di tempo si ricostruisse. E si reclamò allora che il dimissionario Sindaco Paino tornasse al suo posto: questi però non volle in nessun modo addivenire, né altri tentativi ebbero migliore fortuna, perché la situazione finanziaria faceva spavento.
Dopo vivissime, insistenti pressioni dovetti cedere io nell’assumere il posto di dovere e di sacrificio, e ciò avvenne nel gennaio 1920.

Il primo calice lo ebbi dagli impiegati[3] del Comune i quali non pagati da circa otto mesi, non prestavano servizio regolare, spesso tumultuavano, e minacciavano ancora uno sciopero generale, onde tutti i servizi erano nel più completo ed assoluto abbandono. Il disordine era generale in tutti i rami di servizio e sovraneggiava spaventosamente. La situazione era più tragica di quanto non immaginassi ed ebbi anch’io, con i miei collaboratori, momenti di grande scoramento e perplessità. Ma la voce del Dovere, l’amore sconfinato per il mio Paese, per il quale in ogni tempo la mia famiglia avea affrontato i più duri sacrifizi mi sostennero nello spirito e nell’azione e mi decisero alla più faticosa resistenza.
Chiamai a me tutti gli impiegati, feci loro comprendere il dovere e la necessità del paziente sacrificio per tutti, promisi loro tutta la mia benevolenza, come pretesi la disciplina ed il compimento del proprio dovere. Promisi di dare la precedenza al pagamento dei loro averi, arretrati di circa otto mesi, a rate ed appena possibili, rinviando il pagamento di tutti gli altri debiti del Comune. Riunii i medici condotti[4], li resi edotti della situazione, li esortai al sacrificio di rinviare l’esazione dei loro averi, al momento possibile e, con nobile sentimento di civismo, ebbi la loro incondizionata adesione[5]”.
Ma dove prendere le risorse? Questo è il primo problema da risolvere per potere ricominciare. Non potendo pensare a nuove tasse due sole sono le strade che Ferlazzo può percorrere: un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e un decreto governativo che lo autorizzi a raddoppiare la tassa sulla pomice. Questa tassa infatti non cade sulle spalle dei contribuenti locali ma sulle ditte che acquistano. L’esportazione ha raggiunto nel 1918 il punto più basso a livello del 1901 ma si spera che da un momento all’altro, finita la guerra, rasserenatisi i rapporti commerciali, riprenderà a salire[6]. Due strade difficili. La più immediata sembrerebbe quella del mutuo ed invece si rivela la più lunga tanto che nell’aprile del 1923 è ancora in itinere. Invece riesce a spuntarla prima per il decreto.
“…escogitai – spiega Ferlazzo - un provvedimento sanitario; l’invocazione al Governo di un Decreto legge che autorizzasse il Comune a raddoppiare la tassa sulla pomice all’imbarco. Appena il Consiglio comunale deliberò il provvedimento, ed ottenuta l’approvazione da parte del Prefetto, e l’inoltro al Governo, corsi a Roma, dove dopo intenso, faticoso ed incalzante lavoro, presso i Ministeri competenti, riuscii ad ottenere il sospirato Decreto, che doveva restaurare le finanze comunali.[7]”.
Quanto al mutuo, che dovrà essere di almeno 300 mila lire, si potrebbe eccepire che esso sposta l’onere in parte sulle generazioni future. Ma al nuovo primo cittadino questo non procura preoccupazioni morali giacché questa generazione ha patito “le più indicibili privazioni e sofferenze e la perdita di tanti cari, è bene [quindi] che i posteri con i benefici che in un prossimo futuro deriveranno dalla vittoria , abbiano anche una parte di oneri[8]”.
La ripresa e il rilancio di opere e servizi pubblici
Il secondo punto – dopo quello delle risorse per ripianare o contenere il deficit - riguarda la ripresa dei lavori pubblici e delle altre opere relative alla vita urbana come la pubblica illuminazione che mancava del tutto. “I fanali - ricorda Ferlazzo - nella quasi totalità, raccolti nei magazzini di deposito del Comune erano fuori uso. Provvedetti a farne riparare il maggior numero possibile e nuovi ne acquistai. Così potetti ripristinare l’illuminazione”[9].
Ma quando in quegli anni si parlava di opere pubbliche si pensava principalmente alle rotabili che si attendevano da anni ed anni. Purtroppo, a questo proposito non si poteva più pensare ad un altro mutuo, e quindi andava conseguito “nel più breve tempo possibile l’assunzione da parte dello Stato dei lavori delle strade statali Lipari Canneto e Lipari Quattropani, ed il proseguimento di quella di Canneto per Acquacalda, onde possano essere presto ripresi i lavori per quella di Canneto, appaltati quelli per Quattropani e redatto il progetto di lavori appaltati nel proseguo Canneto – Acquacalda.” E con i lavori per le strade bisogna sollecitare il Governo anche per la ripresa “dei lavori del porto, la sistemazione dei moli e delle difese degli abitati nelle rade di Sottomonastero e Piazza Sant’Onofrio per la collocazione delle promesseci boe nelle rade di Lipari, Canneto, Acquacalda, Stromboli, Filicudi, Panarea ed Alicudi, per i pontili di sbarco a Lipari e Milazzo, per il miglioramento dei servizi marittimi sia per la nostra Isola sia per Stromboli e Filicudi ed Alicudi.[10]”.
Ed insieme alle opere pubbliche, quello dei collegamenti marittimi.

Piroscafo Adele in rada
“Per effetto della guerra – ricorderà Ferlazzo nel rapporto del 1923 - i servizi marittimi delle Isole Eolie erano stati ridotti e sconvolti, da non corrispondere alle minime esigenze e necessità delle popolazioni, del commercio e dell’industrie. Per le isole che non hanno altro mezzo di comunicazione con il resto del mondo è una delle questioni delle più vitali, e le popolazioni reclamano insistentemente e talvolta eccitatissimi il ripristino dei servizi dell’ante guerra. Le isole di Panarea, Stromboli con la frazione di Ginostra e le isole di Filicudi ed Alicudi, per i loro nuovi bisogni, reclamano energicamente una nuova linea settimanale in aggiunta a quella dell’anteguerra. Sulla linea di Napoli giustamente si pretendeva un piroscafo di maggiore tonnellaggio, e di maggiore velocità, con migliori e più umani adattamenti, per la terza classe e anche per quella unica[11]. … Ma il trionfo della giusta causa arrise ancora una volta, alla sorte delle isole Eolie le quali oltre al ripristino dei servizi dell’anteguerra poterono conseguire:
- una nuova linea Lipari-Panarea- Stromboli con approdi alla frazione Ginostra e ritorno;
- una linea Lipari – Filicudi – Alicudi e ritorno quindicinalmente prolungata a Messina ;
- un piroscafo denominato Jost[12] sulla linea di Napoli di notevole tonnellaggio e di ottima velocità con magnifici adattamenti”.
Senza trascurare rotabili e piroscafo, Ferlazzo ha un occhio anche per le novità delle comunicazioni.
“Nelle mie gite a Roma potei prospettare al Ministro – ricorda il 14 aprile del 1924 - la indifferibile necessità dell’impianto del Telefono, ed alle obiezioni ministeriali delle difficoltà finanziarie, poiché il cavo sottomarino da collocare fra Lipari e Milazzo, sarebbe costato enormemente io potei suggerire di ricercare nel materiale di guerra, dei cavi presi ai tedeschi. Fatte queste ricerche ed avendo dato favorevole risultato, si poté senza troppe spese per lo Stato , ottenere l’impianto del telefono tra Lipari ed il continente, tra i primissimi altri impianti che collegarono i capi luoghi di mandamento”[13].
Non è impegno di poco conto quello che si è assunto il Sindaco Ferlazzo. Un impegno svolto diligentemente. E comunque le emergenze sono esperienza di tutti i giorni e quando si verificano, gli effetti incidono per mesi ed anni.
Il 22 maggio 1919 si era avuta un’altra terribile eruzione dello Stromboli e questa volta non erano stati colpiti solo i beni ma anche le persone. Esplosioni molto forte, grosse “bombe” e blocchi di 30-60 tonnellate si riversarono anche sui luoghi abitati. Il bilancio fu di quattro morti ed una ventina di feriti, otto case distrutte a San Vincenzo e due a Ginostra ( a S. Vincenzo una bomba di 10 tonnellate ridusse in frantumi una casa), 20 danneggiate. L’eruzione non fu preceduta o accompagnata da terremoti, ma da un forte spostamento d’aria. Il mare prima si ritirò, poi invase la spiaggia per lunghi tratti. Il Consiglio oltre a raccomandare al Governo di condonare per cinque annualità le imposte sui terreni e fabbricati perché tutti quegli abitanti sono stati fortemente danneggiati, delibera di assegnare ai cittadini di quell’isola, danneggiati nella proprietà, un sussidio di 3000 lire e si duole di “non potere concorrere per una somma maggiore date le difficili condizioni finanziarie in cui versa il Comune[14]”.

Lipari - Via Vittorio Emanuele nel 1896
Così nel precedente gennaio-febbraio si erano avute delle forti alluvioni che avevano distrutto le strade campestri, isolando diversi centri nelle campagne tanto da impedire il trasporto dei raccolti. Su una spesa preventivata di 35 mila lire per ripristinare i collegamenti, il Ministero dei lavori pubblici ne aveva elargito 15 mila ma il Genio civile non dava inizio ai lavori se non aveva a disposizione l’intera somma. Il Comune non sapeva dove reperire le rimanenti 20 mila e doveva chiede al Governo di provvedervi ampliando il sussidio[15]. Nel rendiconto del lavoro fatto il 14 aprile del 1923 il Sindaco accenna ad “interventi per le strade mulattiere rese assolutamente impraticabili dalle frequenti alluvioni degli ultimi anni che si è provveduto con un mutuo oltre ad altri sussidi dello Stato” e di “interventi per le isole minori che si stanno eseguendo”.
Il sindaco Ferlazzo fra difficoltà e tenacia
Ancora il 12 giugno 1920 il Consiglio deve rescindere il contratto con l’appaltatore, la ditta Onofrio Russo, di via Vittorio Emanuele e di via Maurolico per inadempienza in quanto dopo due anni non ha ancora ripreso i lavori. Il 14 aprile 1923 Ferlazzo può ricordare che “le domande dell’impresa erano di una tale entità e la causa così intricata e manipolata che se non si fosse data tutta la più attenta e incessante assistenza il Comune pericolava di avere la peggio, pure avendo sostanzialmente ragione”.

Nemmeno i cimiteri sono stati trascurati, sosterrà il Sindaco, contestando le affermazioni del commissario Bua. Riconosce che le vecchie mura che ne chiudono il recinto sono in parte in cattive condizioni statiche ed anche cadenti e da qualche parte è anche agevole l’accesso in maniera che qualche volta è possibile eludere la vigilanza. Tale stato di cose si è determinato a causa delle alluvioni recenti e l’amministrazione oltre ai provvedimenti urgenti adottati per i lavori di minore entità, ottenne dal Consiglio comunale nella seduta del 18 agosto 1922 l’approvazione del progetto della ricostruzione delle mura di cinta e la costruzione di nicchie a colombaia. Per cui quanto prima si procederà all’esecuzione dei lavori. Inoltre nel 1922 fu dato incarico all’ing. Amendola di redigere progetti per i cimiteri di Alicudi, Filicudi, Panarea, Ginostra, Vulcano Piano, Vulcano Gelso, Quattropani ed Acquacalda.
La relazione di autodifesa del 14 aprile 1923 trova il voto contrario dell’opposizione anche se quando il nuovo consiglio, dopo le elezioni amministrative, era tornato a riunirsi l’11 ottobre 1920, Ferlazzo era stato rieletto Sindaco all’unanimità. Grazie al raddoppio della tassa sulla pomice ma, soprattutto, alla ripresa della sua esportazione si era riusciti se non a risanare il bilancio quanto meno a contenerne il deficit. Nel dibattito che ne era seguito il consigliere De Mauro si augurava che ora venissero affrontati in particolare tre problemi: la sistemazione della città murata lasciata libera dai coatti sgomberando le casupole cadenti e realizzando, al loro posto, nuove case e magari anche un albergo “per stimolare qui in Lipari il movimento dei forestieri”; la costruzione di un nuovo ospedale giacchè quello esistente – l’Ospedale dell’Annunciata - oltre ad essere malmesso, dovrà subire una demolizione parziale quando si porrà mano alla sistemazione di via Vittorio Emanuele[16]; infine e soprattutto la scuola sia per quanto riguarda i locali, “diversi dei quali sono stati giudicati pericolanti e purtroppo ancora frequentati dagli alunni e dai maestri”, ma soprattutto per quando riguarda l’istruzione : bisogna che l’amministrazione si assuma l’impegno di fare sparire dalle Eolie la parola analfabetismo.
Per il resto questa prima seduta si era consumata fra elogi e convenevoli. Si salutava e si elogiava il prof. Emanuele Carnevale, definito “autorevole milite della concordia cittadina” che tornava in Consiglio dopo molto tempo; si salutava e si elogiava il marchese Ugo di Sant’Onofrio, ”benefattore delle Isole Eolie, venerato cittadino onorario” che era stato nominato Senatore del Regno; si salutava Fiume, “città martire”ed “il suo eroico comandante Gabriele D’Annunzio” e con Fiume tutta la “infelice ed eroica” Dalmazia.
Anche il Consiglio del 22 gennaio se ne andava, in parte, – come abbiamo già detto nei capitoli precedenti – per commemorare il risultato della vittoria alla Corte di Cassazione nella controversia col vescovo per la proprietà delle cave; poi il Sindaco informava sulla missione a Roma – sempre accompagnato dal marchese Ugo di Sant’Onofrio, da altri parlamentari e dal consigliere provinciale De Mauro - per sollecitare i vari ministeri per i collegamenti marittimi, per i lavori pubblici, per i sussidi alla gente di Filicudi che aveva avuto le case danneggiate dal terremoto, dell’acqua potabile per la siccità estiva che sarebbe stata questa volta a carico dello Stato.
Infine illustrava le linee programmatiche del suo quadriennio cominciando col ricordare che i problemi finanziari non erano ancora finiti ed il bilancio presentava un deficit ancora di 300 mila lire. Sui servizi. L’illuminazione pubblica a petrolio non sarebbe stata più gestita direttamente dal Comune ma data in appalto mentre si sperava al più presto di arrivare all’illuminazione elettrica. A questo proposito informava di un progetto che voleva utilizzare le fumarole di Vulcano per ricavare l’energia necessaria a produrre elettricità.
Quanto all’acqua non poteva che constatare che il costo di questa, durante i periodi di siccità, era divenuto pesante. L’anno precedente era costato 60 mila lire e si era riusciti a convincere il Ministero dell’interno a farsene carico ma non era strada che potesse essere ripercorsa facilmente. Bisognerebbe verificare una volta per tutta se nell’isola esistesse acqua sorgiva.
Infine il problema delle scuole. “Le attuali aule scolastiche, sono delle più umilianti, mentre il Comune è costretto a pagare ingenti fitti, per i locali che spesso è difficile trovare. Si faranno sollecitamente studiare i progetti e ottenere la costruzione coi benefici provenienti dalle leggi”[17]. Ma per incamminarsi in questa prospettiva dovranno passare ancora trent’anni.
E’ un Sindaco tenace Ferlazzo, ma i problemi sono tanti e sembra che tutti si avvitino su se stessi. Le strade non ripartono, le opere marittime procedono lentamente, la pomice fatica a riprendere, l’elettricità e l’acqua sufficiente sembrano una chimera. Che fare?
Nel giugno dell’anno precedente è di nuovo al Governo il vecchio Giolitti e Ferlazzo pensa di rivolgersi a lui. Chiede a Sant’Onofrio che gli procuri un appuntamento e lo ottiene. Si prepara bene il Sindaco all’incontro. Scrive una memoria con i problemi più importanti. Ed è un bene che l’abbia fatto perché a Roma – il 18 aprile 1921 - non riesce a vedere il Presidente ma deve accontentarsi del Sottosegretario alla Presidenza a cui consegna la nota. E Giolitti si interessa. Mette in moto il Ministro dei Lavori Pubblici e questo dopo qualche tempo relazione al Presidente del Consiglio e il Sindaco può leggere con soddisfazione la nota al Consiglio. Il Ministro ha interessato il Genio Civile di Messina e le opere pubbliche terrestri e marittime dovrebbero risvegliarsi.
Nella lunga autodifesa del 14 aprile 1923 a proposito dei lavori pubblici Ferlazzo dirà.

Canneto "vucca u vadduni"
“Altro problema vitale per quanto annoso, era quello delle strade rotabili Lipari – Canneto con prolungamento ad Acquacalda e Lipari – Quattropani, che per l’entità della spesa, se non fossero passate al totale carico dello stato e della provincia sarebbero sempre rimaste un’aspirazione. Con Decreto ministeriale del 30 febbraio 1920 furono ammessi al beneficio del Decreto luogotenenziale del 1918 le rotabili a) Lipari Canneto; b) Lipari Quattropani; c) Lipari Porto Pignataro; d) Canneto Acquacalda” e successivamente la mulattiera dalla frazione Ginostra a S. Vincenzo nell’isola di Stromboli.
“Un lavoro veramente estenuante – commenta il Sindaco - ha dovuto affrontare l’Amministrazione comunale e quotidianamente per ottenere la ripresa dei lavori della rotabile Lipari – Canneto e per l’inizio di quella per Quattropani; ed io in ogni mio viaggio a Roma, ho fatto il diavolo a quattro, conferendo con Ministri, sottosegretari di Stato, interessando anche S. Ecc. Giolitti quando presiedeva il Ministero. Ora ho potuto avere sicuri affidamenti da S. Ecc. Carnazza, per sperare che , sotto il Governo di S. Ecc. Mussolini, al fine si potrà conseguire quanto è stato per decine di anni, la costante legittima aspirazione della popolazione di Lipari”.
[1] Il discorso tenuto il 23 dicembre 1919 è riportato nel verbale della seduta del 2 febbraio 1920.
[2] Questo documento comprese le risultanze dell’inchiesta del Commissario Francesco Bua è nel verbale del consiglio comunale del 14 aprile 1923.
[3] Il Comune doveva contare circa 40 dipendenti. Quando il 13 aprile 1925 il Consiglio discute della nuova pianta organica questa prevede appunto 41 dipendenti divisi in sette ruoli. Il primo ruolo riguarda i dipendenti presenti nella casa municipale e sono 17 (un segretario, un vice segretario, un ragioniere, un tesoriere, un archivista, cinque applicati di segreteria, un agente riscossione della tassa pomice in Canneto, un dattilografo copista, un usciere, un messo comunale e tre messi rurali); corpo delle guardie municipali era composto da un capoguardia e da cinque guardie; il corpo addetto alla vigilanza per la pomice comprendeva: un direttore tecnico minerario, un comandante guardie campestri o vigili pomici feri, cinque guardie, un conduttore battello comunale; la custodia del cimitero prevedeva: un custode cimitero di Lipari, un seppellitore cimitero di Lipari e un custode e seppellitore cimitero di Stromboli; un maestro di musica; per le scuole vi erano un bidello scuola tecnica o complementare e due bidelli scuole elementari; per le carceri: un custode carcere mandamentale e un giardiniere.
[4] Il Comune contava allora sette condotte mediche: due a Lipari centro ( 11.000 ab circa.) di cui una sovrintendeva le borgate di Pianoconte (500 ab.) , Quattropani (500 ab.) e Vulcano ( 400 ab.); una a Canneto ( (2.000 ab.) con le frazioni di Sparanello, Lami ed Acquacalda ( 500 ab.); una a Stromboli (2.200 ab,) con Ginostra ( 400 ab.), una a Filicudi ( 1.300 ab.), una ad Alicudi ( (800 ab.).
[5] Verbale del Consiglio comunale del 14 aprile 1923.
[6] Proprio nel 1919 l’esportazione riprenderà a salire ma solo nel 1923 si porterà ai livelli dell’anteguerrà e ciò sulle 30 mila tonnellate all’anno.
[7] Verbale del 14 aprile 1923
[8] Verbale del 23 dicembre 1919.
[9] Verbale del 14 aprile 1023.
[10] Verbale del 23 dicembre 1919.
[11] Le richieste del Comune per i servizi marittimi approvate nella seduta del 18 agosto 1922 erano state::
Linea I Milazzo- Lipari – Canneto- Acquacalda- S. Marina – Malfa – Rinella – e ritorno, giornaliera sia fatta con piroscafo di 500 tonnellate di stazza lorda e di velocità di 14 miglia orarie Che tutti i locali per i passeggeri, anche quelli di terza classe, siano in buone condizioni con istallazioni chiuse in grado di riparare i viaggiatori dalle intemperie. Le stesse caratteristiche deve avere il piroscafo “di rispetto” cioè che dovesse sostituire quello di linea per emergenze o riparazioni.
Linea II che parte da Messina-Lipari- Canneto – Acquacalda, S. Marina – Malf – Capo – Panarea – Ginostra – Stromboli e ritrono, settimanale con piroscafi della velocità di 10 miglia orari e di 500 tonnellate di stazza lorde.
Linea III a – Messina – Lipari – Canneto – Acquacalda – S. Marina – Capo – Malfa – Pollara – Filicudi porto – Filicudi Pecorini – Alicudi e ritorno passando da Flicudi Pecorini – Filicudi porto -
Rinella – Lingua – S. Marina – Acquacalda – Canneto – Lipari – Messina.
Linea III b – invertendo l’andata e ritorno con la linea III a) entrambe settimanali con piroscafi di 500 tonnellate velocità 10 miglia orarie.
Linea IV – Lipari – Canneto – Panarea – Ginostra – Stromboli e ritorno settimanale sempre con piroscafi di 500 t. e 10 /mh.
Linea V – Messina – Lipari- Canneto – Acquacalda – Filicudi Porto – Filicudi Pecorini e ritorno
Linea V bis – Lipari – Canneto – Vulcano Gelso – con ritorno a Vulcano porto – Canneto – Lipari settimanale
Linea II bis ( Gruppo Sicilia) Messin a- Milazzo – Lipari- Canneto- Acquacalda – S. Marina – Lingua – Rinella – Pollara – Malfa – Capo – Panarea- Ginostra – Stromboli – Napoli e ritorno, settimanale con piroscafi di stazza lorda di 1000 tonnellate e dalla velocità minima di 12 mh.
[12] Probabilmente questo piroscafo venne sostituito perché non risulta che sulle rotte per le Eolie sia mai entrato in funzione un mezzo con questo nome.
[13] Verbale del 14 aprile 1923.
[14] Dal verbale del Consiglio comunale del 28 giugno 1919.
[15] Dal verbale del Consiglio Comunale del 21 giugno 1919
[16] Nel Consiglio del 14 aprile 1923 il Sindaco a proposito dell’Ospedale esistente dirà che esso dipende dalla Congregazione di Carità. Esso però è anche un ricovero di mendici inabili al lavoro. L’amministrazione comunale intende provvedere, rassicura il Sindaco, ad un nuovo ospedale secondo le esigenze moderne e ne ha già acquistato il terreno. La demolizione parziale di cui parla il consigliere De Mauro riguarda la parte che si spingeva verso la chiesetta del Rosario lasciando lo spazio di un vicolo, il cosiddetto ‘u strittu a Sena dove terminava, appunto con una strozzatura che doveva essere eliminata, via Vittorio Emanuele.
[17] Dal verbale del Consiglio comunale del 22 gennaio 1921.
Eruzione dello Strombolll personaggio: Madre Florenzia Profilio
Fanciullezza e gioventù a Pirrera


Sopra . L'aurora su Pirrera e , sotto, la cassa dove nacque Giovanna Profilio e visse la sua fanciullezza e prima giovinezza. Due acquerelli di Armando Saltalamacchia.
Madre Florenzia Profilio, al secolo Giovanna, nasce a Pirrera all'alba del 30 dicembre del 1873 da Giuseppe e Nunziata Marchese. Quella dei Profilio è una onesta e laboriosa famiglia contadina. Il padre coltiva la sua terra ed altre che prendeva a mezzadria ed in più – visto che la famiglia andava crescendo e le esigenze si facevano sempre più numerose – commercia vino andandolo a vendere a Napoli e Torre del Greco. Finchè Giuseppe potrà lavorare la famiglia vivrà in una parsimoniosa agiatezza il quieto ritmo delle giornate contadine. Giovanna che è la terza di sette fratelli frequenta , la scuola elementare fino alla terza .



Altri tre acquerelli di Armando Saltalamacchia. In alto. Lipari vista da Pirrera. Sopra a sinistra, i sentieri che collegavano Pirrera a Lipari e a destra, Un bagghiu di una casa di campagna.
La bambina cresce serena nella tranquilla calma di Pirrera, distante dai problemi e dalle tensioni di Lipari, molto di più dei pochi chilometri che la separano. Fin da piccola mostra una tendenza al misticismo ed all'introspezione ed ha anche imparato ad ascoltare delle voci che sente dentro di se, come confida alla sorella. Questa vita cadenzata dal ritmo delle stagioni entra in crisi nel 1885 con la malattia del padre, una forte artrosi a cui si aggiungono , nel tempo, complicazioni cardiache. Quando il padre muore, dieci anni dopo, oramai tutti i risparmi si sono prosciugati e mamma Nunziata non vede altra prospettiva che emigrare in America, a New York, dove da tempo si è stabilito un suo fratello che ha fatto una discreta fortuna. Così in una mattina di marzo del 1896, mamma Nunziata con sei dei suoi sette figli (Antonino rimarrà perchè studia in Seminario per diventare prete) affronta - come altre centinaia di migliaia di italiani in particolare del Meridione – la prova dell'emigrazione.



Tre immagini di Florenzia in tre momenti della sua vita
L'esperienza americana
L'esperienza Americana durerà per Giovanna nove anni e saranno nove anni decisivi per la sua vita . E decisivi non solo perchè scoprirà la miseria e la sofferenza nella durezza del viaggio in nave ed in terza classe, le umiliazioni della quarantena di Ellis Island, il ritmo vorticoso e dissipatore di una metropoli in crescita quale è la New York di fine 800, la vita in fabbrica con i problemi legati all'organizzazione del lavoro così lontani dalla vita fino allora vissuta, ma soprattutto perchè lì, a New York, nel quartiere dove andrà a vivere, si chiarirà la sua vocazione e deciderà – anche contro la volontà di sua madre – di farsi suora e suora francescana come francescani sono i frati della chiesa di Saint Antony in Sullivan Street e le suore di Prince Street, a cento metri dalla chiesa, che ha preso a frequentare giornalmente.

La chiesa di Sant'Antonio a New York in Sullivan street
Al di là dei progetti della madre probabilmente Giovanna, divenuta nel frattempo - il 22 luglio 1900 – Florenzia con la professione dei voti semplici, pensa che lì in quella terra nuova e dai mille problemi che impara giorno per giorno a conoscere si svilupperà la sua esistenza futura. Ma non sarà così. Il vescovo di Lipari vuole che torni in patria perchè a Lipari c'è bisogno di lei per creare un istituto di suore che si occupi dei bambini e delle ragazze abbandonate. E Florenzia ubbidisce e il 7 febbraio 1905 si imbarca per l'Italia.
La nascita dell'Istituto

La casa madre di Lipari oggi.
A Lipari però scopre che il progetto che le è stato prospettato non è di facile realizzazione e capisce che il suo Istituto nascerà soprattutto se a volerlo sarà lei e se la sua famiglia la aiuterà non solo col sostegno morale ma anche quello economico. Il Vescovo e i preti amici la sosterranno ma il carico di impegno sarà soprattutto suo. E così sarà. L'1 novembre nasce il nuovo Istituto con il decreto del Vescovo mons. Raiti e l'approvazione delle Costituzioni e degli statuti. La cerimonia sarà solenne e ampiamente partecipata, ma non bisognerà farsi illusioni, questo è solo il primo passo di un lungo e faticoso cammino, pieno di sofferenze.
Il primo problema difficile che le si pone è quello di creare una casa di noviziato in Sicilia perché a Lipari le vocazioni sono poche e le famiglie siciliane non mandano volentieri le loro figlie in un’isola. E sarà questo il problema che angustierà Florenzia per molti anni: conservare a Lipari la casa madre e costituire ad Acireale la casa del noviziato. Per questo obiettivo si batterà anche con i superiori ecclesiastici come Mons. Ballo, Amministratore Apostolico di Lipari dal 1921 al 1928, che invece riteneva che Florenzia non fosse adatta a fare la superiora e la scelta migliore era di chiudere l'Istituto e fare confluire le suore in qualche altra Congregazione.
La avrà vinta Florenzia che saprà perseverare con pazienza ed umiltà, sempre ubbidiente ma anche tenace , richiedendo sforzi durissimi al suo organismo che infatti ben presto comincerà a risentirne. Nel giugno del 1922 quando decide di andare ad Acireale e fare ogni sforzo per aprire lì la casa nel noviziato, l'Istituto può contare poche esperienze in piccoli centri, spesso caratterizzate dalla precarietà, come Alimena, Malfa , Gangi. Più solida si dimostrerà l'esperienza di Petralìa Sottana che aprirà il 16 novembre 1921 e che con Acireale e Lipari rappresenteranno, per un certo tempo, le tre punte di forza dell'Istituto. Comunque gli anni che vanno dal 1920 al 1924 furono anni terribili perchè l'atteggiamento di ostilità di Mons. Ballo verso Florenzia ed il suo Istituto di fatto aveva bloccato le vestizioni e le professioni di fede. E pure ci furono quelle che perseverarono ed anche questa fase si poté superare. Finita l'Amministrazione Apostolica di Mons. Ballo, che nel 1926 si era estesa anche ad Acireale, l'Istituto prende vita. Si diffonde nei grandi centri della Sicilia: prima Trapani nel 1930, quindi Catania, nel 1933, quindi a Palermo nel 1930. Questo non vuol dire che si trascurano i centri minori: nel 1935 si apre la casa di Adrano, nel 1938 a Stromboli,nel 1940 a Giarratana, nel 1941 a Pettineo, nel 1942 l'Istituto passa lo Stretto e si apre una casa a Rosarno in Calabria.
L'apertura della sede a Roma

Casa Generalizia di Roma
Ma il pensiero costante di Florenzia è quello di aprire una casa a Roma e di farne la Casa Generalizia. E' questo, le sembra, che sancirà la stabilità definitiva dell'Istituto che lo ancorerà al cuore della Chiesa. Così il 22 maggio 1945, appena sancita la fine della guerra, parte per Roma sapendo che si trattava di un avventura durissima con le ferrovie interrotte, molte strade impraticabile, la città che usciva da un periodo travagliato nel quale era stata dichiarata “città aperta”, con problemi giganteschi sul piano sociale a cominciare da quello delle abitazioni che erano introvabili. La “missione romana” di Florenzia ha del miracoloso. Il 22 maggio parte per Roma, accompagnata da due suore, senza sapere nemmeno dove alloggiare appena arrivate, senza una indicazione per l'acquisto di una residenza e tantomeno senza garanzie sull'autorizzazione del Vicariato ad aprire una casa a Roma, ed il 30 giugno entra nella nuova sede di Monte Mario ancora parzialmente occupata da famiglie sfollate.. Il 25 aprile del 1949 l'Istituto , che fino ad allora era stato solo di “diritto diocesano”, col cruccio di Florenzia che ciò rappresentasse un elemento di precarietà, veniva dichiarato con Decreto della S. Congregazione dei Religiosi di diritto pontificio.
Le missioni in Sudamerica

Cravinhos in Brasile . Sotto, la casa delle suore negli anni 60.

L'apertura della sede di Roma non interrompe il processo di apertura di nuove sedi. Ma Florenzia non ha mai smesso di pensare alle missioni e l'occasione arriva nel 1953 quando un cappuccino missionario in Brasile le prospetta l'apertura di una sede a Iataì, nello stato di San Paolo. Ha ormai 80 anni la madre ed è piena di acciacchi e di malanni ma sempre attenta ai problemi dell'Istituto e delle suo suore, che segue una per una anche se ormai si avvicinano al centinaio.. Ma a Jatai i rapporti con l'Ospedale non sono buoni e così le suore decidono di spostarsi a Cravinhos sempre nello stato di San Paolo. Questa sarà l'ultima decisione che prenderà Florenzia perchè il 21 febbraio del 1956 morirà a Roma. Le suore si stabiliranno a Cravinhos il 28 maggio. In America Latina la missione delle nostre suore procederà nel 1975 in Amazzonia fino al 1983 quando l'esperienza verrà conclusa, ed infine nel 1985 in Perù.
Oggi Florenzia è in cammino per essere riconosciuta santa. Il processo di beatificazione è iniziato il 25 dicembre del 1985 e da quel momento Florenzia può essere chiamata “Serva di Dio”. Il cammino naturalmente è molto lungo e difficile. Se esso dovesse andare in porto sarebbe la prima santa che Lipari potrebbe vantare o il secondo se si dovesse contare quel Sant'Agatone che fu il primo vescovo ed accolse a Portinente le reliquie di San Bartolomeo il 13 febbraio del 264.
Bibliografia
M.Giacomantonio, Florenzia che ha svegliato l'aurora, Edizioni Paoline, 2009
G.A. Castagna, La roccia e lo spirito, Paoline, 1967.
A.Lo Cascio ofm cap., Un piccolo strumento nelle mani della Provvidenza, Palermo, 1975.
Mons. Ballo
Le Eolie e la “grande guerra”.
Una guerra lontana per i più

Certo le Eolie, come d’altronde tutta la Sicilia, erano lontane dal fronte di guerra, eppure non si può dire che ne siano rimaste estranee ed indifferenti. Al di là di molta retorica che voleva che la guerra affratellasse l’Italia in realtà gli effetti interni, economici e sociali, furono sicuramente più negativi che positivi. Perché, se è vero che i contadini meridionali e gli operai settentrionali parteciparono alla lotta a fianco alla borghesia, scoprendo di fare parte di una stessa nazione e sperando in un riscatto sociale, è ancora più vero che la guerra del 1915-18, come d'altronde quella coloniale del 1911-12 voluta da Giolitti, si rivelò – oltre che pesante in termini di perdita di vite umane tanto che non c'è paese della Sicilia che non abbia la sua lapide di caduti - anche eccessivamente costosa ed incise duramente proprio sul mezzogiorno e le zone rurali bloccandone lo sviluppo, stravolgendo i commerci, comprimendo i prezzi del grano e della farina e alimentando così il mercato nero e con esso la mafia. Inoltre i contadini tornati dal fronte trovavano disoccupazione e nuove restrizioni all'emigrazione e vivevano in clima di continua tensione ed agitazione come, d'altronde, i piccoli borghesi che avevano ricoperto, durante i combattimenti, ruoli di ufficiali e di comando ed ora mal sopportavano di dover tornare a funzioni subalterne. Questa tensione e questa agitazione qualche volta divenivano protesta politica come per l'occupazione delle terre, oppure progettualità sociale attraverso il movimento cooperativo, ma più spesso, purtroppo, trovavano sfogo in forme di microcriminalità e di prevaricazione E sarà proprio questa miscela esplosiva di frustrazione, microcriminalità e prevaricazione – diffusa su tutto territorio nazionale – che verrà utilizzata da strutture di potere senza scrupoli per dar vita a quella svolta reazionaria che porterà al fascismo.
Di questa travagliata vicenda le Eolie, oltre alle lapidi con i loro tributi di sangue, conservano ben poco nella memoria collettiva anche se Lipari, come abbiamo visto, non mancò allora di partecipare all'eccitazione nazionalistica e patriottica che si sviluppò dal 1911 fino al 1918. Ma Lipari e le Eolie soprattutto risentirono gravemente delle restrizioni e dei condizionamenti bellici a cominciare dall'industria della pomice che si vide chiusi molti mercati e quindi ridurre fortemente le esportazioni e con esse il lavoro degli operai e le entrate del Comune per il quale la tassa sulla pomice era divenuto l'unico vero provento. Una economia di sopravvivenza, mancanza di lavoro, carenza di generi alimentari, collegamenti marittimi traumatizzanti , blocco delle opere pubbliche sono i caratteri più significativi di questa fase.

Ma i problemi economici si fanno sentire
Dure e realistiche sono le considerazioni a proposito del Bilancio comunale che fa il consigliere Palamara nel Consiglio del 2 maggio 1917. “Nessuno ha saputo prevedere – esordisce il relatore in un discorso che è lontano dalla retorica nazionalistica di quei tempi – la durata di questa immane conflitto e nessuno può ergersi a profeta per prognosticare la fine. Di ciò la necessità di occuparci e di preoccuparci delle risorse del nostro bilancio che vanno sempre più sensibilmente assottigliandosi e necessariamente si dovrà al più presto ricorrere alle odiate tasse, che potrebbero in parte scongiurarsi imponendosi la più stringata economia”. Ma nel momento attuale il paese non può sopportare alcuna tassa e quindi bisogna rinunciare alle spese facoltative. Già nel 1916 senza le spese facoltative si avrebbe un disavanzo di circa 100 mila lire che nel 1917 raddoppieranno sempre non considerando le spese facoltative. Quanto al mutuo in cui si spera, si tratta di “un pio desiderio per gli ingenui”. Quindi si è di fronte ad una alternativa: o aumentare le tasse o prendere delle decisioni drastiche rispetto alle uscite “sopprimendo e sospendendo tutto ciò non dovuto per legge e limitando le spese obbligatorie al vero fabbisogno”.
Nel Consiglio del 21 dicembre dello stesso anno si discute sulla risposta della Cassa Depositi e prestiti a cui si era chiesto un mutuo di 300 mila lire per portare a compimento le opere appaltate fin dal 1914 che sono la rotabile Lipari-Canneto e il lasticamento delle vie Vittorio Emanuele e Maurolico di Lipari e i cui lavori procedevano regolarmente. La Cassa dice che vista la situazione generale, Lipari deve ridurre la richiesta al finanziamento di una sola opera. L’assessore ai lavori pubblici Felice Ferlazzo dice che questo è impossibile. Lipari fin che ha potuto ha fatto fronte con i fondi comunali ma ha chiesto il mutuo quando questi, per la crisi della pomice, si sono venuti esaurendo. Bloccare alcuni lavori vuol dire subire danni ingenti. Per cui alla Cassa si deve rispondere che Lipari ha bisogno di non meno di 170 mila lire.
Comunque la crisi del Comune si trascinerà e nel luglio del 1919 si arriverà alle dimissioni perché l’amministrazione è bloccata da uno sciopero dei dipendenti salariati che reclamano gli aumenti, il carovita, il pagamento degli arretrati. Il Sindaco Gaetano Paino non sa come farvi fronte proprio per le gravi condizioni del bilancio conseguenza della guerra che “ha tutto sconvolto”.
Fra paura delle epidemie ed ospiti indesiderati
La guerra non vuol dire per le Eolie soltanto crisi economica ed amministrativa. Pesa su queste isole il marchio di luogo di confine e per alcuni relegati che partono altri ne arrivano e comunque la psicosi dei possibili arrivi di ospiti indesiderati portatori di epidemie fisiche o morali permarrà a lungo.
La vittoria in Libia aveva avuto una conseguenza. Sul finire del 1912, erano stati mandati al confine a Lipari una decina di persone reduci della resistenza in Tripolitania. Questi erano stati alloggiati in casupole e magazzini fatiscenti nel quartiere di Sopra la terra. Da allora quella zona si chiamò quartiere arabo e questa etichetta rimase nel tempo anche quando questi reduci, dopo meno di un anno, andarono via e lì rimasero ad abitare solo i pescatori acitani che divennero anch’essi “gli arabi”[1].
Comunque la paura che “gli arabi” potessero tornare ed in maggior numero, rimase nel paese tanto che il 10 giugno 1915 il Consiglio comunale si mobilita quando si diffonde la notizia dell'arrivo di 600 arabi espulsi dalla Tripolitania. Si decide di telegrafare al Ministro dell'interno, al Prefetto ed al deputato del collegio, l’on.Ugo di Sant'Onofrio, chiedendo di sospendere l'invio, per l'oggi ma anche per l'avvenire. E si ricorda, una volta di più, che Lipari se malamente sopporta una colonia di domiciliati coatti – che è ancora presente - non potrebbe tollerare questi nuovi confinati, i quali costituirebbero grave pericolo per la pubblica salute e per la moralità.
Il 27 dicembre il Consiglio Comunale viene convocato perché ci sono due novità: una che rallegra ed una che preoccupa. La buona notizia è che finalmente è stata tolta la colonia dei coatti e per questo si ringrazia il Governo e ci si augura che il futuro non debba più presentarsi questo problema perché – viene detto in Consiglio – la colonia non è scuola di redenzione ma di criminalità.
Chiusa la colonia i reclusi vengono in parte trasferiti, altri tornano alle loro case, diversi - oltre quelli che da tempo si erano accasati e si erano rifatti una vita - rimangono a Lipari, molti sbandati ed emarginati. a vivere come barboni, sempre ubriachi, gettati lungo le strade. Ancora nel 1919 il Consiglio fa voti che sia ripristinata a Lipari una Brigata di Pubblica Sicurezza ed a Canneto una sottobrigata giacché nel Comune c’è “un numero considerevole di coatti che possono turbare, come speso avviene, l’ordine pubblico”[2] .
La notizia che preoccupa e che a Lipari sono arrivati e stanno arrivando nuovi ospiti. Quanti? La voce di popolo parla addirittura di 30 mila. Il 27 dicembre ancora non si sapeva se si trattasse di profughi o prigionieri ed il Consiglio – pur ritenendo che un contributo Lipari doveva darlo ai sacrifici per la guerra in corso – aveva chiesto che - piuttosto che profughi che, per i disagi patiti, potevano essere veicolo di malattie ed inoltre sarebbero stati liberi di muoversi per il paese – si mandassero a Lipari dei prigionieri che sarebbero stati controllatati dai soldati e alloggiati in luoghi assegnati. Infatti Lipari era un’isola popolosa, aveva problemi d’acqua, non aveva adeguate strutture sanitarie e se scoppiava una epidemia sarebbe stato un dramma per tutta la popolazione. Inoltre una epidemia avrebbe nociuto al commercio della pomice che ora, dopo la guerra, si sperava che riprendesse a pieno ritmo. Invece, quando il Consiglio torna a riunirsi il 27 gennaio è chiaro che si tratterà di profughi e fra di essi alcuni sono malandati in salute. Inoltre l’ufficio sanitario dove vengono visitati è proprio posto in centro al paese e quindi cresce l’allarme. A questo punto il voto del Consiglio è che ci si limiti ai profughi già arrivati e non se ne mandino altri e se proprio altri ne devono arrivare vengano dopo un periodo di quarantena, che vengano mandati infermieri e personale sanitario e il gabinetto batteriologico sia tolto dal paese e spostato al Castello, che anche al Castello vengano fatti alloggiare gli ospiti.

Probabilmente la preoccupazione per i profughi rientrò in fretta . Essi furono mandati al Castello ed anche al Castello, nei locali dell’ex palazzo vescovile, fu spostato il gabinetto batteriologico Rimase invece viva nella popolazione la preoccupazione per il ripristino della colonia coatta .Ed ogni tanto questa esplodeva. Come quando si diffuse la voce che alcuni interessati avessero inviata una petizione al Governo per chiedere il ripristino della colonia. Così il Consiglio del 5 dicembre 1916 vota un ordine del giorno in cui si minacciano le dimissioni in massa se dovesse verificare questa eventualità ed all’on. Ugo di Sant’Onofrio si fa sapere che la fiducia che il paese ripone nella sua persona sarebbe scossa profondamente.
Il Lazzaretto a Pignataro di fuori
Ma per quante assicurazioni si ricevessero la preoccupazione restava e, come vedremo, nel 1926 portò ad una vera e propria sollevazione popolare.
Quando l’amministrazione comunale faceva presente al Governo che l’isola era impreparata a far fronte ad epidemie e che l’eventuale diffusione di queste avrebbe creato problemi drammatici era perché con questa preoccupazione si era convissuti fin dal 1911 quando si ripresentò il problema del colera e più tardi, negli anni della guerra e del dopoguerra[3], anche quello del vaiolo. Ed è stato per questo che fin dal 21 giugno 1911 l’amministrazione comunale fu sollecitata dalla Prefettura a disporre di un ospedale di isolamento per mettere i malati di malattie infettive. Così fu preso in affitto un fabbricato a Pignataro di Fuori di proprietà del’ing. Gaetano Martines e quel posto, da allora, si chiamò il Lazzaretto. Non sappiamo se si trattò di una pura formalità perché era necessario avere un posto con questa finalità o se veramente lì furono ricoverati dei malati infettivi. Il fatto è che nel 1919 l’edificio risultava non “idoneo,” perché semidistrutto, mancante degli infissi, inaccessibile via terra e raggiungibile solo a mezzo barca[4]” e per queste ragioni, quando ci fu una epidemia di vaiolo, non si potè farne uso e si dovette occupare, per tale scopo, il vecchio palazzo vescovile[5] al Castello. Così il Commissario prefettizio, Attilio Stagno, che era stato mandato a sanare una situazione disastrosa, disdisse l’affitto..

Pignataro case di fuori dove era collocato il Lazzaretto.
[1] G.Iacolino, Strade che vai, memorie che trovi, Milazzo 2008, pag.140-141.
[2] Verbali del Consiglio Comunale del 4 febbraio 1919.
[3] Una epidemia vaiolosa si sviluppa nel 1919 e 1920 infatti nel Consiglio del 28 marzo 1922 il Presidente informa che “il signore Esposito Salvatore ha fornito al Comune per gli infermi ricoverati in questo Lazzaretto, il casermaggio per un complesso di giorni 377 e precisamente dal 19 marzo 1919 al 31 marzo 1920 al prezzo convenuto di lire 0,55 per ogni fornitura di letto completo” e quindi per un totale di lire 4.385,00.
[4] Verbale del Consiglio comunale del 17 settembre 1919.
[5]Per questo edificio che probabilmente era divenuto ospedale di isolamento e anche centro di controllo sanitario dei profughi giunti nel 1915, ma non era entrato nelle disponibilità del Comune, il 22 febbraio 1919 il Consiglio chiede al Governo l’occupazione temporanea del caseggiato che afferma essere di proprietà demaniale, il camerone San Nicola, il gabinetto batteriologico ed il bagno annessovi potendo il Comune avere bisogno di adibirlo in linea provvisoria per ospedale qualora venisse a mancare l’ospedale attuale. Delibera anche di chiedere il materiale sanitario di arredo. Dal verbale del Consiglio del 22 febbraio 1919
L'ing. Gaetano Martinez
“Noi manchiamo di tutto!Tutto!Tutto!”
Le difficoltà dei collegamenti marittimi

Con la Società Siciliana di navigazione a Vapore, come abbiamo visto, si erano avute corse quotidiane con Milazzo, settimanali con Messina e da qualche anno funzionava anche una linea con Napoli ma il vero problema era la qualità dei navigli. I collegamenti con Filicudi e Alicudi erano quindicinali - più tardi settimanali e bisettimanali- e venivano subappaltati all’armatore liparese don Francesco La Cava il quale utilizzava dei navigli piuttosto modesti suoi modesti natanti - l’Unione, la Famiglia, l’Organetto - che male sopportavano il vento ed il mare e la situazione non migliorò di molto quando la Società acquistò dalla Finanza due ex motovedette – la Flora e la Zelina – che affidò alla gestione di padron La Cava. Non più stabili però erano i mezzi della Società armatoriale: il Mazzini che faceva la linea giornaliera, l’Eolo quella per Napoli e lo Scilla che veniva utilizzato nelle frequenti sostituzioni dei primi due. Erano navigli logori e fradici che non superavano le 10-12 miglia orari cioè due ore e mezza da Lipari a Milazzo e cinque per Messina. Anche il vapore Adele che fu immesso nel 1908 sulla linea principale era vetusto e con pessime condizioni di stabilità. La terza classe era a cielo aperto e angusta e in pochi metri quadrati erano costretti a stare insieme passeggeri, detenuti in transito e bestie da macello intossicati dal fumo della ciminiera o schiaffeggiati dalle onde del mare o dalla pioggia. Eppure la convenzione aveva fruttato, per stare solo al 1909, alla Società di Navigazione ben 250 mila lire annue.

Il piroscafo Vulcano nel porto di Messina
Ma quando arriva la guerra la situazione peggiora. Il 9 marzo del 1915 il Consiglio comunale discute di un primo taglio effettuato dalla Società armatrice senza avere preventivamente informata l’amministrazione. E’ il primo segnale al quale ne seguiranno altri. Nella primavera del 1917 si giunti a tre corse settimanali con Milazzo e si vorrebbero integrare utilizzando l’”Unione” di La Cava per quanto piccola e carente sia. Infatti ridotta la frequenza e siccome il piroscafo Flora è di dimensioni ridotte, all’imbarco scoppiano risse fra i viaggiatori per chi debba avere la precedenza per partire – visto che è stato prefissato un limite e si da la precedenza ai militari - e così qualche volta è successo che qualcuno, nella confusione, è caduto in mare. Inoltre, il Consiglio protesta perchè i viaggi avvengono di notte ritenendoli più sicuri più sicuri, invece creano solo un maggior disagio ai viaggiatori[1]. Inoltre mancano sedili e tende per cui “chi viaggia è costretto a buttarsi a terra come gli animali, e per giunta allo scoverto dalle intemperie della stagione e da tutte le esalazioni più o meno nocive che derivano dalla macchina” [2].

Per garantire almeno il servizio postale quotidiano si chiede il 14 giugno 1918 l’utilizzo di un idrovolante da Milazzo. Finalmente qualche settimana dopo l’autorizzazione viene concessa. Il veivolo era comandato dal liparese Salvatore Iacono, sergente dell’aviazione, che era ideatore dell’iniziativa.. Il successo fu enorme e la gente correva a Marina Corta per assistere all’ammaraggio e per attendere la posta dei parenti e degli amici dal fronte. E proprio una gran folla assistette l’8 settembre 1918 all’avaria dell’idrovolante che si fracassò – in un fuggi fuggi generale – sulla spiaggia, finendo contro le barche tirate a secco. Grazie a Dio, Salvatore si salvò e un pezzo del veivolo finì come cimelio nel suo laboratorio di falegname che aprì, qualche tempo dopo, in via Roma[3].
Quando l’11 novembre del 1918 si conclude la guerra il Consiglio nella seduta del 24 dicembre chiede che siano ripristinate al più presto le linee che vi erano prima del conflitto ma con navigli più adeguati di quelli che fino ad ora aveva disposto la Società Siciliana, anzi sarebbe stato bene che il servizio passasse allo Stato e possibilmente alle Ferrovie. E sempre nello steso Consiglio, si parla anche delle opere marittime, che erano direttamente collegate ai trasporti
E si tratta di un’altra grossa emergenza perché ancora il trasbordo dalle navi alle banchine – anzi nelle isole minori mancano persino le banchine - avviene attraverso barche e non esiste un vero porto rifugio. Così le priorità che si indicano sono molto ampie: il completamento dei lavori portuali e di difesa dell’abitato; la sistemazione delle banchine e dei pontili di sbarco. I lavori già iniziati sono quelli di Pignataro e Sottomonastero e cioè a Pignataro il prolungamento del braccio in costruzione, le “le calate” perché esso “possa rendersi utile alla marineria sia come ricovero sicuro, sia come ormeggio e traffico” e la strada di accesso; a Sottomonastero occorre che la banchina sia elevata di livello e portata sino a Punta Scaliddi, con un braccio ad angolo, per rendere più sicuro l’ormeggio delle navi e provvedere ai lavori di difesa dell’abitato fino alla foce del torrente Valle perché il mare già batte sui fabbricati e durante le mareggiate c’è il rischio che vengano portati via. Si parla anche del porto di Marina San Giovanni dove le banchine devono essere elevate di livello perché probabilmente il bradisismo negativo si fa già sentire e quella che guarda Vulcano va prolungata con un braccio ad angolo per permettere l’attracco del postale. A Canneto c’è invece bisogno”di un pennello di molo”.
Il problema dell'acqua
 Quello dell’acqua è sempre stato un problema per le Eolie. Prima vi era il grande serbatoio del Castello costruito all’epoca dei normanni e che aveva sopperito, bene o male, alle esigenze dei liparesi quando si viveva nella città alta. Poi, via via che si sviluppava la città bassa si era provveduto con i pozzi che raccoglievano l’acqua piovana e le “senìe” che servivano per i campi. Così nel 700 i vescovi fanno costruire delle cisterne nei pressi del palazzo Vescovile di Diana e quel posto si chiamerà d’allora in poi “u’ Puzzu”. La gestione pubblica e privata dell’acqua piovana raccolta era sempre meno sufficiente, soprattutto nei periodi di siccità, ed era allora che l’Amministrazione comunale faceva provvedere a portare l’acqua da fuori forse qualche volta con le navi della marina militare ma il più delle volte acquistandola da armatori privati che possedevano navi adatte per questo trasporto. A Lipari, una volta giunta l’acqua veniva immessa nelle cisterne pubbliche e forse anche in qualche cisterna privata di abitazioni più vicine al porto giacchè ancora il 22 agosto del 1911 il Sindaco rendeva noto ai consiglieri che “malgrado lunghi studi non si era potuti addivenire ad una soluzione” per quanto riguardava le condutture di acqua potabile nella città. Il 12 maggio del 1912 il Sindaco informa il Consiglio che, “per la mancanza assoluta di acqua in Paese”, ci si era rivolti al Ministero tramite la Prefettura ma la risposta era stata negativa perché tutte le cisterne erano impegnate per il rifornimento dell’acqua per l’Esercito e la Marina. Così si era sentita alla ditta Valenzano di Napoli con cui si era in rapporti da tempo. Erano rapporti non sempre pacifici perché già in passato vi era stata una contestazione sul quantitativo arrivato. Ma probabilmente non erano molte le ditte che svolgevano questo servizio e quindi si tornav a servirsi di questa che aveva già inviato un primo carico al costo di lire10,15 la tonnellata. Il Consiglio apre in Bilancio un capitolo di spesa imputandovi lire 10.000 segno che le necessità annue erano stimate, quando vi erano periodi di siccità, intorno alle mille tonnellate.
Quello dell’acqua è sempre stato un problema per le Eolie. Prima vi era il grande serbatoio del Castello costruito all’epoca dei normanni e che aveva sopperito, bene o male, alle esigenze dei liparesi quando si viveva nella città alta. Poi, via via che si sviluppava la città bassa si era provveduto con i pozzi che raccoglievano l’acqua piovana e le “senìe” che servivano per i campi. Così nel 700 i vescovi fanno costruire delle cisterne nei pressi del palazzo Vescovile di Diana e quel posto si chiamerà d’allora in poi “u’ Puzzu”. La gestione pubblica e privata dell’acqua piovana raccolta era sempre meno sufficiente, soprattutto nei periodi di siccità, ed era allora che l’Amministrazione comunale faceva provvedere a portare l’acqua da fuori forse qualche volta con le navi della marina militare ma il più delle volte acquistandola da armatori privati che possedevano navi adatte per questo trasporto. A Lipari, una volta giunta l’acqua veniva immessa nelle cisterne pubbliche e forse anche in qualche cisterna privata di abitazioni più vicine al porto giacchè ancora il 22 agosto del 1911 il Sindaco rendeva noto ai consiglieri che “malgrado lunghi studi non si era potuti addivenire ad una soluzione” per quanto riguardava le condutture di acqua potabile nella città. Il 12 maggio del 1912 il Sindaco informa il Consiglio che, “per la mancanza assoluta di acqua in Paese”, ci si era rivolti al Ministero tramite la Prefettura ma la risposta era stata negativa perché tutte le cisterne erano impegnate per il rifornimento dell’acqua per l’Esercito e la Marina. Così si era sentita alla ditta Valenzano di Napoli con cui si era in rapporti da tempo. Erano rapporti non sempre pacifici perché già in passato vi era stata una contestazione sul quantitativo arrivato. Ma probabilmente non erano molte le ditte che svolgevano questo servizio e quindi si tornav a servirsi di questa che aveva già inviato un primo carico al costo di lire10,15 la tonnellata. Il Consiglio apre in Bilancio un capitolo di spesa imputandovi lire 10.000 segno che le necessità annue erano stimate, quando vi erano periodi di siccità, intorno alle mille tonnellate.
Ma indubbiamente la soluzione non era soddisfacente se nel giugno del 1913 si dovette nominare una commissione presieduta dall’assessore all’igiene dott. Francesco De Mauro per studiare “il miglior modo come fornire di acqua potabile l’Isola di Lipari “[4].
In questi anni ripetutamente viene sollecitata l’amministrazione per realizzare serbatoi d’acqua potabile anche a Canneto ed Acquacalda. Nel Consiglio del 15 dicembre 1915, ad una interrogazione in proposito, il Sindaco risponde “ che non si è potuto provvedere date le difficoltà tecniche per la costruzione di esse”.
Nel Consiglio del 24 dicembre 1918, nell’ambito della rilevazioni delle esigenze di lavori pubblici nel Comune a proposito dell’acqua si dice che “Lipari fa uso di cisterne per provvedersi l’acqua potabile. Il Governo ha qualche volta delegato persona che venisse in aiuto a questa popolazione. Ma le persone incaricate a tal fine non hanno fatta opera completa.” Sarebbe necessario, per fare un lavoro serio, che venissero inviati, più di una volta, dei tecnici specializzati che compissero dei saggi e prospettassero concretamente il lavoro da farsi e lo riferissero al Governo dal quale il Comune attende “aiuto sollecito e completo”. Si pensa naturalmente a rintracciare, se esistono, sorgenti di acqua sorgiva.
Fra le priorità che il Consiglio prospetta al Governo sulle opere pubbliche necessarie, per quanto riguarda l’acqua si indicano la sistemazione dei bacini montani e la conduttura per l’acqua potabile a Lipari.
Se quello delle strade rotabili, dei collegamenti marittimi e del rifornimento e distribuzione dell’acqua potabile sono le grandi emergenze altri problemi nelle isole non mancano. Sempre a proposito delle opere pubbliche nel Consiglio del 24 dicembre 1918 si parla anche di ospedale, plessi scolastici, vie urbane, ecc. E’ una seduta fiume che si carica di molte speranze ma dove anche affiora il risentimento per essere stati a lungo trascurati e dove ancora brucia quella nota del Consiglio di Stato dei primi mesi del 1914 dove si definiva Lipari un Comune troppo ricco per potere avere diritto a particolari attenzioni finanziarie. L’assessore De Mauro – in un ampio intervento che spazia su tutti i problemi - invoca una legge speciale per le isole minori che affronti i problemi delle strade e degli scali marittimi. “Lo Stato e la Provincia , da che è stato costituito il Regno d’Italia – incalza l’assessore – hanno avuto tutti i contributi senza mai avere aiutato questo Arcipelago il quale ancora oggi ha le sue vie costituiti da letti di torrente, da viuzze semplicemente fatte dal solo piede dell’uomo e dove ancora oggi non può neanche passare l’asino. Noi abbiamo le isole di Alicudi, Stromboli, Panarea dove le sole spalle dell’uomo debbono soddisfare ai bisogni di ogni genere di trasporto, abbiamo le isole di Filicudi e Vulcano dove solo in minima parte l’asino può giovare in qualche modo dove però in massima parte le comunicazioni sono fatte in precipizi…. Nel mentre in tutto il mondo oggi si gode il lusso di viaggiare anche per aria, nelle isole nostre ancora oggi nemmeno è possibile andare a cavallo di un asino! E non solo di vie noi manchiamo. Noi manchiamo di tutto, tutto, tutto!”[5]

Cisterna a Vulcano ora scomparsa
[1] Non hanno torto i consiglieri se si pensa che i viaggi sulle tratte per Flicudi e Alicudi e per Panarea e Stromboli avvengono invece di giorno malgrado la navigazione avvenga in un mare più aperto mentre fra Milazzo e Lipari c’è la protezione costante dei cannoni posti alla punta di Capo Milazzo e alla punta S.Francesco a Lipari. Inoltre insistere con i viaggi notturni nella stagione invernale aumenta il pericolo e costringe a saltare molti viaggi.
[2] Dal verbale del Consiglio comunale del 3 agosto 1917. Dove non dichiarato diversamente le informazioni di questo capitolo si intendono tratti dai verbali del Consiglio comunale.
[3] “Don Salvaturi, postino per via aerea!”, in “I quaderni”, Aercipelago Eolie di P. Paino, in appendice a L.S. d’Austria, Le Isole Lipari, vol.III, Lipari; Iacono mio padre…, R.De Pasquale, Il mio tempo. Ricordi ed immagini, Lipari 1990, p.13.
[4] Dal verbale del Consiglio comunale del 21 giugno 1913.
[5] Verbale del Consiglio comunale del 24 dicembre 1918.
L'assessore Mauro
Retorica nazionalista e il difficile cammino della modernità
La retorica nazionalista

Festa nazionale a Piazza Mazzini
Il 29 settembre del 1911 il governo Giolitti dichiara guerra alla Turchia e anche Lipari partecipa con manifestazioni popolari e fiumi di retorica alla campagna nazionalistica che ormai dilagava da almeno quattro anni.. La solita “Voce della Patria” arriva a scrivere che “Lipari, che ancora ricorda, malgrado i secoli trascorsi, la ferocia musulmana che distrusse portandone via schiavi quasi tutti i suoi abitatori, oggi che si vede vendicata dalle armi gloriose della Patria unita, ha il dovere di associarsi con entusiasmo all’opera patriottica ed umanitaria che da Torino a Palermo l’Italia unanime ha secondata”[1].
Quando le truppe italiane occuparono Tripoli il Consiglio comunale, il 20 ottobre del 1911, si riunì per inviare al Ministro della Real Casa un telegramma di plauso, inneggiando alla vittoria che portava “libertà, progresso, fraternità” mentre nelle strade si svolgevano cortei con alla testa il Sindaco Franza,la musica e le bandiere e si recavano al Castello ad acclamare i soldati del presidio al grido di “Viva l’Esercito”, “Viva la Marina”, “Viva il Re”, “Viva Tripoli”pensando – scriveva “La Voce” - “ai valorosi bersaglieri, ai militari tutti, che lontani, in terra straniera, fra gente selvaggia e vile, combattono per l’onore e la dignità della patria”. Al Castello ci sono i discorsi del Sindaco e del Tenente comandante del distaccamento. Poi nuovamente in corteo, con i soldati del distaccamento, per le vie del paese[2].
Qualche giorno dopo “La Voce” si farà promotrice di una sottoscrizione popolare a favore della Croce Rossa.
In quegli anni Lipari si arricchisce di nuovi locali pubblici di spettacolo, di incontro, di consumo, come non si erano mai visti prima. Nel febbraio del 1911 si aprono contemporaneamente il cinema Marconi, che aveva l’entrata su via Vittorio Emanuele da cui si accedeva ad una struttura in legno collocata nel terreno retrostante, e il teatrino Tripoli, “Supra u’ Chianu”, con un generatore proprio, un proiettore a manovella, un pianoforte in sala. Entrambi i locali avranno vita breve: due anni il Marconi ed un anno il Tripoli distrutto da un incendio. Nel 1912, in un giardino du Strittu Luongo si apre un cinema teatro estivo chiamato “Eolo”. L’anno dopo, il posto del Marconi viene preso da un altro cinema-teatro, l’Elena.
Qualche segnale di "modernità"
Grande interesse provocano l’apertura di due o tre negozi di barbiere con poltrone girevoli e posizionabili, specchi che coprono le pareti, vetrine d’esposizione di prodotti da toilette. Portavano a Lipari modelli americani ed infatti il primo barbiere fu don Gaetano Zaia che era tornato giusto allora dagli Stati Uniti e non la finiva di raccontare le meraviglie di laggiù. “Si eseguisce il lavaggio della testa con un nuovo sistema Italo-Americano” prometteva la pubblicità ma oltre a tagliare barbe e capelli, a lavare le teste ed a vendere saponi e profumi don Gaetano praticava i salassi e cavava i denti. Subito dopo un altro barbiere sempre “di stile americano” aprì la sua bottega, “u’ Puzzu” che aveva preso da poco il nome di Piazza Giolitti. In via Garibaldi invece aprì i battenti una sorta di grande magazzino dove si trovava di tutto dagli abiti confezionati, alle camice, alle scarpe, alle valigie , agli specchi, all’oreficeria.

Supra u' timparozzu, la strada centrale di Lipari nell'800 e primi novecento
Erano gli anni in cui a Lipari come a Salina si cercava di lasciarsi dietro le spalle la crisi dell’agricoltura e dei trasporti a vela riconvertendo le produzioni con l’innesto della vite, sperimentando la navigazione a vapore, puntando sull’industria della pomice che nel 1912 supera le 30 mila tonnellate di esportazione, traendo vantaggio dai nuovi collegamenti marittimi con la Sicilia e con Napoli e soprattutto, come abbiamo visto, dalle rimesse degli emigrati. In quegli anni si porta a compimento il nuovo palazzo di città con la ristrutturazione dell’antico convento dei frati minori osservanti che era passato al Comune. La notizia che era stato completato il primo piano e quindi mancavano solo i lavori di rifinitura viene dato nel Consiglio del 22 agosto 1911 ed il Sindaco Franza ottiene il plauso dei consiglieri. L’anno dopo, il 22 luglio 1912, il Consiglio approva la spesa per l’arredamento del nuovo edificio e così il Municipio si trasferisce da via Garibaldi a sopra la Civita. I locali a pianterreno dell’edificio ristrutturato vengono occupati dalla scuola tecnica commerciale pareggiata.
Ed è in questo clima che si promuovono nuove imprese ed attività industriali e commerciali come la fabbrica del ghiaccio di Carmelo Biscotto di cui si è detto, la fabbrica di gazzose di don Ferdinando Maggiore, una sala di “Bigliardo e caffè”, un locale di mescita con annessa cucina casereccia che aprì, supra a’ Civita, un ex agente di polizia don Cesare Bernardi[3] e dove al sabato ed alla domenica si ballava al suono di una pianola americana. Anni dopo, questo locale diventerà un rinomato ristorante col nome di “Filippino”.

I primi tempi del Ristorante Filippino
Fra tanti fermenti non si può non pensare alla realizzazione di una centrale elettrica che in Italia si erano cominciate a realizzare già da circa trent’anni. Dal 21 maggio del 1906 al Comune giacevano due progetti uno proposto da don Onofrio Palamara e l’altro da don Giovanni Paternò.Il primo aveva preventivato una spesa annua di L. 20 mila ed il secondo di solo 8 mila. Ora nella seduta del Consiglio del 3 aprile 1911 si interrogava il Sindaco per sapere che fine avesse fatto il progetto proposto da Palamara. Il Sindaco si riservò di rispondere in altra seduta, ma lascò cadere l’argomento che per un po’ di tempo non fu più ripreso. I progetti erano fermi perché l’Amministrazione non sapeva che fare. I proventi della pomice ammontarono il primo anno che era entrata in vigore la legge a 100 mila annue per via delle numerose contestazioni, nel 1912 essi erano arrivati a circa 225 mila ed il bilancio comunale rispetto a dieci anni prima era praticamente raddoppiato. Ma non tutto si poteva fare con le entrate della pomice soprattutto se si voleva che queste servissero per contenere le imposte dei cittadini.
La lunga odissea delle rotabili
E poi, in una realtà che sognava il futuro e voleva vivere gli agi delle grandi città, vi erano ancora troppe emergenze che forse venivano prima della luce elettrica. Vi era innanzitutto il problema delle strade di collegamento fra le frazioni che non esistevano. Anzi non esistevano nemmeno delle buone mulattiere. Vi era il problema dell’acqua potabile e cioè del rifornimento visto che aumentando le esigenze non bastava più quella piovana raccolta dai tetti e nemmeno i serbatoi pubblici esistenti. Vi era infine il problema dei collegamenti marittimi che ora finalmente erano entrati in funzione regolarmente e con una buona frequenza ma lasciavano molto a desiderare per la qualità del servizio.
Vediamo come il Comune affronta queste tre emergenze. Il problema delle rotabili, innanzitutto. Si parla di Lipari perché è l’isola più abitata e quella dove esistono diverse borgate distribuite sul territorio. Un problema quasi identico – in scala però inferiore – lo ha Salina e la mancanza di strade praticabili è uno dei nodi, forse il maggiore, che avvelena i rapporti fra le borgate. Ma ormai l’isola ha l’autonomia amministrativa. Le borgate di Lipari sono distribuite su tutti i 37 chilometri quadrati della sua superficie. C’è Lipari che è il centro più popoloso – nel 1911 contava 6.000 abitanti - col suo porto e quindi il nodo di convergenza di tutti i traffici commerciali sia quelli relativi all’agricoltura che si sviluppa soprattutto intorno a Quattropani e Pianoconte, sia quelli relativi al termalismo alle terme di San Calogero che si raggiungono da Pianoconte, sia quelli relativi alla pomice di Canneto e di Lipari anche se gran parte di questo traffico avviene con navigli che caricano direttamente dalle rade di queste due borgate. L’idea di realizzare almeno due tronchi di strade rotabili una da Lipari a Canneto ed una da Lipari a Quattropani passando per Pianoconte si pose fin dal 1884 quando fu dato l’incarico all’ing Molino Foti di stendere i relativi progetti per ottenere i finanziamenti in base alla legge del 30 agosto 1968. Questo lavoro fu interrotto una prima volta nel 1894 quando viene revocata la legge la legge per il finanziamento delle strade. L’8 luglio del 1903 esce una nuova legge e subito viene chiesto all’ing. Molino di riprendere i lavori. Ma purtroppo l’ingegnere incaricato muore nel terremoto di Messina e con la sua morte vengono persi anche i suoi elaborati. L’amministrazione incarica un nuovo progettista, l’ing. Rumore e questo il 7 gennaio 1911 presenta al Consiglio comunale il lavoro fatto. La “rotabile dell’isola di Lipari” proposta consta di tre tronconi: La Lipari- Quattropani via Pianoconte, la Lipari- Cannetto, la Pianoconte- San Calogero. Il problema torna in Consiglio il 28 novembre perché il Genio Civile di Messina ha fatto sapere che la legge riguarda solo i collegamenti del centro abitato con il porto o stazioni ferroviarie e il vero centro abitato dell’isola è Lipari. Tutt’al più, “in considerazione della disagiata viabilità all’interno dell’isola” il Ministero dei Lavori pubblici potrebbe finanziare un solo tronco ed il Comune deve decidere quale. Ma il Consiglio insiste sulla necessità dei tre tronconi e così si forma una commissione presieduta dal il Sindaco che è il cav. Franza. Questa va a Roma e qui, accompagnata dall’on. di Sant’Onofrio cerca di convincere il Ministero della necessità di un progetto così articolato per l’isola. Riescono ad avere tanta comprensione ma la situazione non cambia. Con la legge del 1903 si può finanziare, tutt’al più, un solo tronco. Ma discutendo si trova una qualche soluzione. Oltre alla legge del 1903 vi è il Regio Decreto del giugno 1904 che finanzia però solo un quarto dell’importo dei progetti e la rimanenza è a carico dei Comuni. Si potrebbe chiedere un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti e così l’incidenza sul bilancio comunale sarebbe diluita nel tempo. E la proposta che la Commissione fa al Consiglio del 9 aprile 1912 è così articolata: chiedere di finanziare con la legge del 1903 la Lipari-Quattropani via Pianoconte che è la strada più lunga, finanziare con il Regio Decreto del 1904 e con il prestito sia la Lipari-Canneto che dovrebbe essere prolungata fino ad Acquacalda visto che questa frazione sta crescendo di importanza, sia la Pianoconte- San Calogero. Nella stessa seduta il Consiglio approva la proposta nella sua globalità ma propone di dare un altro incarico per la Canneto- Acquacalda proprio per non ritardare i progetti già in corso.
Ma siamo solo all’inizio di un percorso travagliato perché il Consiglio di Stato respinge il finanziamento con la legge del 1903 sostenendo che il Comune di Lipari è troppo ricco per avere diritto ad eccezioni e se proprio è necessario ricorra alla Cassa depositi e prestiti. E così viene fatto anche per non perdere tempo con ricorsi e reclami. Ma qualche anno dopo, nel pieno della guerra, il Comune deve constatare che il commercio della pomice ristagna e con essa la tassa relativa per cui, per fare fronte ai costi delle opere pubbliche chiede prima, inutilmente, un aiuto della Provincia e poi un nuovo ricorso alla Cassa.

Così il 24 dicembre, a guerra finita, si fa un bilancio in Consiglio, del problema delle opere pubbliche necessarie a cominciare proprio dalle strade per potere accedere al miliardo che il Governo ha stanziato a favore di Ministeri, Province e Comuni con il Decreto Luogotenenziale del 30 giugno 1918 n. 1019..E’ una sorta di programmazione di lungo respiro che vale la pena richiamare: i lavori della Lipari- Pianoconte- Quattropani e della Lipari-Canneto- Acquacalda , sebbene iniziati, sono stati sospesi a causa della guerra e non si sa come riprendere i lavori perché il conflitto ha lasciato le casse comunali in condizioni miserrime. Per questi tronchi di rotabili come anche per la Pianoconte- San Calogero, il Consiglio chiede al Governo la priorità. Inoltre si indicano le esigenze di reti stradali delle campagne di Liapri e delle altre isole minori: la strada per Castagna e Lami; per Pirrera; per Piano Greca; per i Bagni di S.Calogero per cui fu richiesto il sussidio ma che non è mai arrivato; per Monte; per S.Salvatore; per Alicudi; per Filicudi al fine di collegare le frazioni Pecorini, Valle di Chiesa, Zucco Grande, Liscio fra di esse e con lo scalo marittimo; per Panarea collegando le frazioni di Iditella, Draut, Punta Milazzese fra di esse e lo scalo marittimo; per Stromboli per collegare Ginostra e Stromboli fra di loro ed allo scalo marittimo; per Vulcano collegando le frazioni di Gelso, Piano e Porto sempre fra di loro e con il porto. Nel febbraio del 1919 mentre si sollecitano i lavori delle rotabili in corso si parla anche di un possibile collegamento di Quattropani con Acquacalda.
Dovranno passare però ancora degli anni perché le rotabili siano completate e funzionanti . La Lipari- Canneto nel luglio del 1925 era già transitabile da pedoni, da uomini a dorso d’asino da carrettieri e da ciclisti, ma bisognerà aspettare il 1932 per vederla perfettamente rifinita. Nel 1932 invece quella di Pianoconte consentiva il transito ma si trovava ancora in fase di completamento; anche se il rustico era stato tracciato sette anni prima. Per raggiungere Quattropani ed Acquacalda invece si sarebbe dovuto aspettare la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni 60 anche se questa seconda era già stata tracciata dagli inglesi del colonnello Jeo tra il 1943 e il 1944.
[1] Nel numero dell’Ott. Nov. 1911
[2] La Voce della patria, anno I, n.4 nov-dic. 1911, p.3.
[3] Don Cesare Bernardi era nato a San Genesio di Macerata nel 1877 e morirà a Lipari il 23 agosto 1923. Con gli anni la “cucina” diventa ristorante e si chiamerà prima “Ristorante Belvedere” e poi, nel 1950, “Ristorante Filippino” in memoria del padre di don Cesare.
Carmelo Biscotto
Gli anni della polemica nei confronti del Vescovo
Mons. Paino, un vescovo colto ed aperto
 La personalità e l’opera di Mons. Paino venivano ad inserirsi nella vita di Lipari proprio in questi anni di grandi aspirazioni. Il 22 agosto 1908 Mons. Paino fa la sua entrata solenne a Lipari sbarcando alla marina di San Giovanni.
La personalità e l’opera di Mons. Paino venivano ad inserirsi nella vita di Lipari proprio in questi anni di grandi aspirazioni. Il 22 agosto 1908 Mons. Paino fa la sua entrata solenne a Lipari sbarcando alla marina di San Giovanni.
Angelo Paino fu fatto vescovo di Lipari perché a Lipari c’era bisogno di un pastore che avesse diretta conoscenza degli uomini e delle situazioni del paese, giacché in un breve volgere di anni nelle Eolie s’erano verificati mutamenti sostanziali di cui era bene che la chiesa locale prendesse consapevolezza. Dotato com’era di vasta cultura, di esemplare pietà, di risoluto dinamismo, di diplomatica prudenza egli sembrava l’uomo adatto al momento.
Nella prima lettera pastorale egli lancia uno sprone forte ai preti:”Troppo dormimmo e dimenticammo che la corona non è degli’infingardi, che la Chiesa non ha che farsi de’ pusilli, che non a riposo c’era data la terra, che il riposo dei forti è il Cielo! Oh! Io non tollererò mai l’ignavia dei miei Curati, che tradirei la mia missione e le speranze della Chiesa…. Si disingannino coloro che sono venuti a cercar agi e riposo all’ombra del santuario, milizia fra tutte la più aspra e faticosa. Azione ci vuole, zelo, costanza, abnegazione”.
Come primo gesto di amministratore della diocesi è la creazione delle parrocchie, spogliando il vescovo della figura di parroco universale. Così eleva al rango di parrocchie le 15 vicarie curate. Per ogni singola parrocchia istituisce un beneficio in denaro che, fatti salvi i diritti della Suore di Carità, preleva dal legato Ideo col consenso della S. Congregazione concistoriale. Ancora, con i fondi della mensa vescovile rimise mano al progetto della scalinata per la Cattedrale che si era interrotta nel 1903 con la dipartita di mons. Audino. L’opera venne compiuta in meno di tre anni dal 1910 al 1913.
Di preti ne aveva a disposizione quarantadue oltre a sei padri cappuccini[1] e ad uno dei quali affidò la Parrocchia di Porto Salvo. Non vi erano le risorse per far rinascere il Seminario ma il Vescovo cercava di tenersi vicini gli adolescenti creando una sorta di associazione cattolica che ospitò al primo piano del palazzo vescovile ed alla quale assegnò un piccolo campo di gioco nel quadrato che allora si estendeva a ponente del palazzo stesso.
Era di carattere aperto sebbene a volte poco duttile e alquanto spigoloso, obiettivo comunque e tuttavia appassionato, spesso deluso dall’impatto con la realtà ma restando sempre operante e propositivo. Fu questo carattere a portare mons. Pajno a cacciarsi, come abbiamo visto, nella grande mischia che, dopo il 5 gennaio del 1908, aveva ripreso a divampare intorno ai campi pomiciferi dell’isola di Lipari.

Arrivo del Vescovo Paino
I progetti che andava delineando di rilancio della diocesi e dell’azione pastorale abbisognavano di risorse sicure. Da qui la richiesta di accedere ad una parte delle risorse che il Comune si apprestava ad incamerare col dazio sulla pomice. Ma questo fece scattare il corto circuito al di là di quanto egli stesso potesse pensare. Infatti, se ai suoi occhi le richieste che avanzava potevano apparire ragionevoli e moderate, negli uomini della classe dirigente locale, anche in quelli come i popolari che dovevano essere più vicini alle esigenze dei vescovi e della Chiesa, c’era la preoccupazione che un atteggiamento di mediazione, anche un riconoscimento parziale delle richieste della mensa, potesse rappresentare un ritorno al passato, al regime feudale che, per la verità, nessuno rimpiangeva.
Una vertenza che mette in gioco il futuro del Comune e della Diocesi

Il Sindaco Franza, come abbiamo visto, era fortemente impegnato, tra ingiunzioni e regolari procedimenti giudiziari, a contenere tutti i tentativi di intolleranza verso la legge ed a combattere le usurpazioni ed il contrabbando di fatto dei proprietari dei terreni pomiciferi.. Ora si vede parare dinanzi, inserito tra le fila degli aventi causa del Comune, mons. Angelo Pajno con tutto il peso della sua personalità e l’acume della sua intelligenza, che agiva in nome e per conto della mensa vescovile di Lipari. Era stato eletto il Franza, al di sopra delle parti, proprio per rilanciare il Comune e portarlo fuori dalle secche della crisi. La legge n. 10 era l’approdo di un lungo cammino e il punto di partenza di un percorso ancora tutto accidentato. Come poteva aderire alle richieste del vescovo? Come riconoscere che le terre pomicifere erano del vescovo e non del demanio comunale? Voleva dire rinnegare anni ed anni di lotte. Voleva dire rompere l’unità del Consiglio e del paese che si è creata intorno alla sua persona e consegnare il Comune alle posizioni più radicali bruciando tanti sogni e tante speranze. Se il vescovo di Lipari riteneva di difendere la sopravvivenza della chiesa in un territorio complesso e difficile come era un arcipelago con l’esaurimento delle vecchie provvidenze e l’assoluta mancanza di nuove, del pari con ragioni forti veniva presentata la tesi comunale. Dice infatti l’avv. Carnevale: “La interpretazione dei diplomi normanni ( come quello di Lipari e analoghi, ve ne sono parecchi altri) è grave argomento che interessa tutta la Sicilia, e che non solo richiama l’antico contrasto tra potere ecclesiastico da una parte e autorità civile e diritti delle popolazioni dall’altra, ma ha insieme evidente attinenza con tutto il vasto problema della riforma agraria e del migliore ordinamento delle terre pubbliche: se la tesi di mons. Pajno avesse potuto trionfare, gli ultimi residui del feudalesimo avrebbero pesato ancora sulle più ardenti aspirazioni delle nostre plebi rurali”[2].
Se sono soprattutto il futuro della diocesi e del comune a livello locale che sono in gioco nella vertenza non si può nascondere che essi rimandino a questioni più generali. Forse né il vescovo né il sindaco nel 1910 possono immaginare il rilievo anche nazionale che la disfida sulla proprietà dei terreni pomiciferi finirà con l’assumere. Ed è indubitabile che essa coinvolga anche forze a livello nazionale. Puoddarsi che sia vero, come afferma il prof. Carnevale che in appoggio delle tesi del vescovo si muoveva il Vaticano, ma non si può nemmeno escludere, come sosteneva Mons. Paino, che in tutto il corso della procedura dibattimentale ebbero buon gioco le manovre della Massoneria.
Quando si chiude nel 1921 la lunga querelle che era durata dieci anni l’attenzione che l’aveva caratterizzata nei primi anni era di molto scemata e questo sia per la difficoltà a seguire un procedimento così lungo e complesso, sia perché di mezzo si erano avuti eventi gravi come la grande guerra e l’epidemia colerica che ne seguì.
Ma dal 1911 al 1913 la polemica contro mons. Pajno divampò vivace ed anche violenta. Non solo i consiglieri democratici ma anche gran parte di quelli della maggioranza manifestarono il loro risentito sdegno morale perché leggevano nell’azione del Vescovo una volontà di restaurazione del dominio temporale.

Piazza Mazzini 1900
A quel punto, tutto diventava occasione di polemica da parte de “La Voce della Patria – Cronaca Mensile delle Isole Eolie”, che è il giornaletto locale che si faceva portavoce del pensiero laico[3]. Il Vescovo aveva ripreso i lavori per la scalinata della Cattedrale e da un anno questi procedevano alacremente? La scalinata, si sottolinea, è un danno grave al nostro patrimonio storico. Doveva assentarsi per impegni fuori Lipari e non poteva così presenziare alle feste di San Bartolomeo del 13 febbraio e del 5 marzo 1912? Lo si considera un fuggiasco che abbandona il suo popolo. Indiceva una manifestazione religiosa per solidarietà ai reali che avevano subito il 14 marzo 1912 un attentato fortunatamente fallito? Gli si rimprovera di aver scelto al chiesa di San Giuseppe troppo piccola e quindi è responsabile di un increscioso ma limitato diverbio che vi capitò. Il 9 maggio, per la Madonna di Pompei organizzava nel viale vescovile un pranzo per i poveri? E’ solo propaganda e non carità perché: “A proposito di carità, scusi, eccellenza, ricorda cosa dice il Vangelo? Ah! Vostra Eccellenza, ‘in tutt’altre faccende affaccendato’. Non può ricordarlo, altrimenti avrebbe proibito simili sistemi nel fare la carità…”.
Un carnevale sopra le righe
In questo clima si inseriva il Carnevale del 18-20 febbraio 1912. Ecco come ne parlava la Voce: “La prima mascherata, approvata ed applaudita dalla maggioranza della folla presente lungo le strade, uscì verso le ore 17 dell’ultima domenica. Essa rappresentava la lotta tra il Vescovo e il Paese per la questione pomicifera. Ammiratissime furono le maschere rappresentanti il Vescovo, il fido Alazza e i sagrestani… Di questa mascherata abbiamo disapprovato gli estremi, ma dopo tutto non possiamo dire male. Lungo le strade le donnicciuole e la ragazzaglia trattavano in malo modo la maschera rappresentante il Vescovo..”[4].
“Abbiamo disapprovato gli estremi”, scrive “La Voce” ma intanto fra il pubblico che ammirava lungo la via Vittorio Emanuele la sfilata delle maschere si faceva circolare un foglietto a stampa con un lunga filastrocca satirica intitolata “Occhio alla stola”. In questa fra l’altro si leggeva:
“Concittadini, non vi crediate
Che voglion bene alle vostre contrade.
Un mondo, insomma, di fesserie
Van predicando per tutte le vie
Monaci, preti, Chiese e altari,
grasse perpetue e campanari.
Le loro carte logore e belle?
Buone ad avvolgere strutto e sardelle” [5]
Si era così creata una situazione di irrequietezza popolare alla quale, come abbiamo visto, mons. Paino pensò bene di sottrarsi, abbandonando l’isola nell’estate del 1913[6]. Rimane però Amministratore apostolico della diocesi e rinuncerà a Lipari solo il 20 gennaio del 1921.
Ancora due anni dopo la partenza, il risentimento nei confronti del vescovo era molto forte come dimostra – fra l’altro – il Consiglio comunale di fronte ad un evento drammatico che si verifica il 5 marzo 1915.

La scalinata per la Cattedrale con il muro crollato.
La famosa gradinata di cui si parlava fin dai tempi di mons. Ideo e che collegava via Garibaldi con la Cattedrale era stata completata finalmente nel 1913 ed inaugurata dal vescovo Paino. Non era sempre accessibile al pubblico perché all’ingresso erano stati posti dei cancelli voluti dalle autorità politiche per ragioni di pubblica sicurezza visto che ancora al Castello vi erano i coatti. Il 5 marzo era una delle tante feste di San Bartolomeo, quella dedicata ai contadini istituita da mons. Lenzi nel 1823, e si svolgeva la tradizionale processione che sarebbe tornata alla Cattedrale per la nuova scalinata e per questo i cancelli erano stati aperti. Ne avevano profittato un gruppo di ragazzetti per giocarci. Quando la processione è sulla via del ritorno e sta per accedere alla scalinata ecco che si verifica la tragedia. L’alto muro di contenimento sulla sinistra della salita che era stato posto all’altezza della breccia nel muro del castello, sotto la chiesa dell’Immacolata, crollò e seppellì tre ragazzini fra i 10 ed i 13 anni. Un evento sconvolgente che rimase impresso nella memoria popolare. Ciò che colpisce è invece il comportamento del Consiglio comunale, almeno per quello che emerge dai verbali. Nessun accenno alla tragedia nemmeno per ricordare i morti nelle riunioni del 9, del 13 e del 17 marzo. Si parla dei tagli ai trasporti marittimi; di norme per la vendita del grano; del mosaico “Il Ratto d’Europa” trovato negli scavi di via Umberto ed ora al museo di Siracusa per il quale si chiede la restituzione; del bando di concorso per il posto di Segretario comunale; ma non del crollo del muro e delle vittime.
Di questo evento se ne parlerà esattamente un mese dopo, ma l’argomento sarà affrontato solo per dare conto delle spese che il Comune ha sostenuto per lo sgombero dei materiali, la ricerca dei cadaveri e il puntellamento dei muri non caduti ma pericolanti. Anche qui nessun cenno di cordoglio per le morti da parte di consiglieri che solitamente non sono avari di commossa retorica per la patria, la “santa guerra[7]”, per gli eroici sacrifici dei soldati ecc. ecc. Un clima decisamente polemico si coglie nei confronti del vescovo in particolar in alcuni interventi che però non vengono contrastati. In conclusione si vota un ordine del giorno, con solo tre astensioni, per chiedere al vescovo la rivalsa della somma spesa “autorizzando il Sindaco al relativo giudizio contro lo stesso, esaurite infruttuosamente le trattative bonarie”[8].
[1] I cappuccini erano tornati a Lipari nell’ottobre del 1900. Erano due padri e un fratello laico; poi, nel giugno del 1901 la comunità sarà composta da tre padri, tre chierici teologi e un fratello laico. P. Agostino da Giardini, I Frati Minori Cappuccini a Lipari, Catania 1962, pp.90 e ss.
[2] E.Carnevale, Miei ricordi di vita e di lavoro, Palermo 1923. G. Iacolino, inedito cit. Quderno XII p. 695.
[3] La “Voce della patria “ era un mensile e consisteva di due fogli, direttore era un certo Giuseppe Favorito ed uscì tra il 1911 ed il 1912. L’intellighenzia laica si riuniva presso la tipografia Amendola, quella di Accattatis e la farmacia Esposito. Probabilmente lì si pensavano e si imbastivano i pezzi da pubblicare che non venivano mai firmati ma al più comparivano con le iniziali o con pseudonimi di fantasia. D’altronde così facevano anche gli autori di due o tre pieghevoli di segno opposto che apparvero in quei mesi con la firma “Un gruppo del clero”. Uscì anche un bollettino laico dal titolo “La libertà delle terre di Lipari”.
[4] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno XI
[5] G: Iacolino, idem, pag. 708.
[6] Nel 1913 pare che a mons. Paino venga prospettata la possibilità di trasferirsi alla sede di Otranto ma non accetta. Consigliato anche dalla Santa Sede egli andò via da Lipari perché “pensò che forse miglior partito sarebbe stato, per il bene della anime a lui affidate, restituire all’isola completa serenità allontanandosene”(G. Foti, Un Console per Messina, Messina 1968, p.44).
[7] Sulla retorica del periodo basti questo saggio tratto dal discorso del Sindaco Notar Gaetano Paino all’apertura del Consiglio del 10 giugno 1915 : “ In questi momenti solenni per tutti in cui la madre patria è impegnata in una santa guerra d’indipendenza, è doveroso che Lipari, eminentemente patriottica e civile, si unisca agli altri centri per raccogliere, a pro delle famiglie dei soldati di terra e di mare le offerte cittadine onde alleviarne in parte i disagi e la miseria”.
[8] Verbale del Consiglio comunale del 14 aprile 1915.
Il fido Alazza
Il terremoto di Messina e il rilancio delle Terme
Il terremoto di Messina


Il 28 dicembre del 1908 nasce con l’evento drammatico del terremoto di Messina che alla commozione per la città distrutta con i suoi 80 mila morti sui 150 mila che allora la popolavano, si accompagnò l’apprensione per la sorte di tanti eoliani che lì dimoravano o vi si erano recati occasionalmente per affari. Almeno una ventina dovettero essere i liparesi periti nel disastro e fra questi diversi studenti che erano a Messina per studiare, professionisti ed operai. Vi erano anche un assessore, Bartolomeo La Cava, ed un avvocato, Giuseppe Ferlazzo, del Comune di Lipari che erano a Messina in missione per chiarimenti sul regolamento di esecuzione della legge n. 10. Altri furono dati per dispersi mentre invece erano stati trasferiti a Palermo da dove poi ricompariranno sani e salvi.
Sin dalla tarda serata di quello stesso 28 dicembre – e per molti giorni appresso – il banditore del Comune, preceduto dal rullo del tamburo, invitò i giovani e gli uomini validi che lo volessero, ad imbarcarsi sui battelli che facevano la spola con Messina per portare cooperazione e aiuto nelle operazioni di scavo. Non mancarono però anche azioni di sciacallaggio di cui si macchiò qualche eoliano come quel proprietario di una motobarca che, in quei giorni, faceva viaggi fra le isole e Messina per portare sui luoghi del disastro persone alla ricerca dei propri familiari scomparsi e riportare isolani scampati al terremoto che tornavano a casa spesso con sul corpo i segni della catastrofe. Il “padron” della barca attirò su di sé l’attenzione e quindi le denuncie per il comportamento insensibile ed egoista che dimostrava nei confronti dei trasportati, rifiutando, nei loro confronti, il minimo segno di solidarietà umana. I sospetti si dimostrano veritieri quando nella sua casa alla Serra i carabinieri ritrovarono diversa refurtiva sottratta a negozi ed abitazioni devastati dal terremoto[1].
Non causò seri danni nelle Eolie questo terremoto se non alcune crepe e lesioni ai fabbricati ma le provvidenze varate dal Governo invogliarono parecchi proprietari a portare migliorie ai loro stabili. Qualcuno ingaggiò anche artisti per decorare pareti e soffitte.

Lipari Marina corta. L'arrivo di due eoliani morti nel terremoto di Messina
In quel tempo si riparlò anche dello sviluppo delle Terme di San Calogero. Abbiamo detto che nel 1905, il Comune aveva ricevuto una nuova proposta di gestione, quella dei farmacisti Luigi Mancuso e Nunzio Esposito. Il contratto fu firmato il 12 luglio del 1906 e la durata della locazione era prevista per trent’anni con possibilità di recesso ogni cinque anni con disdetta un anno prima della fine del quinquennio. Per i primi dieci anni non vi era canone di affitto ed in seguito il canone era crescente dalle trecento lire dell’undicesimo anno alle millecento lire l’anno del sesto quinquennio. Inoltre i concessionari si impegnavano a investire nello stabilimento in restauri, migliorie compreso la strada che porta a mare lire novemila e cinquecento. Vi erano tariffe agevolate per gli utenti liparesi e per i poveri.

Il rilancio delle Terme
“Noi ci proponevamo – scriverà Luigi Mancuso – un programma molto esteso: migliorare, trasformare, perfezionare, ingrandire tutto lo Stabilimento, provvedendo fin dal primo anno a tutte quelle opere indispensabili che la scienza Balnoterapeutica moderna imponeva ed esigeva; un po’ di eleganza e comodità in tutte le sale; comodità e completa aereazione nei camerini da bagno, nella sala per le docce e per la stufa; trasformazione delle vasche poiché quelle esistenti erano veramente un’ironia…Ci proponevamo di impiantare una sala elettroterapica, applicata alla idroterapia…, aggiungendovi la kinesiterapia, con l’obiettivo di impiantarvi qualche altro ramo di terapia fisica, e tutto ciò oltre le modifiche, secondo le esigenze dell’igiene moderna, che si rendono necessarie ed indispensabili ad ogni stabilimento termale”[2].
L’obiettivo era di far diventare Lipari “una stazione climatica di prim’ordine” capace di attrarre forestieri e stranieri. Ed, infatti, dopo due anni lo stabilimento, per la bontà delle sue acque verniva ritenuto fra i migliori d’Italia, poi però giunsero le difficoltà. Prima il terremoto di Messina che blocca il flusso di utenti da quella città, poi la guerra, poi la crisi…
Dopo ben venticinque anni di lavoro, di sacrifici, di stasi prodotte dal terremoto, dalla guerra, dalla crisi economica, di angherie subite da parte di varie amministrazioni, una fra le quali, veramente assillante, per l’andamento dello Stabilimento, siamo stati costretti a rinunciare alla concessione, notificando l’atto di rinuncia e domandare il risarcimento di quello che si era speso in più a beneficio dello Stabilimento, collaudando i lavori eseguiti di cui lo stesso ha usufruito e continua ad usufruire”.
Già una volta nel 1921 c’era stato un contrasto fra concessionari delle terme e amministrazione comunale. Dovendo realizzare dei lavori si chiede la riduzione del canone e la regolarizzazione degli arretrati attraverso la compensazione fra canoni dovuti e lavori fatti. Ma il Comune non volle sentire ragioni e quindi si chiese la rescissione del contratto con disdetta anticipata. Ma poi nel 1923 grazie alla mediazione del commissario prefettizio si venne ad una amichevole composizione. Ma dieci anni dopo la rottura diviene insanabile. Nel 1934 il Comune torna alla gestione diretta.
Nel contratto del 1906 si era parlato anche di una rotabile da Pianoconte a San Calogero.Ma la rotabile non si fece [3].
Per altri quarant’anni lo stabilimento continuò ad operare ed ospitò numerosi pazienti di Lipari ma anche forestieri. Vi accudivano, per conto del Comune, Angelo Favaloro ed il figlio Bartolo che facevano da infermieri e da custodi.

Angelo e Bartolo Favorito
Il travaglio di Salina
L'iniziativa e l'alacrità di Salina

Sul finire del secolo scorso Luigi Salvatore d’Austria considerando globalmente il rapporto degli eoliani col lavoro scriveva: “L’iniziativa e l’alacrità non sono in genere molto spiccate nelle Eolie, tranne che a Salina e a Stromboli, dove la gente si dimostra veramente instancabile nel lavoro”.[1]
Ed è proprio grazie all’alacrità ed all’iniziativa se Salina, come abbiamo visto, qualifica il suo sviluppo nell’800 superando nella seconda metà del secolo la stessa Lipari in alcuni settori dell’economia. E la nascita del nuovo Comune nel 1867 dà maggiore impulso alla crescita. Ma sul finire del secolo si viene scoprendo una insospettabile fragilità nel modello di sviluppo dell’isola. Il punto di forza della marineria a vela viene insidiato dalle imbarcazioni a vapore, il grande successo del vino, della malvasia e della passolina sono legate alla vite che dovunque in quegli anni in Europa ed in Italia è colpita dalla fillossera. E siccome il male della vite nelle isole giunge in ritardo rispetto alle altre località, finchè resiste la vite resiste anche la marineria ma il dilagare della fillossera colpisce al cuore l’economia salinara. Così, come per il resto dell’arcipelago, anzi più che nelle altre isole, a Salina comincia l’esodo dell’emigrazione e all’inizio del nuovo secolo, nel 1901, degli 8.904 abitanti - che erano stati iscritti nei registri anagrafici nel 1891 - ne mancano ben 3.900[2].
Come abbiamo visto nella nuova amministrazione salinara, fin dagli inizi si manifesta una tensione fra Santa Marina da una parte e Malfa e Leni dall’altra giacchè queste ritengono che la frazione sanmarinese sia avvantaggiata dall’essere sede del capoluogo e cercano così di spostarlo a Malfa. Proprio questa tensione probabilmente avrà contribuito ad l’indebolire il tentativo dell’avv. Tripi di creare la società “La navigazione Eolica” fra gli armatori dell’isola - che avevano visto le proprie attività entrare in crisi per l’introduzione dei navigli a vapore e dalla malattia dell’uva - con l’obiettivo di puntare a partecipare alla gara per ottenere i collegamenti dell’arcipelago con la costa tirrenica.

Ma tutti i tentativi di spostare a Malfa la sede del municipio – malgrado siano approvati dal Consiglio comunale dove la maggioranza è dei consiglieri di Malfa e Leni – venivano puntualmente bocciati dalla Giunta provinciale amministrativa con la motivazione che il porto di Santa Marina era il terminale dei traffici mercantili e di linea. Oggetto delle recriminazioni di Leni e Malfa era in particolare il notaio Domenico Giuffrè che era stato il primo Sindaco di Salina dal 7 febbraio 1867 al 25 luglio 1870 ed era tornato ad esserlo dal 25 febbraio 1876 al 21 ottobre 1877 per poi occupare il ruolo di segretario comunale. A lui si attribuiva una costante prevaricazione degli interessi delle due frazioni a tutto vantaggio di Santa Marina anche se obiettivamente il notaio aveva sempre operato a favore del decentramento dei servizi comunali. Così aveva promosso l’istituzione di distinti uffici di stato civile e di scuole separate, aveva curato di correlare le spese a favore delle diverse borgate alle entrate di Bilancio, aveva promosso una polizia urbana strutturata in tre nuclei di frazione, aveva diviso la condotta medica ed aveva fatto costruire quattro cimiteri, aveva cercato di portare a Salina la sede di un ufficio pretorile. Rimaneva il fatto che fosse fermamente determinato a conservare a Santa Marina la sede municipale e in questa direzione spendeva tutta la sua influenza. E siccome questo era risaputo, per quanto facesse per allentare la tensione, le avversità nei suoi confronti andavano aumentando anche perché col progredire della crisi economica la possibilità di triplicare i servizi diventa più difficile mentre crescevano i sospetti . Così all’inizio del 1902 Giuffré viene accusato di illeciti contabili e l’1 febbraio viene arrestato e sospeso dalla carica mentre l’amministrazione viene sciolta e nominato un commissario col compito di svolgere una indagine amministrativa parallela a quella giudiziaria. Le due inchieste hanno esito favorevole per Giuffré ma la situazione rimane di grande tensione. Dopo le elezioni dell’11 maggio 1902 vengono ricostituiti gli organi ma il municipio è ingovernabile perché è un continuo scontro fra gli otto consiglieri di minoranza di Santa Marina e i dodici di maggioranza di Leni e Malfa.
Fra il 1902 ed il 1906 il consiglio funziona malissimo e nei due anni successivi praticamente non funziona affatto. Nel 1906 si riunisce solo una volta e deve arrivare a Salina un commissario prefettizio, accompagnato da trentacinque carabinieri e da un delegato di pubblica sicurezza.
Alla fine anche il notaio Giuffré si convince che non c’è alternativa alla divisione malgrado rimanga convinto che “è un delitto che grida davanti a Dio[3]” . Così nel gennaio del 1907 il Consiglio comunale approva all’unanimità la proposta di scissione e, con il parere favorevole del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa, la invia al governo perché la trasformi in disegno di legge.
Il Comune si divide in tre

Ma il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati viene respinto al Senato. La situazione è nuovamente nel caos mentre il Consiglio comunale riesce a riunirsi soltanto il 20 agosto 1908 per deliberare, una volta ancora, lo spostamento della sede municipale a Malfa. Il 27 dicembre il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario governativo che, constatata l’impossibilità di ogni pacificazione, fa lui stesso la proposta di tripartizione che il 26 dicembre 2009 diventa legge dello Stato col n. 807.
Ma le diatribe non sono finite. Si riaprono proprio sulla ripartizione del territorio. Malfa e Santa Marina si contendono la piccola frazione del Capo mentre tutte e tre le frazioni litigano sulla ripartizione di Monte delle Felci. Ma il vice prefetto Antonio Savagnone che ha il compito della divisione amministrativa del territorio, va avanti per la sua strada e consegna la proposta alla fine dell’estate del 1910. Nel 1911 ci sono le elezioni per i tre consigli comunali e quindi per gli organi di governo. Primo Sindaco di Santa Marina sarà patron Salvatore Re, patron Giuseppe Bongiorno sarà il primo Sindaco di Malfa e il sacerdote Bartolo Picone sarà il primo Sindaco di Leni[4].


Salvatore Re primo Sindaco di S. Marina . A destra il primo Sindaco di Malfa, Giuseppe Bongiorno. Sotto, il primo Sindaco di Leni, il sacerdote Bartolo Picone
![]()
Nonostante le tensioni fra le frazioni comunque intorno al 1910 si hanno cenni di ripresa economica grazie anche ai servizi regolari e giornalieri di collegamento marittimo con la costa siciliana. Così qualcuno comincia a pensare di reimpiantare i vigneti con i portainnesti americani sperimentati in Sicilia ma ciò di cui si sente la necessità, per dare una nuova spinta al commercio dei prodotti della vite, è un collegamento con il continente. Sul finire dell’800 la Società Siciliana aveva proposto un servizio di collegamento con Porto Santa Venere in Calabria ma non se n’era fatto niente. E’ solo a seguito del terremoto di Messina del 1908 che il Ministero della Marina Mercantile autorizza un collegamento settimanale con Napoli. Ed è proprio questa nuova linea che stimola molti proprietari di Malfa e Leni a reimpiantare i vigneti e si parla addirittura di avviare un commercio della malvasia con le Americhe.
Anche a Salina come a Lipari e nelle altre isole, giungono le rimesse degli immigrati ad alimentare l’economia. Secondo stime nel 1905 presso la Cassa postale di S. Marina Salina sono depositati risparmi per 392 mila lire, 200 mila presso quella di Malfa e 54.960 in quella di Leni. Un flusso che andrà via via aumentando fino a raggiungere, nel primo dopoguerra, una media annuale di 3 milioni di lire per l’intera isola. Sono diversi inoltre i salinari che , fatta fortuna negli Stati Uniti, tornano nelle Eolie per investire i loro risparmi. Valga per tutti l’esperienza di Carmelo Biscotto di S. Marina che vende il suo negozio di generi alimentari di New York ed apre a Lipari, sulla banchina di Sottomonastero, una fabbrica di ghiaccio e, più tardi, in società con Bartolo Zagami e Giuseppe de Luca fonderà la Società Elettrica Liparese.

Lipari. Sottomonastero. La fabbrica del ghiaccio
Ma, malgrado questi segnali, la strada per uscire dalla condizione di marginalità cui da una parte l’isolamento insulare e dall’altra la lunga stagione del confino - che riprenderà sotto il fascismo pur con altra qualità di confinati - avevano relegato le Eolie sarà ancora lunga.
Inoltre a bloccare, praticamente sul nascere, sogni e speranze arriva la grande guerra. La linea con Napoli viene sospesa e le navi della Società Siciliana vengono requisite. I collegamenti fra l’arcipelago e la Sicilia, con cadenza bisettimanale, sono affidati ai vecchi ferry boats che facevano il servizio sullo stretto di Messina, mentre il collegamento fra le isole è abbandonato a piccoli motovelieri che svolgono un servizio approssimativo e saltuario. I cenni di ripresa economica sono così congelati e bisognerà aspettare il 1919 per riparlare di ripresa.
[1] L.S. d’Austria, op. cit., vol VIII, pag. 25.
[2] M. Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit., pag. 159; A. Savignone, Relazione amministrativa per la divisione territoriale e patrimoniale del Comune di Salina nei tre Comuni autonomi di Santa Marina,, Malfa e Leni giusta la legge 26 dicembre 1909, n. 807, letta dal Commissario relatore l’1 agosto 1910, Stabilimento tipografico G. Fiore e figli, Palermo 1911.
[3] D. Giuffré, Pro Santa Marina, Messina 1907.
[4] M.Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit, 171-193. Tutto questo paragrafo si basa sul terzo capitolo di questo libro.
il sac. Bartolo Picone
Il primo Novecento e la speranza di uno sviluppo diverso
Villa Mazzini ai primi del secolo.
I fermenti del primo 900
Il primo 900 è ricordato nella storia italiana come l’”età giolittiana”, cioè una fase in cui la figura di Giovanni Giolitti - che fu presidente del consiglio dei ministri quasi ininterrottamente per un decennio, dal 3 novembre del 1903 fino al 7 marzo 1913 - svolse un ruolo preminente contribuendo ad ammodernare lo Stato ed a fare crescere la società. Furono gli anni in cui uscirono leggi per la tutela del lavoro delle donne e dei bambini, fu resa obbligatoria l’istruzione elementare, nacquero le ferrovie dello stato, si stabilì un modus vivendi fra governo e sindacati e gli scioperi non vennero più repressi, si svilupparono movimenti popolari come quelli dei socialisti e dei cattolici, si introdusse il suffragio universale maschile portando gli elettori da 3 milioni e mezzo a circa 9 milioni. Si ebbe cioè, in questo periodo, una notevole crescita della società civile.
Anche Lipari in qualche modo partecipò a questo fermento associativo. Nel novembre del 1903 si costituì un comitato provvisorio “Pro Isole Eolie” sotto la presidenza dell’avv. Gaetano De Pasquale che si proponeva di “gittare le fondamenta di un’Associazione che abbia lo scopo, in generale, di sollevare un pochino le sorti di tutti gli eoliani, e più particolarmente quelle di molti piccoli proprietarii che il flagello fillosserico, nonché quello d’’emigrazione ha ridotto…a mal partito”[1]
Continuavano intanto ad operare la Società operaia di mutuo soccorso animata dall’avv. Onofrio Carnevale Rossi e dall’avv. Francesco Casaceli, il Circolo cattolico, il Circolo dei cacciatori, il Nuovo Circolo che era un’associazione culturale e forse anche una Associazione dei Commercianti.
Inoltre proprio l’1 novembre 1905 nasceva l’ “Istituto delle suore francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari” promosso da una giovane liparese, Giovanna Profilio[2], che era emigrata a New York nove anni prima e li si era fatta suora. Giovanna divenuta suor Florenzia era stata richiamata a Lipari dal vescovo mons. Raiti perché diversi esponenti del clero eoliano avevano convinto il presule che a Lipari ci fosse l’esigenza di un istituto locale che si dedicasse ai bambini abbandonati ed alle ragazze madri giacchè le suore di Carità sembravano privilegiare l’insegnamento per le ragazze delle famiglie borghesi[3].
 Suor Florenzia Profilio
Suor Florenzia Profilio
In Consiglio comunale si fronteggiavano il Partito popolare liberal-progressista e del Fascio dei Lavoratori che detenne la maggioranza dai primi del novecento sino alla vigilia della prima guerra mondiale e il Partito democratico che rappresentava l’opposizione e di cui i consiglieri più attivi erano Felice Sciarrone e Nino Marchese che erano anche animatori del movimento degli operai della pomice.
Come abbiamo avuto già modo di dire furono anni questi di grande instabilità amministrativa. Per ben due volte fu nominato un regio commissario. La prima fra i 27 settembre 1903 ed il 22 febbraio 1904 al culmine di uno scontro in Consiglio comunale fra l’Amministrazione del Sindaco Faraci e il consigliere Caserta che aveva denunciato “ furti e corruzioni che si commettono ogni dì da persone di questa Amministrazione”. I furti e le corruzioni riguardavano il contrabbando che, secondo Caserta, praticavano molti borghesi di Lipari proprietari di terreni pomiciferi fra cui anche esponenti della maggioranza. La seconda nomina del regio commissario è fra il 15 gennaio ed il 15 luglio 1907 ed, ancora una volta ad essere interrotta, è l’amministrazione del Sindaco Faraci. Il problema è sempre quello del contrabbando della pomice per non pagare i diritti comunali ed è a proposito di esso che viene votata la sfiducia il 27 agosto 1906. La Giunta procede il suo mandato, sebbene in minoranza, fino alla fine di dicembre.
E fu proprio nel periodo del commissariamento che a Lipari maturano nuove prospettive politiche ed economiche. Si ha la certezza che verrà approvata la tanto attesa leggina che istituisce il dazio sulla pomice a favore del Comune garantendo così un flusso di risorse che si prevede notevole e si prospetta una amplissima convergenza – al di là degli schieramenti politici – sul cav. Giuseppe Franza.. Ed il 16 luglio 1907 il Consiglio comunale elegge con 28 voti Sindaco il Franza che presentò il suo programma nella seduta del 12 agosto.
Nel suo discorso il Sindaco disegnò grandi scenari di sviluppo non solo grazie alle entrate della pomice . Annota il segretario comunale nel verbale che “accenna parimenti ad opere da farsi onde abbellire la cittadina pel richiamo dei forestieri i quali, trovando tutto il confortabile della vita specie in buoni e decenti alberghi, in amene passeggiate, in fronsute villette, darebbero quell’utile da cui il piccolo commercio troverebbe quell’incremento che attualmente non vede”[4]. Già Franza sogna il turismo.
L'esigenza di uno sviluppo diverso
Parlare di sviluppo turistico all’inizio del 900 poteva sembrare avventato perché le Eolie allora, a parte i bei paesaggi ed un mare limpido, non avevano proprio nulla di accogliente e non solo in senso ricettivo ma anche per molti usi e costumi degli abitanti. Un esperto come Luigi Vittorio Bertarelli del Touring Club Italiano – che aveva visitato l’arcipelago alla fine dell’800 e vi era tornato dieci anni dopo - scriveva[5] nel 1909 : “Gli alberghetti sono al di sotto di qualunque infima osteria di un paese settentrionale e così sporchi da apparire inabitabili. Il ristorante – quasi l’unico – che passa per il migliore di Lipari è una bottega sudicia ad archivolti bassi, dove si mangia alla meno peggio ma dove il servizio è fantasticamente diverso da quanto s’usa in luoghi rispettosi del viaggiatore. La commissione per il miglioramento degli alberghi del Touring qui nulla potrebbe fare; si troverebbe come un missionario incompreso in partibus infidelium… L’evoluzione è ancora lontana, l’abiezione attuale non è quasi avvertita”.
E facendo il raffronto con i ricordi della prima visita scriveva:” Essa mi è sembrata quest’anno identica alla Lipari di dieci anni fa, quando un’altra volta visitai le Eolie. Anche oggi trovai l’identica mancanza di confort e la stessa sporcizia per la quale, messo piede nell’Albergo Nazionale, che passa per il principale, fuggii in strada inorridito senza saper bene dove avrei posato il mio scarso bagaglio. Mi indicarono un altro albergo di cui poi da altri sentii parlare come d’un canile, ma mentre mi avviavo, fui fermato per la strada da un bottegaio che mi offrì una camera mobiliata dove stetti discretamente…Non vidi nella pubblica edilizia alcun che di mutato in dieci anni”
A questo punto il Bertarelli si sofferma a descrivere un “vespasiano” che esisteva ancora negli anni 40 ed era alla sinistra, guardando, la chiesetta del Purgatorio.
” Dietro la Capitaneria di Porto vi è ancora come allora (dettaglio zoliano ma caratteristico di cui non posso defraudare i lettori della Rivista )un pubblico ed utile ritrovo. E’ costituito da una sala intorno alla quale corre una specie di divano orientale o gradino, coperto di piastrelle bianche con vaghi disegni azzurrini, opportunamente perforato nel piano superiore da una dozzina di buchi rotondi di trenta centimetri, come una cucina economica. Su questo bel piano si assidono per le proprie occorrenze i cittadini liparoti, conversando piacevolmente dei propri affari, e dimostrando così una grande attività poiché senza perder tempo compiono due servizi. L’ingegnoso monumento vespasiano ritrae particolare pregio dall’essere impostato sopra una grossa roccia quasi a raso del mare, in cui guardano direttamente i sopradetti trafori. Quando c’è un po’ di maretta gli schiaffi delle onde battono di sotto in su e il rinfresco deve essere detersivo e delizioso”.
Ma il grottesco di questo “servizio pubblico” si sposa ad altri elementi che farebbero fuggire qualsiasi turista di oggi.
“Le case liparitane hanno –continua il fondatore del TCI - un aspetto prettamente orientale. La maggior parte sono basse, con tetto a terrazzo lievemente convesso per inviare le acque nelle cisterne. Purtroppo non vi sono nell’isola sorgenti. Tutta l’acqua che si beve è piovana e , di regola, neppure grossolanamente filtrata[6]. Vi sono dei pubblici serbatoi[7] accanto ai quali furono installate delle piccole pompe col criterio igienico di impedire che nella loro acqua fossero immersi i secchi di tutti ma, forse per non guastar le pompette, queste sono chiuse accuratamente da uscioli di legno, la cui chiave sarà, credo, al Municipio, e così tutti attingono colle proprie corde ed i propri secchielli…
Nelle pittoresche casette, brillanti internamente di sempre rinnovato imbianco, la pulizia privata lascia a desiderare, non meno di quella pubblica, in troppi siti. Dalle screpolature, assai spesso sismiche, che un po’ dappertutto fanno capolino alla superficie degli intonachi, vengono fuori, specialmente alla sera a prendere il fresco, insetti di ogni qualità che non sono abbastanza etmologo per classificare, ma che vanno dai centopiedi e dai ragni, dei quali la dimestichezza non è poi tanto spiacevole, alle blatte e alle cimici di cui guai a preoccuparsi perché non si avrebbe più il coraggio di dormire. E le pulci? Che dire delle pulci? D’estate in generale in tutta la Sicilia sono un flagello..Nulla dico delle zanzare…”

Certo, osserva ancora Bertarelli a “ Lipari vi sono del resto numerose case di ricchi negozianti, di industriali in vino e in pomice e di agricoltori che nulla lasciano a desiderare, ma sono case private alle quali naturalmente non può accedere chi vuole.
Comunque, che a Lipari in quegli anni stia maturando anche un nuovo senso estetico e si cominci a pensare anche all’immagine della propria cittadina, lo dimostra una lettera che abitanti della Marina San Nicolò, proprietari delle case e dei terreni lungo quella strada, scrivono al Sindaco ed ai Consiglieri per proporre un intervento su di essa.
“Se gli on. Signori del Consiglio – si legge nella lettera – si fanno due passi per la detta Marina, che poi in tutti i tempi e più specialmente nelle stagioni calde è la passeggiata preferita anzi ambita da indigeni e forestieri, si accorgono a prima vista degli sconci enormi che essa presenta. Case, che rientrano; case che escono più in fuori; piccole cucine e scale aperte costruite sulla pubblica via. Sembra, ce lo consentano, una strada di un centro ancora adamitico!...Ora, gli esponenti, desiderosi di estetica e di ordine nelle vie, e di vedere con lo sviluppo economico il progresso edilizio e un rinnovamento del Paese, si offrono spontaneamente per l’allineamento del tratto di detta via, sulla quale fronteggiano, pronti a subire la spesa per l’acquisto del terreno, a titolo di vendita o di concessione, pagando la spesa a cui ognuno rispettivamente sarà tenuto”.
In premessa gli scriventi[8] avevano detto che “sarebbero disposti ad incontrare qualsiasi sacrificio, pur di vedere un po’ di quell’ordine nella costruzione dei fabbricati che tanto di bello farebbe acquistare al Paese”. A loro non dispiacerebbe che un tale provvedimento “fosse adottato per tutto Lipari” ma comunque intendono dare un segnale importante ed allegano anche uno schizzo planimetrico. Naturalmente il Consiglio approva all’unanimità. Un solo contrario e due astenuti sul punto della delibera che stabilisce l’allineamento anche per l’ultimo tratto della Marina adiacente alla proprietà Famularo il cui proprietario non era fra gli scriventi.
Se Lipari lascia a desiderare sotto diversi aspetti, ben più grave deve essere, in genere, la vita nelle borgate e nelle isole a cominciare da Canneto che, nel comune, dopo Lipari, è la realtà più popolosa.
Ancora nel 1910 Canneto era un piccolo borgo di contadini, pescatori e cavatori che sul finire dell'800 ed i primi del 900 aveva avuto una crescita esponenziale della popolazione a causa dell'industria della pomice [9]. Si perveniva per una mulattiera profondamente incassata nel tufo che prima si arrampicava sul timpuni della Serra e poi scendeva a Canneto di Dentro. Canneto si raggiungeva da Lipari o a piedi, con una buona ora di cammino, o a dorso d'asino, o con il vapore che vi faceva scalo operando con le barche, il cosiddetto rollo. Lungo tutta la spiaggia che si sviluppa a falce sorgevano case bianche alternate con grandi magazzini e baracche che servivano da depositi della pietra pomice. Al centro del paese, come oggi, la chiesa di San Cristoforo che dava direttamente sulla spiaggia, stretta ai fianchi ed alle spalle da case e casupole nate senza alcun ordine.[10].

Il sentiero che da Bagnamare (Pignataro) portava alla Serra e da lì a Canneto.
La condizione di Canneto e i problemi di Stromboli
A Canneto nel 1890 erano stati istituiti una collettoria postale e un ufficio telegrafico, quando il Consiglio affronterà il dibattito sul Bilancio del 1900 fra le opere previste si parla del tracciamento di una strada interna nel villaggio parallela alla spiaggia e di una condotta medico-chirugica. Nel dibattito emerge anche la necessità di un cimitero, di una farmacia, di una strada che metta “ in diretta comunicazione quella borgata col capoluogo del Comune”. Nella seduta del 5 novembre 1906 vengono fatti voti al governo perché il piroscafo di linea giornaliera faccia scalo nella rada della borgata “essendo Canneto, specie d’inverno, tagliata interamente fuori dalla Città di Lipari, ove avvengono gli attuali approdi essendo che tra Lipari e Canneto non hanno alcuna strada rotabile e mulattiera”.

Una testimone[11] ricordando quei tempi lontani, descrive il villaggio di Canneto come “abbandonato”. “C'erano poche case. Mio padre era considerato benestante perché aveva due case.... A quel tempo erano quasi tutti contadini o pescatori; non sapevano né leggere né scrivere. A Canneto non c'era luce, non c'era gas, né un dottore, né una farmacia. Bisognava andare a Lipari. La gente partiva al mattino per lavorare in campagna e tornava la sera. Oppure si lavorava per cavare la pietra pomice, cento palmi sotto terra[12]. La gente tirava avanti col ricavato della campagna, della pesca e della vendita della pietra pomice. La sera si accendevano i lampioni, che ogni mattina venivano riempiti di petrolio. La sera non usciva nessuno. Il gelato si vedeva per San Bartolo o san Cristoforo. La carne si mangiava raramente e la mangiavano chi aveva galline o qualche coniglio... Si mangiavano legumi. Anche la pasta era scarsa. Dopo la guerra si ritirava con la tessera. Arrivava un vaporetto e tutti si mettevano in fila per ritirarla. Qualche volta anche inutilmente perché la distribuzione finiva prima che tutti potessero avere la loro razione e a volte doveva intervenire un pubblico ufficiale per evitare le particolarità.”
Le cose vanno meglio a Stromboli, almeno sotto l’aspetto della pulizia e dell’igiene ma anche qui i servizi, a cominciare dall’acqua, sono completamente assenti.
“Gli abitanti – commenta Bertarelli – non hanno segreti né paure, ossia nulla da nascondere moralmente e materialmente: tutte le porte sono aperte, né vi è un solo carabiniere in tutta l’isola. Si guarda perciò liberamente dappertutto, si entra dove si vuole, certi d’essere accolti cortesemente. Davanti ad ogni casa c’è un allegro pergolato; nel complesso le abitazioni hanno un’aria, se non d’agiatezza, per lo meno di decorosa povertà…C’è, complessivamente, una certa pulizia, favorita dal clima sempre secco, anzi purtroppo così secco che la mancanza d’acqua è una grave calamità normale. Come in tutte le Eolie, qui non c’è una sola fonte, o, per essere preciso, ce n’è una la quale dà, goccia a goccia, si e no una bottiglia d’acqua ogni dieci minuti! Tutta l’acqua che si beve è di cisterna, ma talora le cisterne sono insufficienti, e si patisce la sete. D’estate non piove mai e quando le cisterne sono presso ad esaurirsi, l’acqua è veramente pessima. Io mi portai dell’acqua minerale da Lipari, ma siccome non mi bastò, mi provvidi poi di acqua filtrata al semaforo, per gentilezza dei semaforisti”[13].
Forse il problema maggiore degli abitanti di Stromboli è il loro vulcano con cui convivono ma che ogni tanto crea dei problemi. Come nel 1916.
“Nella notte tra il 3 e il 4 luglio – scrivono al Sindaco ed al Consiglio trentanove cittadini di Stromboli – questo vulcano esplodendo violentemente, lanciò in aria migliaia di tonnellate di materiale infuocati, di cui una parte cadde sulla sciara del fuoco e quindi in mare ed un’altra parte si riversò sul versante coltivato dell’isola , giungendo fino in prossimità dell'abitato. Si verificarono molti incendi e nei due terzi superiori dell'isola fu distrutto tutto il raccolto ed una gran parte dei vigneti. La scossa dell'esplosione ruppe tutti i vetri dell'abitato e molte imposte producendo pure lesioni alle case. Non si ebbero a lamentare vittime perché tutto ciò successe di notte ed in un'ora in cui tutti gli abitanti erano a letto. Il Governo inviò i professori Ponti e Palonà di Catania per verificare ciò che era successo e il Brigadiere del Regio Carabinieri fece subito un primo elenco dei danni che in seguito, negli ultimi di luglio, furono pure constatati da un Tenente dei carabinieri venuto espressamente. Si calcola che il danno ascenda a più di 150.000 lire[14]”. Gli scriventi chiedono lo sgravio della tassa fondiaria per almeno dieci anni. Il consiglio all'unanimità fa voti perchè il Governo accolga la richiesta.
Ed è proprio il vulcano che già allora attira turisti. Tanto è vero che Bertarelli ne incontra due nella sua escursione: sono un professore di geografia, polacco e slavo che fa un viaggio di istruzione a spese del governo austriaco ed un giovane fotografo professionista tedesco.
Ad Alicudi non c'è serenite nemmeno per i morti

Ma se i servizi pubblici lasciavano a desiderare a Stromboli ed a Lipari la situazione è veramente intollerabile ad Alicudi ,”isola perfettamente dimenticata” come ebbe a definirla il 5 febbraio 1900 in Consiglio comunale Giovanni Caserta pretendendo che si leggesse una lettera inviata il 26 novembre del 1899 dai capi famiglia dell’isola e rimasta in evasa. Tre sono i problemi che essi fanno presenti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale: il medico che manca da quattro mesi e non si è potuto fare il vaccino del vaiolo per i bambini mentre nell’ultimo anno ci sono stati morti per malattie infettive ; la levatrice che non si è mai avuta e che ora viene richiesta pressantemente perché molte donne sono in stato interessante; la mancanza di un cimitero. E a proposito del seppellimento dei morti la situazione che descrivono e degna di un racconto dell’orrore. “Da sei mesi in qua, ogni qualvolta si deve seppellire un cadavere, si dovrà prima piggiare i morti nella sepoltura con dei legni o con i piedi per poter fare andare il morto”.
Ma se non era ancora il momento del turismo certo , grazie all’appoggio del deputato locale e le nuove risorse che vengono dalla pomice, si può pensare a tante cose che fino ad ora si erano trascurate. E fu negli anni del Sindaco Franza che si ottennero miglioramenti nei servizi marittimi, nel rifornimento idrico a mezzo navi cisterne della marina militare, che arrivarono anche finanziamenti per qualche opera pubblica. Si lastricò con basole di pietra lavica per intero via Garibaldi, si accelerarono i lavori del nuovo edificio sulla Civita destinato a sede municipale, si risistemarono e prolungarono di qualche metro le banchinette nord e sud della penisoletta del Purgatorio, si realizzò un pezzo di approdo a Sottomonastero, si attrezzò e prolungò di quaranta metri il molo di Pignataro, vennero progettate le rotabili Lipari-Canneto e Lipari-Quattropani con deviazione per San Calogero anche se ancora nel 1920 non c'erano strade carrozzabili e la cosiddetta mulattiera Lipari-Canneto era in realtà un sentiero da capre, malamente praticabile per gli uomini e per gli asini.
Grazie alla legge n.10 del 1908 i proventi permisero al Sindaco di ridurre notevolmente le tasse ordinarie e di riportare a pareggio il bilancio. La legge prevedeva un regolamento applicativo che fu approntato e pubblicato il 21 luglio e con delibera dell’8 agosto il Consiglio comunale fissava l’ammontare delle tangenti a seconda della qualità dei prodotti. Ma per via di contestazioni da parte dei cavatori, nei primi anni, il Comune ebbe serie difficoltà a far rispettare i suoi diritti. Comunque dopo le prime difficoltà i proventi ammontarono a circa L. 100.000 annue. Non erano i 500 mila calcolati, o forse solo sperati,ma si trattava comunque di una buona entrata che poteva permettere a Lipari di guardare con più serenità e fiducia al futuro.
Le contestazioni riguardavano l’esenzione dei materiali estratti in data anteriore al giorno di pubblicazione del regolamento e giacenti nei magazzini. Ora malgrado il Comune avesse nominato una commissione per accertare queste giacenze, alcune aziende piccole e grandi, si diedero a praticare una sorta si contrabbando smaltendo le giacenze e ripristinandole via via, in maniera occulta con materiale di recente escavazione.
Comunque – malgrado le forti carenze - la società liparese sembrava sollecitare uno sviluppo diverso, capace di andare al di là di una agricoltura ormai divenuta insufficiente e di una industria della pomice, per quanto in crescita, sempre limitata di fronte alle esigenze crescenti. Uno sviluppo meno pauperistico ed austero ed in qualche modo già con qualche licenza consumistica.
[1] G. De Luca, L’economia Eolia, Riposto 1926, prefaz. P.IV. Altri componenti di questo Comitato furono il notar Domenico Giuffré, l’avv.Giuseppe La Rosa, il dott. Giuseppe Pittorino, il dott. Favazza …
[2] Madre Florenzia Profilio, al secolo Giovanna, nasce a Pirrera all'alba del 30 dicembre del 1873 da Giuseppe e Nunziata Marchese. Vedi la scheda sulla sua vita.
[3] M.Giacomantonio, Florenzia che ha svegliato l’aurora, Cinisello Balsamo 2009.
[4] Verbale del Consiglio comunale del 12 agosto.
[5] L.V. Bertarelli, Escursione alle Isole Eolie, in “Rivista mensile Touring Club Italiano”, agosto 1909, pp.340-342.
[6] Le famiglie più agiate, annota Iacolino (Inedito, cit. Quaderno XI, pag. 528 a 2).disponevano di un filtro ingegnoso costituito da una grossa pietra di natura porosa sagomata a forma di anfora romana, cava all’interno e con la base a punta. Siffatto contenitore veniva collocato su un treppiedi di legno e ferro. Ripieno d’acqua, anche limacciosa, il filtro restituiva dal ‘pizzo’, a goccia a goccia, il liquido discretamente limpido.
[7] Le famose “gibbie” che si trovavano al Pozzo,all’inizio del viale vescovile
[8] Ecco i nomi degli scriventi dotati di senso civico: Giuseppe Cincotta, Antonino Profilio, Giovanni Gioffé fu Antonino, Bartolo Le Donne di Giuseppe, Giovanni Natoli fu Antonino, Nicola Fazio di Giuseppe, Salvatore Sciacchitano, Caterina Merlino, Matteo Giuffré, Caterina Sciacchitano, Giovanni Tesoriero, Caterina Favorito vedova Paternò Gaetano, Ferdinando Paino fu Onofrio, Nunziata Macrì fu Vincenzo, Giuseppe Casaceli.
[9] G. Iacolino, Strade che vai, ecc., op.cit. pagg. 99-113. Nel 1810 la borgata era ancora “ piccolo casale”, nel 1971 contava 792 abitanti, nel 1907 questi erano saliti a 2.526.
[10] Per la ricostruzione dell'immagine di Canneto come della strada di collegamento ci siamo appoggiati al libro di Luigi Salvaore d'Austria, Le isole Lipari. Vol. III , Lipari, op.cit. pag. 56-60, ritenendo che nel 1912 i cambiamenti rispetto a venti anni prima dovessero risultare minimi. V. anche G. Iacolino, Strade che vai..., op.cit.
[11] Anna Megna vedova Virgona nata a Canneto il 16 giugno 1906 ed avente l'età di 87 anni al momento della deposizione ( 13 settembre 1993). La testimonianza si trova nell'Archivio della Casa generalizia delle Suore a Roma in una cartella denominata “Segnalazioni di grazie attribuite all'intercessione della Serva di Dio Madre Florenzia Profilio”.
[12] Oltre ad essere un lavoro faticoso e pericoloso come lo può essere il lavoro in cava sempre a rischio di crolli nelle piccole gallerie, quello dei cavatori di pomice era un mestiere anche a rischio a causa, come abbiamo visto, delle “liparosi”.
[13] Idem, settembre 1909, p. 388.
[14] Dal verbale del Consiglio comunale del 22 agosto 1916.
Le difficoltà di un territorio, e le difficoltà di un vescovo
La valvola dell'emigrazione
 Alla fine dell’800, cade vistosamente l’agricoltura soprattutto per via della malattia della vite, la fillossera, che colpisce i tre quinti dei vigneti e soprattutto la produzione di vino e passolina; si esaurisce il ruolo strategico svolto dall’arcipelago come tappa obbligata sulle rotte mediterranee, in un’epoca in cui la navigazione a vela costituiva il mezzo principale per il trasporto di merci e persone dalla Sicilia al continente[1]; armatori e padroni di piccoli velieri si trovano in difficoltà oltre che per la concorrenza delle navi a vapore, perché le ferrovie e le strade, soprattutto lungo la costa tirrenica meridionale, rendevano più facili e meno onerosi i trasferimenti via terra di certe merci[2]; è sepolta dall’eruzione di Vulcano la piccola industria di zolfo e allume; scarsamente redditizia la minuscola salina di Lingua. Vi era l’industria della pomice che- come abbiamo visto – fra alti e bassi cercava di trovare un proprio percorso di crescita ma non poteva soddisfare tutte le esigenze occupazionali. Vi era anche la marineria peschereccia che si manterrà più o meno stabile quantitativamente anche se stenta a divenire una vera e propria attività professionale. I vuoti causati dalle emigrazioni verranno riempiti da graduali immigrazioni di altri pescatori provenienti dal palermitano, messinese, dalla riviera di Acitrezza del catanese. [3]
Alla fine dell’800, cade vistosamente l’agricoltura soprattutto per via della malattia della vite, la fillossera, che colpisce i tre quinti dei vigneti e soprattutto la produzione di vino e passolina; si esaurisce il ruolo strategico svolto dall’arcipelago come tappa obbligata sulle rotte mediterranee, in un’epoca in cui la navigazione a vela costituiva il mezzo principale per il trasporto di merci e persone dalla Sicilia al continente[1]; armatori e padroni di piccoli velieri si trovano in difficoltà oltre che per la concorrenza delle navi a vapore, perché le ferrovie e le strade, soprattutto lungo la costa tirrenica meridionale, rendevano più facili e meno onerosi i trasferimenti via terra di certe merci[2]; è sepolta dall’eruzione di Vulcano la piccola industria di zolfo e allume; scarsamente redditizia la minuscola salina di Lingua. Vi era l’industria della pomice che- come abbiamo visto – fra alti e bassi cercava di trovare un proprio percorso di crescita ma non poteva soddisfare tutte le esigenze occupazionali. Vi era anche la marineria peschereccia che si manterrà più o meno stabile quantitativamente anche se stenta a divenire una vera e propria attività professionale. I vuoti causati dalle emigrazioni verranno riempiti da graduali immigrazioni di altri pescatori provenienti dal palermitano, messinese, dalla riviera di Acitrezza del catanese. [3]
Rimaneva – osserva Giuseppe Arena – ben poco della già fiorente vita economica eoliana[4] e la crisi esplode gravissima. L’incremento e la regolarizzazione del lavoro nelle cave e il piccolo contributo, che può venire da una pesca ancora in via di professionalizzazione, non possono compensare la crisi dell’agricoltura e così la situazione economica generale, al principio degli anni 90 , cominciò a farsi pesante e, nel giro di qualche lustro, divenne drammatica[5].
Una crisi che si riflette sul popolo minuto. Per tali motivi gli eoliani furono costretti a cercare altrove nuove occasioni di reddito e ciò spiega l’esodo massiccio che a partire dai primi anni del 900 ha interessato l’arcipelago: emigrazione definitiva di interi nuclei familiari prevalentemente rivolta verso i paesi extraeuropei[6].
Nel 1893 cinquecento eoliani vivevano all’estero[7]. Nel 1901 questi dovevano essere non meno di cinquemila, per lo più originari di Lipari e Salina. Dal 1901 al 1914 emigrarono 9.916 eoliani e di questi 6.719 in USA, 2.527 in Argentina e 670 in Australia[8]. Nei primi anni del secolo varie decine di marinai di Filicudi ed Alicudi andarono a lavorare come palombari o come braccianti generici nella costruzione dei nuovi porti in Tunisia, Algeria e a Marsiglia.[9] Non erano pochi i braccianti che non se la sentivano più di fare affidamento sul precario reddito delle campagne o di logorarsi l’esistenza nelle cave pomicifere dove ogni anno due o tre uomini ci lasciavano la pelle. Era poi improbabile che qui, come avveniva in molti altri paesi della Sicilia, si organizzassero società operaie volte ad obiettivi di rivendicazione. [10]
Punto di arrivo per molti? Five Point a New York

Emigranti eoliani in partenza da Canneto
La gran parte degli eoliani che emigra è quindi gente povera che deve affrontare viaggi lunghi e difficili verso i continenti d’oltreoceano su navi che impiegano settimane, stipati in terza classe, superando i travagli e le difficoltà che una letteratura ormai ricca ci ha fatto conoscere. Per chi va negli USA ed a New York, è sono come abbiamo detto la maggioranza, dopo veti giorni di viaggio c’è la quarantena di Ellis Island e poi una metropoli in piena trasformazione con i gravi problemi dell’abitazione, del lavoro, della lingua, dell’assistenza sanitaria. Molti eoliani andarono ad abitare nel quartiere italiano fra Mulberry street e Baxter Steet, “un agglomerato di casacce nere e ributtanti, dove la gente vive accatastata peggio delle bestie”[11]. Eppure moltissimi di essi riuscirono a mantenere un loro decoro. E il decoro, malgrado la povertà, è il tratto da cui, forse la maggior parte, non deflette distinguendosi dalla gran parte degli altri immigrati. Il decoro e la dignità ecco il tratto , in genere, dei liparesi che emigrano in quegli anni. Gente che ha famiglia e che tiene alla famiglia e, anche quando la lascia al paese, non se ne distacca spiritualmente, ma pensa a ragranellare un suo gruzzolo per tornare a investirlo a casa e migliorare le dure condizioni di vita. Gente povera ma parsimoniosa e soprattutto profondamente onesta, i liparesi di allora, che sanno che cosa vuol dire “degrado” perché lo hanno conosciuto attraverso la condotta di vita di molti coatti, e se ne vogliono mantenere distanti, separati come da una linea ideale che però loro hanno ben presente. E così appena possono non vanno ad abitare nel calderone di Five Point ma nelle sue prossimità tenendosi ad una certa distanza come nel quartiere di Sullivan Street dove c’è una chiesa di francescani italiani e possono continuare a praticare una religione che ricorda quella di casa loro. Una vita che in qualche modo ricordi le isole di provenienza. Ed in ciò sono aiutati da tutta una rete di società di mutuo soccorso che permettono un’agevole integrazione nella società americana. Fra il 1898 ed il 1915 se ne costituiranno, fra gli eoliani, ben quattro[12].

New York, Little Italy fine 800
Comunque quell’ondata migratoria non incise più di tanto sulla popolazione eoliana. 21.210 abitanti contavano le Eolie nel 1891 e 20.610 ne avevano nel 1911. Inoltre diversi emigranti del primo flusso erano tornati nelle isole per investirvi i loro risparmi mentre quelli che erano partiti lasciando nelle isole la famiglia, regolarmente inviavano le rimesse in valuta che influivano positivamente bell’economia dell’arcipelago che, come si è detto, contava problemi non indifferenti. Ed è proprio grazie a queste rimesse che si cominciano a notare fabbricati interamente ristrutturati, con i prospetti messi a nuovo e finalmente, con all’interno, moderni servizi igienici.
Ma dall’emigrazione non rientrano solo capitali o persone che intendono investire, come vedremo, nelle isole. Rientrano anche persone inferme e affette da malattie contagiose “per le privazioni e dure fatiche in quelle terre” [13]
Le difficoltà di un vescovo
Ma mentre gli eoliani costretti ad emigrare ricercano nella chiesa cattolica un dato di continuità con la loro vita passata e si stringono ad essa a cominciare proprio dai salinari che all’emigrazione danno un contributo imponente, la borghesia di Salina rimasta nell’isola polemizza col nuovo vescovo mons. Audino giunto da poco a Lipari. Il 24 ottobre del 1899 in una “Lettera del Vescovo di Lipari ai suoi fedeli diocesani” mons. Audino afferma che “Il soffio della malvagia rivoluzione” - intende quella risorgimentale - ha invalidato la norma evangelica del “dare a Cesare quello che è di Cesare, e ad Dio quel che è di Dio” per cui la Mensa vescovile è giunta allo stremo e non si sa se possa esistere o debba scomparire.
Al vescovo, un comitato di salinari, risponde con una lettera di sette pagine a stampa, con in calce una decina di firme delle personalità in vista. Ricordando la lunga battaglia per affrancarsi dalle decime che giudicano ingiuste perché si usava il frutto annuale dei poveri coltivatori per fare arricchire altri con gli appalti, colle laute pensioni della mensa e perfino con maneggi più o meno loschi. Le rendite della Mensa non gravano in giusta proporzione su tutti i diocesani. La Mensa ha bisogno di sostegno finanziario? Si ricorra ad una forma di autotassazione che gravi su tutti i fedeli indistintamente e non sui soli contadini. “Salina non tenta di sottrarsi al peso rateale del mantenimento della Sede Vescovile; dice soltanto: Dividiamo i pesi in giusta proporzione” [14].
Questa risposta, certo polemica, ma con un fondo di verità non dovette offendere il prelato se, nei quattro anni in cui governa la diocesi, andrà a Salina[15] diverse volte – e vi tornerà anche quando è vescovo di Mazara del Vallo - ed il 21 luglio 1901 consacra il Santuario della Madonna del Terzito a Val di Chiesa.
Nella lettera pastorale che riguardava l’anno santo, l’1 gennaio del 1900, mons. Audino annunzia - in realtà come diremo i primi passi li aveva già compiuti - la volontà di aprire, “entro quest’anno memorando”, la nuova strada che permetta di accedere alla Cattedrale, “il maggior tempio, e forse l’unico degno di tale nome, che si ammiri in questa città”.
 Lavori di fronte alla Cattedrale
Lavori di fronte alla Cattedrale
I lavori, come si ricorderà, erano stati avviati da mons. Palermo che aveva acquistato i terreni dove doveva essere fatto il taglio e forse aveva anche avviato i lavori di sbancamento. Per questo lavoro il vescovo deve attingere al lascito di mons. Ideo che era – dopo il prelievo fatto da mons. Palermo – di 80 mila lire in titoli che il suo predecessore aveva cadenzato secondo una precisa sequenza di obiettivi. Fra questi non c’era la scalinata ma c’era la costruzione di una nuova Cattedrale e quindi mons. Audino, come prima di lui mons. Palermo, pensando che le due opere fossero fungibili, ritiene che anche la scalinata rientri nel lascito. I titoli di credito mons. Natoli li aveva consegnati alle suore di Carità che ne amministravano anche gli interessi giacchè fra le destinazioni, all’ultimo posto, vi erano anche le suore di Carità. Così il vescovo si rivolge alla superiora delle suore e chiede i titoli.
Suor Luisa Mandalari, superiora delle suore di Carità, consegna, per ubbidienza, il lascito ma è tutt’altro che convita. Visto infatti che la cattedrale in piano non si faceva e il Seminario era praticamente chiuso pensava che ormai fosse acquisito che, se non tutta la somma, almeno una buona parte, sarebbe andata alla realizzazione dell’Istituto delle suore. Così mentre consegna i titoli fa formale ricorso alla Congregazione dei vescovi e dei regolari chiedendo comunque la tutela degli interessi del suo istituto. L’Audino, cerca di rassicurare le suore mettendo a loro disposizione 20 mila lire di quel capitale, e contribuendo con fondi suoi propri si appresta a dare il via alle opere di scavo e di sfondamento delle mura. Il preventivo è di 50 mila e pensa che , tutto sommato, può starci dentro. Ora gli occorrono le autorizzazioni di Comune e Governo. Il 9 settembre 1899 scrive al Sindaco trasmettendogli il progetto e si augura che il Consiglio lo approvi nel più breve tempo ed all’unanimità perché “vuole subito cominciare i lavori e compirli con fondi suoi privati entro pochi mesi”.
Il progetto della scalinata per la Cattedrale
Il Sindaco, avv. Ferdinando Paino, si muove celermente e non solo per deferenza al vescovo ma anche perché i lavori possono assorbire un po’ di quella disoccupazione che affligge l’isola per via della siccità e della fillossera. E così il 19 ottobre il progetto arriva in Consiglio con la proposta di discuterlo al primo punto dell’ordine del giorno. Ma già fa fatica il Sindaco a fare passare questa precedenza e comunque non riuscirà ad ottenere l’unanimità, come il vescovo sperava, ma si dovrà contentare di diciassette voti contro tre. Inoltre la discussione durò per più sedute e se in generale gli interventi furono tutti di consenso e di plauso non mancarono però osservazioni e critiche. Così il consigliere Caserta vorrebbe la strada a rampe e non a gradini perché una “scalinata immensa stancherà tutti quelli che devono salire alla Cattedrale, tanto che molti preferiranno la vecchia[16]”. Inoltre il Caserta si opporrà anche alla richiesta di chiedere al governo la demolizione di ventun metri di mura perché “si deturperebbe la vetustà monumentale del Castello”[17] e suggerisce che si chieda il parere della Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti d’arte antichi.
Prima la discussione in Consiglio e poi la burocrazia, i tempi si allungano. Se mons. Arduino pensava che si potesse realizzare l’opera in pochi mesi, entro l’anno santo, dovette ricredersi presto. Infatti soltanto nel maggio del 1903 giunse l’autorizzazione per demolire i fabbricati sulla via Garibaldi di fronte al tratto di mura da sventrare[18], e in agosto si poté mettere mano al taglio delle mura con la gente che accorreva a vedere come ora la Cattedrale sembrasse più vicina. Ad ammirare “la Cattedrale più vicina” però non c’era fra i tanti mons. Audino che proprio nel mese di giugno era stato trasferito a Mazzara del Vallo e con la sua partenza l’opera si bloccherà e passeranno anni prima che venga ripresa.
Probabilmente è con mons. Audino che si inaugurano le collette all’estero fra gli emigranti eoliani per realizzare opere religiose e sociali. La colletta serve per opere di restauro nella Cattedrale ed il 9 settembre 1901 il vescovo - quando sono giunte le prime rimesse per 3.300 lire - elenca le cose fatte e quelle che rimanevano da fare[19].
Si deve anche a mons. Audino l’idea di ampliare e abbellire la chiesetta di Santa Lucia che era ai margini del Vallone fuori città. Lì tutte le domeniche mattine i contadini delle campagne scendevano con gli asinelli per vendere i prodotti della loro terra e fare provviste per la settimana. Legavano gli asini agli anelli che pendevano numerosi dal muro di recinzione del terreno vescovile e andavano alla chiesetta di Santa Lucia per ascoltare la messa. Ma i contadini erano tanti e la chiesa era piccola e così la messa finivano con l’ascoltarla solo le donne mentre gli uomini stavano sulla soglia a chiacchierare. Era un andazzo che al vescovo non piaceva e così pensò di affidare la chiesa alle cure spirituali di don Emanuele Scolarici che era un giovane prete vivace socialmente e politicamente ma che aveva anche doti di buon predicatore . Ed in una decina d’anni la chiesa fu ingrandita e restaurata.

Pensava di rimanere a lungo mons. Audino a Lipari perché era giovane e pieno di buona volontà, ma era anche un uomo combattivo che amava impegnarsi ed esporsi nelle cose in cui credeva. Così quando il 28 novembre del 1902 il presidente del consiglio on. Zanardelli presentò alla Camera il disegno di legge sul divorzio, il vescovo decise di fare una crociata sull’indissolubilità del matrimonio. E quale migliore occasione della novena dell’Immacolata per parlare contro il divorzio? Così fece venire a Lipari dei valenti oratori ed organizzò, nell’omonima chiesa al Castello, un grande raduno impegnando confraternite ed associazioni. La chiesa si riempì oltremisura e stava per prendere la parola il primo oratore quando fece irruzione la polizia ed il commissario avvicinatosi all’altare intimò al vescovo lo scioglimento del raduno. Il vescovo – come ebbe a scrivere in una lettera pastorale che fece stampare il 12 gennaio del 1903 – “da prudenza consigliato” dovette “cedere alla forza per evitare altri malanni”.
Ancora poche settimane ed il 4 aprile 1903 riceveva un biglietto da Roma nel quale gli si comunicava, ufficiosamente, che era stato deciso il suo trasferimento a Mazara del Vallo.
[1] La navigazione a vela diventa un ricordo storico e i vettori liparesi non dispongono dei capitali necessari per rinnovare le loro imbarcazioni. Feluche, brigantini, paranze, paranzelle e bovi, scibbecchi, scorridori e speronare dopo la metà del secolo rimangono ferme sui lidi delle isole dove si consumano divenendo miseri scheletri. Sul finire del secolo solcano però ancora i mari il brigantino Orsolina, la goletta Bella Anima, le tartane Madonna dell’Arco e S.S. Vergine, la bilancella Nuova Rosina, i brigantini a palo Alabama e Luigia. Angelo Raffa – Pirati, corsari, schiavi, marinai, mercanti - in Atlante.
[2] G. Arena, op. cit. pag. 52. Rocco Sisci – Marineria di pesca e da traffico nella tradizione eoliana, in Atlante:“Verso la fine degli anni venti del 900 la marineria da traffico appare Lipari in fortissima crisi: i velieri di un certo respiro sono del tutto scomparsi, mentre sopravvivono ancora, in numero poco elevato, piccole imbarcazioni. Non risolverà il problema – se non per i viaggi a livello locale e con la Sicilia – neppure la trasformazione dei natanti a vela in motovelieri nel corso degli anni 30. E così dopo una effimera ripresa del traffico a vela nel periodo a cavallo del secondo conflitto mondiale, il veliero scomparirà per sempre agli inizi degli anni 50”.
[3] Rocco Sisci – Marineria di pesca e da traffico nella tradizione eoliana, in Atlante:Questo fenomeno inizia ai primi del novecento e andrà gradualmente aumentando fino agli anni 40 del 900. I pescatori acitani ( acatani) si stabiliscono a Lipari a Marina Corta ed adoperano una barca delle loro parti, la palummedda. Comunque, nella prima metà del 900 ( anni 20 in particolare) la pesca è divenuta a Lipari già una attività professionale, mentre non lo è ancora nelle altre isole.
[4] G.A.M. Arena, L’economia…, op. cit., pp.51-52
[5] G. A.M. Arena, op.cit. , pag. 51.
[6] Maria Basile- Linee storico-evolutive della consistenza della popolazione . in Atlante.
[7] 1891- In tutto il Comune di Lipari si sono avuti 109 emigranti per New York, 50 in Australia e 22 a Marsiglia. Da Salina sono emigrate 147 persone per USA, 72 in Australia e 5 per l’Argentina.
[8] A. Mori, Emigrazione delle Isole Eolie, in “Rivista Italiana di Socilogia”, XIII, pp.51-63. L’emigrazione eoliana continuò ad essere rilevante anche nel primo trentennio del Novecento. Si fermò quasi del tutto dal 1931 al 1945, riprese con ritmo sostenuto dal 1946 e cessò quasi completamente negli anni Sessanta.Negli anni 50 l’emigrazione eoliana sarà diretta in prevalenza verso l’Australia. G.Arena, op. cit., pag. 53.
[9] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno XI , pag. 525.
[10] Pur tuttavia si avvertirono segnali di effervescenza borghese, di risveglio sociale e di invito al libero dibattito con la creazione di due periodici locali.
[11] A.Rossi, Un italiano in America, Milano, 1894. Una panoramica efficace della vita degli italiani negli Usa in quegli anni in G.A. Stella. L’orda, Milano 2003.
[12][12] Marcello Saja, Il museo dell'emigrazione eoliana di Salina, Gualdo Tadino, 7-8 giugno 2002, in www.emigrazione.it Anzi la prima società costituita da liparesi e salinari (provenienti dalla vicina isola di Salina) nasce a Brooklin nel 1887 – ben prima della grande crisi della vite – e si chiama “La Lega eoliana. Società di mutuo soccorso”. Dalla bella mostra itinerante “Sicilian Crossing to America and Derived Communities” predisposta dal CIRCE, Centro internazionale di ricerca per la storia e la cultura eoliana.
[13] Dal verbale del Consiglio comunale del 3 agosto 1912.
[14] A S.E. Mons. Nicolò M. Audino, Vescovo di Lipari, Tipografia P. Conti Lipari 1900. Il Vescovo di Lipari ed i suoi mezzi di sussistenza. Breve risposta del Popolo di Salina alla lettera del Vescovo di Lipari del 24 ottobre 1899 diretta ai suoi Diocesani.
[15] A favore dell’ipotesi che il vescovo si fosse riconciliato con le personalità di Salina, non solo ma che avesse stabilito un rapporto particolarmente cordiale sta il fatto a fine agosto, prima di lasciare la diocesi, passerà nell’isola alcuni giorni di riposo visitando la chiesa della Madonna del Terzito.
[16] Verbale del Consiglio comunale del 19 ottobre 1899.
[17] Verbale del Consiglio comunale dell’1 luglio 1903.
[18] In gran parte fabbricati della famiglia Bongiorno.
[19] G. Iacolino, inedito cit., Quaderno XI, p.512.
don Scolarici
La polemica dimentica il dramma dei lavoratori nelle cave. La "liparosi"

Una "foto di gruppo" dei cavatori con tanti.bambini.
Le condizioni di lavoro nelle cave
In tutta questa controversia fra Comune e Vescovato non si parla mai di quali fossero le condizioni di lavoro nelle cave. Innanzitutto quanti erano sul finire dell'800 i lavoratori della pomice? Vueiller nel 1893 parla di 1500 lavoratori che abitavano nei borghi di Canneto ed Acquacalda. Douglas che compie una indagine per conto del Foreing Office nel 1895 parla di 1000 addetti di cui almeno 600 destinati all'attività estrattiva; Gastone Vueiller nel suo resoconto del viaggio ci lascia due testimonianze : una diretta ed una del comandante la nave che lo trasportava a Messina.
Nella testimonianza diretta fra l'altro si legge: “ Provvisto di un cestino, di un piccone e di una lampada... l'operaio esce di casa alle quattro del mattino e arriva, dopo un'ora e mezzo di cammino, all'antico cratere. Là comincia per lui l'ascesa molto faticosa sul pendio. Alla fine raggiunge il capo di grotta, che comanda una squadra che conta dieci o quindici lavoratori. Insieme scendono tre o quattrocento metri sotto terra attraverso un sentiero inclinato. Ma prima di arrivare a quella profondità dove oggi si trova la pomice, gli operai hanno dovuto scavare per quindici o venti giorni senza profitto il fianco della montagna per aprirsi un varco attraverso la sabbia bianca, fino alle viscere del suolo. Il metodo di scavo non è cambiato da un secolo. I lavori di sostegno sono sconosciuti, ci si fida di un terreno franoso, che ogni anno causa delle vittime”.
 Foto di Cecilia Mangini
Foto di Cecilia Mangini
La testimonianza del comandante della nave: “ La vita di quei poveracci è spaventosa. Nel nord avete le miniere di carbone: la vita è dura per i lavoratori, è vero, ma almeno alcune società forniscono loro dei mezzi per lo sfruttamento della miniera e il trasporto del materiale. Ci sono compagnie che li assicurano e in caso di incidenti si da una pensione alle vedove, ai vecchi. L'operaio della pomice non ha niente; lavora quattordici o quindici ore al giorno guadagnando un franco o un franco e venticinque centesimi, non di più. Vive nel paese del vino e non conosce che acqua, a tavola non conosce la carne e campa soltanto di legumi e pane cotto un mese prima. Eppure non si è mai messo in sciopero. Dopo la sua faticosa giornata, scende al villaggio con 50 o 60 chili di pomice sulle spalle, attraverso i sentieri pericolosi che ha percorso al mattino. Arriva dal sensale e deposita il suo fardello ricevendo un acconto. Quando la pomice si è seccata viene pesata e l'operaio riscuote il prezzo convenuto. E' lì che lo aspetta il sensale, o piuttosto il suo aguzzino, che stabilisce il peso a proprio piacimento. Il povero disgraziato non può protestare, perché ha ricevuto un anticipo ed ha bisogno di quell'individuo il giorno dopo...” [1].
Douglas ci informa sul lavoro dei bambini nella cave[2]. Bambini di ambo i sessi erano inviati dai loro genitori al lavoro, con stipendi ridicoli, nella raccolta del pezzame, o nel trasporto sulle spalle delle pesanti ceste lungo la ripida discesa di Canneto, sotto un sole abbagliante, per due volte al giorno. Douglas ritiene che il lavoro di trasporto era molto più duro dello scavo in grotta ed aveva effetti fortemente dannosi soprattutto sullo sviluppo dei giovani ragazzi tra i 5 e i 14 anni quali sono quelli impiegati nelle cave[3].
Un’altra testimonianza è quella di Luigi Vittorio Bertarelli fondatore del Touring Club Italiano. Reduce di una visita all'arcipelago scriveva nel 1909 che le cave sono “profonde, caldissime all’interno…coltivate con metodi vecchi, industrialmente non lodevoli ed igienicamente perniciosi.. Dura vi è l’opera di estrazione, che si fa col piccone; durissimo il trasporto all’esterno, entro sacchi e recipienti di stuoie e di vimini, al quale sono adibiti anche ragazzi giovanissimi, evidentemente senza alcun rispetto della legge sul lavoro dei fanciulli. Producono abbastanza per tutta Europa ed anzi per esportarne oltre mare. Dei vapori sono sempre sotto carico a Canneto e ad Acquacalda dove in grandi molini, di cui vari appartengono ad una ditta tedesca, si opera una cernita di materiale ed in parte la sua macinazione in mezzo ad un pulviscolo folto, persistente che si diffonde a distanza come una nebbia intorno agli stabilimenti ed è visibile a più chilometri…”[4].
 |
 |
 |
 |
Quattro immagini di lavoratori della pomice. Le foto in alto mostrano le entrate delle gallerie dove si scavava. Più fortunati quelli che lavoravano all'aperto o sul nastro trasportatore o guidando le decovilles
Fra incidenti di lavoro e "liparosi"
Non meraviglia che in queste condizioni gli incidenti sul lavoro siano all’ordine del giorno. In Consiglio comunale giungono due petizioni di vedove che chiedono che venga loro condonato il pagamento del diritto di percezione dovuto dal loro congiunto. La prima è del 28 marzo 1899 ed è della moglie di Giovanni Portelli di Nicolò Antonino che “l’abisso inghiottì tanto immaturamente …, dopo quest’altra vittima del sudato lavoro, essa è rimasta sola a piangere sul capo dei suoi quattro orfanelli, di cui il quarto porta ancora in seno, ed il secondo è cretino”. La seconda è del13 marzo 1906 e riguarda Gaetano Villanti “rimasto vittima di una frana prodotta dal terremoto dell’8 settembre ultimo, lasciando la moglie con sei figli minori, in cattivissime condizioni economiche”[5] .Nel 1921 un medico di Canneto il dott. Giuseppe Di Perri comprende e denuncia che la polvere da pomice per l’alta percentuale di silice libera e silice combinata, provoca una forma di silicosi di particolare gravità e di polimorfa evoluzione, denominata liparosi.[6]. Il rischio coinvolge anche gli abitanti soprattutto quelli che esercitano privatamente la lavorazione dei prodotti. Finalmente nel 1943 dopo vari studi ed indagini la silicosi sarà riconosciuta tra le malattie professionali.

1. Questa tabella è stata realizzata assemblando i dati presenti in G. Arena, op. cit. e Carmelo Cavallaro – La pomice nell’isola di Lipari. Aspetti geografici economici e sociali. In Atlante.. Dello stesso autore si veda anche “Le risorse minerarie delle Isole Eolie nei processi di trasformazione economica”, “Annali della Facoltà di Economia e Commercio” dell'Università di Messina, n. 12, 1978.
[1] G.Vuillier, Escursione alle Eolie, Impressioni del presente e del passato, a cura del Centro studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani, Pungitopo editore.
[2] L’11 febbraio del 1996 un Regio Decreto il n. 3657 vietava l’impiego dei bambini sotto i 9 anni di età negli opifici, nelle cave e nelle miniere e di adibire al lavoro notturno quelli inferiori a 12 anni. Ma la legge escludeva le piccole industrie, l’artigianato, i lavori agricoli, il lavoro a domicilio che erano i settori che impiegavano i minori in massa. Solo il 19 giugno del 1902 ( legge n. 242) il Parlamento italiano emanò un altro provvedimento per i minori, nel quale si elevava il limite di assunzione a 12 anni, 13 e 14 per i lavori in miniera, a 15 i minori potevano fare tutti i lavori.
[3] Copia del rapporto è conservato presso la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, Raccolta Amalfi, v. G. La Greca, La storia della pomice di Lipari, vol. II, pag. 78.
[4] Giuseppe Iacolino, inedito, Quaderno XI.
[5] G. La Greca, op. cit. pp. 82-83.
[6] G. Di Perri, La silicosi nei lavoratori dell’industria della pomice di Canneto-Lipari, Lipari 1950; C. Cavallaro, La pomice dell’isola di Lipari: aspetti geografici, economici e sociali, in “Bollettino della società geografica Italiana”, anno 1979 n. 4-6. pp. 277-278
La
La vittoria del Comune in tutti i tre gradi
Aspettando la sentenza

Nel Consiglio Comunale del 24 luglio 1915 si parla del commercio della pomice bloccato a causa della guerra. “Non si può disconoscere – informa il Sindaco - che il nostro paese vive quasi esclusivamente col commercio della pietra pomice con l'estero. Questo commercio, in seguito alla dichiarazione di guerra dell'Italia, è stato completamente sospeso e quindi si sono chiusi i mulini e sono venute meno le entrate che davano al Paese una certa agiatezza”.
Nel Consiglio comunale del 25 aprile 1916 il cav. Franza chiede al Sindaco un aggiornamento sull'andamento della causa contro il Vescovo e il notaio Paino non si fa pregare. Questa è una causa – esordisce - molto grave e la più grave che si sia mai avuta. Infatti nel passato l'avversario ha chiesto sempre una certa somma di denaro o il preteso suo diritto su di una cosa determinata. Qui invece l'avversario chiede tutto ciò che costituisce l'esistenza del Comune, chiede il suo Demanio, il suo patrimonio ed è ovvio che non può esistere comune senza demanio, senza patrimonio. Quali sarebbero le conseguenze finanziarie non occorre molto per spiegarlo. E si noti che la pretesa del Vescovo oggi ha per oggetto Lipari anzi tutto l'arcipelago che diverrebbe un feudo della Mensa Vescovile. Quanto allo svolgimento procedurale della causa si può dire che si sono avute due fasi. Nella prima i differimenti si susseguirono ai differimenti; oggi abbiamo avuto un risveglio da parte dell'avversario e siamo entrati in un periodo di febbrile attività. La causa doveva essere discussa all'udienza del 4 corrente e malgrado le forti insistenze dell'avversario, essa fu rinviata al 9 maggio giusto gli accordi presi ed anche perché, dopo la presentazione di nuovi documenti da parte del Vescovo, occorreva che essi fossero esaminati. E' già pronta la memoria in risposta a quella dell'avversario. Memoria stesa dal prof. Emanuele Carnevale. Sono dolente di non potere distribuire ora ai consiglieri la memoria, perché, benché sollecitato da diversi giorni, il Procuratore legale del Comune di Messina non ha sin'ora inviate le copie a noi destinate. Fra giorni un illustre componente del consiglio di difesa, il prof. Salvioli si recherà a Messina per esaminare e studiare i nuovi documenti presentati dal Vescovo.
Il consigliere Palamara prega il Sindaco di volere partecipare alla seduta a Messina del 9 maggio e di consentire, mettendo a disposizione un mezzo locale, di partecipare anche a quei cittadini che lo volessero. Il consigliere Ferlazzo deplora che mentre il paese è impegnato a portare avanti il Risorgimento e la libertà ci sia chi voglia rigettarci nel feudalesimo. Il Consiglio vota all'unanimità di stanziare lire 800 per il vaporetto Unione che dovrà portare il Sindaco e la commissione a Messina e per le ulteriori spese.
Il 3 luglio tutta la seduta del Consiglio verte sulla causa col Vescovo e sulla posizione assunta dal Procuratore del Re che non è intervenuto a difesa del demanio pomicifero ma, assumendo la rappresentanza del Regio Patronato, si è unito all'attore ( il Vescovo) e ne ha fatto sua l'istanza e la tesi fondamentale, dichiarando di operare così in seguito ad ordine del Ministro della Giustizia. Quest'azione del Regio Governo è, si fa notare da parte del Sindaco, in contraddizione con quella da questo sempre svolta di riconoscimento, disciplina e tutela del demanio pomicifero: riconoscimento da ultimo proclamato anche dalle legge del 5 gennaio 1908. Perciò il Consiglio delibera di elevare una rispettosa ma viva rimostranza al Governo per quanto è avvenuto all'udienza del Tribunale di Messina del 10 maggio scorso; di manifestare, ora che la causa è in decisione, la sua piena serena fiducia nella giustizia del Tribunale, di cui ossequiosamente attende la sentenza.
La vittoria del Comune

E la sentenza giunge il 23 luglio dopo che la prima sezione del tribunale civile e penale di Messina ha escusso la causa nella udienza dell'11 maggio e la discussione è continuata animatissima nei giorni 12 e 13. La sentenza è favorevole al Comune.
Anche se si tratta di una sentenza ancora di primo grado comunque rappresenta un ottimo risultato e Sindaco ed amministratori possono trarre un respiro di sollievo. Ma non è tempo di speculazioni e rivincite politiche. Il 24 maggio l’Italia aveva dichiarato guerra all’Austria e molti giovani dalle Eolie erano partiti per le armi ed altri si preparavano a partire. Inoltre le condizioni economiche della popolazione erano sempre più gravi.
Emanuele Carnevale non rinuncia però a cogliere pubblicamente il significato di una vittoria che ritiene in gran parte, ed a ragione, sua. Il 3 settembre 1916 attraverso un manifesto rivolto ai cittadini di Lipari, esulta per l'esito e rivendica il suo ruolo di estremo difensore dei diritti civili. Scriverà nelle sue memorie :”Io ne cominciai lo studio nel 1911, e principiò per me da allora una ben dura fatica, durata senza tregua sino al novembre del 1920: una fiera lotta che mi dette infine la grande soddisfazione del trionfo, ma seminò la mia strada di amarezze e di dolori, fra cui non ultimo, la mancata gratitudine del mio paese, da me salvato da grandissima iattura... Avvocato d'una delle parti, fui dall'altra selvaggiamente aggredito, in fogli volanti e memorie difensionali, con attacchi velenosi e triviali; e non mi fece scudo la calda e decisa solidarietà di coloro per i quali io subivo questi attacchi. Scrissi sei o sette memorie a sostegno degli assunti del Comune, e soltanto in alcune collaborarono due dei colleghi di difesa, ma sempre in minor grado; e del resto posso per la verità affermare che tutti gli accennati assunti furono pensati, sviluppati ed illustrati da me...Passarono dei mesi prima che essi si decidessero ad accettare il mio sistema difensivo, al quale opponevano dubbiezze e riserve che non mi persuadevano...Al momento della discussione orale in Tribunale e in corte d'Appello....dovetti sobbarcarmi ad una fatica che mi pareva superiore alle mie forze fisiche, non troppe, specie la seconda volta; ma Dio aiuta... Dovetti per più udienze sostenere quasi tutto il peso della causa, lottando contro valenti avversari...Dico quasi tutto il peso perché in Tribunale parlarono solo e brevemente i senatori Scialoia e Fadda su questioni limitate e secondarie, e poi partirono, lasciando a me tutta la sostanza della controversia; in Corte d'Appello non parlai che io, essendo completamente assente il numeroso collegio di difesa del Comune (Salandra, Scialoia, Fadda, Salvioli, Bruschettini), meno del valoroso penalista senatore Fulci, che aggiunse breve discorso ad illustrare ulteriormente alcune delle cose da me dette”[1].
La discussa sentenza della Cassazione

Carnevale lamenta di avere avuto anche poche soddisfazioni tangibili: mediocre compenso, grave fatica, e una sola volta, dopo la sentenza favorevole del 23 agosto 1916, un coro di voci popolari, si fece sentire sotto i balconi della sua villa al torrente di Santa Lucia. Vogliamo osservare come le parole di Carnevale lasciano intuire che quei dissensi e contrasti nel collegio di difesa - di cui si era parlato soprattutto nell’autunno del 1913 quando Vescovo e Sindaco si incontrano a Roma nell’ufficio dell’on. Ugo di Sant’Onofrio per verificare se c’erano le condizioni di una transizione - erano tutt’altro che false.
Quanto alla partecipazione popolare a dire il vero, osserva Iacolino,[2] l'adesione partecipativa dei liparesi ci fu, e si estrinsecò fervida, appassionata e clamorosa, ma solo nei primi anni quando la cosa aveva il fascino della novità e le cronache del processo rimbalzavano in mezzo a quello stato d'animo euforico che anche nelle Eolie, come in tutta Italia, era alimentato dal nazionalismo, dalla propaganda bellica per l'impresa di Libia e dall’individualismo anarchico praticato dal D'Annunzio e proclamato da Filippo Tommaso Marianetti.

La sentenza d’Appello giunge a conclusione delle udienze che vanno dal 10 al 19 agosto del 1918 ed infine il 10 gennaio 1921 giunge anche la sentenza favorevole della Corte di Cassazione.
“Per mons. Paino – commenta Iacolino – fu come un colpo di lancia infertogli a tradimento. Egli non se l'aspettava davvero quel verdetto tanto più che l'ultima fase del dibattimento doveva essere decisa da una sezione presieduta dal prof. Mariano D'Amelio il quale per il suo equilibrio e per la sua imparzialità ispirava la miglior fiducia. Ma all'ultimo momento comparve sullo scanno il prof. Sen. Lodovico Mortara, già ministro della Giustizia, notoriamente 'ebreo e massone'[3].Nell'animo di mons. Paino quel nome risuonò come il preludio di un fallimento totale e irreversibile”[4].
“Un decennio di studi (1911-1921) – osserva concludendo il suo saggio il prof. Marcello Saija – nel quale otto secoli vengono passati al vaglio della più sagace curiosità. Questo sforzo che ha impegnato valenti storici del diritto ed ha permesso, con un notevole carico finanziario per le parti in contesa,di raschiare archivi italiani e stranieri, attende ancora oggi di avere frutti maturi[5]”.
Il sen. Lodovico MortaraTransare o andare in giudizio?
Gli intransigenti si oppongono ad ogni mediazione
 Ora anche la situazione generale spinge per una mediazione e il Prefetto il 14 dicembre cerca di farlo capire al Sindaco, anzi gli mette per iscritto la richiesta da leggere in Consiglio Comunale.
Ora anche la situazione generale spinge per una mediazione e il Prefetto il 14 dicembre cerca di farlo capire al Sindaco, anzi gli mette per iscritto la richiesta da leggere in Consiglio Comunale.
Ma il partito intransigente è sulla difensiva. E’ riuscito già una volta a bloccare le manovre per un accordo ed è il momento per giocare d’anticipo prima del Consiglio comunale convocato per il 26 dicembre. Viene fatta circolare nel paese una lettera aperta al Sindaco
Così, quando si apre il Consiglio, il Sindaco è obbligato a partire proprio da questo fatto.
E' circolata - dice - una lettera aperta al Sindaco, a stampa, sulla vertenza Comune- Mensa vescovile, dove dietro i “si dice”, si avanzano delle insinuazioni. La lettera porta la firma dei Consiglieri comunali Palamara, Giacomo Maggiore, farmacista Salvatore Fenech, notaio Salvatore Scolarici e si chiede al Sindaco di rendere di pubblica ragione i motivi dei ripetuti incontri col Prefetto ed. in particolare, se fosse vero che questi aveva esercitato vere e proprie pressioni per transare la causa con la Mensa vescovile.
Il Sindaco smentisce di avere avuto, nel merito, delle imposizioni da parte del prefetto e che a questa discussione sarebbe intervenuto anche il vescovo. Nessun prefetto può imporre alcunché ad un Sindaco e le transazioni non le fa il Sindaco ma il Consiglio comunale. Comunque una lettera del prefetto Buganza scritta il 19 dicembre, è arrivata al Sindaco e questi ne dà lettura integrala. In essa, fra l'altro, si dice: “La Mensa Vescovile si batte pel conseguimento di un vantaggio, il comune si batte per la propria medesima esistenza. Soccombendo l'avversario la Mensa Vescovile rimane pressapoco quello che è, col solo danno delle spese; soccombendo il comune, il comune è finito. Ora, l'Amministrazione Comunale si è essa resa conto di questa formidabile situazione? Si assume che già da tempo il collegio di difesa opportunamente interpellato dal Municipio sulle probabilità della causa, non sia stato troppo esplicito ed abbia emesso un parere dubitativo. E' così? Se lo è, io penso che l'amministrazione debba ben ponderare quello che fa, come penso che nemmeno l'autorità tutoria debba rimanere indifferente di fronte ad un andamento di cose che può essere periglioso. Se non lo è, ed io auguro e spero che non lo sia, mi pare che dopo trascorso tanto tempo nel quale la causa non ha fatto un passo, l'amministrazione debba ad ogni modo mettersi in grado di sapere a che punto siamo e quali siano oggi, dopo tante ricerche di documenti e rinvii della causa, le probabilità che presenta. Inseguire supinamente le vicende forensi per avventura fino ad ora poco attive, mi pare incauto da parte dell'amministrazione comunale, la cui responsabilità non finisce con la nomina di un collegio di difesa. Io troverei pertanto non solamente prudente, ma doveroso che, profittando di questo periodo di sosta, il Comune invitasse il Collegio della difesa a riferire sullo stato della causa, sui presidi approntati per sostenerla, sulla probabilità che i patrocinatori illuminatissimi ai quali è affidata, prevedono. Questa, ripeto, non è una lite ordinaria; e non è semplicemente una lite grave; essa è per il Comune vitale, investendone la sua stessa esistenza. E quindi necessita che gli amministratori responsabili, sappiano come procede e presumibilmente come potrà finire.”.
Foto di Cecilia Mangini
A questo punto si apre la discussione. L’avv. Palamara anche a nome del notar Maggiore, notar Scolarici e del farmacista Fenech si dichiara soddisfatto nel sentire che l'amministrazione attiva difenderà ad oltranza i diritti del Comune, non è soddisfatto invece della risposta data a proposito dei “si dice” sugli avvenuti colloqui e pressioni vescovili. La risposta non è chiara. Che i “si dice” siano veri e che le pressioni vi siano state è dimostrato dalla lettera del Prefetto, nella quale si consiglia la transazione.
Il Sindaco ribadisce che non vi è stata nessuna pressione e nessun intervento di terzi ai colloqui.

Il Prefetto vuole la transazione
Palamara ribadisce che la lettera del Prefetto non rispetta la realtà dei fatti quando dice che gli avvocati hanno emesso dei dubbi sul buon diritto del Comune, ma offende il Consiglio e lede gli interessi e la dignità del paese. Propone che la seduta si sciolga in segno di protesta.
L'assessore Onofrio Paino parla della situazione internazionale e della lotta di libertà contro l'imperialismo austro-tedesco. “Tutto questo non commuove il Vescovo di Lipari, il quale va ramingo di porta in porta per chiedere ausilio e protezione per restaurare una delle antiche signorie in queste Isole Eolie, le quali al par di tutti gli altri italiani, altra Signoria non riconoscono, se non che quella che regna per grazia di Dio e volontà della nazione, quella cioè della gloriosa casa Sabauda. Lipari, malgrado i consigli del Prefetto che desidererebbe la transazione col Vescovo, non cederà un palmo delle sue terre a chicchessia”.

Il consigliere dott. De Mauro dice di non spiegarsi la lettera del Prefetto che contiene notizie che non potevano essergli date che dalla parte avversa al Comune. E' il Vescovo che insinua che vi è incertezza fra gli avvocati del Comune, mentre lui che ha partecipato all'ultima loro riunione sa che sono tutti convinti e compatti. Perchè il Prefetto si è fatto l'opinione solo sulla base delle informazioni del Vescovo e non ha chiesto ad altri come i consiglieri provinciali del comune?Il Vescovo continuerà con l'intrigo e con l'inganno per trarre dalla parte sua la pubblica opinione. La lettera odierna è provocata dall'intrigo del Vescovo che carpisce la buona fede del Prefetto. Anche Paino si unisce a Palamara nel chiedere di togliere la seduta.
Il consigliere Franza protesta sdegnosamente contro l'operato del Vescovo, il quale non ha lasciato mezzo intentato per ottenere una transazione che Consiglio e cittadinanza non vogliono a qualsiasi costo.
Il consigliere Ferlazzo informa che tutti i documenti a sostegno della tesi del Comune sono pronti da tempo e che i rinvii di discussione dipendono dalle convenienze ora dell'una ora dell'altra parte.
Il consiglio approva all'unanimità una mozione del consigliere Palamara che dichiara di togliere la seduta in segno di protesta perchè giudica lesiva della dignità del Consiglio la lettera del Prefetto.
La riunione del Consiglio e le nuove manifestazioni di piazza mettono la parola fine alle possibilità di accordo e mons. Paino ne prende atto: “Il Vescovo di Lipari – si legge in un breve comunicato – che lotta più per l'adempimento di un dovere che per il riconoscimento di un diritto, si era illuso che potesse il ragionamento produrre l'effetto salutare di far comprendere ad un popolo, sobillato da pochi, che le questioni di diritto non si discutono in piazza e che le grida incomposte della folla irresponsabile non possono né creare, né annullare diritti secolari. Egli è cittadino ma è anche Vescovo, e quando ha fatto il possibile per conciliare i suoi doveri contrapposti, la responsabilità di questa causa cade su chi l'ha voluta, chiudendo gli occhi alla luce meridiana che viene dai documenti della Mensa”.
In questo ultimo scorcio di causa circolano documenti e memorie e in tutti il motivo dominante non è più quello dell'autenticità e della veridicità dei documenti concessori, ma si sposta sulla natura dei titoli e su quale fosse la natura della concessione che davano e potevano dare i vescovi.

Il farmacista Fenech
Si delinea il conflitto Vescovado - Comune
Il Vescovo chiama in giudizio il Sindaco

Il 29 aprile 1911 mons. Paino cita in giudizio il Comune di Lipari. Lo fa quando vede che la via della trattativa pacifica non è possibile ed intuisce che sulla questione si era ormai innescato un disegno politico Premurandosi di far sapere, con un foglio a stampa, il suo immutato convincimento a definire il contenzioso in via transattiva e a ritirare l'istanza in qualsiasi momento si fossero create le condizioni per l'accordo.
Nella chiamata in giudizio del Sindaco di Lipari al Tribunale di Messina il Vescovo vuole: “
1.Far dichiarare che nessun diritto sia di proprietà che di possesso, può il comune vantare sulle terre pomicifere esistenti nel territorio di Lipari nelle contrade: Pilato, Montepilato, Russo, Rocche Castagna, Grotta delle Mosche, Acqucalda, Foss Castagna, Serro, Rocche Rosse, Chirica, Altapecora, Serro della Chirica, Monte Bianco, Porticello e altre denominazioni, ed inibirgli di più rilasciare licenze per la escavazione della pomice.
2.Far dichiarare che questo diritto di scavazione, come di ogni altro di assoluto proprietario, compete allo istante, libero da ogni vincolo, per titolo certo ottenuto dai sovrani normanni nel secolo XI, confermato dagli stesi nel secolo successivo ed esercitato dalla Mensa nei secoli a seguire, salvo l'obbligo di corrispondere quelle tasse che possano essere dovute, e sono effettivamente pagate a norma di legge da tutti gli altri proprietari di terre pomicifere.
3.Far condannare il Comune di Lipari alla rifazione dei danni ed interessi da liquidarsi in separata sede per l'arbitrario esercizio di un diritto che non gli compete e che ha ostacolato l'esercizio dei diritti di proprietà dell'istante.
4.Far condannare il Comune di Lipari alle spese tutte del giudizio e competenze degli avvocati in causa, munendo l'emettenda sentenza di clausola esecutiva salvo ogni altro diritto od azione”[1].
La squadra di studiosi che il Vescovo schiera è di alto livello. Oltre al prof. Garufi di cui si è detto, vi sono il prof. Filomusi Guelfi e il prof. Francesco Scaduti.
Contro l’iniziativa del vescovo si costituisce il Comune di Lipari. Il 4 maggio 1911 il Consiglio comunale è chiamato a ratificare la delibera della Giunta “a stare in giudizio e nominare un collegio di difesa contro il Vescovo di Lipari”.Il collegio del Comune sarà composto oltre che dall'avv. Emanuele Carnevale, dall'avv. Ludovico Fulci, ordinario di diritto penale, incaricato di storia del diritto all'Università di Messina e deputato al Parlamento, dal prof. Giorgio Arcoleo, ordinario di diritto Costituzionale all'Università di Napoli e senatore del Regno, da Arnaldo Bruschettini, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Roma, da Carlo Fadda, ordinario di Diritto Romano nell'Università di Napoli e deputato al parlamento, da Giuseppe Savioli, storico del diritto ed autore di parecchi saggi in materia di decime ecclesiastiche, da Vittorio Scialoia. ordinario di Diritto romano all'Università di Roma, senatore e, fino a pochi mesi prima, ministro della Giustizia. Al Prefetto tutti questi nomi altisonanti sembrano troppi ma il Sindaco fa osservare che non si tratta di un giudizio di routine ma di una causa decisiva per il Comune.

La risposta del Comune: si costituisce in giudizio e avvia la polemica
Oltre a decidere di stare in giudizio ed a nominare il collegio di difesa, questo Consiglio dà il via ad una fase fortissima di polemiche con il vescovo che si protrarrà per oltre due anni fino a quando nell'agosto del 1913 Paino lascerà Lipari. La posizione non solo dei consiglieri democratici – tendenzialmente anticlericale - che rispecchiano la posizione massonica e laica, ma anche quella dei popolari è di sdegno morale per una strategia, quella del Vescovo, che appare loro anacronistica e viene giudicata tendente a restaurare il “dominio temporale”.
Onofrio Paino, nel suo intervento, afferma che “gli sanguina il cuore al solo pensare che un Vescovo nativo delle isole Eolie sia venuto per ostacolare il risorgimento economico di queste popolazioni” e comunque bisogna accettare il guanto di sfida che egli ha lancito e abbattere definitivamente un potere temporale ormai condannato dalle nazioni più civili del mondo. Il Consigliere Paternò pur dichiarandosi d'accorso sulla difesa dei diritti del Comune non lo è per la sfida contro il potere temporale. Non è di questo che è chiamato a discutere il consiglio A questo punto il pubblico in sala e fuori comincia a protestare tanto che il Paternò è costretto a interrompere il suo intervento. Il Consiglio approva la delibera con 18 voti a favore ed uno astenuto ( Paternò).
Non ci fu un'eco collettivo e universalizzato di odio nel confronto del Vescovo ma una polemica che si trascinò per tre anni dal 1011 al 1013 sulle strade e sulla carta stampata.. Non furono mai più di ottanta o cento i cittadini che improvvisarono manifestazioni pubbliche per le vie del paese con alla testa un drappello di borghesi, di massoni e di esponenti del Partito Democratico e del socialismo. In prima fila si notavano il farmacista Nunzio Esposito, il dott. Francesco De Mauro, il dott. Gaetano Fenech, l'ingegnere Gaetano Martinez, don Giuseppe Bonica, don Domenico Ziino, don Edoardo Bongiorno, don Giuseppe Tonelli e persino i sacerdoti don Emanuele Scolarici e don Emanuele Palmisano. Anzi lo Scolarici era solito portare lui la bandiera italiana e gridare con quanto fiato aveva in gola “Abbasso il Vescovo”.[2]
Quanto alla carta stampata il riferimento è ad un mensile, formata da due fogli, dal titolo “La voce della Patria. Cronaca mensile delle Isole Eolie” diretto da Giuseppe Favorito. A questo periodico ed ai foglietti volanti che alimentavano la polemica da parte laica si risposte da parte “cattolica” con due o tre pieghevoli propagandistici firmati “ da un gruppo del Clero”.
Nel mese di maggio esce un volantino a cura di questo gruppo denominato “Una parola serena” che faceva riferimento alle prime dimostrazioni di piazza e ricostruiva la posizione del vescovo con la spiegazione del motivo che l'avevano condotto a agire contro il Comune dopo aver tentato la via amichevole, e comunque sempre pronto a rivedere la posizione se ci fosse stato un cenno di attenzione e di distensione.
Verso giugno o luglio da parte laica si fa uscire un “foglio volante” intitolato “La libertà delle terre di Lipari”. Il suo autore , un certo B.T.; si difende su “La Voce della patria” dalle accuse di “veemenza” dicendo di avere una ferma convinzione “che Mons. Paino non è un ignorante, ma semplicemente un giovane pastore inesperto, consigliato e guidato da un essere le cui opere, diremo col poeta, non furono “mai leonine , ma di volpe”[3].
La polemica dilaga sui giornali e per le strade
Nel 1911 il collegio non era ancora entrato in funzione e il prof. Carnevale replica alla memoria del vescovo, utilizzando un parere del prof. Savioli e stampa un saggio intitolato “La libertà delle terre di Lipari ed il preteso dominio del Vescovo”[4]. Le linee d'attacco sono tre: il dubbio sull'esistenza dei diplomi normanni per cui le “prove” del Garufi sarebbero solo “indizi”; l'insufficienza sostanziale del diploma di conferma del 1134 – per cui l'inciso che fa riferimento alle isole potrebbe essere una interpolazione effettuata in epoche successive -che nonostante l'analisi del Garufi resta comunque inutilizzabile; la possibilità che il Constitutum, in assenza di esplicito riferimento, possa avere una fonte di legittimazione diversa da quella indicata dal Garufi o addirittura non averne alcuna. Detto questo in via principale, Carnevale in via subordinata sostiene che, pur ammettendo l'autenticità e veridicità dei titoli concessori, la natura dei poteri che venivano dati all'abate traeva origine non dalla proprietà della terra ma dal diritto concesso al signore di amministrare e di esercitare su di essa la giurisdizione. Si trattava insomma di una concessione di feudo (signoria politica) e non in allodio( in proprietà privata). Questo feudo, aggiunge Carnevale, finisce con l'intestazione della Capitania e della Castellania di Lipari a Antinolfo da Procida nel 1357 e a Federico Chiaramonte nel 1366 e se i vescovi continuano a fare concessioni enfiteutiche sino all'800 é per via dell'esercizio abusivo di un potere utilizzando la lontananza delle isole dai centri da cui promanava l'autorità sovrana. E comunque, in via subordinata, questo feudo non esiste più con la legge del 1812 che ha tolto di mezzo i poteri feudali.
Da questi presupposti si dipana tutta una polemica con battute acide soprattutto fra il Garufi ed il Carnevale. Quindi la polemica dilaga non solo per le strade, non solo sui fogli volanti d'attacco e sui giornaletti locali, ma anche sulle riviste di studio. Parleremo più avanti di questo clima di scontro che si crea nel paese. Qui basti qualche rapido accenno. La “Voce della Patria”, il giornaletto locale che incontreremo più avanti, saluta calorosamente ed enfaticamente il rientro a Lipari di Carnevale[5]: “Tu sei vero figlio, vero amico, sii benedetto!”mentre gli attacchi al vescovo, speso irriverenti ed oltraggiosi sono ormai all’ordine del giorno.
Mons. Paino lascia Lipari

Trasporto della pomice
Ed è in questo clima che un giorno, nel dicembre 1912, corse voce – ma forse era solo il parto dell'eccitazione del momento – che qualcuno avesse pensato ad assoldare un ex coatto che viveva ai margini della società, perchè procedesse all'eliminazione fisica del vescovo. Di concreto c'era solo il racconto dei familiari di mons. Paino che in una fredda serata, lasciando il palazzo dove avevano assistito il prelato, per far ritorno alle loro abitazioni, all'estremità del viale, nei pressi delle gibbie scorsero un individuo dall'atteggiamento sospetto che cercava di nascondersi dietro una siepe. Il giovane nipote del vescovo, anche lui di nome Angelo Paino, si avvicina e lo invita a venire allo scoperto. Lo riconosce e perquisendogli gli trovava addosso un coltello. Lo stesso nipote sporge denuncia al commissariato ma , arrestato l’ex coatto, non si arrivò ad alcuna incriminazione.
Forse non fu per questo fatto, forse intervennero altre considerazioni comunque in un canicolare pomeriggio di agosto del 1913 mons. Paino fu visto uscire dal palazzo tutto solo, con una valigia contenente effetti personali e carteggi vari, e dirigersi verso Marina Corta dove si appartò nella chiesetta del Purgatorio. Lì attese che arrivasse l'Adele, il vaporetto di linea, alle 15. Prese posto sulla barca del rollo e salì a bordo. Mons. Paino si diresse a Messina dove fu accolto dall'arcivescovo Mons. Arrigo che qualche anno dopo, alla fine del 1916, lo nominò suoi ausiliare pur restando Amministratore apostolico di Lipari.

Perchè questa partenza che da qualcuno fu interpretata come una fuga? Per restituire all'isola un po' di serenità giacchè la sua sola presenza non faceva che rinfocolare le passioni? Può essere, m forse lui stesso pensò che fuori da Lipari, in una realtà come Messina, avrebbe avuto maggiore libertà di movimento per seguire la vertenza e nell'esercitare le opportune pressioni diplomatiche su enti e personaggi da cui potesse sperare appoggi e mediazioni. Infatti solo qualche settimana dopo è a Roma per cercare di pervenire ad un accordo col Sindaco.
E’ tra settembre e ottobre del 1913 che a Roma nello studio dell'on. Ugo di Sant'Onofrio avviene un incontro a cui partecipa mons. Paino con alcuni suoi consulenti e il Sindaco di Lipari accompagnato da un consigliere provinciale e da due consiglieri comunali. All'incontro non era presente l'avv. Carnevale. Il vescovo consegnò nuove memorie e disse di rimettersi al giudizio degli avvocati del Comune. L’impressione è che nel collegio difensivo del Comune vi siano dei contrasti e forse le tesi sostenute dal prof. Carnevale non sono sempre condivise dagli altri membri. Certo il marchese Sant’Onofrio che si era fatto promotore dell’incontro dovette sostenere la tesi della possibilità di una mediazione e forse, poggiandosi sull’ascendente che aveva nei confronti degli amministratori eoliani - anche se il Sindaco da aprile non era più il cav. Giuseppe Franza ma il notaio Gaetano Paino, parente del prof. Carnevale - qualche ipotesi dovette farla. Se in quella sede non si definì alcun accordo però qualche spiraglio si dovette aprire.
Ai primi di gennaio gli avvocati del Comune fanno giungere al Sindaco un invito a partecipare ad una riunione del collegio di difesa convocata a Napoli per il primo febbraio con l'obiettivo di adottare importanti decisioni di strategia processuale in vista dell'udienza ormai prossima. Qualcosa deve essere avvenuto fra l’autunno e l’inverno a raffreddare le ipotesi di mediazioni se pure ne erano state fatte. Così nella Giunta del 30 gennaio si decide che non è il caso che intervengano amministratori in un incontro di luminari della scienza del diritto. Anzi nel deliberato di Giunta si rinnova piena fiducia all'avv. Carnevale ed agli altri membri del collegio, segno che Carnevale aveva ripreso pienamente il controllo della situazione.
Intanto a livello internazionale spirano venti di guerra che raffreddano le relazioni commerciali ed il 21 agosto 1914 , durante la discussione sul Bilancio il Sindaco osserva che siamo entrati in un periodo di crisi allarmante che ha determinato la soppressione totale del nostro commercio della pomice, l'unica fonte di ricchezza per noi. Il ristagno del commercio ha portato alla disoccupazione di operai e al Comune sono giunte varie domande di sussidio. Troppe, per poterle prendere in considerazione. Il Consiglio comunale l’1 settembre si interroga sul che fare. L’unica possibilità è dare il via a dei lavori pubblici che creerebbero occasione di nuovo lavoro. La proposta è quella di appaltare subito i lavori della rotabile Lipari- Canneto. La costruzione della rotabile rappresenterebbe un sollievo in questa direzione.
[1] Dall’atto di citazione del 29 aprile 1911, ripreso dal dispositivo della sentenza di primo grado, registrata in Messina l’11 settembre 1916, vo. 160, numero 261, foglio 97, in M.Saija,La seconda controversia liparitana, op. cit., pag.127.
[2] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno XI
[3] Il riferimento è a don Giovanni Paino esperto segretario della Curia detto Alazza per via che andava in giro sempre con un mantello che per l'andatura claudicante sembrava un'ala svolazzante
[4] E. Carnevale, La libertà delle terre di Lipari e il preteso dominio del Vescovo. Ragioni esposte in difesa del Comune, Stabilimento tipografico Carlo Nava, Siena 1911.
[5] Nel 1911 il prof. Emanuele Carnevale che viveva ormai stabilmente a Palermo dove insegnava torna a Lipari per distribuire la sua “memoria” a favore del Comune intitolata “La libertà delle terre di Lipari e il preteso dominio del Vescovo” che era stata stampata a Siena. A Lipari non aveva molta sintonia con la classe politica locale perché era ritenuto un radicale di estrema sinistra mentre al Comune la maggioranza era moderata. Nel 1919 il Carnevale sarà eletto vice presidente dell’Unione radicale di Palermo e poi presidente.
La squadra del Comune
Mons. Paino fa una proposta di mediazione
Mons. Paino, un vescovo eoliano

Quando il Parlamento approva la leggere n. 10 la sede vescovile di Lipari è vacante da più di due anni ed era stata retta da Amministratori apostolici. Dal 6 dicembre 1906 al 2 luglio 1907 da mons. Francesco Raiti[1] che era stato eletto vescovo di Lipari il 22 luglio 1903 e trasferito a Trapani il 6 dicembre 1906, dal 13 luglio 1907 al 13 luglio 1908 da mons. Audino[2] che era stato già vescovo di Lipari dal 1898 e poi era divenuto vescovo di Mazzara del Vallo e dal 13 luglio 1908 al 20 aprile 1909 dall’arcivescovo di Messina mons. Letterio D’Arrigo[3].
La nomina a vescovo di Lipari – che è del 12 luglio 1909 - raggiunge mons. Angelo Paino[4] mentre è a Santa Marina Salina, sua cittadina natale.Parleremo nel prossimo capitolo di questo importante personaggio della storia eoliana: qui ci interessa specificamente per la controversia sulla pomice. Il 9 agosto 1909 inizia il suo ministero e probabilmente già lavora ad una ipotesi di transazione. La soluzione a cui pensa parte dalla posizione classica della Chiesa di Lipari ma contiene alcuni tratti di novità. Le prospettive di crescita della produzione e commercializzazione della pomice, l'esistenza della legge n.10, la creazione di un consorzio che toglierebbe la concorrenza fra produttori locali – di cui si parla e che un clima di pacificazione favorirebbe - ,permetterebbero un sicuro sostentamento per tutti: per gli scavatori, per il Comune e , pensa, il nostro giovane vescovo, anche per la mensa. Anche se Paino ritiene che la Chiesa ne abbia diritto non pensa a rivendicare le decime perchè questo provocherebbe sterili conflittualità dannose per l'azione pastorale. Si concentra quindi sui terreni pomiciferi ed osserva che niente cambierebbe per i cavatori se in luogo di pagare un fitto al Comune lo pagassero alla mensa. Certo qualcosa cambierebbe per il Comune ma non tantissimo giacchè il Comune con la legge n. 10 i maggiori introiti li riceve dalla tassa per l'escavazione della pomice che grava sulle proprietà pubbliche come su quelle private. E tale tassa dovrebbe essere pagata anche alla Chiesta una volta riottenuta le proprietà delle terre pomicifere.
La proposta di mons. Paino per la pomice
 Cav. Franza, sindaco di Lipari
Cav. Franza, sindaco di Lipari
Il Comune perderebbe solo gli introiti sulle concessioni, ma non tutti perchè, al fine di ricompensare queste perdite, il vescovo. pur deciso a rivendicare tutte le terre, sarebbe disposto a trattenerne solo un parte, lasciando l'altra nella disponibilità della municipalità. Una posizione questa, sulla quale il Paino rifletteva da tempo e, probabilmente, sugli aspetti storici e giuridici fin da 1907, quando rettore del seminario di Trapani aveva avuto modo di ascoltare una conferenza del prof. Carlo Alberto Garufi sulla storia dei monasteri greci e latini in Sicilia e quindi anche del Monastero di San Bartolomeo. Il docente di Paleografia latina e diplomatica dell'Università di Palermo, doveva aver riferito in quell'occasione di avere trovato, quattro anni prima, nell'Archivio Capitolare di Patti, un documento inedito, di tale importanza, da permettere il completamento del mosaico di conoscenze sul Monastero di Lipari: il Constitutum originario dell'Abate Ambrogio. E proprio il Constitutum era il nuovo documento che si aggiungeva a quelli di Ruggero, di Urbano II, di Ruggero II …sancendo il buon diritto della Chiesa di Lipari sui terreni delle isole.
Da qui, da queste potenziate premesse storiche e giuridiche, prendeva le mosse la proposta economica che il Paino aveva elaborata..
E nei primi mesi del 1910, è questa l'ipotesi che Mons. Paino spiega al Sindaco di Lipari, il cav. Franza, popolare e buon cattolico, in un incontro privato. “Raccoglierò documenti e ragioni – così il vescovo riassumerà qualche tempo dopo la sua posizione - che farò studiare e vagliare dai miei avvocati. Lo studio di questi avvocati presenterò al Comune, il quale lo sottoporrà agli avvocati suoi; e se questi, sia pure dopo un'amichevole discussione coi miei legali, troveranno infondata la pretesa, io vi chiederò scusa del disturbo e non se ne parlerà più, se invece si conosceranno i diritti della mensa, allora e solamente allora io dirò: questi diritti non li voglio fare valere tutti perché amo anch'io il mio paese, e non voglio che esso abbia per me iattura”[5].Egli ne vuole riconosciuta una parte e dice anche come intende spenderla : una parte andrà a vantaggio del Seminario e quindi del ginnasio aperto a tutti e non solo ai chierici; una parte al capitolo della cattedrale; una parte ai curati poveri; una parte per gli istituti di beneficenza ed “una tenue rendita infine sarà per la Mensa”.

Sebbene la proposta avesse accolto il consenso dell'on. Ugo di Sant'Onofrio, trovò il Sindaco molto freddo alle posizioni del vescovo. Probabilmente sapeva che il partito dell'intransigenza a Lipari era fortissimo e non poteva spuntarla. E questo partito era capitanato dall'avv. Emanuele Carnevale, che era divenuto nel frattempo, docente alla cattedra di diritto e procedura penale dell'Università di Palermo. Carnevale era stato anche candidato come deputato nel collegio nelle elezioni del maggio 1909 ma nulla aveva potuto contro Ugo di Sant'Onofrio che l'aveva sconfitto con 1285 voti contro 322. Questo voleva solo dire che una sua contrapposizione con l’esponente popolare su questo terreno non poteva che favorirlo in prospettiva se avesse di nuovo voluto tentare l’avventura politica.
Marchese Ugo di Sant'Onofrio in tenuta militare
[1] Mons. Francesco M. Raiti nato a Linguaglossa in provincia di Catania il 7 febbraio del 1868. Divenuto monaco dell’ordine dei Carmelitani nel monastero di Malta, si laureò a Roma dove rimase ad insegnare filosofia e teologia nel Collegio Carmelitano di S. Alberto Magno. Viene eletto vescovo di Lipari il 22 giugno del 1903 ma giunge in diocesi fra il febbraio e il marzo del 1904. L’1 novembre 1905 approvava la costituzione dell’Istituto delle Suore Francescane dell’Immacolata concezione di Lipari. Entrò in conflitto con le Suore di Carità di Lipari che lo accusavano di favorire il nuovo istituto francescano a loro danno. Inoltre l’Amministrazione comunale lo minacciava di un’azione penale per non avere portato avanti la scalinata della Cattedrale iniziata dal suo predecessore. Per tutti questi motivi il vescovo chiese il trasferimento dalla diocesi e l’ottenne nella diocesi di Trapani rimanendo Amministratore apostolico di Lipari sino al 2 luglio 1907. Morì a Trapani l’1 maggio del 1932.
[2] Mons. Nicolò M.Audino nato a Vallelunga in provincia di Caltanissetta il 15 ottobre 1861. Laureato in teologia e diritto canonico all’Università Gregoriana di Roma. Venne nominato vescovo di Lipari il 28 novembre 1898. Prese possesso canonico della diocesi l’1 gennaio 1899 e fece solenne ingresso a Lipari il 15 marzo dello stesso anno. Nell’agosto del 1900 organizzò un grande pellegrinaggio a Roma degli eoliani per l’anno santo con oltre 150 persone di cui 50 religiosi.. Nei quattro anni della sua permanenza a Lipari espletò per ben tre volte la visita pastorale in tutte le borgate e frazioni dell’arcipelago. Venne trasferito a Mazzara del Vallo nel giugno del 1903 dove morì il 20 giugno 1033.
[3] Mons. Letterio D’Arrigo era nato a Messina il 15 novembre del 1849, Fu canonico teologo alla Cattedrale della sua città. Divenne arcivescovo di Messina il 25 marzo 1898. Rimasto illeso nel terremoto di Messina del 1908 si diede ad organizzare i soccorsi e quindi all’opera di rinascita civile e religiosa della città malgrado gli ostacoli della massoneria che non voleva che si ricostruissero le chiese preesistenti. Morì a Messina il 18 dicembre 1922.
[4] Mons. Angelo Paino, era nato a S.Marina Salina il 20 giugno del 1870. Si era laureato in teologia a Napoli ed in filosofia e diritto ecclesiastico civile a Roma presso l'Accademia di S. Tommaso. Aveva insegnato nei seminari. Nel novembre del 1898 fu chiamato dal vescovo di Anglona e Tursi in Calabria a ricoprire la responsabilità di rettore in seminario insegnandovi anche teologia . Verso il 1907 fu chiamato da mons. Raiti a Trapani per interessarsi della formazione morale dei chierici. L’anno dopo rifiutò la nomina a vicario generale dell’arcidiocesi di Messina che gli offriva mons. D’Arrigo per non tradire le aspettative del vescovo di Trapani. Eletto vescovo di Lipari il 20 aprile 1909 all’età di soli 39 anni, prese canonico possesso della diocesi il 22 agosto 1909. Nell'ottobre 1916, su richiesta dell'arcivescovo D'Arrigo, fu nominato, sub secreto, ausiliare di Messina, governando la sua diocesi di Lipari dal capoluogo. Il 10 gennaio 1921 fu eletto arcivescovo titolare di Antinoe e coadiutore con diritto di successione di mons. Letterio D'Arrigo Ramondini. Quindi, il 22 dicembre 1922, fu eletto vicario capitolare, il 10 febbraio 1923 la sua nomina ad Arcivescovo Metropolita di Messina e Archimandrita del SS. Salvatore fu confermata dalla Sede Apostolica e il 3 marzo dello stesso anno prese canonico possesso dell'Arcidiocesi di Messina.Fu assistente al Sacro Soglio e resse l'arcidiocesi sino al 7 marzo 1963, giorno in cui furono accolte le dimissioni presentate per l'età avanzata. Di conseguenza fu trasferito alla sede arcivescovile titolare di Serre di Macedonia. Decano dei vescovi del cattolicesimo, si spense nel Seminario Arcivescovile di Messina il 29 luglio 1967 all'età di 97 anni.
[5] Genuardi, Siciliano, Scaduto, Garufi, Il dominio del Vescovo nei terreni pomiciferi dell'isola di Lipari, Acireale 1913.
Il prof. Carlo Alberto Garufi
La "leggina" sulla pomice
Il problema del contrabbando

G.Vuillier, Calandra di Canneto
Nel frattempo il problema del contrabbando si era fatto sempre più spinoso e più scandaloso quando apparve evidente che in questi traffici erano coinvolti non solo operai ma anche alcuni proprietari e quindi persino consiglieri comunali ed alcuni assessori[1] tanto che si arrivò a dare la sfiducia , nel Consiglio del 26 agosto 1906, intrecciandosi il problema del contrabbando con l’inchiesta sulle guardie campestri, sulla base di un ordine del giorno presentato dal consigliere Carnevale con sedici voti contro dodici, all’amministrazione Faraci.[2]
Sulla vicenda del contrabbando furono promosse due inchieste ministeriali. Di grande interesse l’analisi che, di questo fenomeno fa, nella sua relazione l’ing. Moretti, dell’ufficio minerario di Caltanissetta.
“Il contrabbando – afferma il relatore – si esercita su vasta scala su tutta la regione pomicifera, essendo le piccole proprietà private frazionate qua e là in mezzo alle terre comunali. Più particolarmente però il contrabbando ha luogo per le cave della Castagna, internamente all’isola e per quelle di Campo Bianco ed Acquacalda alla marina, e tale contrabbando viene fatto dagli escavatori a danno del Comune per sottrarre i loro prodotti al pagamento attuale della tassa in vigore, con il favore di alcuni fra i più importanti proprietari specialmente ad Acquacalda. Malgrado tutti gli sforzi fatti dal Comune per eliminare tale contrabbando, finora non ottenne risultati pratici e lo dimostra il fatto che nel 1906 ben 6129 tonnellate di pomice prodotte nelle terre comunali sono sfuggite al pagamento della tassa. Infatti nel 1906 si produssero tonnellate 16.266 di pomice delle diverse qualità e risulta dai ruoli comunali della tassa di percezione attuale che solo tonnellate 6788 pagarono la detta tassa al Comune. Figurerebbero quindi come prodotte nelle cave private tonn. 16266- 6788= tonnellate 9487. Questa cifra è un assurdo. Ammessa anche la maggior ricchezza delle cave private perché meno sfruttate, la maggior facilità di escavazione e di trasporto per le loro migliori condizioni topografiche, pure è logico ritenere che una tale cifra esorbita oltre i limiti del possibile se si tiene conto del rispettivo numero di cave e degli operai impiegati nelle une e nell’altre.”
E qui il Moretti effettua un calcolo. Nel territorio del demanio operano attualmente 24 cave a cielo aperto e 100 (106) sotterranee, e in seguito a nuove constatazioni risulta che vi siano occupati circa 504 operai contro 11 cave a cielo aperto, 9 sotterranee e 140 operai delle proprietà private. Sulla base di semplici calcoli proporzionali dovrebbe risultare che la quantità prodotta nei terreni demaniali dovrebbe essere di 12 917 tonnellate contro 3349 dai terreni privati. “Ammettendo che per le migliori condizioni delle cave private la loro produzione sia stata rispettivamente a quelle comunali, del 10% in più le cifre di produzione su riportate sarebbero trasformate in tonnellate 3648 per le cave private e tonnellate 12582 per quelle comunali, cifre queste molto vicine al vero”.
Il risultato di questa dimostrazione è che su 12582 tonnellate prodotte nei terreni demaniali nel 1906, ben 6129, e cioè quasi la metà, rappresentano l’ammontare del contrabbando a danno del Comune.
Quanto alla localizzazione risulterebbe che il contrabbando maggiore si verificherebbe ad Acquacalda , Campobianco e Castagna. A Castanga ed Acquacalda le cave private sono vicine e confinanti con quelle demaniali da qui la facilità di contrabbandare. “I proprietari delle cave private di queste regioni sono quelli che maggiormente insorgono contro la tassa del dazio alla marina compresi quelli di Porticello (attigue alle ricche cave comunali di Campobianco) e ciò perché con l’applicazione della nuova tassa alla marina, cesserebbe per loro il provento attuale del contrabbando che esercitano e verrebbe definitivamente tolto il modo di poterlo praticare”.

G. Vuillier, donne che lavorano la pomice
La “leggina” sulla pomice
Gli anni che vanno dal 1902 al 1907 furono anni di grande instabilità politica. I sindaci - con l’esclusione dell’avv. Giuseppe Faraci che lo sarà sia nel 1902-1903 e poi per quasi due anni dal 22 febbraio 1904 al 30 dicembre 1906 - duravano pochi mesi ed al massimo un anno. E questo fino a quando verrà eletto il cav. don Giuseppe Franza, già maggiore dell'esercito.
L’approvazione di una leggina che rendesse obbligatoria la tassa sulla pomice e ne permettesse l’esazione all’imbarco, sembrava l’unica risposta valida per rimettere in piedi le tristi sorti del bilancio comunale, causa dell’alternarsi di Amministrazioni fragili. Nel Consiglio del 15 giugno 1904 il Sindaco avv. Giuseppe Faraci da conto di un incontro con l’on. Ugo di Sant’Onofrio, deputato del collegio, proprio sul problema del miglioramento del diritto di percezione della pomice.
Il secondo mandato di Faraci terminò nel dicembre del 1906, dopo le elezioni parziali del 22 luglio 1906 ed il cambio di maggioranza del Consiglio. A Lipari fu mandato ancora una volta un commissario nella persona del dott. Eugenio De Carlo. Intanto si costituì un “Comitato pro pomice” del quale facevano parte le più spiccate personalità dei due partiti, il democratico ed il popolare, fino ad allora profondamente divisi. Questo Comitato si batteva per un ritorno al regime in vigore sino al 1887 e cioè la percezione dei diritti alla partenza. Una commissione con a capo il dott. De Carlo andò a Roma per sostenere questa posizione col Governo. “Il Governo – riferì l’on.di Sant’Onofrio, in Parlamento - dopo un accurato esame della questione riconobbe trattarsi non di dazio di esportazione o consumo: ma di una vera e propria tassa di escavazione mineraria” e quindi, essendo immutata la legislazione in materia, rimaneva valido il sovrano rescritto del 1855. “E tale opinione veniva autorevolmente confermata dal Ministero delle Finanze, direzione generale delle gabelle, con nota del 12 aprile 1907”.
Sull’onda di questo chiarimento 484 elettori eoliani, fra i quali molti proprietari di cave, mandarono una petizione al Parlamento perché fosse regolamentata la situazione e l’on. Di sant’Onofrio, visto che esisteva un forte accordo a Lipari su una comune piattaforma, presentò una proposta di legge.
La pomice caricata su una nave.
L'on.Di Sant'Onofrio ed mil cav. Franza
Particolarmente attivo nel Comitato e nei rapporti con l’on. di Sant’Onofrio era stato il cav. Giuseppe Franza, già maggiore dell’esercito e fratello del canonico Franza Ed il cav. Franza fu eletto sindaco, praticamente all’unanimità, il 16 luglio 1907. Agli anni dell'instabilità amministrativa seguono ora per Lipari anni particolarmente fecondi. Il Franza si rivelò un amministratore dotato di perizia e dedizione esemplari. Al Governo c'era Giolitti che cercava di andare al di là degli schieramenti politici e di mettersi direttamente in contatto con le esigenze popolari. Così furono continue le puntate che il Franza faceva a Messina e Roma per conferire con il Prefetto ed i titolari dei vari ministeri o con lo stesso presidente del Consiglio. E si racconta che fosse abbastanza insofferente delle etichette per cui non amava le lungaggini dell'anticamera. Una volta andando a trovare il Prefetto fu fermato da un uscire che gli disse con durezza:
“Dove va lei? Deve fare la fila, deve farsi annunziare ed aspettare di essere chiamato. Questa è la regola.” e lui rispose”Dite al signor Prefetto che c'è il Sindaco di Lipari e che Lipari è fuori regole”. La battuta piacque al Prefetto che fece capolino dal suo ufficio e subito lo ammise al colloquio.
Il cav. Franza e Lipari avevano però anche un efficace sostenitore nella persona dell'on. Ugo del Castillo marchese di Sant'Onofrio[3], del Partito Popolare, del collegio di Castroreale.
 Il marchese di Sant’Onofrio lo conoscevano tutti a Lipari perchè si faceva vedere spesso e non mancava mai di tenere un comizio alla vigilia delle consultazioni. Quelli del P.P.I. gli facevano trovare addobbato il vasto magazzino di falegnameria di don Giuseppe Casserà che era a metà della Salita di S.Giuseppe. Le sedie per il pubblico venivano prelevate dalla vicina chiesa.
Il marchese di Sant’Onofrio lo conoscevano tutti a Lipari perchè si faceva vedere spesso e non mancava mai di tenere un comizio alla vigilia delle consultazioni. Quelli del P.P.I. gli facevano trovare addobbato il vasto magazzino di falegnameria di don Giuseppe Casserà che era a metà della Salita di S.Giuseppe. Le sedie per il pubblico venivano prelevate dalla vicina chiesa.
L'onorevole era stato uno degli ideatori e operatori della campagna che aveva determinato l'elezione di Franza approfittando del ruolo di sottosegretario agli interni e facendo leva sul regio commissario avv. Eugenio De Carlo che gestì il comune di Lipari nei sei mesi che precedettero l'elezione.
Fu De Carlo che riuscì a convincere tutti che bisognava uscire dalla precarietà e che con l'approvazione della leggina sulla pomice che sarebbe arrivata da lì a poco una grande stagione era alle porte.
E la leggina arrivò il 5 gennaio 1908. Era la legge n. 10 dal titolo .”Sulla escavazione della pomice nel Comune di Lipari”. In realtà si trattava di una legge che con modificazioni e aggiunte veniva a confermare l'antico sovrano rescritto del 14 giugno 1855 riguardante il medesimo oggetto; un rescritto che, applicato saltuariamente e senza un serio impegno da parte della classe dirigente del paese, era “caduto nel volger degli anni in desuetudine”. Più specificatamente, la legge del 1908 che autorizzava il Comune ad emanare al più presto il regolamento applicativo, contemplava “una tassa di escavazione” sulle pomici provenienti dalle “cave situate in quell’isola” da riscuotersi “ sia in locali appositamente destinati sia al momento dell’imbarco “, e un così detto “diritto di esercizio o di licenza, da applicarsi mensilmente ad ogni singolo escavatore”. All’art. 3 la legge faceva obbligo al Comune di curare “che tutti gli operai occupati nelle cave e nel trasporto della pomice sino al mare, tanto per le cave di sua proprietà quanto per quelle di proprietà privata, siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro”.
Il regolamento fu approntato e pubblicato tempestivamente, il 21 luglio dello stesso anno e malgrado fosse chiaro e comprensibile a tutti, non mancarono , tra i cavatori, dissensi e avversioni, per cui nei primi anni il Comune ebbe serie difficoltà a far rispettare i suoi diritti. Comunque i proventi ammontarono a circa 100 mila annue e questo permise al Sindaco Franza di ridurre le tasse, di riportare in pareggio il bilancio e di far guadagnare a Lipari la fama di comune più ricco d'Italia.
La leggina ebbe una grande ripercussione a Lipari. Il tripudio per questa legge fu notevole e si fece a gara per ringraziare quelli che risultavano i massimi promotori della sospirata norma: Giovanni Gilitti, Presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno, e l’on. Ugo di Sant’Onofrio. Il Consiglio comunale fu convocato il 19 gennaio con all’ordine del giorno “ onoranze a S.E.Giolitti ed all'on. Marchese Ugo di Sant'Onofrio”. Per i due fu decisa la cittadinanza onoraria, si redisse una pergamena di lode e si decise di dedicare loro una piazza ciascuno: quella di Marina Corta ex Marina S.Giovanni e ora Piazza del Commercio a Ugo di Sant’Onofrio e quella di sopra la Civita ora Piazza degli Studi al Giolitti. A Sant’Onofrio fu anche deciso di dedicargli un mezzo busto da collocare nella sala del Consiglio. Ma mentre il primo ebbe la sua piazza ma non il mezzo busto, per il secondo ci furono diverse vicissitudini. Infatti ci si era … dimenticati che già l’anno prima la piazza degli Studi era stata dedicata a Mazzini e così si pensò di intestare a Giolitti la piazza del Pozzo[4]. Ad Ugo di Sant’Onofrio, inoltre, furono dedicati, alla sua presenza, grandi festeggiamenti pubblici il 28 ottobre dello stesso anno.
L’escavazione della pomice andò avanti sino al 2007 quando cessò perché il Consiglio Comunale non rinnovò le concessioni che erano scadute nel 2001.
[1] Nella seduta del Consiglio del 9 marzo 1905 l’assessore Paternò accusa il consigliere Giuseppe Casaceli di essere il mandante di alcuni contravventori. Nel Consiglio comunale del 28 febbraio del 1906 è lo stesso assessore Paternò ad essere chiamato in causa. G. La Greca, op. cit., pp.61-66.
[2] G. La Greca, op.cit., pp.61-72.
[3] Ugo di Sant’Onofrio era nato a Baden Baden in Germania nel 1845 dove il padre, colpito da condanna per cospirazione contro il Borbone, si era rifugiato. Studiò a Torino dove si laureò in giurisprudenza, Superato un concorso al Ministero degli Affari Esteri, operò per quindici anni nella diplomazia. Quando nel marzo del 1878 Benedetto Cairoli divenne primo ministro, fu nominato suo segretario particolare ed ebbe parecchi importanti incarichi all’estero. Morto il padre che rappresentava alla Camera il collegio di Castroreale, fu chiamato a succedergli dal voto unanime degli elettori. Ricoprì ruoli di responsabilità in diverse commissioni parlamentari, nel 1900 fu Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici nel Ministero Saracco e nel 1903 Sottosegretario all’Interno nel ministero Giolitti.
[4] Ma questa denominazione avrà vita breve perché nel 1926 verrà chiamata piazza Mussolini poi, caduto il fascismo nel ’43, prima piazza Quattro novembre ed infine piazza Matteotti.
La legge n.10 del 1908
ll primo scontro Comune - Vescovo per la pomice
Il primo scontro con il vescovo

Lo sfruttamento delle terre pomicifere nel corso del secolo si andò sempre più intensificando , assumendo la piena fisionomia industriale solo a partire dal 1884[1].
Intanto l’esportazione della pomice aveva raggiunta la media annua di 5 mila tonnellate e questo anche per via dei nuovi sistemi di lavorazione e dell’introduzione dei motori a carbone impiantati dalla ditta Barthe e dalla società anonima Eolia Oltre che a Canneto ed Acquacalda esistevano due forni di essicazione a Lipari , uno al termine di via Santa Lucia con prospetto sul torrente el’altro in fondo al vicolo Ausonia.


Il Vescovo Natoli, a sinistra e il prof. Emanuele Carnevale a destra
Fu talmente florida, in quegli anni l’industria della pomice che, col ricavato della concessione – come si afferma nel Consiglio comunale del 4 aprile 1889 - si poteva provvedere ai bisogni del Comune “senza far gravare sulla popolazione imposta alcuna”. Questo spinse il Comune – con delibera del 4 aprile 1889 - a perseverare nella reintegra delle terre comunali usurpate. Il nuovo sindaco avv. Emanuele Carnevale[2] si intestò questa battaglia, nella quale trovò sostegno nel Prefetto e finalmente il 19 giugno 1891 arrivò l’ordinanza del regio commissario degli affari demaniali che respingeva l’eccezione dell’avv. Natoli La Rosa secondo il quale molte terre pomicifere erano proprietà della mensa vescovile. L’amministrazione successiva, quella del Sindaco avv. Onofrio Carnevale, dall’ottobre 1891 all’agosto 1895,la mise in esecuzione , così “fu delimitato il demanio pomicifero e si fecero oltre duecento esecuzioni” [3].
Di quella esperienza scrisse lo stesso Emanuele Carnevale: “Il Comune aveva un cospicuo demanio pomicifero, e in gran parte era stato usurpato: io lo rivendicai ricercando e raccogliendo per la prima volta i documenti del suo diritto e impegnando un’asprissima lotta con gli usurpatori: ottenni l’Ordinanza di reintegra nel giugno del 1891”[4].
Alle manovre di reintegra operate dal Comune si oppose energicamente il vescovo tramite l’avv. Antonino Natoli La Rosa. Scrive l’avv. Natoli che la volontà di spogliare il vescovo del suo patrimonio si manifestò prima nel 1890 e riguardava una parte dei giardini che circondavano l’episcopio, ad opera del Demanio dello Stato. Ma il ricorso al Ministero bloccò quella operazione. Dal 1891 in poi la Rappresentanza Municipale si era impossessata di estese tenute dell’Isola,”molte delle quali da qualche secolo e più furono dai Vescovi concedute in entiteusi. Per questi fondi gli utilisti espropriati, avendo spinto giudizio di rivendica contro il Municipio, minacciano di tradurre presso il Tribunale anche il Vescovo…per garantirli ed indennizzarli della patita evizione[5]” .”Fu nell’anno 1884 che i Municipalisti di Lipari cominciarono a spacciare che quelle terre pomiciose fossero proprietà demaniale del Comune istesso. L’audace menzogna faceva monopolizzare in mani cointeressate la lucrosa industria delle pomici a tutto danno dei proprietarii utilisti e dei poveri che i vescovi, originari proprietarii, avevano sempre favorito con le contrattuali concessioni delle terre. Quella bugiarda invenzione si rivestiva della officiale autenticità col contratto del 14 novembre 1884 col quale si dichiarava di locarsi al francese Barthe terre pomiciose di demanio Comunale: terre che il Comune non ha…Quale sia l’eco straziante di queste dolorose note si rivela da …Telegramma: Ministro Interni, Roma. Tormentati Liparesi 1000 privatamente riuniti lacrimando implorano Regio Governo liberarli tormentatore Municipio che rispogliali proprietà e tassali ferocemente. Lipari agosto 1891[6]”.
La tesi del vescovo era che l'Amministrazione comunale, sin dal 1890 si era inventata “gratuitamente” l'esistenza di un demanio comunale in numerose contrade di Lipari mentre in realtà essere erano della mensa vescovile che fondava il suo possesso – come si è detto - sulla donazione del Conte Ruggero all'Abate Ambrogio, il Breve di Urbano II del 1901, il diploma di Re Ruggero II del 1134, ecc.
“La pretesa demanialità di tale terre non può neanco sostenersi contro le attestazioni positive degli atti e contratti autentici, che loculentemente addimostrano, quelle terre non essere state mai proprietà del Comune , ma bensì di altrui. E oltre a tutto ciò, non può senza un'audacia dissennata, oggi ancor tuttavia ricantarsi una tale demanialità: quando delle asserzioni di proprietà Comunale dell'Ente Comune di Lipari, nel mentovato giudizio contro Barthe, cotanto lungamente ed accanitamente sostenuto, non potette giustificarsene alcuna. E il pretendente Comune non produsse verun atto probatorio della sua pretesa proprietà e possesso su quelle terre !!! La mancanza di quei titoli può dirsi oramai giuridicamente costatata: mentre dopo lunghe e ripetute diffide, e parecchi termini dilatori accordati tanto preso il Tribunale di prima istanza, che preso la superiore Corte d'Appello non fu mai possibile al Comune produrne[7]”.


Sulla scorta della pianta topografica predisposta – continuava l’avvocato della mensa vescovile nella presa di posizione contro la reintegra - si era avviata la reintegra con forme di esecuzione forzata di proprietà parecchie delle quali “erano state già concesse ad enfiteusi dalla Mensa vescovile di Lipari “. Era successo che questi possessori per enfiteusi vescovile si erano rifiutati di pagare in censo alla Mensa. Anzi, alcuni di questi, per quieto vivere, erano passati a riconoscere il Municipio come proprietario primitivo. Molti altri invece citarono nel corso del 1894 il Municipio di Lipari chiedendo il rilascio dei fondi, e minacciavano di trascinare in giudizio anche la Mensa vescovile. Così per evitare di essere citato in giudizio, l'avvocato del Vescovo aveva assunto gratuitamente la difesa di costoro.
All'indomani dell'Ordinanza il vescovo,luglio 1892, invitava al bonario componimento le migliaia di debitori del censo fisso. Ma siccome questi si erano rifiutati il vescovo faceva presente che non poteva più proseguire su questa strada.
Ancora nel 1895, il 28 febbraio, il vescovo Natoli inviava una nota al Ministero di Grazia, Giustizia e del Culto sollecitando il R. Economato dei Benefici Vacanti, ma questo ugualmente respingeva le tesi della mensa.
A questo punto le acque si calmano. Ancora mons. Audino che succederà a mons. Natoli, alla morte di questo, scriverà ai Sindaci di Lipari e di Salina per lamentare la triste situazione delle finanze della diocesi per via dei diritti negati in censi e decime ma questo non produrrà effetto alcuno. Una nuova contesa si aprirà con il vescovo Paino dopo che sarà varata la tanto attesa legge sulla pomice.
La questione dell’esazione del dazio sulla pomice
.
 Le risorse provenienti dall’escavazione della pomice rappresentavano oltre il cinquanta per cento del bilancio comunale e – venendo a mancare un affittuario monopolista – le entrate erano diminuite significativamente col risultato che l’ente ne risentiva. Per porvi rimedio era necessario ricorrere ad un adeguato corpo di guardie campestri ma il suo mantenimento si rivelava molto oneroso. Vi era anche il problema dei luoghi, montagnosi e di difficile raggiungimento, che non permettevano una efficace sorveglianza. In queste condizioni il contrabbando poteva prosperare. Nel 1891 si avviò la procedura per ottenere il decreto reale che autorizzasse il Comune – come d’altronde avveniva prima del contratto con l’Eolia basandosi sul rescritto sovrano del 25 giugno 1855 - a riscuotere il diritto di percezione sull’escavazione della pomice all’imbarco della stessa. Così infatti la sorveglianza diveniva più agevole concentrandosi sui luoghi di imbarco. Ma la richiesta del Comune, pur avendo ottenuto il parere favorevole del prefetto, non viene accettata dal governo.
Le risorse provenienti dall’escavazione della pomice rappresentavano oltre il cinquanta per cento del bilancio comunale e – venendo a mancare un affittuario monopolista – le entrate erano diminuite significativamente col risultato che l’ente ne risentiva. Per porvi rimedio era necessario ricorrere ad un adeguato corpo di guardie campestri ma il suo mantenimento si rivelava molto oneroso. Vi era anche il problema dei luoghi, montagnosi e di difficile raggiungimento, che non permettevano una efficace sorveglianza. In queste condizioni il contrabbando poteva prosperare. Nel 1891 si avviò la procedura per ottenere il decreto reale che autorizzasse il Comune – come d’altronde avveniva prima del contratto con l’Eolia basandosi sul rescritto sovrano del 25 giugno 1855 - a riscuotere il diritto di percezione sull’escavazione della pomice all’imbarco della stessa. Così infatti la sorveglianza diveniva più agevole concentrandosi sui luoghi di imbarco. Ma la richiesta del Comune, pur avendo ottenuto il parere favorevole del prefetto, non viene accettata dal governo.
Intanto il 23 dicembre del 1902 il Consiglio per cercare di fare quadrare un Bilancio che si trovava in difficoltà decide di aumentare il diritto di percezione sulla pietra pomice raddoppiandola. Contro questa decisione un centinaio di escavatori ricorrono al Prefetto asserendo che questa decisione li danneggia. In Consiglio il 7 febbraio 1903. si sviluppa una forte polemica fra i consiglieri Esposito e Faraci da una parte e Caserta dall’altra. Caserta che pure si era fatto promotore del raddoppio del diritto nella seduta del 23 dicembre ora, dice ,di essere stato tratto in inganno. La discussione si fa animata ed il pubblico entrato nella sala partecipa con grida e urla. Ad un certo punto viene decisa la chiusura della discussione togliendo la parola al Caserta ed esplode il caos. Furono rovesciate sedie e tavoli e corsero anche pugni, calci e colpi di bastone. Quando – a distanza di alcuni mesi, il 20 marzo – il Consiglio si riunirà nuovamente l’animosità non si era ancora esaurita.
Il comune torna alla carica sul tema della percezione dei diritti all’imbarco nel 1894 e vuole chiedere la riproposizione del rescritto sovrano. Ma fra le carte del Comune questo non si trova più. Non rimane altra strada che chiedere al Ministero delle finanze una “leggina” che autorizzi il “dazio d’uscita”.. Il Sindaco avv. Onofrio Carnevale – il 2 agosto - fa presente, in consiglio comunale, come, quando si applicava questa forma di esazione si percepivano dalle 80 mila alle 90 mila all’anno e non era necessario ricorrere, come è invece poi avvenuto, “alla sovraimposta comunale, all’aumento del dazio consumo sul vino e sulla carne e alla tassa fuocatico ( o imposta di famiglia), pesi cotesti che il paese sopporta appena”. Invece il dazio sulle pomici da riscuotere all’imbarco “grava sull’estero,nelle di cui piazze esse vengono esportate, e migliora le condizioni degli operai, i quali trovano così meglio retribuito il loro lavoro”.
Il 9 gennaio 1895 il Sindaco in Consiglio comunale riferisce la risposta negativa del Ministero delle finanze perché avrebbe per oggetto “una imposizione che è in aperto contrasto col sistema tributario in vigore per i Comuni, e perché costituirebbe un precedente che la tutela dovuta al commercio consigli di prevenire”.
E’ il consigliere avv. Emanuele Carnevale che indica due strade per riprendere con efficacia l’iniziativa. La prima è una verifica dell’attuale sistema di riscossione. E’ vero che il Consiglio ha provveduto alla nomina di un direttore che sovrintenda al sistema ma non ha dato grossi risultati.”Egli con ciò non intende dire che si sia fatto male, perché è certamente la cosa in sé stessa che offre molte spine e difficoltà, ma se mai si potesse usare un sistema più conducente egli ne sarebbe lieto”.La seconda è quella di insistere col Ministero perché ha l’impressione che la questione non sia stata studiata con attenzione “giacché non è l’imposizione di un dazio nel vero e stretto senso della parola che si domanda, ma una modalità di esazione di quel diritto di percezione legalmente riconosciuto e dovuto sull’escavazione della pomice nei demani comunali”.
Il "sovrano rescritto"
Nel Consiglio del 26 marzo 1895 si prende atto che il Comune ha richiesto ed ottenuto dall’Archivio di Stato di Palermo copia del “sovrano rescritto” e si delibera di inviarlo ai Ministri dell’Interno e dell’Agricoltura, industria e commercio per chiedere l’autorizzazione all’esazione all’imbarco delle pomici. Per diversi anni non si hanno riscontri del governo su questo piano. Comunque le delibere del Consiglio per l’esazione del dazio all’imbarco concorrerà alla formazione, come vedremo, della legge n. 10 del 1908.
Nel consiglio comunale del19 ottobre 1899 il consigliere Giovanni Carbone denuncia che i diritti di escavazione non rendono alla finanze comunali neanche la quinta parta di quello che dovrebbero - visto che l'esportazione supera i 150 mila quintali l'anno - e questo perchè la maggior parte della pomice sfugge alla verifica della Guardie Campestri.
Quello del funzionamento del sistema di riscossione non è problema nuovo. Più volte era venuto alla ribalta in Consiglio. Nel consiglio del 12 novembre del 1894 si era data notizia di aver licenziato quattro guardie campestri perché non svolgevano il servizio con regolarità e quindi lasciavano spazio al contrabbando. Si parla anche di affidare il servizio ad un esattore piuttosto che al tesoriere perché l’esattore può procedere alla riscossione forzata. A questo proposito un problema sorge su chi debba gravare l’agio dell’esattore: sui singoli cavatori o sul Comune? Viene alla fine chiarito e deciso che di esso si debba fare carico il Comune.

Ma quello delle guardie campestri doveva essere un problema spinoso. Nel consiglio del 5 settembre 1895 il nuovo Sindaco avv. Giuseppe La Rosa riferisce che il sistema di sorveglianza lascia molto a desiderare per mancanza di personale perché con quello esistente non si possono organizzare i turni notturni ed il contrabbando avviene soprattutto di notte e per questo servizio servono delle guardie scelte. Il problema è quello dell’età? E’ meglio spingere l’età fino ai quarant’anni per avere persone più responsabili e dotate di esperienza o invece contenerla al massimo ai trent’anni perché siano in grado di affrontare le fatiche di lunghe e escursioni in località impervie e scoscese? Nel 1899 il corpo era composto da un direttore, un caporale, un appuntato e quattordici guardie. Nel settembre del 1902 si comunica che la Giunta aveva provveduto al licenziamento dell’intero corpo per migliorare il servizio che lasciava molto a desiderare.
Nel corso del 1905 si procede alla modifica del regolamento organico delle guardie. Il corpo prevede due capo guardie, quattro guardie di prima classe e sei guardie di seconda classe. Ma fra il 1905 ed il 1906 scoppia una grave crisi che verrà risolta solo nel 1907. Vi è una inchiesta, vi sono varie dimissioni che – nel luglio del 1906 - sono accolte dalla giunta Faraci che indice un concorso per sostituire i dimissionari. Poi invece emette una delibera di conferma senza tener conto del bando e delle domande pervenute. La delibera di riconferma viene annullata dall’autorità tutoria. Il 9 settembre la Giunta procede allo scioglimento del corpo dando facoltà agli agenti di rimanere in servizio finché non si sarebbe provveduto ad una nuova sistemazione. Ma anche questa delibera viene bocciata ed il corpo rimane affidato a personale avventizio. Finalmente il 30 gennaio del 1907, dopo anni di caos e confusione, il regio commissario procede alla nuova sistemazione portando le guardie da dodici a quattordici, nominando due agenti provvisori, confermando nel servizio le guardie che non si erano dimesse nel luglio del 1906 mentre quelle che avevano date le dimissioni rimangono come avventizi.
[1] G. Arena, L’economia delle isole Eolie, op. cit., pag. 46.
[2] Emanuele Carnevale nasce a Lipari il 4 marzo 1861 dall’avv. Emanuele Carnevale Salpietro e da Giovanna Rossi. Si Laurea Messina nel 1884 e proprio negli anni universitari inizia a fare politica fra i democratici di Messina. Aderisce alla massoneria di Palazzo Giustiniani e sostiene nelle elezioni del 1882 la lista radicale. Tra il 1884 ed il 1891 dopo aver ricoperto la carica di presidente fondatore di una Società di mutuo Soccorso di Salina, diventa presidente della Società operaia di Mutuo soccorso di Lipari e nel novembre del 1889 diventa primo sindaco elettivo del Comune di Lipari e lo sarà fino all’ottobre 1891.
[3] O. Carnevale Rossi, Pro veritate, Lipari 1903, p.6.
[4] E.Carnevale, Miei ricordi di vita e di lavoro, palermo 1923, pp.43-44.
[5] A.Natoli La Rosa, Sul beneficio Vescovile di Lipari e le sue rivendiche. Note rischi arative, Messina 1896, pp. 11, 24 e 25.
[6] A.Natoli La Rosa, Studii politico-sociali, Palermo 1896, pp. 95,100.
[7] A.Natoli La Rosa, Il monopolio commerciale per la pomice nell’isola di Lipari, 1889, in G.La Graca, op.cit. ,vol II, pp.32-33.
Giovanni Carbone
L'arciduca che amava le Eolie
Luigi Salvatore d'Austria si innamora delle Eolie[1]

Luigi Salvatore in età avanzata
Tra il 1893 ed il 1896 venivano pubblicati a Praga otto grossi volumi sulle isole Eolie – uno per isola ed uno generale – ad opera dell’arciduca Luigi Salvatore d’Austria. L’arciduca d’Austria era nato in Italia e precisamente a Firenze il 4 agosto 1847. Il padre era Leopoldo II di Asburgo-Lorena e granduca di Toscana dal 1824 al 1859, la madre Maria Antonia figlia di Francesco I dei Borboni di Napoli. Nel 1859 alla vigilia dell’unificazione d’Italia, perduto il granducato di Toscana, per la famiglia cominciò il pellegrinaggio dell’esilio da Roma, in varie sedi dell’impero austro-ungarico fino a Vienna e quindi a Praga. Ma Luigi Salvatore non amava le corti imperiali ma fantasticava di viaggiare in mare aperto alla scoperta di posti sempre nuovi. E così quando, nel 1867 visse il dramma della fidanzata bruciata fra le fiamme di un incendio senza che lui riuscisse a salvarla, l’unico sollievo lo trovò nel viaggiare da un posto all’altro del Mediterraneo, sempre immerso nel silenzio e nel raccoglimento.
E fu durante uno di questi viaggi nel 1868 che scoprì prima le Eolie e quindi Maiorca due realtà che rimasero nel suo cuore. A Maiorca stabilì la sua sede, alle Eolie fece più volte ritorno nel corso degli anni 70. Quando veniva alle Eolie era avido di informazioni e di notizie sulle isole e fu in uno di questi contatti che nel 1875 conobbe l’avv. Antonino Natoli La Rosa che gli diede un “Prospetto descrittivo delle Isole Eolie” con dedica. Da quell’anno le sue visite ed i soggiorni alle Eolie si fecero sempre più frequenti e prolungati.
Prese in affitto la casa posta su un piccolo promontorio sul mare a Capistello Sottano che si affaccia sulla spiaggia detta di donna Ina. E di donna Ina era detta anche la casa perché era appartenuta a donna Caterina Paino. Alla casa era annessa una cappellina seicentesca con il suo campaniletto e la croce in muratura dedicata alla Vergine Maria, che l’arciduca fece restaurare. Luigi Salvatore scelse questa casa come dimora perché “ da questo posto si offre un meraviglioso panorama e una deliziosa veduta su Lipari e lo scorcio di Stromboli. Ristoratrice è anche l’aria che qui spira[2]”.


A sinistra, la prima edizione in tedesco stampata a Paraga. A destra l'edizione italiana curata da Pino Paino. Il sesto volume su Alicudi
Da questa casa scendeva alla spiaggia per salire sul suo yacht la Nixe[3], con la sua corte di disegnatori e naturalisti, da cui non si separava mai e che lo accompagnavano nelle sue peregrinazioni. E sempre da questa casa, a piedi, raggiungeva Lipari col “ suo vestire più che dimesso, [che] lo faceva spesso scambiare per un manovale, cosa di cui egli si compiaceva”[4] per chiacchierare con gli isolani, personaggio di rilievo e gente del popolo. Ed era allora che la sua austerità ed il suo silenzio melanconico si stemperavano nella conversazione che sapeva essere spiritosa ed originale. Strinse amicizia con diversi liparesi ma, come ebbe a scrivere lui stesso in un messaggio del ‘aprile 1893, “a due persone sono io obbligato da particolare riconoscenza, all’agente consolare austroungarico don Angelo Pajno e al dott. don Giovanni Rodriquez, i quali sono stati sempre disponibili a darmi tutte le informazioni desiderate”.

Il suo yacht con cui girava il Mediterraneo
Una documentazione imponente sull'800 eoliano
Ed anche grazie a queste informazioni potè descrivere il nostro arcipelago con attenzione e competenza lasciando una documentazione imponente di immagini e di informazioni sulle Eolie della seconda metà dell’800. ”Dalle generalità geografiche, dalle linee fondamentali della sua morfologia – ebbe a commentare il geografo Giovanni Marinelli, fondatore e presidente della Società di studi geografici e coloniali di Firenze -, si passa gradatamente all’esame delle sue particolarità geofisiche e a quelle della geografia biologica ed antropogeografia. Specialmente le genti vi sono studiate con una cura ed una diligente disamina dei caratteri speciali ed accidentali veramente rare. Non soltanto se ne espongono i tratti somatici ed antropologici, ma gli usi, i costumi, i portamenti e sto per dire i pensamenti: se ne descrivono le dimore, le occupazioni, le vesti, gli utensili e i cibi: se ne danno raccolti i proverbi, le canzoni i giuochi: se ne studia la vita complessiva al lume della statistica tanto sotto il rispetto demografico, quanto sotto quello del movimento economico, agricolo, industriale e commerciale… L’opera così com’è, costituisce una delle più insigni pubblicazione geografiche dei nostri tempi ed uno dei più larghi contributi alla conoscenza di un lembo interessante del suolo italiano”[5].
Alle Eolie dopo il 1891non fu più visto ma le isole e i liparesi gli rimasero sempre nel cuore . Queste isole dove “il forestiero può aggirarsi in piena sicurezza fra questo popolo cortese, gaio, sereno, che fa presto a conquistarti il cuore”[6]
 La famiglia dei duchidi Lorena quando andarono in esilio dalla Toscana
La famiglia dei duchidi Lorena quando andarono in esilio dalla Toscana
Un bel ritratto della personalità dell’arciduca ce l’ha lasciata un altro contemporaneo. “Né la vita militare, né la corte – scrisse Angelo De Gubernatis - avevano alcuna attrattiva su questo principe pacifico e filosofico, e si piegò nella solitudine e nella meditazione; e il mare dove egli si porta di costa in costa, da isola a isola, sul suo Yacht, ha in modo meraviglioso contribuito a mantenerlo in questo spirito d’indipendenza e di astrazione religiosa e filosofica. Si può dire che, come Ulisse, egli è esperto degli uomini e delle cose, e le bufere del mare gli paiono meno spaventose delle bufere della vita. L’uomo gli ispira spesso pietà, ed egli si sforza, ove può, con la sua amabilità e con la sua generosità, d’addolcire e di alleviare le grandi miserie dell’umana esistenza.[7]” .
Morì nel suo castello di Brandeis sull’Elba, a nord di Praga, il 12 ottobre 1915 lasciando numerose opere, soprattutto relative ad isole del Mediterraneo[8], oltre a quelle sulle Eolie e sulle Baleari – a Maiorca, sempre in cima ai suoi pensieri è dedicata l’ultimo lavoro “Torri di avvistamento e di guardia a Maiorca” - ma anche sulle puntate che fece negli oceani “Los Angeles, un fiore nel paese dell’oro” (1878) e “Intorno al mondo senza volerlo” (1881) in cui parlò del suo viaggio a Melbourne.
La calunnia di essere una spia
Dopo la sua morte fecero la loro comparsa anche sospetti e critiche. Perché tutti quei viaggi nel Mediterraneo e quelle descrizioni così minuziose delle coste? E perché questa rete di relazioni numerosissime e “non tutte confessabili”?.
“Sebbene malato e lontano – afferma il giornalista francese Ernest Gaubert il 5 dicembre del 1917 - , Luigi Salvatore poteva ancora dirigere con i suoi consigli la campagna sottomarina. Egli solo conosceva bene le Baleari, e in quelle acque furono segnalati i primi sommergibili. Nell’opinione dei marinai e degli Alleati, i Tedeschi si sono giovati largamente dell’informazioni dell’Arciduca. Forse questi cominciò l’opera sua per inclinazione e senza secondo fine; poi, accorgendosi della sua utilità militare, la proseguì con vedute dinastiche e per farsi perdonare dall’imperatore d’Austria quelle che Vienna chiamava ‘le sue manie’[9] ” .
Nel 1920 è un italiano Etrurio Gamberini a rilanciare e avvalorare i sospetti. “Certo che le isole Eolie … potevano sembrare…, ad un metodico organizzatore, un piede a terra magnifico per le battaglie navali mai combattute. L’opera dell’arciduca tedesco sulle isole Eolie… è minuziosa, pesante, e rivela una mancanza di studio ideale e psichico; forse nasconde altri fini politici e militari che fortunatamente sono mancati nelle loro linee generali. Possiamo ben dirlo: nella campagna feroce dei sottomarini gli scogli delle Eolie non hanno servito da base al nemico mercé l’opera costante e oculata della nostra Marina.[10]”.
E dal sospetto, alla polemica ideologica, alla calunnia il passo è breve. Eccone un incredibile saggio: “Maestro e informatore degli ufficiali della marina germanica poté essere dunque questo Arciduca che, come dice la leggenda, degenerato, perseguitato da un vizio odioso e da sciagure, si era formato però – nel mondo degli ingegneri e degli idrografi che lo accompagnavano da per tutto – anche la sicura conoscenza degli uomini più corrotti dei bassi fondi delle sue possessioni e delle isole. Si attribuiva questa sua predilezione ad una mania di vecchio sognatore che, con la sua andatura monastica, rozzo di modi, sporco negli abiti come un pezzente, ma pieno di cultura, veniva reputato l’uomo più innocente del mondo.[11]”.
Comunque nelle Eolie non si è mai prestato ascolto a queste insinuazioni e la memoria dell’Arciduca ha continuato ad essere conservata e coltivata nel tempo[12].

A casa di Donna Ina - dove abitava Luigi Salvatore quando veniva a Lipari - sopra la spiaggetta omonima
[1] Tutto questo paragrafo fa riferimento a G.Iacolino, Archietettura e territorio nelle Eolie, in Gente delle Eolie, Lipari 1994, pp. 179-192.
[2] L. S. d’Austria, Le isole Lipari, Lipari, vol.III,p.124.
[3] Nixe starebbe per “ondina” o ninfa delle acque”. La prima Nixe si infranse nel 1880 sugli scogli di capo Caxine in prossimità di Algeri e immediatamente Luigi Salvatore si fece costruire una nuova imbarcazione che chiamò Nixe II.
[4] E. Gaubert, “L’Arciduca misterioso”, in “Revue de Paris”, del 15 dicembre 1917, anche in “Minwerva”, a. XXVIII, 1 febb. 1818, n.3 p.91.
[5] “ Rivista geografica italiana”, Firenze, anno III, 1986, vol III p. 148.
[6] L.S. d’Austria, Le isole Lipari, Parte generale, VIII volume.
[7] A. De Gubernatis, Dictionaire International des scrivane du monde latin, Roma, Firenze, 1905., alla voce “Ludwing Salvator”.
[8] Ricordiamo: Leuconia, la capitale di Cipro (1873), Le Caimeni (1874), Il Golgo di Corinto (1876), Biserta (1897), Oaxos e Antipaxos (1897),Ustica ( 1898), Alboran ( 1898), Bugia, la perla dell’Africa Settentrionale (1899).
[9] Op. cit., pp 90 e ss.
[10] E. Gamberini, Monografia marittima della Sicilia Nordorientale, Messina 1920,pp.190-191.
[11] Idem.
[12] Pino Paino ha pubblicato e curato dal 1977 al 1986 gli otto volumi; il Comune di Lipari nel 1997 vi ha dedicato una edizione di “Festadimaggio” con l’intestazione di una piazza nel centro della città e l’avvio di un gemellaggio con Maiorca nel nome dell’arciduca che si è perfezionata nel tempo.
don Giovanni Rodriquez
Lo stato del clero e delle chiese
La disciplina del clero ed il decoro dei riti

La chiesa del Santa Lucia
La situazione in relazione ai luoghi di culto, dopo l’applicazione delle leggi eversive, era sconfortante. Nelle due chiese dei religiosi, si officiava ancora ma erano ormai di proprietà del Comune, le tre chiese del Castello rischiavano l’abbandono ed inoltre la chiesa delle Grazie era chiusa al culto per via del crollo della volta – avvenuta nel 1879 - e non si avevano i mezzi per ripararla; gli altri luoghi di culto erano in gran parte cappelle più che vere e proprie chiese. In tutto erano 55 e, eccettuate quattro o cinque che avevano modesti redditi, la grande maggioranza versava in estrema povertà e possedeva appena le suppellettili indispensabili ai riti grazie alle elemosine dei fedeli ed alle collette[1].
Non migliore era la situazione del clero e doveva essere peggiorata significativamente nell’arco di qualche anno. Infatti se nel 1864 Mons. Ideo può scrivere che “i costumi del Clero secolare sono nel loro complesso esemplari. Se ne trovano appena uno o due che, dimentichi del loro ufficio e della loro dignità, si sono allontanati dal retto sentiero”[2]già all’’inizio degli anni 70, fra i preti che erano una novantina, il vescovo non trovava un ecclesiastico idoneo a sostituirlo durante la sua visita a Roma e dovette scegliere il suo vicario generale fuori diocesi, fra i benedettini. Fra i propositi di questo vescovo ora vi era quello di riportare la disciplina fra il clero a cominciare dall’imporre la prescritta divisa – il cappello a tre punte, l’abito talare o soprabito di color nero lungo – che molti preti trascuravano. Toccò a mons. Palermo rilanciare nel 1885 il Seminario che vivacchiava, organizzare esercizi spirituali per tutti i sacerdoti e trasformare, il 28 maggio 1882, le cappellanie in curazie con la facoltà di amministrare, cresima esclusa, tutti i sacramenti[3].
 Mons. Natoli
Mons. Natoli
Merito di mons. Natoli fu quello di riportare il decoro nei sacri riti, ma soprattutto cercò di dare nelle feste padronali più spazio alla spiritualità e meno alle manifestazioni tutte esteriori (banda musicale, mortaretti...). Dai suoi sacerdoti esigeva esemplarità di vita e obbedienza, e in un suo decreto pastorale sulla disciplina del clero ribadiva l’obbligatorietà dell’abito e si mostrava intransigente verso i preti che andavano a caccia di lasciti e legati, circuendo anziani inebetiti e moribondi[4]. Forse fu proprio questa intransigenza ma anche il contenzioso relativo alla proprietà dei terreni pomiciferi che portarono il Consiglio Comunale il 27 ottobre 1893, su proposta del Sindaco Onofrio Carnevale, a votare un ordine del giorno in chi i chiedeva la governo che il vescovo fosse “rimosso da quest’isola o diocesi, e subordinatamente, in ogni caso gli sia tolto il Regio Exequatur”[5], sostenendo che questa iniziativa rispondeva ad un desiderio vivissimo del paese senza distinzione di classe o di parte inclusa la maggioranza del clero. L’anno dopo saranno alcuni esponenti della borghesia di Salina a stampare un opuscolo dal titolo “Supplica degli abitanti dell’Isola di Salina a S.S. Leone XIII”[6] chiedendo al Papa la rimozione del vescovo per evitare “ che più di mille anime, nate e cresciute cattoliche, siano spinte all’apostasia e alla miscredenza”.
Negli anni ’90, su una settantina di preti, almeno una quindicina svolgevano il loro ruolo di cura d’anime nelle frazioni rurali di Lipari e Salina e nelle isolette di periferia con una condizione di vita modestissima fino alla povertà ( simile d'altronde a quella dei parrocchiani); nel capoluogo comunale di Santa Marina vi erano sei preti che godevano di un discreto benessere, mentre oltre quaranta dimoravano stabilmente nella città di Lipari,e molti senza incarichi religiosi. Nel giro di vent’anni la massa del clero si era letteralmente dimezzata, ma il rammarico di mons. Natoli, che proveniva dalle fila del clero liparese, era quello di avere sacerdoti di scarsa dottrina e comunque non all'altezza dei compiti richiesti o, peggio, rinchiusi in un disimpegno di altri tempi.
La reazione del clero e dei laici cattolici alla massoneria
Sarebbe troppo semplicistico – fa osservare il prof. Giuseppe Iacolino - liquidare il clero liparese di allora con un sommario giudizio di condanna. C’erano i preti cattivi ma ce n’erano di buoni… Un difetto comunque ci appare fosse come il loro denominatore comune, quello di sentirsi ancora casta di eletti, occupati e frastornati dalla ricerca dell’utile personale e di famiglia, carenti di quegli stimoli fecondi che avrebbero dovuto portare a rispondere alle istanze della società del loro tempo. Apparentemente rispettati e riveriti perfino dai laicisti più convinti, ignoravano di essere nel contempo additati come emblemi del depotenziamento dei valori religiosi.[7]
Comunque non c’è dubbio che fu merito di mons. Natoli se la vita religiosa della diocesi era significativamente migliorata e il clero liparese, alla fine del XIX secolo, si venne arricchendo di nuove vocazioni, mentre fra i laici si diffusero e si rinverdirono devozioni ed associazioni popolari del tipo tradizionale e di nuova istituzione.
In particolare proprio a cominciare dalla metà degli anni 80 ed anche come reazione all’attivismo della massoneria contro il papa e la Chiesa in generale, manifestatisi fra l’aprile e il maggio del 1889 a Roma, ma anche in altre parti d’Italia, in occasione dell’inaugurazione in Piazza dei Fiori del monumento a Giordano Bruno, che comincia a organizzarsi una presenza dei cattolici a Lipari, oltre che su temi devozionali, anche su quelli politici e civili. Anche su questo piano si mosse mons. Natoli sollecitando i liparesi all’apostolato attivo. Nasce così la lettera di solidarietà a Leone XIII del 9 giugno 1899, sottoscritta da numerosi liparesi convenuti in Cattedrale[8]e hanno luogo diverse riunioni ed assemblee di cattolici per creare una opinione pubblica di reazione all’anticlericalismo dominate nei ceti abbienti. In una di queste riunioni si presentò la figura di Alessandro Manzoni come “esempio di verità” in contrapposizione a Giordano Bruno, “esempio di corruzione”[9].

Scheletri dei canonici nella cripta della Cattedrale di Lipari disegnati da Vuillier
Non mancarono nelle Eolie sul finire dell’800 figure di preti culturalmente e socialmente vivaci. Ne vogliamo ricordare in particolare uno: don Tanino Renda[10], conosciuto come il prete di Stromboli dove era nato e dove era tornato a vivere una volta ordinato prete a Napoli. Dotto, eloquente e di bell’aspetto era ritenuto un prete moderno e anche un po’ ribelle. Il vescovo Palermo lo aveva voluto a Lipari ad insegnare italiano nel seminario negli anni 1884 e 1885. Poi sembra che sia tornato a vivere a Stromboli dove dovette ricoprire l’incarico di cappellano o di curato non trascurando anche qualche puntata nel continente e in particolare a Napoli ed a Genova dove era chiamato a predicare. La fama di lui fra la gente dell’isola era andata crescendo come difensore dei più deboli e perché sempre pronto a pacificare i contrasti, inoltre era un punto di riferimento per quei viaggiatori colti che visitavano l’isola come Annibale Riccò e Luigi Salvatore d’Austria. A Lipari invece si parlava di lui come di un agitatore politico da quando si era messo a capo di un movimento popolare che voleva – ripercorrendo la strada di Salina - fare di Stromboli un comune autonomo.

La sua vita fu improvvisamente spezzata il 3 di giugno, sabato del 1893, alle sei e mezza del pomeriggio, nel sagrato della chiesa di S. Vincenzo,con alcuni colpi di pistola, quando aveva solo trentacinque anni. Su questa morte si dissero tante cose. Qualcuno disse che era stata voluta dai borghesi di Lipari per togliere un sostenitore scomodo dell’autonomia dell’isola e ne fece un martire dell’autonomia stromboliana. Si parlò anche di delitto d’onore da parte di un marito tradito.
In realtà da una ricerca sulle fonti dell’epoca si ricava una storia diversa.
La vera storia dell'uccisione di don Tanino Renda
Negli ultimi due anni a Stromboli era stata mandata ad insegnare nelle scuole elementari femminili la maestra Maria Randazzo di 27 anni. Maria era spostata , al municipio, con Ottavio Oliva di Mirto e, trasferitasi a Stromboli la coppia, il 20 novembre del 1892 aveva avuto una bambina. Don Tanino fece amicizia con la coppia ed aveva rapporti molto stretti ed affettuosi con entrambi.
Ottavio che era persona impulsiva e focosa aveva battibecchi continui con la moglie e probabilmente le faceva frequenti scenate di gelosia. La situazione divenne esplosiva quando don Tanino venne a sapere che Ottavio, due anni prima, era stato condannato dal pretore di Mirto a due mesi di carcere che non aveva espiato rendendosi latitante. Il prete cercò di convincere l’amico a presentarsi spontaneamente per regolarizzare la situazione che, nel tempo, poteva diventare difficile anche per la figlioletta. Ma siccome questi faceva orecchie da mercante alla fine fu lo stesso don Tanino a denunciarlo e farlo quindi arrestare. L’Oliva scontò la pena covando nel suo animo il pensiero che questo fosse dipeso dal fatto che il prete avesse una relazione intima con sua moglie. Da qui, una volta liberato, la vendetta.
I giornali dell’epoca scrissero che “il popolo di Stromboli dell’uccisore voleva fare giustizia sommaria e ci volle tutta la potenza e la forza dei Reali Carabinieri per salvarlo dall’ira popolare”[11]. Di questa ira popolare fu testimone lo scrittore francese Gastone Veuilleur che assistette all’imbarco dell’omicida sulla nave con cui stava raggiungendo Lipari.
“Nel tempo che stiamo fermi, aspettando la posta – scrive Veuilleur - , vediamo una folla schiamazzante accorrere sulla spiaggia, e davanti a questa un uomo incatenato che corre disperatamente protetto da un carabiniere. Per sottrarlo a quel furore popolare, questi lo trascina in una barca, e i rematori fanno subito ogni sforzo per allontanarsi dal lido. Ma la folla è lì, che come un branco di molossi feroci reclama la sua preda. Le donne, al solito, sono le più accanite; alcune megere entrano nell’acqua e si aggrappano ad una barca, altre urlano minaccianti, scarmigliate, con gli artigli tesi. Frattanto è riuscito al battello di lasciare la sponda, ma una sassaiola di pezzi di lava vi piove sopra. Si vedono delle persone abbassarsi e lanciare poi con furore le pietre. Dinnanzi a quell’assalto il carabiniere, per istinto di conservazione, si nasconde da una parte, e il condannato è quasi lapidato. Giunge vicino al nostro bastimento col cranio scoperto e il viso insanguinato, tutto lordo di fango nero e coi capelli insozzati, irti sopra la testa. Il battello si accosta a fatica, e allorché quel disgraziato traballando mette piede sulla scala del bastimento, un barcaiolo prende un grosso pezzo di lava che serviva da zavorra e glielo scaglia sul dorso con quanta forza ha; egli caccia un urlo di dolore, seguito da quelli d’indignazione di quanti siamo a bordo. Laviamo il viso del prigioniero, un bel viso pallido dall’espressione ancora fiera, e gli prestiamo delle cure. Il giudice istruttore, che è pure a bordo, ci aiuta, gli arresta il sangue, gli medica le ferite, e parla con bontà a quell’uomo scampato per miracolo al furore d’una folla sanguinaria e feroce. Questo sventurato aveva ucciso un prete che l’aveva disonorato…Seppi di seguito che era stato rinchiuso nel castello di Lipari e che il suo cervello aveva tardato poco a dar di volta”[12]

[1] Giuseppe Iacolino, Inedito, Quaderno XI.
[2] Relatio ad Limina del 20 marzo 1864 in Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff. 218-228.
[3] Archivio Vescovile, Bullario 1874-1923, ff.35-35v.
[4] Archivio vescovile. Decreto pastorale di S.E.R.ma Mons. Giovan Pietro Natoli Vescovo di Lipari, Palermo 1893. Sulla vicenda della circuizione dei moribondi in cui alcuni sacerdoti cercarono di coinvolgere il vescovo. Si veda Giuseppe Iacolino, inedito cit. ,quaderno X, 468 a e b, 469.
[5] Dal verbale del Consiglio Comunale del 1893. L'accusa forse più forte che il Sindaco avanzò verso mons. Natoli fu di avere usurpato col fratello Antonino, l'avvocato, una vasta estensione del demanio Comunale produttivo di pomici in contrada Rocche Rosse e di istigare “gli usurpatori ignoranti e in mala fede di non venire a conciliazione col Comune”. Questa vicenda dei terreni alle Rocche Rosse risaliva al luglio 1883 quando don Antonino Natoli aveva denunciato alcuni scavatori che oltre a danneggiare i suoi terreni si erano appropriati di “una considerevole quantità di pietra pomice… di un valore approssimativo calcolabile in quattrocentonovanta lire”.Nella vicenda era intervenuta la Giunta sostenendo che “la condanna dei minatori ricorrenti sarebbe di gran pregiudizio al Comune, in riguardo a quella estensione demaniale del Serro delle Rocche Rosse” e certo questa non potrebbe essere sostenuta in giudizio dagli operai per le loro precarie situazioni economiche. Probabilmente il giudizio fu favorevole al Comune. ( si veda anche G.La Creca, La storia della pomice di Lipari. Vol.II, Lipari 2008, pp.12-16). Il Sindaco aveva proposto inizialmente solo che fosse revocato al Vescovo il Regio exequatur. Fu l’avvocato Emanuele Carnevale, nel dibattito, ad alzare il tiro ed ha richiedere l’allontanamento.
[6] Stabilimento Tipografico Caserta e Favaloro di Lipari.
[7] “Per quanto concerne il popolo e i suoi comportamenti( intendiamo parlare del ceto inferiore e soprattutto dei villaggi) dovremmo dire….popolo costumato e degno di lode. Infatti in queste isole ( eccezion fatta per la Città di Lipari), le quali sono disseminate in una vasta plaga di mare e sono distanti dai grandi centri fitti di popolazione, l’attuale nefasto progresso non è riuscito a farsi strada. Gli indigeni di queste isole, benché si ritrovino poco istruiti nelle cose della Religione e siano per lo più privi di Sacerdoti animati da fervore che li possano animosamente guidare per le vie del Signore, tuttavia no mancano ad essi un’anima naturalmente cristiana, trascorrono l’esistenza nella semplicità e nella morigeratezza, si astengono dalla bestemmia, osservano i giorni festivi e il precetto pasquale e attengono alle altre pratiche che si convengono ad ogni buon cristiano”.Relazione “ad Limina” di mons. Palermo. Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff. 275-275v.
Sulla pietà religiosa nelle isole nei secoli passati ci sarebbe da aprire una seria ricerca. La contrapposizione fra una Lipari secolarizzata con la presenza di forti elementi di crisi morale e una realtà delle contrade e delle altre isole dove viveva una popolazione devota nella semplicità di una religiosità popolare e moralmente “sana”, appare troppo schematica. Già le osservazioni di Mons. Ideo e Mons. Palermo, che abbiamo riportato, come le considerazioni raccolte sul clero diocesano, dovrebbero fare riflettere. Inoltre negli anni recenti, grazie all'impegno trentennale della prof.ssa Marilena Maffei, è emersa una narrazione popolare eoliana, che persiste ancora oggi nelle vecchie generazioni ma affonda le sue radici nei secoli passati, la cui natura è decisamente pagana ed i riferimenti alla religione cristiana sono marginali e del tutto formali. Si veda in particolare l'ultima opera dell'autrice, “La danza delle streghe. Cunti e credenze dell'arcipelago eoliano”, 2008, Roma, ma anche, soprattutto per i riferimenti al culto di San Bartolomeo, “La fantasia,le opere e i giorni”,2000, Milazzo.
[8] Archivio Vescovile, Bull., vol.IV, f.61.
[9] Discorso di don Onofrio Paino di Alessandro ( da non confondere con don Nofrio il pirata) del 5 marzo 1888 in Giuseppe Iacolino, inedito, cit., Quaderno X, pag. 466 a. Il prof. Iacolino ha ottenuto questo discorso in copia manoscritta dal capitano Peppuccio Paino di Giuseppe.
[10] Don Tanino Renda era nato a Stromboli il 22 maggio 1858 da padre di origine calabrese anche lui di nome Gaetano, agricoltore e marinaio benestante.
[11] Gazzetta di Messina, dell’8 giungo 1893 in G. Iacolino, inedito cit., quaderno X, pp. 483-4.
[12] G.Veuilleur, La Sicilia, Milano 1987, pp.415-416.
don Tanino Renda parroco di Stromboli
Il conflitto fra Vescovado e Comune
A Lipaeri si segnala un recupero di cultura
Quello che un tempo era l'ex Ospedale dell'Annunziata
Circa il deperimento delle funzioni del vescovo abbiamo già fatto cenno all’assistenza ed alla beneficenza che divengono di competenza comunale[1]. Lo stesso bisogna dire per l’istruzione pubblica. Così nel 1862 a Lipari si istituiscono le prime scuole elementari e nel giro di un quindicennio l’istruzione primaria raggiunge le isole minori[2]. Nel convento dei Minori sopra la Civita - quando questo diventa l’edificio delle scuole liparesi - vengono programmate, all’inizio degli anni 70, anche delle cattedre supplementari per diversi insegnamenti specifici: una “ scuola di lingua italiana, lingua latina, letteratura italiana e letteratura latina”; una “scuola d’istruzione letteraria lingua francese e disegno”, una “scuola di aritmetica e contabilità” e “una scuola d’algebra e geometria”. Sopra la Civita viene chiamata così Piazza degli studi e la stradina che dalla Civita porta Sottomonastero, l’attuale salita Meligunis, viene chiamata salita degli Studi.
Sul finire del secolo nella città di Lipari almeno la metà della popolazione poteva dirsi alfabetizzata. Scolari e studenti ammontavano ad oltre 1200. Le tre classi del ginnasio inferiore, istituito verso il 1888, accoglievano una trentina di allievi. Fu nel 1893 che il Comune volle impiantare anche le classi superiori del Ginnasio ma l’esperimento non ebbe successo e venne soppresso nel giro di un decennio. Poi, nel 1906 si opterà per la creazione di una scuola tecnica destinata a durare più a lungo. Non bisogna trascurare che a Lipari, in quegli anni, operavano tre biblioteche e quella del Seminario era aperta al pubblico.
Negli anni 80 si sviluppano movimenti di solidarietà fra lavoratori e piccoli borghesi come la “Società operaia di mutuo soccorso sussidiata dal Municipio per mantenimento di una scuola elementare serale pei figli dei soci[3]” e una “società cooperativa tra gli esercenti di arti e mestieri”. Vengono rifatti, per iniziativa dell’avv. Rosario Rodriquez, gli ospedali di S. Bartolomeo e dell’Annunziata[4]
Fra il 1890 e il 1905 crescono di importanza le stamperie[5] ed alcune nascono proprio in questo periodo. E con le stamperie giungono pubblicazioni di carattere diverso. Vedono la luce nel 1890 anche due pubblicazioni periodiche – Il Gazzettino liparese e L’indipendente – che ebbero però brevissima durata [6], ma anche il libretto a nome del popolo di Salina di cui si è detto, regolamenti di confraternite, libri di poesia[7]…Verso il 1900 un ex relegato trapanese Filippo Bellet (divenuto poi Belletti) apre il primo centro vendita giornali in via Garibaldi.

Il libretto dei salinari contro le decime
Come si vede, nel decennio di fine secolo si ha a Lipari, un notevole recupero di cultura sia negli ambienti laici e laicisti sia in quelli cattolici ed ecclesiastici.
Se nell’ambito degli ecclesiastici – osserva Giuseppe Iacolino[8] - si registrò come una rimonta di qualificazione, ci fu pure tra i laici una certa ansia di aprirsi alla vita politica, culturale e artistica del tempo, i cui fermenti venivano mutuati all’esterno attraverso la stampa quotidiana, periodica e libraria.
Ancora in questo periodo, grazie alle rimesse degli immigrati o al fatto che questi facevano ritorno portando con sé il gruzzolo acquisito, non era raro che nei centri urbani di Lipari, Salina e Stromboli si vedessero fabbricati interamente rinnovati nei prospetti, nella strutturazione degli interni e nella funzionalità dei servizi. Nella disposizione degli ambienti, cucina e bagno cominciavano ad assumere un ruolo di importanza mai prima immaginato. Questo non voleva dire che la povertà fosse scomparsa; anzi risultava ancor più rilevante in larghe fasce della popolazione. Soddisfacente remunerazione ricevevano invece gli artigiani qualificati e i maestri muratori. Sino a tarda sera il centro di Lipari era animato dalle botteghe dei falegnami, fabbri, stagnari, scalpellini, sarti, calzolai e barbieri, mentre nei vicoli adiacenti si sfornava il pane e si discuteva nelle cantine.
La borghesia liparese nei confronti della religione
Nonostante che le classi scolastiche fossero differenziate per sesso, i genitori della piccola e media borghesia ostacolavano la frequenza delle loro figliole. E mentre i più abbienti provvedevano a loro spese all’insegnamento privato, si cominciò a parlare di un istituto di educazione ed istruzione per fanciulle, gestito dalle suore. Anzi già il 15 gennaio del 1864 gli amministratori avevano dichiarato di avere avviato contatti con le “Suore di carità dello stabilimento di Milano” ma le trattative risultarono infruttuose. Per avere le suore di Carità a Lipari bisognerà attendere il 1886[9].
Può sembrare incomprensibile questa iniziativa se non si entra nello spirito della società liparese di allora dove, come abbiamo visto, i massoni[10] avevano l’egemonia. E sebbene spesso i rapporti fra vescovo e comune fossero molto tesi – sia per le ragioni viste in ordine alle decime ed ai beni ecclesiastici sia per i terreni pomiciferi – la stessa borghesia esigeva la presenza della Chiesa nelle cerimonie importanti (nascite, matrimoni, funerali). Concepivano cioè – si direbbe oggi – la religione cattolica come “ religione civile”. Per questo il 17 aprile del 1866 il Consiglio Comunale poteva deliberare a maggioranza con 8 favorevoli e 4 astenuti che Sindaco e Giunta facessero quanto in loro potere per conservare a Lipari la Sede Vescovile. E passò addirittura all’unanimità la disposizione di rendere più agevole e comodo l’esercizio del culto visto che la Cattedrale, per via della presenza dei coatti e dei gendarmi, era impraticabile in particolare alle donne, le quali, costrette ad attraversare la zona maledetta, erano fatte oggetto di commenti sconci.
In molte altre occasioni invece i comportamenti della borghesia liparese e dello stesso Consiglio Comunale nei confronti dei vescovi e della Chiesa furono di scontro arrivando fino alla richiesta di allontanamento. Così fu – come vedremo - nei confronti di mons. Mariano Palermo[11] per l’interdetto di questo sul camposanto, nei confronti di mons. Giovanpietro Natoli[12] per lo scontro sul demanio comunale[13] e più tardi ancora nei confronti di mons. Nicolò Maria Audino, di mons. Francesco M.Raiti e infine – come avremo modo di dire - di mons. Angelo Paino.
Una borghesia aggressiva ed una chiesa sulla difensiva
Questo scontro più o meno esplicito, fino a manifestazioni clamorose, non aveva alla base però una questione di potere e di egemonia. Non c’era cioè nei Vescovi la volontà di riappropriarsi di quel ruolo detenuto fino al regno borbonico e che poi avevano perso. C’era piuttosto l’esigenza di sopravvivere giacché veramente le leggi cosiddette eversive avevano privati dell’essenziale il Vescovo e il clero.
“Ora io stanco di tutte queste traversie e da questa diuturna e tenace lotta, - scriveva a Pio IX mons. Ideo il 9 ottobre 1877 - e giacché mi mancano i mezzi idonei per la difesa delle decime, mi vedo costretto, almeno per il momento, a desistere ed a chiedere alla Santità Vostra ( lo dico con sommo mio dolore!) come io possa continuare privo come sono, ormai da sette anni, di ogni provento o beneficio!… Nutro poi un grande timore che , senza compenso alcuno [per il clero] e, per così dire, senza alcuna speranza di emolumenti per l’avvenire, si possa tirare avanti, specie se si osserva come l’obbedienza dei sacerdoti vada sensibilmente scemando”[14].
Ed il suo successore mons. Palermo doveva ben presto constatare che il Capitolo dei Canonici della Cattedrale si disgregava e si scioglieva giacché perdeva l’ultima sua piccola risorsa consistente nelle offerte di messe che provenivano da obblighi gravanti su beni immobili di cittadini privati[15], obblighi che la legge sullo “svincolo” aveva abolito. Venuto meno l’interesse economico il vescovo si appellava al sentimento religioso chiedendo ai canonici di non trascurare il servizio del coro. Un appello dello stesso tipo veniva rivolto ai fedeli chiedendo di provvedere spontaneamente ai bisogni della chiesa con nuovi sistemi e nuove tariffe.
Appelli che dovettero avere scarso successo, soprattutto a Lipari, perché “questo popolo – constatava il vescovo con amarezza - si attacca con i denti alla roba non sua e la vuole tutta per sé” e non mancavano “ avvocatuzzi, satelliti del Demonio, che inculcano e fomentano questa persecuzione”[16].
Proprio la vicenda delle decime evidenziava come la rottura tra la Chiesa e il popolo si fosse fatta profonda, e il povero vescovo trovava il suo campo tutto cosparso di triboli e spine.
L’interdetto sul cimitero

Il cimitero di Lipari
Oltre al problema dei mezzi di sussistenza economica i vescovi vivevano in quegli anni una particolare situazione di tensione perché si sentivano assediati dalla massoneria che direttamente o indirettamente influenzava l’amministrazione civica ed aveva incidenza anche sull’opinione pubblica. D’altronde anche le notizie che riguardavano la situazione nazionale non erano più rassicuranti. Nel luglio del 1881 a Roma la salma di Pio IX, mentre veniva traslata in San Lorenzo al Verano, subì un’aggressione da un gruppo di facinorosi che voleva gettarla nel Tevere E così poteva succedere che in un clima così esacerbato, ci si abbandonasse a qualche gesto inconsulto le cui ripercussioni non erano state ben considerate e che andavano ad accentuare le tensioni del vescovado non solo con la massoneria ma anche con il popolo. E’ questo il caso dell’interdetto sul nuovo cimitero di Lipari, inaugurato da soli sette anni, che arrivò all’interno di un urto frontale, a metà aprile del 1884, fra il vescovo e l’amministrazione civica.
Tutto ebbe inizio il 12 aprile quando a Vulcano morì la signora inglese Costance Emily, giovane moglie di Antony E. Narlian, fattore degli Stevenson che aveva sostituito il vecchio Picone . Fu richiesto un loculo dove seppellirla e il sindaco, don Emanuele Rossi, firmò l’autorizzazione senza pensare minimamente che la signora era protestante. La cosa non sfuggì invece a mons. Palermo che vide in questo atto una ennesima angheria dei massoni tesa ad umiliare la chiesa violando “l’ultima dimora dei cattolici” per avervi seppellito una persona che era “vissuta e morta Protestante”,ed il giorno stesso dell’inumazione, il 15 aprile, emette l’interdetto e dichiara dissacrato il Cimitero. Per conseguenza, a cascata, rimane interdetta la chiesa attigua al cimitero, in essa non potranno aver luogo più le funzioni funebri; i parenti dei defunti morti “nel bacio del Signore” potranno celebrare il funerale in altra chiesa e poi trasportarlo al cimitero, da questa chiesa però sino al cimitero il cadavere non doveva essere trasportato da nessun sacerdote, i morti che direttamente dalla loro abitazione saranno portati al cimitero potranno essere accompagnati da sacerdoti ma questi dovranno ritirarsi ad una certa distanza da esso; i sacerdoti che contravvenissero a quiete norme oltre che alle pene “fulminate dai Sacri Canoni in simili casi, resteranno ipso facto sospesi a divinis per quel tempo che Noi crederemo opportuno”.[17]
La decisione del vescovo provocò grave turbamento nella popolazione della città, non solo rinfocolò le polemiche da parte dei “laici” nei confronti del vescovo, ma anche la gente devota, considerando il disagio che provocava, giudicarono troppo rigido l’atteggiamento di mons. Palermo non solo ma si interrogavano dove poteva essere seppellita la povera signora inglese e comunque tendevano a scusare il Sindaco che non pensava assolutamente di provocare un simile tafferuglio. Le polemiche andarono avanti sulla stampa e fu pubblicato anche un libello con espressioni pesanti nei confronti del vescovo tanto che i rappresentanti di un Comitato chiamato “Verità, Onestà, Giustizia ed Ordine Pubblico” con a capo don Antonino Natoli sentirono il bisogno di esprimergli solidarietà sia per “la violenta guerra che pochi tristi fanno alle rendite, che formano il vitale sostegno del Vescovo e delle Chiese di tutta la Diocesi Liparese”, sia “contro le ree calunnie che, per farsi onta della Chiesa, ognor sacrilegamente anche con pubblica stampa sonosi lanciate su la sacra persona della E.V. Rev.ma, che è il nostro Pastore e Padre venerato”.[18]
Comunque al di là delle solidarietà formali la frattura fra popolo e vescovo era un fatto reale del quale forse il presule non si rendeva conto, tanto che non approfittò nemmeno del cambio del Sindaco al Comune quando nell’ottobre del 1886 venne eletto l’avv. Ferdinando Paino settimo figlio di don ‘Nofrio il pirata.
Era una situazione insostenibile per tutti e dovette essere probabilmente per cercare di dare ad essa una soluzione che la Santa Sede il 14 marzo del 1887 trasferì mons, Palermo alla diocesi di Piazza Armerina incaricandolo però anche dell’amministrazione apostolica di Lipari. Una mossa di prudenza diplomatica chefaceva preludere ad una soluzione.
E fu probabilmente perché assente in seguito a questo trasferimento che mons. Palermo non era a Lipari quando una mattina proprio del 1887(la data non è il 1887 ma il 1902 come si spiega nel documento in appendice al paragrafo) la regina Margherita sbarcò all’improvviso a Marina S. Giovanni per una breve visita all’isola. Ad accoglierla arrivarono, subito informati, il Sindaco, il vicario generale in rappresentanza del vescovo assente ed i carabinieri. E dopo una rapida visita al Municipio la regina volle visitare il Castello e la Cattedrale. Ed fu proprio mentre il piccolo corteo visitava la Cattedrale che si verificò un fatto destinato a rimanere nella memoria della regina e dei liparesi a cominciare dal Sindaco. Improvvisamente dalla porta della chiesa entra un gruppo di coatti che si dirige a passo lesto verso la regina. Vi è un momento di perplessità è di panico nel piccolo corteo. La regina sbianca in volto ma ecco che i relegati si inginocchiano di fronte a lei e le baciano il piede. In mano hanno una supplica. Ma è comunque tanto l’emozione che la regina vacilla e sarebbe forse scivolata a terra se il Sindaco non fosse stato pronto a sorreggerla e accompagnatala fuori dalla chiesa ed a farla adagiare sulla portantina vescovile che aveva accompagnato il corteo dalla Marina sino al Castello. Una rapida sosta a casa di don Ferdinando Paino per bere un bicchiere d’acqua e poi subito Margherita volle tornarsene a bordo per ripartire immediatamente.[19]
 Regina Margherita di Savoia
Regina Margherita di Savoia
Una soluzione per il cimitero
Malgrado la lontananza del vescovo il pensiero dei liparesi, e non certo con benevolenza, andava a lui ogni volta che c’era un funerale. E in quello scorcio di mesi funerali di spicco ce ne furono diversi perché il 27 aprile 1887 morì don Giovanni Canale, il 4 giugno 1887 fu la volta di don Filippo De Pasquale, il 26 febbraio 1888 toccò a donna Francesca Salpietro mamma del povero Policastro.
Ma il vicario can. Tommaso Paino aveva finalmente trovato una soluzione. Aveva fatto isolare con cancellata ed ingresso separato, l’angolo dove stava la sepoltura della signora Costanza dichiarandolo “terreno segregato per seppellirvi gli acattolici” . E così finalmente con decreto del 18 maggio 1888 mons. Palermo poteva revocare l’interdetto sul camposanto e quindi anche le sospensioni a divinis per i sacerdoti che avessero accompagnato i feretri nel camposanto e celebrato la funziona nella chiesetta dei cappuccini[20].
Intanto, a seguito all’effervescenza di Vulcano iniziata il 3 e 4 agosto 1888 mentre entrava in fase di quiescenza il cratere centrale si videro spuntare sull’arenile del porto di levante,nuove e più vivaci effusioni di acqua marina fangosa e bollente che investirono anche il palazzotto merlato che a poche decina di metri si era costruito lo Stevenson . Spaventato da questi fenomeni l’imprenditore decise di abbandonare baracche, calcaroni e palazzo e tornarsene alla sua Glasgow. Il 3 ottobre del 1903 il dott. Giuseppe Favaloro e i fratelli Conti acquistavano, assistiti dal notaio Bonucci, per 37 mila lire, tutta la proprietà immobilire e mobiliare degli eredi Stevenson sita nell’isola di Vulcano[21]

[1] Di Ospedali a Lipari nel XIX secolo ve n’erano due, il S.Bartolomeo a Marina lunga nei pressi dell’attuale chiesa di S.Maria di Portosalvo che era sorto nel XVII secolo per iniziativa di un privato e continuò a vivere con il sostegno della civica amministrazione ed uno femminile, l’Ospedale dell’Annunziata, che aveva sede al Pozzo ad angolo fra l'attuale via Vittorio Emanuele e l’attuale via Emanuele Carnevale ed era stato voluto nel 1782 dal Vescovo Mons. Giuseppe Coppola..
[2] Nel periodo precedente all’Unità, vi erano state, come abbiamo visto, scuole promosse dai vescovi. Erano però scuole a cui vi accedevano per lo più i figli del ceto borghese mentre le famiglie dei contadini e dei lavoratori le guardavano con diffidenza. Peraltro la borghesia per la prima istruzione ricorreva all’insegnamento privato e per gli studi superiori avviava i giovani alle scuole ed alle università di Napoli e Messina. (cfr. Giuseppe Iacolino, inedito, cit. Quaderno XI).
[3] Alla nascita questa società era presieduta dall’avv. Onofrio Carnevale e dal 1884 al 1891 dall’avv. Emanuele Carnevale.
[4] S. Salomone, Le province Siciliane, III, Provincia di Messina, Acireale 1888, pag. 95.
[5] C’era a Lipari la Tipografia Aliberti che fu rilevata ed ammodernata da Pasquale Conti di Malfa e trasferita da via Vittorio Emanuele a Via Maurolico; lo Stabilimento Tipografico Caserta e Favaloro, la Tipografia Carlo Accattatis in via Vittorio Emanuele, la Tipografia economica F.Amendola di Carlo con officina e cartoleria in via Garibaldi
[6] G. Arena, op, cit. pag. 51; : Arena, Politica ed economia nelle isole Eolie del tardo ottocento. Fonti giornalistiche a confronto, Messina 2006.
[7] Fra questi un libretto di don Ferdinando Maggiore (1865-1938) intitolato “Versi”.
[8] Giuseppe Iacolino, Inedito, Quaderno XI.
[9] Il 16 dicembre 1886 - dopo circa due anni di trattative tra il vescovo e la curia generalizia delle suore - giungevano a Lipari le prime tre monache, delle quali una, superiora e maestra patentata, era suor Luisa Mandalari. A questa si assegnava un compenso annuo di l. 600 e 550 ciascuna alle altre due. Le loro scuole parificate si dissero “ Scuole private vescovili”. Il concorso di fanciulle – e pure di maschietti – andò al di là del previsto. Dalle Suore di Carità si andava, non soltanto per frequentare la scuola vera e propria, ma anche per il catechismo domenicale, per l’apprendimento del cucito, del ricamo, della musica. (cfr Giuseppe Iacolino, inedito Quaderno XI).
[10] In consonanza con quanto avveniva in Italia con la forte espansione di ideologie laiche e spesso anticlericali, nell’ambito della Città di Lipari fece buona presa l’attività della locale sezione della loggia massonica del Grande Oriente che si era inaugurata nel 1864. Probabilmente fu dovuto alla iniziativa di questi “ fratelli” se in Lipari si crearono movimenti di solidarietà fra i lavoratori e fra i piccoli borghesi ( società operaia di mutuo soccorso sussidiata dal Municipio per il mantenimento di una scuola elementare serale per i figli dei soci, società cooperativa per gli esercenti di arti e mestieri). Per il resto, i massoni, qui, si dedicavano ad una critica spicciola e corrosiva verso la Chiesa e il clero, ostentando, pur nella correttezza apparente dei comportamenti, spregiudicatezza paganeggiante nella condotta di vita e stoica degnazione nell’accettare l’ineluttabilità del mistero della morte. Coloro che ebbero potere al Comune riuscirono perfino a far bandire dallo stemma civico la tradizionale immagine del protettore S. Bartolomeo. Su molte tombe della buona borghesia facevano spicco le simbologie massoniche mentre erano rarissimi i simboli cristiani. I servizi religiosi erano comunque richiesti, anche da parte dei non credenti, ed era palese il tentativo di strumentalizzare i riti sacri ai fini puramente mondani dello sfarzo in occasione di battesimi, di nozze, e di funerali. Cfr. Giuseppe Iacolino, inedito., Quaderno XI.
[11] Mons. Mariano Palermo era nato a Maletto in provincia di Catania il 17 dicembre 1825. Venne eletto vescovo di Lipari il 13 maggio del 1881 all’età di cinquantasei anni. Prese possesso della diocesi il 12 giugno successivo. Con ogni probabilità gli fu impedito di prendere possesso del Palazzo vescovile come accadde a diversi vescovi italiani in quel periodo perché la legge detta delle Guarentigie pretendeva – per potere accedere ai benefici ed ai vescovadi – le nomine dei vescovi fossero sottoposte a exequatur (gradimento) del ministero italiano del culto mentre la S. Sede aveva dato precise disposizioni in contrario. Così mons. Palermo dovette stabilirsi in Seminario. E’ una situazione di disagio che durerà fino al 1883 quando il papa prenderà una posizione più prudente. Il 4 marzo del 1887 mons. Palermo viene trasferito a Piazza Armerina dove reggerà la diocesi sino al 1903. Rimarrà Amministratore apostolico di Lipari fino a quando il 15 giugno del 1888 viene nominato a questo ruolo il canonico Giovanpietro Natoli.
[12] Il canonico Giovanbattista Natoli era nato a Lipari il 17 aprile del 1829. Il padre, don Giuseppe, era stato sindaco dal1828 al 1832, la mare era una La Rosa., il fratello era quel don Antonino Natoli che abbiamo già incontrato. Probabilmente la scelta sul can. Natoli cadde perché dalla Santa Sede si cercava una persona che per vincoli di sangue e affinità avesse buoni rapporti con la classe dirigente dell’arcipelago e quindi potesse aiutare a superare la grave situazione di contrapposizione.. Il can. Natoli fu Amministratore apostolico dal 1988 al 1990. Il 23 giugno del 1890 venne nominato vescovo di Lipari. Fra le sue iniziative l’editto del 4 gennaio 1891,da leggere e commentare in tutta la diocesi nel giorno dell’Epifania , sulla “liberazione della schiavitù degli Africani” e la particolare attenzione dedicata alla evangelizzazione dei coatti tenuti “circoscritti per migliorarli e convertirli al bene”.( Da una lettera di mons. Natoli del 6 novembre 1895 in Avv. A. Natoli La Rosa, Sul beneficio Vescovile di Lipari e sue rivendicazioni , Note rischi arative, Messina 1896, pp.33, Archivio Vescovile, Bull. Vol. IV ff 64-65). Mons. Natoli introduce una nuova festa di S. Bartolomeo, quella del 16 novembre per lo scampato pericolo del terremoto e così le feste diventano quattro. Mons. Natoli morì il 27 gennaio 1898.
[13] Giuseppe Iacolino, inedito, Quaderno X. Il sindaco avv. Onofrio Carnevale propose al Consiglio di Comunale il 27 ottobre 1893, di chiedere ai ministri di grazia e Giustizia e dei culti ed al ministro dell’Interno di adoperasi per la rimozione del Vescovo Natoli da quest’Isola ed in ogni caso che gli fosse tolto il Regio Exquator e questo perché “egli non trovasi all’altezza della propria missione, giacché, invece di essere elemento di pace e di carità cristiana, è causa di perturbamento morale e civile”.
[14] Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff.246 e 243 v. ; G. Iacolino, indedito cit., Quaderno IX, p.241 b. Malgrado Mons. Ideo lamentasse la situazione di indigenza in cui era caduta la diocesi alla sua morte lasciò in eredità di L.100 mila in titoli , con l’interesse annuo di L. 5000, per la costruzione della Cattedrale o in alternativa , se non fosse stato possibile, il seminario e altre indicazioni che crearono qualche conflitto fra i successori del vescovo e le suore di Carità che erano a Lipari. A questa contraddizione faceva riferimento polemicamente l’opuscolo “A S.E. Mons. Nicolò Maria Audino Vescovo di Lipari – Breve risposta del Popolo di Salina alla Lettera Pastorale del Vescovo di Lipari del 24 ottobre 1899, Lipari 1900. Comunque anche il suo successore mons. Palermo trovava il fatto “sorprendente” (Archivio Stato Vaticano, Cass. 456 B, f.258 v).
[15] Si tratta dell’obbligo di stornare una percentuale dei redditi della terra per la celebrazione dei suffragi.
[16] G. Iacolino, inedito cit., Quaderno IX. Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, f. 261.
[17] Archivio Vescovile, Bullario vol. IV, f.50.
[18] “Sua Eccellenza Rev.ma Mons. D. Mariano Palermo Vescovo e i Cittadini Liparesi, op.cit, pp3-4.
[19] Don Ferdinando Paino fu sindaco di Lipari fino al dicembre 1887 ma verrà rieletto nel biennio 1897-99.La visita della regina fece guadagnare a don Ferdinando la commenda di Cavaliere ufficiale della Corona d’Italia. Ma soprattutto gli permise di vantasi tutta la vita di avere ospitato a casa sua la regina anche se per un breve momento.
[20] Archivio vescovile, Bull. Vol.IV f. 58.
[21] G.Iacolino, inedito.cit. Quaderno XI, pag. 518.
can. Tommasom PainoIl nodo del patrimonio ecclesiastico
Il problema delle decime
Abbiamo già visto come le rivendicazioni dei salinari, prima ancora che sul tema dell’autonomia, fossero focalizzate sul problema della proprietà delle terre e sui censi e le decime che dovevano pagare alla mensa vescovile e dai quali cercavano di affrancarsi. Questa iniziativa è parte di un problema più generale. Col cessare del regno borbonico e l’affermarsi dell’unità d’Italia e del governo liberale si realizzava nella società liparese un cambio di egemonia. Se prima era stato il vescovado che aveva potuto continuare a godere, per la particolare collocazione geografica delle isole e per la loro storia , di una serie di privilegi di origine feudale ( il regime dei censi e delle decime) che la Chiesa non aveva più, almeno in questa misura, in altre parti del Paese ora, con tutta una serie di provvedimenti – che in qualche modo si erano avviati già nel periodo borbonico - si ha un forte ridimensionamento delle risorse e quindi delle funzioni che fanno deperire il ruolo del vescovado e della chiesa locale e crescere, invece, l’istituto municipale.
Cerchiamo di vedere come entrano in crisi le risorse della chiesa liparese. L’iniziativa contro il patrimonio ecclesiastico ed i cespiti della mensa vescovile che gli amministratori comunali liparesi avviano nei primi anni dopo l’unità d’Italia, ha due motivazioni di fondo: la prima è la situazione critica delle entrate del comune che non permettono di mettere mano ai mille bisogni che vengono sempre più avvertiti dalla popolazione ( l’istruzione, le strade, le risorse idriche,ecc.); la seconda è tutta ideologica e riguarda un sentimento anticlericale, per molti aspetti ispirato alla massoneria ma che ha sempre serpeggiato nell’animo della borghesia eoliana anche indotto dalle rivendicazioni della mensa vescovili sui terreni se non addirittura sulle isole nel loro complesso.
 Francesco De Mauro, importante esponente della massoneria eoliana
Francesco De Mauro, importante esponente della massoneria eoliana
Ora questo sentimento si rafforza sull’onda dell’impresa garibaldina visto che proprio Garibaldi veniva proclamato Gran Maestro della massoneria siciliana. Così, nel 1864, anche a Lipari nasce una loggia massonica promossa dall’alta borghesia che si chiamò “Eolia” e che – con buona pace di mons. Ideo[1] - doveva contare diversi esponenti. Ispiratore di questa battaglia ad un tempo ideologica e civile era un personaggio di grande rilievo, quel don Filippo De Pasquale che abbiamo già incontrato come sindaco di Lipari, membro del parlamento siciliano rivoluzionario del 1848, vicino a Garibaldi nella presa di Palermo, amministratore fiduciario del dittatore dei beni della Real Casa. Don Filippo conosceva bene il problema delle decime perché vi aveva dedicato un opuscoletto nel 1842 mettendo a frutto l’esperienza ed i problemi che aveva incontrato quando era stato sindaco la prima volta nel triennio 1837-1840, inoltre non gli mancavano amichevoli rapporti con parlamentari liberali e sapeva bene che il governo stava già pensando a requisire i beni ecclesiastici.
Il 10 agosto del 1862 il parlamento aveva emanato una legge che prevedeva l’enfiteusi forzosa redimibile dei beni fondiari ecclesiastici in Sicilia mentre con legge del 19 maggio 1664 – che era stata preceduta da un decreto di Garibaldi del 1860 - veniva disposta la conversione in denaro delle decime prediali che prima si versavano al vescovo in natura. L’1 agosto 1863 l’ufficio demanio e tasse di Messina, comunicava al Comune di Lipari di avere accolto la richiesta di intestargli, nei registri catastali, 258 salme di terreno vescovile di Vulcano.
Più complesso fu il discorso delle decime. Nell’aprile del 1866 il vescovo, scrivendo al prefetto di Messina, denunciava – alludendo alla seduta consiliare del 4 aprile - che il comune aveva già deliberato e dichiarato soppresse le decime dovute al vescovado e ne aveva chiesto l’omologazione al governo[2]. Effettivamente dal 1866 in poi di decime se ne versarono sempre meno e si esaurirono, praticamente, nel 1870 ma questo non fu solo effetto delle decisioni del governo e del comune ma anche a causa di inadempienze della mensa vescovile.
La questione nasceva dal particolare sistema di esazione che vigeva nelle Eolie che non era quello in vigore in tutta la Sicilia ma uno più arcaico. In Sicilia, all’atto della riscossione, gli importi in  natura o in denaro, venivano annotati a fianco ai fondi di provenienza ed ai relativi produttori e così era facile verificare la produttività di ciascun podere. A Lipari invece le decime venivano riscosse in natura e portati sulla spiaggia nelle varie isole dove il gabelliere, che attendeva per caricarle sulla barca, non annotava né il fondo di provenienza, né il proprietario ma valutava sulla base della conoscenza e dell’esperienza se la raccolta era soddisfacente. Tutt’al più ci poteva essere una qualche contrattazione che si concludeva, eventualmente, con un nuovo conferimento. Proprio questo speciale sistema legato proprio ai problemi dell’insularità aveva richiesto una leggina specifica per le Eolie nel 1836 che adeguasse la legge del 1833.
natura o in denaro, venivano annotati a fianco ai fondi di provenienza ed ai relativi produttori e così era facile verificare la produttività di ciascun podere. A Lipari invece le decime venivano riscosse in natura e portati sulla spiaggia nelle varie isole dove il gabelliere, che attendeva per caricarle sulla barca, non annotava né il fondo di provenienza, né il proprietario ma valutava sulla base della conoscenza e dell’esperienza se la raccolta era soddisfacente. Tutt’al più ci poteva essere una qualche contrattazione che si concludeva, eventualmente, con un nuovo conferimento. Proprio questo speciale sistema legato proprio ai problemi dell’insularità aveva richiesto una leggina specifica per le Eolie nel 1836 che adeguasse la legge del 1833.
Decime prediali e decime sacramentali
Il discorso era ancora più complicato dal fatto che le decime erano di due tipi: quelle prediali (dette anche enfiteutiche o dominicali) che erano dovute al signore – nelle Eolie il vescovo - in quanto proprietario del terreno e le decime sacramentali che erano il corrispettivo dell’amministrazione dei sacramenti e di altri servizi spirituali. Le decime sacramentali erano state soppresse già dai Borboni il 25 luglio 1772 ma in molte parti della Sicilia quel decreto non si era applicato anche perché, spesso, come nelle Eolie, non era facile distinguere fra decime prediali e sacramentali. Garibaldi il 4 ottobre del 1860 aboliva in Sicilia le decime sacramentali e ordinava la conversione in denaro delle decime prediali il cui ammontare doveva effettuarsi su parametri prevalentemente calcolati per ciascun fondo e ciascun debitore. Questa normativa venne reiterata con legge del 19 maggio del 1864. Ma perché la conversione avesse luogo - e così si chiarisse se la decima sussisteva o meno - bisognava che l’avente diritto, il vescovo nel caso delle Eolie, presentasse alla Commissione enfiteutica della provincia l’elenco dei debitori con i titoli e la descrizione dei fondi, nonché l’ammontare delle decime da ciascun debitore pagate negli ultimi vent’anni .
Visto il sistema di esazione vigente nelle Eolie si trattava di un lavoro praticamente impossibile. “Subito e nel miglior modo che potei – commenta lo stesso mons. Ideo -, preparai quell’elenco, che non era né perfetto né completo, e neanche lo presentai entro il termine fissato di quattro mesi”.
Naturalmente l’elenco non venne accettato e il pagamento delle decime venne sospeso sia dalla Commissione che dai Giudici del Tribunale civile. Mons Ideo si vide costretto quindi a rifare con pazienza e più cura l’elenco dei terreni e dei proprietari. “Fu necessario, con grandi spese e fatiche, sfogliare tutti i volumi della fondiaria e ricavare i nominativi dei debitori e i confini dei fondi”. Concluso il lavoro il vescovo le inviò alla Commissione e questa volta – non sappiamo con quali mezzi o espedienti – la relazione venne accolta. Ma dovettero passare quattro anni perché fossero trasmesse alla Commissione provinciale e si procedesse alla conversione delle decime.
Ma a questo punto scattano i ricorsi che soprattutto miravano a sostenere che non di decime prediali si trattava ma di decime sacramentali e quindi abrogate. Ascoltiamo ancora il vescovo: “Una volta pubblicate le dette liste dalla Commissione, la maggior parte dei debitori, istigata dai soliti nemici della Mensa, reclamò innanzi alla predetta Commissione Enfiteutica impugnando e la natura delle decime e l’entità degli oneri che risultavano dalle liste e che, a loro dire, erano esorbitanti”. A questo punto comincia la battaglia legale che è anche dibattito pubblico perché oltre che nei tribunali si svolge nell’opinione pubblica con la stampa di libretti. Cominciano gli avvocati dei ricorrenti che sostenevano il principio della soppressione definitiva delle decime. Il vescovo fa “stilare da colti e rinomati giureconsulti di Palermo” ben tre libretti per ribattere. Finalmente dopo varie deliberazioni la Commissione dichiarò le dicime prediali.

Mons. Ideo
Ma la battaglia di mons.Ideo non è finita. C’è un nuovo impedimento. I ricorrenti chiedono che si esaminino le differenze fra la prima e la seconda lista presentata dal vescovo. Un lavoro per un perito ed un contabile che dovrebbero andare in giro per le isole. La Commissione accoglie la richiesta e stabilisce che l’accertamento deve farsi a carico del vescovo.
“Ci sarebbe stato da impiegare – osserva mons. Ideo – molte migliaia di lire, una spesa che io non sono in grado di sostenere. Questo espediente fu trovato dagli avversari per prendere tempo e per porre sul Beneficio Vescovile una pietra tombale che fa loro comodo, ma che rappresenta un’ingiustizia.[3]”.
Ed è su questa base che il Consiglio comunale il 4 aprile 1866 emana la deliberazione soppressiva delle decime. Ma già l’anno prima nel Consiglio del 17 aprile, il Sindaco, precorrendo i tempi, e fondandosi su voci che circolavano, dichiara che nel caso in cui fossero soppresse le congregazioni religiose sarebbe stato utile chiedere al governo di destinare ad uso di cimitero l’orto del convento dei cappuccini mentre la chiesa poteva essere adibita a chiesa del cimitero ed il convento a casa dei custodi; inoltre, per quanto riguardava il seminario, questo doveva essere destinato alla pubblica istruzione. E su entrambe le proposte il Consiglio vota all’unanimità.
Non passano che pochi mesi ed il 7 luglio del 1866 il governo – premuto anche dai problemi finanziari che la prossima guerra contro l’Austria, la terza guerra di indipendenza, poneva – approva la prima legge eversiva “Sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull’asse ecclesiastico”, un anno dopo, il 15 agosto 1867, veniva promulgata la seconda legge “per la liquidazione dell’asse ecclesiastico”.


La legge sulla proprietà ecclesiastica
La prima oltre a sopprimere tutti gli ordini e le corporazioni religiose procedeva all’incameramento dei loro beni da parte del demanio con la facoltà di alienarli a favore dei privati. Una quarta parte di questi immobili poteva essere ceduta ai Comuni. Gli immobili che non fossero edifici monumentali o di particolare pregio dovevano essere adibiti a scuole, a caserme o ad altri servizi ed opere di beneficenza. Non venivano incamerati, se erano in esercizio, gli episcopi, le canoniche ed i seminari.
La seconda legge sopprimeva enti del clero come i capitoli e trasferiva i loro beni al demanio. Era però consentito che i capitoli delle cattedrali potessero sussistere se fossero stati ridotti di numero. Cosa che fecero i canonici di Lipari[4].
A Lipari i due conventi vennero chiusi ed i frati rinviati tutti alle loro case. E siccome si era saputo che al convento dei minori sulla Civita erano interessati i Carabinieri il sindaco, don Angelo Florio Paino, riunì il Consiglio comunale – il 28 novembre 1866 – proponendo di chiedere al governo, come era stato stabilito, il caseggiato dell’ex convento dei cappuccini con l’orto per adibirlo a cimitero e asilo di mendicità mentre il convento di sopra la Civita doveva essere destinato a scuola comunale e asilo infantile. E così nel 1867 Lipari ebbe il suo cimitero e la scuola tecnica sopra la civita. Nel 1867 era sindaco Giuseppe Maggiore che però scompare dalla scena politica dal 19 agosto di quell’anno fino al 24 dicembre 1869 e le funzioni di sindaco le svolgerà don Filippo De Pasquale. E sarà lui a tenere le relazioni con il vescovado e si deve a lui se fu consentito ancora di culto nelle due chiese conventuali incamerate e ai frati cappuccini, che lo volessero, di tornare ad occupare una porzione del convento con l’incarico di custodi “morali” del cimitero. E quattro o cinque di essi acconsentirono. Non poté essere però concesso il rientro dei frati minori perché il loro convento era stato adibito a scuola[5].

L'ambito convento dei "minori " sulla Civita.
Oltre al Comune anche il governo aveva mire sulla proprietà ecclesiastica visto che i relegati aumentavano. Al Castello oltre a molte case private abbandonate erano state requisite la chiesa di S. Caterina e il vecchio Palazzo vescovile che era stato trasformato in “ospedaletto”. Ora si sollecitava il passaggio della chiesa di S. Maria delli Bianchi, che era quasi di rimpetto alla chiesa di S, Caterina, e la chiesa dei SS. Giovanni e Nicolò, vicinissima alla chiesa delle Grazie che si voleva destinare ad infermeria. Il 30 luglio 1866 il vescovo rispondeva che entrambe erano già in possesso dei coatti. Rimangono come chiese, e sono tutte attive, concludeva mons. Ideo, la Cattedrale, la Concezione, l’Addolorata e le Grazie.[6]
Quello che rimaneva dei beni ancora disponibili della Chiesa e delle singole cappellanie eoliane venne ceduto all’asta. L’operazione favorì la concentrazione dei poderi nelle mani dei più ricchi. A Lipari e Stromboli, don Onofrio Paino e i suoi figli figurarono fra i maggiori acquirenti[7]. Non rientrarono nel lotto d’asta le terre boscose, aride ed improduttive e quindi anche le terre pomicifere[8] di Lipari su cui l’Amministrazione civica vantava un esclusivo diritto mentre il vescovo riteneva di essere lui il proprietario. E questa, come vedremo sarà oggetto di un’altra lunga e dura controversia liparitana.
In proprietà della Mensa vescovile rimasero i pochi ettari di vigneto e giardino che circondavano il palazzo vescovile nonchè le inflazionatissime quote censuali che i vecchi enfiteuti continuarono a corrispondere fin quasi al 1935.

[1] Nel 1874 Mons. Ideo scriveva al S.Padre: “Da qualche anno a questa parte ho più volte umilmente denunciato che gli abitanti di queste isole, fuorviati da pochi astutissimi nemici della Chiesa, si siano rifiutati di corrispondere a questa Mensa Vescovile le decime dei frutti che da tempo immemorabile le si versavano e che, in questa Diocesi, costituiscono la principale la principale entrata per il mantenimento del culto divino e del capitolo, per elemosine dei poveri e per il sostentamento del beneficio vescovile” .Archivio Vescovile, Corri. Carpetta E.
[2] Archivio vescovile, Corrispondenza, carp, H , in un volume manoscritto al n.50.
[3] Lea posizione e le considerazioni del vescovo sono tratte dalla “Relatio ad Limina” di mons. Ideo del 9 ottobre 1877, in Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff 243-2489.
[4] I capitoli erano già stati colpiti dal decreto luogotenenziale generale per le Due Sicilie del 17 febbraio 1861 che venivano privati dei loro beni immobili costituiti da lasciti per messe e celebrazioni particolari a meno che non avessero ceduto allo stato un terzo del valore dei beni in questione. Così fecero i nostri canonici che però per risparmiare sull’aliquota rivelarono i loro beni per un ammontare molto inferiore a quello reale. Ora con la legge del 1867 i beni venivano interamente incamerati ma si dava facoltà agli enti titolari di beneficiare da parte dello Stato di una rendita in denaro commisurata al valore dei beni medesimi. I canonici di Lipari accettarono questa soluzione e, dopo nove anni di liti e controversie, si videro attribuita la rendita di l.800, commisurata sulla base di quanto essi stessi avevano dichiarato nel 1862, mentre in effetti nel ’62 la rendita ascendeva a L. 2000. Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff. 243v-244. Si veda G. Iacolino, inedito, cit., Quaderno VIII, pp. 298 a-b. Il nostro capitolo perduto l’appannaggio che gli proveniva dalla mensa e da buona parte delle rendite patrimoniali poteva contare solo sulle offerte delle messe e così fra i canonici cominciò a serpeggiare un crescente malumore che non tardò a sfociare in rinunzie e defezioni.
[5] Complessivamente rimasero dispersi quindici monaci e giacché erano tutti nativi dell’isola tornarono alle loro case, alcuni passando ai ranghi del clero diocesano.
[6] Archivio Vescovile, Corrisp. Carp. H, in un manoscritto al n. 66.
[7] AA.VV, Storia della Sicilia, Napoli 1977, vol.IX, pp.210-214; V. Palumbo in “scritti in onore dell’Istituto tecnico ‘Antonio M.Jaci ‘ di Messina”, Messina 1982, vol.I, pag.7
[8] Le terre pomicidere erano quelle “nelle contrade Pilato, Monte Pilato, Russo Rocche Castagne, Grotta delle Mosche, Acquacalda, Possa Castagna, Serro, Uocche Rosse, Chirica, Altapecora, Serro della Chirica, Monte Bianco, Porticello ed altre denominazioni”R. Corte d’Appello di Messina, Comparsa conclusionale per S.E. Mons. Angelo Paino, vescovo di Lipari, contro il Sindaco di Lipari, p.2, opuscolo a stampa senza luogo e data emissione.
Mons. Ideo.La vita nelle contrade e nelle campagne
La serena ed operosa vita dei casolari

Se la vita a Lipari poteva apparire vivace e qualche volta caotica non priva persino di rischi sia per interessi, sia per le passioni sia anche per la presenza della colonia coatta, ben diversa era, in genere, la vita nelle campagne.
Una casa di contadini, era allora una finestra aperta su tutta una serie di attività a cominciare dalla cura dei campi lungo il cambiare delle stagioni. Un evento che si ripeteva ogni anno era la pigiatura del vino che avveniva nel palmento, un grande magazzino addossato all'abitazione. Si cominciava di notte con gli uomini che lavoravano a giornata per la vendemmia, che portavano sulle spalle le ceste d'uva, ne versavano il contenuto nella vasca grande che era stata bel pulita e lavata. Quando la vasca era sufficientemente piena, cominciava la pigiatura. Gli uomini, ma a volte anche le donne, pestavano l'uva con i piedi come in una specie di danza antica cantando vecchie canzoni mentre il mosto colava nella vasca inferiore attraverso la canaletta a cui era appeso un canestro che fungeva da filtro. Poi, terminata la pigiatura, il mosto veniva lasciato fermentare per un giorno o due e nessuno doveva entrare nel palmento perché, si diceva, era pericoloso. I fumi del vino potevano anche tramortire e, a questo proposito, le donne e gli uomini che partecipavano alla lavorazione raccontavano storie antiche.


Sopra, la cernita del grano o dei legumi con "u crivu". Sotto, "u parmientu" dove l'uva diventa vino.
Di grande interesse era anche la spremitura delle olive per ottenere l'olio che si faceva in un altro magazzino chiamato frantoio (trappitu) dove al centro c'era una grande mola rotante posta su una vasca circolare di pietra. Al centro della mola era innestato un travetto di ferro che serviva a farla girare, azionata da due o tre persone, spesso uomini robusti, ma, a volte, anche donne che spingendo il travetto giravano intorno alla vasca circolare. La mola, girando, frantumava le olive fino a farle divenire una poltiglia. Quando questa era divenuta omogenea veniva raccolta con un grande cucchiaio di legno e messa dentro delle sporte circolari di corda che erano poste nel torchio, una sovrapposta alle altre. La pila di sporte veniva compressa dal torchio che ne faceva colare l'olio. Dopo la prima spremitura l'olio veniva raccolto e rappresentava quello migliore. Quindi le sporte venivano bagnate con acqua bollente e continuava la spremitura. L'olio, più leggero dell'acqua, saliva a galla e lo si raccoglieva con un mestolo piatto facendo bene attenzione a non raccogliere anche l'acqua. Si aveva così un olio di seconda qualità, meno pregiato ma pur sempre utile per la cucina ed altri usi domestici. La pasta che rimaneva dopo aver spremuto l'olio veniva raccolta e serviva come mangime per gli animali da cortile o come materiale per riscaldare il forno. Anche l'acqua che avanzava dopo aver scremato l'olio veniva utilizzata nella produzione del sapone[1].

La macina per schiacciare le olive e produrre la sansa da cui, per spremitura, si ottiene l'olio.
La spremitura delle olive come la pigiatura dell'uva rappresentava una grande festa per la famiglia, a cui partecipavano anche i bambini.. La vinificazione e la preparazione dell'olio rappresentavano momenti importanti ma anche eccezionali, e per i bambini erano piuttosto momenti di festa e di svago. Il periodo dei giochi era piuttosto limitato e breve in una famiglia contadina quando c'erano bambini piccoli da accudire..
Il ruolo della donna

Un gruppo di donne impegnate nella raccolta dei capperi.
Abbiamo detto che la donna aveva un ruolo particolare nella casa eoliana era lei che la governava e dava i tempi . La casa[2] e qualche volta anche la campagna, perchè toccava a lei sovraintendere alle raccoglitrici che venivano assunte a giornata per la raccolta e la cernitura dei capperi e degli ulivi e quando era il momento della vendemmia, della mietitura, e della raccolta doveva curarsi degli uomini che lavoravano perché avessero l'acqua, il cibo, il vino. C'era poi ogni giorno da raccogliere la frutta per la tavola. Inoltre il periodo della raccolta coincideva con l’aumento del lavoro in casa perché si facevano le conserve, le bottiglie della salsa, i pomidoro secchi, le scocche, le pinnule, le olive in salamoia e il vinocotto e la passolina, fondamentali per i dolci. E poi c'era l'orto da curare, gli animali domestici – galline, pecore, capre – da accudire. Certo non mancava il lavoro in casa, le pulizie, il rammendo, gli abiti e le camice da stirare, qualche ricamo, qualche lavoro di taglio e cucito e poi bisognava accudire ai bambini più piccoli.


In campagna "u bagghiu" era il vero cuore della casa e spesso in un angolo vi erano il forno, il piano di cottura, la cisterna e le pile per lavare. Sotto, un posto cottura detto "u cufularu".
Ma anche i lavori domestici avevano i loro riti, i momenti magici. Come quello della lavorazione del pane che avveniva almeno due volte la settimana . Appena alzati, si accendeva il focolare e si metteva sul fuoco la pentola con l’acqua, si usciva dalla cassa del pane un pezzo di pasta lievitata ( u lievitu) messo da parte la volta precedente, conservato in un piatto di terracotta con un poco d’olio e coperto da un panno pulito. Ci si faceva il segno della croce, perchè il pane rappresentava la grazia di Dio, e si iniziava quindi a setacciare con il crivo la farina nella marta di legno che stava poggiata su dei trispiti, poi si continuava impastando la farina con l'acqua calda e con la pasta lievitata. Una volta che l'impasto era stato ben lavorato, si passava sullo scannaturi e lo si tagliava con la paletta, disegnando le pagnotte che venivano messe fra due coperte per agevolarne la lievitazione. Mentre le pagnotte lievitavano, si accendeva il forno e quando il pane era pronto, lo si infornava. Una volta cotto, si usciva dal forno, si avvolgeva in teli di cotone e lo si poneva nella cassa del pane perché non si seccasse.
Un appassionato elogio dell’indole degli abitanti delle isole e dei villaggi ed in particolare delle donne eoliane è quello che scrive un professore di scienze botaniche, Mario Lojacono,che visitò le isole nell’aprile del 1878.

Le donne eoliane non si limitano ai lavori domestici ed a quelli nelle campagne. Le troviamo nella lavorazione della pomice ed anche a pescare. Ecco una immaggine di "donne di mare"
“Alle Eolie – scrive l’assistente del Regio Orto Botanico di Palermo – non è l’uomo solo che lavora, lavorano le donne e sono le più perfette contadine, eseguiscono i lavori i più virili; zappano, fanno tutto quel che richiede la cultura la più ragionata alla loro vigna; ogni cura del raccolto dei capperi, delle uve, della passolina è la loro. A Panaria le donne remano sulle loro barchette, e vanno alla pesca; a Lipari ( ed è doloroso il dirlo) le giovanette ancora tenere portano sul dorso i gravi carichi di pietre pomici che dal pelato e dal Campo Bianco, cioè a dire da un’altezza di più di 300 m., scendono al villaggetto di Canneto che ne è il caricatore.
L’attività del loro corpo giova al loro morale, vanno sole per tutta l’isola svelte ed allegre, a pie’ scalzi sempre, e ciò non é segno, come si potrebbe credere, di estrema miseria, sembra fosse uso consigliato po dalla natura dei terreni o dal clima stesso. Non fuggono il forestiere, tutt’altro gli si mostrano amabili, se questi loro rivolge la parola, rispondono gentilmente, procurano essergli utili. Lo guardano con estrema curiosità, tanto è nuovo per loro lo spettacolo di un signore che giri pei loro monti, ma tutto ciò con disinvoltura senza quell’aria di sfiducia e di estrema suscettibilità a cui vanno soggette quelle di Sicilia e di altrove.
L'asino, "a scecca" era il compagno indispensabile per il contadino eoliano.
L’ingenuità, e credo di non errare, è la loro forza: quante belle giovanette dalle mosse eleganti, dalle vesti variopinte, e dal rosso fazzoletto sul capo come pittorescamente si addobbano le donne delle Eolie per li avvallati sentieri vedevo scorrere agili, e per i boschetti di eriche e cisti balzare fiduciose in quelle solitudini come se fossero accanto alle loro mamme. Di una fiducia che non può ispirare che il candore dei costumi che io chiamerei patriarcali. A Salina le donne non faceansi scrupolo alcuno di mostrar la maggior parte delle loro gambe quando sulla riva fanno il loro bucato; i non saprei dire se questi usi che da noi non esistono sono l’estremo dell’impudicizia o la massima innocenza! E’ sempre al lavoro che devesi attribuire la bontà d’animo di quelle popolazioni. Da noi la donna, limitata fra le quattro mura, poltrisce e spesso è cattiva.
Le statistiche provano quel che io ho asserito: gli attentati alla proprietà, i reati di sangue, poi, sono sconosciuti, e non rammento in quale Isola[3] mi si dicea che da un ventennio non si contava un delitto! E l’argomento ha una prova nel vedere i 3000 abitanti di Stromboli, i 600 di Panaria, i 2000 di Filicudi, i 600 di Alicuri amministrati politicamente e spiritualmente da Curati, senza che si risentisse il bisogno della vigilanza del carabiniere o d’ogni altro genere di forza che in quell’Isole benedette è sconosciuta. Per chi come me proveniva da contrate [del palermitano]che soggiacciono all’incubo fatale di un tremendo brigantaggio, l’andare per quei luoghi tranquilli era un piacere insolito. Potrei citare i più bei tratti della loro più larga ospitalità..”[4]

Fra le attivatà di cura delle donne vi è anche l'assistenza degli anziani.
[1] I procedimenti della lavorazione del vino e della spremitura delle olive sono tratte da Sergio Todesco, Aspetti della cultura tradizionale eoliana, pagg 179-195, in Atlante, cfr. F. Fanciullo, Dialetto e cultura materiale nelle Isole Eolie, Palermo, 1983.
[2] Le informazioni sulla vita delle donne contadine eoliane e sulle attività domestiche come la lavorazione del pane sono tratte da Agata Licciardello – Universo femminile e ambiente domestico - in Atlante pag.229-240.
[3] Non certo Lipari dove meno di vent’anni prima vi erano stati tre delitti nello stesso giorno ed altri se ne avevano avuti, come abbiamo visto, qualche anno prima.
[4] M. Lojiacono, Le Isole Eolie e la loro vegetazione, Plaermo 1878, pp. 15-19.
La lavorazione del pane
La colonia coatta e la situazione igienico-sanitaria
Un grave problema: a situazione igienico-sanitaria

Ma se la situazione dei servizi e delle infrastrutture mostrava qualche segno di progresso, quella sociale e morale era sempre più a livello drammatico e questo in particolare per la diffusione di numerose malattie provocate dalla povertà e dalle condizioni igieniche a cui si aggiungeva l'effetto della presenza dei coatti.
La tisi e il vaiolo erano le piaghe dell’epoca. Nei confronti di codeste infermità – ribelli ad ogni terapia, malgrado fosse diffusa la pratica dell’innesto del vaiolo – c’era soltanto la paura ossessionante di venirne sorpresi. Una volta colpiti, gli infelici si rassegnavano e si isolavano in remoti casolari per contare in solitudine i giorni dell’agonia. Il minimo di sussistenza veniva garantito dai parenti che gettavano loro le cibarie da lontano, come si fa con i cani sconosciuti o rognosi.. Di questa triste situazione, osserva Iacolino , non esistono documenti diretti se non le annotazioni sul registro dei morti, ma vi è una lettera di Mons. Natoli dell’1 gennaio 1889 al Vicario foraneo di Salina con la quale l’Amministratore Apostolico si rammarica per le notizie avute dal Prefetto di Messina e cioè che a Rinella sono morti, scappati da Alicudi, alcuni vaiolosi privi di ogni aiuto e soccorso. Essi avevano trovato riparo in alcune grotte “come belve”. Ma la cosa più grave era, osserva il vescovo, che i preti di Salina, “ministri di carità”- che allora erano ben quindici - si erano rifiutati di assistere gli infermi. Indubbiamente la dolorosa vicenda dei vaiolosi di Rinella era un fatto marginale, ma essa apre uno squarcio su una realtà ignorata e dimenticata.[1]


Sopra, Rinella in quegli anni. Sotto, le grotte oggi rifugio per le barche e ricovero dei vaiolosi sul finire dell'800.
Della situazione igienico-sanitaria della gente di Lipari del secolo XIX ne fa una seria analisi il dottore in medicina e filosofia don Ferdinando Rodriquez[2] fratello del canonico don Carlo che abbiamo avuto già modo di conoscere. Egli parla di malattie contagiose della pelle che traevano origine “dal luogo arido e secco” e dalla cattiva alimentazione degli abitanti. E siccome il contagio diffonde le malattie, la prima indicazione sarebbe l’isolamento del rognoso e della sua roba, la pulizia privata e pubblica che a Lipari in quel periodo era molto carente. La moltitudine era miserabile e sudicia; in ogni “tetro abituro” coabitava con gli uomini un “immondo animale” e il popolo si nutriva di cibi malsani come il ferrigno caulo, farina di granturco, legumi, tonnina.. Della scabbia parla anche Luigi Salvatore d’Austria osservando che” è comune tra la povera gente che abita case piccole e malsane che si nutre scarsamente abusando di alimenti salati. Fino al 1870 colpiva in media 200 persone l’anno con recrudescenze che spingeva il dato a 900. Oggi ( 1890) è in fase decrescente.”
Diffuse e numerose erano anche le “ affezioni reumatiche”. Da sole costituivano il 30% delle malattie: reumatologie fisse o vaganti congiunte con forme catarrali che causano anche infezioni gastro-reumatiche, gastroenteriti, pleuriti e pnoumopatie. Colpivano in genere 1200 persone l’anno. Frequenti anche le affezioni biliari ( 600 persone l’anno).[3]
Nel 1890 imperversava anche la sifilide. “La sifilide – scriveva Ferdinando Rodriquez - ha sparso la sua influenza in ogni classe sociale. E la sifilide produce la tubercolosi, la rachitide e la stuma…E tutto ciò lo si scorge soprattutto nei bambini abbandonati, nei figli del meretricio. La gotta, la litiasi ed i mali uretro-vescicali, la stuma e il rachitismo possono congiungersi alla sifilide, ed anche essere da questa prodotti”[4].
Per mettere argine a tutto ciò il Rodriquez aveva proposto al Comune di riunire le meretrici del paese per sottoporle a visite mediche e cerusiche, e condurre gli infermi nei nosocomi civili, per cercare di riparare in tempo ai progressi della sifilide, “sorgiva inesausta di pubbliche calamità”[5]
L'influsso della colonia coatta

Anarchici e coatti al castello. Non sempre questi ospiti creano problemi. Qui sono raccolti in un momento di riflessione pasquale con un predicatore evangelico.
Il prosperare della sifilide era legata alla forte diffusione della prostituzione e questa alla presenza dei coatti. Stazionava infatti nella cittadina di Lipari una nutrita colonia di domiciliati coatti calcolabile fra le 700 e 1000 persone che istituita dal governo borbonico verso il 1790 e ulteriormente potenziata dai regnanti di Savoia, durò ininterrottamente fino al 1915.
Come abbiamo avuto modo di vedere, il considerare Lipari luogo di confine e di detenzione risaliva indietro nel tempo fino a Roma imperiale. Ospiti illustri furono inviati al domicilio coatto sia nel 295 d.C. quando Settimo Severo fece uccidere Caio Fulvio Plauziano accusato da Caracalla, primogenito dell’imperatore di aver complottato contro di lui, e fece relegare a Lipari i figli di lui, Plauzio e Plautilla, moglie di Caracalla, che qui morirono fra privazioni e stenti; sia all’inizio del V secolo quando vi fu mandato Attalo Prisco che Alarico, re dei Visigoti, aveva voluto imperatore di Roma; sia nel VI secolo quando i bizantini relegarono chi aveva favorito i Goti; sia all’inizio del IX secolo quando Nicofero I, imperatore d’Oriente, vi invia – e vuole rinchiusi in prigione – abati e vescovi che avevano ostacolato il Patriarca d’Oriente.
Al domicilio coatto venivano inviati condannati per reati comuni e per reati politici. Riguardo ai primi l’intento era quello di togliere dal loro ambiente persone che dimostravano una persistente tendenza a delinquere con l’illusione che in un ambiente diverso, più ristretto e quindi più controllato, e con l’opportunità di lavorare potessero redimersi. Solitamente il domicilio coatto, per questi condannati, durava da uno a cinque anni. Essi potevano circolare liberamente durante il giorno, ma dovevano passare la notte al Castello.
“Stipati in cameroni privi di pavimento – racconta Leopoldo Zagami -, in maggior parte senza finestre, senza luce e con difficoltà di areazione, tranne quella proveniente dalla porta di accesso, che al tramonto veniva da i sorveglianti chiusa dall’esterno, essi trascorrevano le ore notturne in una situazione veramente spaventevole. In ogni camerone venivano ospitati oltre sessanta coatti; tra un letto e l’altro non vi era spazio di sorta sicché tutti i letti, per il modo come erano ammassati, venivano a costituirne quasi uno solo… Niente lenzuola, né guanciali e coperte, ma un magro pagliericcio ripieno di paglia spesso marcita, per cui quasi tutti si coricavano vestiti, specie nel periodo invernale. Molti usavano mettere sotto una delle testate del pagliericcio un sasso perché così rialzato potesse adempiere anche alle funzioni di cuscino.
Tutti i cameroni erano privi di qualsiasi locale igienico, non esistendo alcun tipo di fognatura o pozzo nero; per le naturali necessità i coatti nelle ore notturne provvedevano con dei ‘buglioli’, ovvero con dei recipienti di legno, che rimanevano entro gli stessi cameroni per tutto il corso della notte e che solo al mattino venivano portati via e svuotati. Vecchi e giovani, uomini di tutte le età, vivevano in un’atmosfera di vizio e di degenerazione[6]”.
Queste condizioni erano aggravate nei periodi di punizione che venivano impartite dal direttore della colonia. Si poteva venire puniti con la cella a pane e acqua da uno a trenta giorni; per i reati più gravi anche con l’applicazione della camicia di forza o con la cella oscura o ancora con la camicia di forza e ferri alle mani e catene ai piedi. Inoltre, nei giorni di detenzione, si veniva privati del sussidio giornaliero.
Il lavoro dei coatti presso i privati

A Vulcano i coatti furono impiegati nella solfatara di Nunziante.
Integravano il magro assegno di Stato, cinquanta centesimi al giorno, con lavori presso i privati. Lavori che non era facile trovare in un’isola e con la fama che si portavano addosso. Inoltre, non potendo allontanarsi dalla cerchia cittadina e dovendo a mezzogiorno presentarsi per l’appello pena il carcere, non potevano andare a lavorare in campagna. Quindi lavori spesso saltuari, i più umili e faticosi, remunerati pochissimo e comunque lavori che facevano comodo alla borghesia del tempo che li strumentalizzava anche per calmierare le richieste dei lavoratori liparesi. Vivere con cinquanta centesimi al giorno ed i pochi soldi che si riuscivano a ricavare dal lavoro non era sempre possibile e così molti coatti si indebitavano con i bottegai o i borghesi e finivano col diventare doppiamente schiavi. Anzi la persecuzione dei creditori spesso era più grave di quella dei carcerieri e molti coatti, per sfuggirvi, facevano di tutto per essere carcerati o essere spediti fuori Lipari al penitenziario di Gavi.
Comunque per molti liparesi il confino era un affare. Per questo, almeno per molti anni, su di loro non si riuscì ad avere una posizione unanime nella popolazione circa la richiesta di allontanamento, perché per alcuni erano fonte di entrata e per altri lavoro a basso costo. Comunque, spia della loro emarginazione sociale era il fatto che risultavano rari i loro matrimoni con isolane. Le leggi eccezionali del 1894 e del 1898 condussero poi alle Eolie anche numerosi relegati politici. .
Ma se la loro presenza poteva tornare di giovamento a qualcuno, i danni che provocavano non erano di poco conto. “Coloro che, qui nell’isola, scontano la pena del domicilio coatto, - scriveva in una relazione alla Santa Sede il vescovo mons. Bonaventura Attanasio[7] - vivendo in ozio continuo, si lasciano irretire dalla turpe corruttela, dando pubblici scandali che vanno poi a contagiare i costumi di molti. Da qui il fenomeno delle donne peccatrici, dedite ad ogni genere di oscenità, ingannate esse stesse e ingannatrici, sedotte e seduttrici”.
Questo stato di cose non poteva non influire sui giovani e sui costumi della società in generale.
“Mentre in tutto il mondo si corre verso un progresso di idee e di civiltà, da noi i giovani – osservava ancora il prof. Ferdinando Rodriquez [8]- sembrano sciolti da ogni dovere, sono attenti solo al loro piacere, e compiono quindi ogni genere di cose sconvenevoli. In questo degrado finiscono col coinvolgersi i giovani di tutte le classi corrompendosi a vicenda e commettendo quei misfatti prodotti dall’avarizia, dalla libidine, dall’ira. Così la gioventù liparese si da al bel tempo, è intricata in futili occupazioni e si pasce solo di ozio e di accidia. In un paese destinato a luogo di relegazione essa viene a contatto con la marmaglia e così finisce col fuorviare dai limiti dell’onesto essendo stata abituata ad oggetti ignobili, ai piaceri sensuali e non a grandi e meritorie azioni, né a sentimenti umanitari”.
Queste forti denunce devono farci comprendere come fossero molte le donne ingannate, sedotte, frustrate, senza un focolare sicuro e senza garanzia di tutela. Infatti – osservava il Vescovo – si era diffusa la consuetudine fra giovani di frequentarsi intimamente per molti anni prima di giungere al matrimonio. “Così molto spesso ragazze, di onesta famiglia, nella prospettiva di un futuro matrimonio, non si vergognavano di convivere, né temevano di diventare madri prima di essere spose. Così talvolta restavano solo madri e non diventavano spose…”[9].
Una triste condizione morale

Il centro di Lipari
Da questo stato di cose veniva di continuo incrementato il numero dei figli di nessuno – detti “figli della Chiesa”[10] – spesso del tutto abbandonati a se stessi, cresciuti nella più totale ignoranza vivendo di miserevoli espedienti.
“La prostituzione e la debolezza – osservava il canonico Carlo Rodriquez[11] - danno dei risultati infelici producendo degli esseri che vengono esposti e, svezzati appena, in preda all’ozio rimangono, alla miseria, alla fame e quindi ai vizi tutti di quelli indivisibili compagni. Perciò si veggono in Comune tanti giovanetti di ambo i sessi fino al numero di 100 circa o interamente nudi o coverti di inutili cenci, presentare un terribile schifoso spettacolo che inorridire fa la vista, rabbrividire il core…”.
Ma se la colonia influiva negativamente sui costumi dell’isola. Le prime vittime erano i confinati stessi. Abbiamo visto come molti di loro si trovassero perseguitati dai debiti ma prima di questo e insieme a questo ciò che colpiva era il loro degrado fisico e mentale. Erano moltissimi quelli che cercavano di risolvere i problemi a cominciare da quelli della fame rifugiandosi nell’alcool. “Era sufficiente – osserva Leopoldo Zagami – mettere piede entro il Castello per sentire un insopportabile tanfo di vino. Bastava all’ora della ritirata osservare i relegati per rendersi conto dell’orrendo scempio che l’alcol andava facendo su tante vite. Gruppi barcollanti di ubriachi, aiutandosi l’un l’altro, si portavano su al Castello, incespicando ad ogni passo e cadendo spesso per terra dove l’aiuto di altri confinati li soccorreva in modo che potessero continuare nel cammino e giungere al posto di riunione dove venivano prontamente prelevati dagli agenti di custodia e rinchiusi in celle di punizione[12]”.
La denutrizione, l’alcolismo, le punizioni finivano col logorare l’equilibrio mentale di molti relegati e così li si vedevano girare per le strade ed i vicoli della cittadina gesticolando, parlando da soli, gridando parole oscene ai passanti ed accrescendo la repulsione dei locali nei loro confronti.
Proprio per la presenza della colonia coatta, il Castello era diventato un luogo da cui tenersi distanti. In esso risiedevano ormai – oltre la colonia – dieci o venti famiglie di liparoti che, per necessità o interessi particolari, se ne restavano lassù entro squallidi tuguri; e quasi tutte erano legate ad attività o mestieri – talvolta tristi e sciagurati mestieri – connessi alla presenza della colonia di coatti. C’erano pure un paio di bettole che facevano affari d’oro rispetto alle altre sessanta mescite di vino che risultavano sparse per ogni vicolo della città bassa.[13]
 Gaston Vuillier
Gaston Vuillier
Gastone Vuillier che visitò le Eolie verso il 1895 ci da di questa colonia una immagine molto suggestiva. “Stasera, dopo aver gironzolato per le strade… siamo andati alla cittadella, per una salita molto ripida. Ho udito suonare una tromba sui bastioni..E’ la ritirata dei coatti. Questi coatti girano tutto il giorno liberi per la città; sono obbligati ogni sera, quando suona questa ritirata, a rientrare nella città vecchia ove restano rinchiusi sino alla mattina…Lo stato dà loro 50 centesimi al giorno, li fa alloggiare al Castello e li riveste; però la loro veste è ornata di due grandi lettere rosse le quali denotano il loro stato sociale…. Giungevamo sotto le oscure arcate del portone, che dà accesso al Castello, insieme coi coatti; soldati, carabinieri e guardie di finanza stanno di guardia all’ingresso, queste ultime come rinforzo alla guarnigione durante la sera. Da tutte le parti della città che noi potevamo scorgere, vedevamo sbucare i coatti i quali si dirigevano verso la città vecchia; alcuni, passandoci dinnanzi, si toccavano il berretto, ed altri, preoccupati, camminavano in fretta senza guardarsi attorno. Tosto che i coatti si trovavo stipati nella via principale del Castello[14] aveva luogo la chiamata, e nel frattempo il mio compagno mi condusse nella parte orientale della città vecchia. Ivi tutto è in rovina : antichi sepolcri spalancati, case sfondate e baluardi che, da pezzi di muraglie rovinati, lasciano scorgere, ad una profondità spaventosa, i neri scogli della riva. Eravamo giunti all’abside della Cattedrale dove un fico gigantesco, circondato da cactus contorti, sporgeva i suoi rami aggrovigliati…. Ci avviciniamo alle prigioni; le case rovinate del castello sono state utilizzate e trasformate in carceri. Dopo la chiamata…erano stati messi i chiavistelli su quei disgraziati. Alcuni erano isolati e chiusi in stanze basse, altri riuniti in gruppo dentro stanzoni, e da ogni parte, alle finestre, agli usci muniti di saldi cancelli di ferro, si attaccavano mani dalle dita adunche come artigli e si vedevano occhi cattivi e scintillanti. Oh quegli occhi!.. La maggior parte facevano venire i brividi a guardarli; lampeggiavano come acute lame di acciaio!... Quegli uomini erano rinchiusi là dentro come bestie feroci e respiravano avidamente, alla luce morente del giorno, gli ultimi buffi dell’aria libera[15]”
I coatti non solo razzolavano all’esterno dei luoghi di culto ma spesso penetravano nelle sacrestie delle Chiesa delle Grazie e dell’Immacolata demolendo mobili e asportando legname e suppellettili per alimentare i fuochi nelle giornate di freddo. Quanto alla Cattedrale, comitive di coatti avevano presa l’abitudine di introdursi – scardinando le inferriate che c’erano alle finestre di levante – nella cripta funeraria dell’abside e di intrattenersi colà a giocare a carte in mezzo ai corpi mummificati dei canonici[16].
L'insofferenza verso la colonia
L’insofferenza per questa situazione andava crescendo nella cittadina. Erano cose di tutti i giorni i ferimenti, le aggressioni, i furti, le risse. Specie le donne non potevano circolare tranquille per la paura di trovarsi di fronte a qualcuno di loro. Qualche volta gli abitanti esasperati avevano bastonato un coatto che si era fatto più intraprendente o aggressivo. E il malumore della gente non poteva non coinvolgere Amministrazione e Consiglio comunale che, su questo stato di cose,vi tornarono sopra a più riprese. Il 24 maggio del 1867 il Sindaco propone di chiedere al governo di autorizzare i liparesi a portare armi per la difesa personale visto che i coatti sono liberi di circolare e la forza pubblica è esigua. Il 13 aprile del 1871 si pongono al governo tre alternative:” che la colonia fosse tolta da Lipari, che si sospendesse l’invio di nuovi coatti, o che per lo meno fossero obbligati a risiedere dentro la Città murata e non uscire fuori dall’ambito della medesima.” Questa idea di lasciare il Castello ai coatti e di spostare quindi tutte le attività a cominciare da quelle religiose nella città bassa, circolava da diverso tempo. Il Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale del 24 maggio 1867 invitava a deliberare – cosa che avviene all’unanimità - la richiesta al governo di 120 mila lire per la costruzione di una Cattedrale “nel circolo dell’abitazione del paese”[17]
Ed è in questo clima e di fronte a questa situazione che il vescovo matura l’insano progetto – trovando naturalmente concorde il Consiglio comunale - di cedere la Cattedrale al Governo “a prezzo discreto e prudenziale…che, per la vastità del locale e il benefizio delle molte conserve d’acqua che i sé contiene, potrebbe inservire alla truppa, ai condannati o ad altri usi più utili cui piacerebbe al governo destinarla[18]” in cambio del finanziamento per una nuova chiesa da costruirsi nella città bassa a fianco del Vescovado. In questo senso scrive al Prefetto di Messina nel marzo del 1867 spiegando che “al di fuori e intono ad essa, non si osserva che una frequenza di esuli, di detenuti e di soldati, che talvolta, per militari circospezioni, vietano lo ingresso agli stesi paesani ed al Capitolo, e sono non di rado le loro intemperanze motivo di scandalo e di temenza e di pericolo alle giovani donne che son costrette indispensabilmente a passare tra mezzo di esse per recarsi a compiere i loro doveri religiosi in detta Cattedrale”[19].

Per fortuna tale progetto fu presto abbandonato, già dallo stesso mons. Ideo, che lo sostituì con quello di una gradinata d’accesso partendo da via Garibaldi[20]. E fu questo progetto che il suo successore mons. Palermo, nel 1885, – dopo aver verificato che la costruzione della Cattedrale era impossibile perché il costo sarebbe stato altissimo – decise di promuovere stanziando 40 mila delle 100 mila del lascito di mons. Ideo e cominciando “a comprare il terreno della città murata lungo la linea che sarà percorsa dalla strada suddetta e sgomberare il terriccio e le macerie che lungo esso si è ammonticchiato”[21]ed avviando i lavori “per la congiunzione della vetusta Chiesa Cattedrale col centro della nuova Città di Lipari[22]” che però languiranno dopo un paio d’anni e verranno ripresi verso il 1910. La scalinata si realizzerà definitivamente solo il 23 agosto del 1931 quando era Vescovo, Mons. Bernardino Re[23].
Le tensioni non erano solo fra coatti e cittadini ma anche fra direzione dei coatti e coatti stessi. Rivelatore di queste tensioni fu l’evento del 3 marzo 1892. I coatti d’inverno avevano diritto ad otto ore di libera uscita che andavano dalle otto di mattina alle 16. Inopinatamente nel 1892 questa libera uscita viene ridotta a quattro ore - dalle 8 alle 12 - questo provvedimento viene chiamato “contr’ora”.
Sommosse e repressioni
Il malumore fra gli internati è notevole anche perché diversi hanno impegni di lavoro in città che a questo punto vedono pregiudicati. Ma da che cosa deriva questo provvedimento? Si diffonde la tesi che sia una manovra per favorire una cantina che si trovava al castello e notoriamente godeva della protezione dell’autorità. Infatti a mezzogiorno avveniva la distribuzione della “massetta” che era la somma di cinquanta centesimi al giorno che spettava ad ogni detenuto. Questa somma doveva servire per vitto, vestiti, lavanderie, e tutte le necessità dell’esistenza ma era anche vero che la gran parte veniva spesa nelle cantine dove i coatti passavano il loro tempo. Rinchiudendoli dentro il castello dopo la distribuzione della “massetta” era chiaro che si favoriva l’unica bettola che era dentro le mura. Per protestare contro questo provvedimento i coatti decidono di riunirsi pacificamente a Marina San Giovanni. Ma saputolo il direttore fa suonare la ritirata a passo di corsa. I manifestanti non si muovono. Allora il direttore da ordine di bloccare tutte le uscite dalla Marina da guardie, carabinieri e soldati. Ad un segnale carabinieri e guardie si precipitano sui coatti colpendoli a calci, a pugni, a sciabolate e sparando colpi di pistola. Fu una repressione orrenda. I liparesi che avevano casa alla Marina guardavano inorriditi da dietro i balconi. Al pestaggio non parteciparono i soldati. Il capitano comandante del presidio, più volte sollecitato a dare l’ordine ai suoi di sparare sul gruppo di manifestanti, tutte le volte si rifiutò. Anzi un tenente del presidio diede l’ordine di lascia passare quei poveretti che immediatamente ne approfittarono per fuggire. Ma la caccia e il pestaggio continuò, per ore, in tutto il paese sotto gli occhi sconcertati e terrorizzati dei liparesi.

E la repressione non finì con i pestaggio. I feriti portati in infermeria passavano da questa alle celle di punizione e poi al carcere e quindi al Tribunale di Messina. Per questo molti feriti preferirono nascondere le loro piaghe sotto i vestiti per non incorrere in gravi sanzioni. Diversa gente di Lipari chiese di poter testimoniare in Tribunale a favore dei coatti ma non fu loro permesso. Non fu nemmeno interrogato il capitano del presidio[24].
Tra il 1894 ed il 1898[25] nella colonia, accanto ai delinquenti comuni che vivevano nell’ozio, nell’alcolismo e nel sudiciume, arrivano politici ed intellettuali. Una categoria sociale del tutto diversa che, se poteva essere temuta per le idee giudicate “sovversive”, era però composta di persone umanamente e culturalmente di tutto rispetto a cui si accostarono – con riverente timidezza - i primi simpatizzanti liparesi del socialismo. Fra questi Edoardo Buongiorno che nel 1895, appena sedicenne, fondava una sezione del Movimento Operaio Socialista che ebbe però vita breve[26]
Il domicilio coatto ebbe termine nel 1915. Alcuni dei relegati, scontata la pena si stabilirono nell’isola aprendo piccole botteghe o andando a cavare pomice. Qualcuno mise su anche famiglia sposando donne del posto. Purtroppo però, come vedremo, non si chiude l’esperienza di Lipari isola di confine.
[1] Giuseppe Iacolino, inedito, Quaderno X. ; Archivio vescovile, Bull. Vol.IV, f.59.
[2] Ferdinando Rodriquez.(1814-1864), Storia delle malattie endemiche ed epidemiche dell'isola di Lipari, Palermo 1856.
[3] Luigi Salvatore d'Austria.
[4] Ferdinando Rodriquez in Iacolino, inedito cit., Quaderno VI, pp.291 a-e.
[5] Anche i Vescovi, sotto i Borboni, come abbiamo visto,avevano pensato ad opere di questo genere.
[6] L.Zagami, Confinati politici e relegati comuni a Lipari, Messina 1970, pp. 28-29.
[7] Archivio segreto vaticano, cass. 456 B f.196 v. In G. Iacolino, inedito cit. Quaderno VI pag. 391 e.
[8] Storia delle malattie endemiche ed epidemiche dell’Isola di Lipari…, op.ci. , Palermo 1856..
[9] Giuseppe Iacolino, ideito cit, Quaderno VI, pag. 391 e.
[10] Perché prima che arrivasse il governo dell’unità era la chiesa che provvedeva ad essi (protei). Infatti, fino al 1770, questi fanciulli erano accolti dal Vescovo in una sorta di asilo e mantenuti a sue spese ma poi, quando il Comune avocò a se il diritto all’assistenza dei poveri e diseredati, l’istituzione deperì fino alla chiusura.
[11] Can. Carlo Rodriquez, Breve cenno storico dell’Isola di Lipari, Palermo 1841.
[12] L.Zagami, op. cit., pag. 32.
[13] Giuseppe Iacolino, inedito, Quaderno IX.
[14] Verso il 1890 di coatti in Lipari c’enerano circa settecento.
[15] G. Vuillier, La Sicilia, Milano 1897, pag. 391 -97 citato da Giuseppe Iacolino, inedito Quaderno IX.
[16] Fu probabilmente per questo che intorno al 1872 il vescovo assunse un sacrista laico per la Cattedrale con l’obbligo di abitare nelle due stanzette dell’ex Palazzo vescovile che ancora erano restate al Vescovado. Era un giovane pugliere, Angelo Pastore, che allora era internato a Lipari. La famiglia Pastore rimarrà a lungo, di padre in figlio, a servire la Cattedrale.
[17] Archivio Comunale. Delibere di consiglio.
[18] A. Lo Cascio da Giardini, Due saggi di Storia Liparitana, Messina 1975, pp.29-31.
[19] Idem.
[20] A proposito di questa scalinata il successore di mons. Ideo, mons. Palermo scrisse: “Mons. Ideo, due o tre anni prima di morire, offriva L.25.000 ai Signori del Municipio per detta via, se esso ne avesse preso l’iniziativa, ma nessuno si mosse perché nessuno qui ha a cuore di fare il bene che non sia il proprio. Però l’idea restò ed era da molti vagheggiata prima che io venissi” ( A.Lo Cascio da Giardini, op. cit., p-35).
[21] A. Lo Cascio di Giardini, op. cit., p.39.
[22] Antonino Natoli in “Sua Eccellenza Rev.ma Mons. D. Mariano Palermo Vescovo di Lipari e i Cittadini Liparesi, Palermo 1886, pp5-6.
[23] Veramente la gradinata era stata completata da Mons. Angelo Paino nel 1912 ma rimase aperta solo pochi anni perché il 5 marzo del 1915 crollò un muro nella fiancata di sostegno di sinistra provocando la morte di tre ragazzi che stavano giocando. La scalinata fu nuovamente chiusa e riparata e riaperta al pubblico da Mons. Re.
[24] La vicenda è stata raccontata qualche anno dopo da un detenuto politico raccogliendo le testimonianze di numerosi liparesi oltre che dei reclusi. E.Croce, Nel domicilio coatto. Noterelle di un relagato, Lipari 1900, pp-96-97.;una conferma di questo episodio in avv. A. Natoli La Rosa, Studii politco-sociali, Palermo 1896, p.123: “Per monopolizzarsi a profitto di alcuni cointeressati la minuta vendita del vino in Lipari, si ordinò a quelli ottocento domiciliati coatti di ritirarsi giornalmente alle ore 12 di mattina in Castello… Contro un tale sopruso i coatti pacificamente reclamarono giustizia. Ma lor si rispose terrorizzando, massacrandoli spietatamente”.
[25] Nel 1893-94 il governo Crispi avendo represso i Fasci siciliani dei lavoratori mandò al domicilio coatto numerosi anarchici e socialisti con la legge n. 316 del 19 luglio 1894. Altrettanto farà qualche anno dopo Rudinì dopo i fatti di Milano del 1898 con provvedimenti del 17 luglio di quell’anno..
[26] J. Busoni, Confinati a Lipari, Milano 1980, p.101.
Gastone Vuillier
Le Terme di San Calogero
Il primo stabilimento nel 1867


Sopra, le terme come le vide Jean Houel nel 1778. Sotto, come le vide Luigi Salvatore un secolo dopo.
Della possibilità di creare uno stabilimento per potere fruire dei “bagni a vapore” di San Calogero[1] a Lipari se ne parlava da tempo. Era una tappa obbligata per i visitatori che dalla seconda metà del 700 erano venuti alle Eolie. Le aveva visitate Jean Houel nel 1778, Déodat de Dolomieu nel 1781, Lazzaro Spallanzani nel 1788, William Henry Smyth probabilmente nel 1814, ecc. Il canonico Carlo Rodriquez, nel 1841 scriveva :”(…) per tradizione di venerandi vecchi di questo paese è mirabile la varietà di morbi per esse curati. Ed in tempi non ai nostri lontani di Sicilia, Calabria, ed altre parti vedeansi ragguardevoli personaggi qui venire afflitti da diverse malattie, e per queste acque sanarsi. Ed è sconfortevolissima cosa il dire, che non più a noi recarsi da vicini, o lontani paesi si veggono degli ammalati per la incuria dei nostri naturali, i quali fanno un abbandono deplorabile giacere i nostri bagni”.[2]
Finalmente nel bilancio del 1864 del Comune di Lipari ,nelle voci del passivo, compare la voce: “Per la restaurazione dello Stabilimento dei Bagni di San Calogero secondo il piano d’arte di Maestro Antonio Fraumeni di Giuseppe… L. 8.287,50”. L’anno successivo, per il solo 1865, si preventivano L. 15.500.

Il vecchio stabilimento come appariva negli anni 50
Il primo stabilimento nell’epoca moderna, degno di questo nome, fu ultimato intorno al 1867. Nel corso del 1872, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Mariano Amendola, affidò gli incarichi a dott. Giuseppe Cincotta e Giuseppe Arrosto per le analisi mediche e chimiche delle acque. Il dott.Cincotta, medico di Lipari affermò che le acque erano utilissime nelle varie forme di dispepsie acide; bevuta in maggior proporzioni – 4 o 5 bicchieri – determina una blanda purgazione per cui se ne raccomanda l’uso “agli individui abitualmente stitici e agli emorroidari”; utili anche contro “il crampo dello stomaco ed i catarri gastrici ed enterici cronici”. Adoperate in forme miste cioè di bevanda e di bagno sono “indicate nei casi di stasi biliari, ingorghi ed eperemie epatiche e calcolosi epatiche”. “Le acque in parola, adoperate variamente or a bagno in vasca, or a doccia nei punti meglio indicati del corpo, giovano a guarire la debolezza nei genitali dell’uomo, e la sterilità della donna. Sono indicate per quelle malattie della pelle che vanno intese col nome di eczemi, erpeti, psoriasi, prurigo, pitiriasi, pachidermie circoscritte, piaghe ulcerose di antica data. Quest’acqua (…) svolge un’azione elettrica speciale sull’organismo, un’azione biologica complessa che accelera e modifica il ricambio mollecolare; per ciò stesso è indicata nelle infezioni e discrasie croniche, come: sifilide, scrofolosi, polisarcia, diabete, reumatismo e gotta. L’uso della stufa è giovevolissimo nei casi di corizza e catarri cronici del laringe e dei grossi bronchi; infine nelle miositi, artriditi, sciatica, nevralgie e paralisi d’indole reumatica”[3].
Il dott. Giuseppe Arrosto di Messina prima di entrare nel merito delle analisi da lui compiute e dei risultati acquisiti fa alcune osservazioni generali che ci sembrano di un certo interesse. Innanzitutto descrive il nuovo stabilimento “spazioso e comodo …sorge meraviglioso in mezzo a quegli alti burroni nati sulle vomitate lave dell’estinto vulcano”. Quindi parla delle acque. “L’acqua sorge limpidissima dalle fessure dell’interno della Grotta in grande abbondanza e caldissima, capace a cuocere le uova, ed in pochi minuti indurirle. L’uomo che entra in quella caverna di forma simile ad una stufa, tollera con piacere la elevata temperatura che i vapori conservano diffondendosi in quel ristretto spazio, in modo da produrre in pochi minuti un sudore abbondante. Tornando fuori, l’uomo grondante di sudore invece di sentirsi rilasciato nelle forze, viceversa sentesi rinvigorito… Le acque raffreddate conservano la loro trasparenza, non svolgono alcun odore, manifestano al gusto un senso leggermente salato e di amaro”.[4]
 L'interno della tholos come si presenta oggi
L'interno della tholos come si presenta oggi
I problemi della gestione
Quando lo stabilimento fu completato inizialmente venne gestito dal Comune direttamente per circa 8 anni, poi il Consiglio comunale del 7 novembre 1878, sindaco Filippo De Pasquale, delibera di darlo in gestione al dott. Francesco Genovesi – che già aveva aperto uno stabilimento idiopatico a Messina in corso Cavour - con un canone di 500 lire all’anno. “Il consiglio considerato che per il numero scarso di bagnati che son venuti in questo ultimo anno il Comune poco ha ricavato, e che cedendola al detto Genovesi per anni dieci ne farebbe rialzare l’importanza ed il valore delle acque e quindi aumenterebbe il concorso dei bagnati e grande vantaggio ne ricaverebbe il paese dall’affluenza dei forestieri, ad unanimità di voti ha deliberato…” .
Il Genovesi mantenne la gestione per circa 8 anni su un trend di prestazioni di qualità con tutti i conforti desiderabili per i degenti sia a livello di prestazioni medico assistenziali che di ristoro. Il pranzo era differenziato nei costi e probabilmente anche nel servizio fra prima e seconda classe comunque il menù offriva una varietà di pietanze amplissima fra sartù, timballi, pasticci e torte e poi vini da pasto, da dessert, marsala, rosolio, granite, sorbetti ecc.[5]. Forse si può capire come le entrate non riuscivano a coprire le spese e così il Genovesi fu costretto a rinunciare. Il Consiglio Comunale nella seduta del 18 aprile 1887, sindaco Ferdinando Paino, “considerando che l’attuale stato di cose non può continuare perché lo stabilimento andrebbe a deperire e gli abitanti non avrebbero neanche il vantaggio dei bagni restando quasi chiuso”, scioglie il contratto ma il contenzioso prosegue per diversi anni anche in Tribunale fino a quando non si arriva ad una transazione nel consiglio comunale del 23 giugno 1895. Intanto lo stabilimento era tornato alla gestione diretta, poi , con atto dell’8 maggio 1892, lo stabilimento viene dato in locazione alla signora Giovanna d’Amico, vedova Picone per la durata di sette anni ed un canone di lire 300 per i primi due anni e 350 per le annualità successive. Ma anche questa gestione si dimostrò deficitaria. La signora pagò la prima rata semestrale ma ritardò la seconda e fu necessario ricorrere ad un atto stragiudiziale. L’inadempienza si ripetè alla terza rata e si decise per la risoluzione anticipata del rapporto alla fine del 1893. Anche qui strascichi giudiziari.

Il manifesto pubblicitario della gestione Mancuso e Esposito
Nel 1896 la giunta presieduta dal Sindaco avv. Giuseppe La Rosa decide di riaprire i bagni tramite la gestione diretta nominando un custode dello stabilimento per il servizio interno ed esterno dei bagni. Si prevedono tariffe differenziati per i forestieri ed i paesani.
Anche la gestione diretta dovette essere deficitaria e nel quinquennio 1900-1905 la perdita sarebbe stata di 387,86 cioè 77,57 in media all’anno. Nel 1905 si tornerà alla gestione in concessione ai farmacisti Luigi Mancuso e Nunzio Esposito di Domenico.
Intanto nella notte fra il 3 ed il 4 agosto del 1888 il cratere di Vulcano sussultò violentemente. Le manifestazioni vulcaniche durarono per diciotto mesi con colonne di fumo che si levavano dal cratere, bolidi enormi che venivano lanciati in mare e nei pressi del porto, nuvole ci cenere che cadevano sulla città e le campagne di Lipari. I risultati dell’eruzione non hanno ripercussioni solo sulla clientela delle terme che veniva dall’esterno ma anche sulla stessa acqua termale per la quale si innesca un lento processo di progressivo abbassamento della temperatura come d’altronde si ha una attenuazione, e qualche volta la scomparsa, dei fenomeni di vulcanesimo secondario delle isole di Lipari e Salina[6]. In particolare a Lipari si estingue la sorgente termale di Acquacalda, si attenua e si restringe l’ampia area fumarolica di Piano Greca.

 Sopra, una veduta dall'alto della tholos con i ruderi delle opere che erano nella prossimità e collegate alla fruizione delle terme. Sotto, la scritta del museo che parla del significato storico dell'edificio.
Sopra, una veduta dall'alto della tholos con i ruderi delle opere che erano nella prossimità e collegate alla fruizione delle terme. Sotto, la scritta del museo che parla del significato storico dell'edificio.
[1] Per questo paragrafo ho largamente attinto a G.La Greca, Le Terme di San Calogero, Milazzo 2004.
[2] Breve cenno storico critico sull’isola di Lipari, Palermo 1851.
[3] G.La Greca, Le Terme di San Calogero, Milazzo 2004, pp44-45 ; G.Cincotta, Rendiconto dei morbi che richiedono l’acqua di S.Calogero, Messina 1872.
[4] G.La Greca, op.cit., pp. 45-46.
[5] F. Genovesi, Notizie sulle acque termo-minerali e sulla grotta o stufa di S. Calogero in Lipari, Messina 1879, pp.59-51.
[6] Da una dichiarazione di L. Bernabò Brea e M. Cavalier riportata in G. La Greca, op. cit., pag. 49.
I farmacisti Mancuso ed Esposito
La "Recitazione" di Sciascia e la controversia liparitana
Dove le ragioni della speranza?
 Leonardo Sciascia
Leonardo Sciascia
Sulla vicenda della “controversia liparitana” Leonardo Sciascia pubblicò nel 1969 una “Recitazione” dedicata a Alexader Dubcek la cui primavera a Praga veniva schiacciata dai carri armati russi. Quello di Sciascia, partendo dalla vicenda di Lipari ed in qualche modo forzandola nel suo significato, voleva essere un inno alla laicità dello stato ma anche e forse sopratutto ad una tesi ottimistica: le ragioni del potere se avevano la meglio in un frangente storico grazie all’uso della forza, non l’avevano però nel lungo periodo. Infatti le ragioni degli uomini che hanno avuto speranza ed hanno mantenuto la schiena diritta di fronte al potere, finiranno, nel tempo, coll’evidenziarsi ed anche col fruttificare.
Le ragioni della speranza per Sciascia, in quella vicenda del settecento, erano rappresentate da uomini come Giacomo Longo, giudice del Tribunale della Monarchia, Francesco Ingastone, giudice della Gran Corte, Ignazio Perlongo, avvocato fiscale sempre della Gran Corte. Ma era proprio così? Che rappresentavano le due parti in competizione? La Sicilia illuminata contro quella reazionaria, come vorrebbe Sciascia sull’ala dell’ottimismo della fine degli anni 80 del secolo scorso? O piuttosto, più in sintonia col realismo disincantato di oggi, due sistemi di potere che cercavano di difendere o accrescere le proprie prerogative?
Cerchiamo di approfondire i fatti.
La “Recitazione” è, da una parte, una riflessione sul potere, sulla sua forza omologante, sulla capacità di piegare valori ed ideali, sulla tendenza al compromesso per la propria conservazione; dall’altra, sulla laicità dello stato che il potere temporale della S.Sede tende a condizionare ma anche sulla libertà della Chiesa che risulta impastoiata in mille logiche temporali che ne offuscano la missione religiosa. Qui, il libero pensatore del XX secolo può addirittura citare il cattolico Pascal in epigrafe al suo lavoro. Gesù sapeva che il potere esercitato in nome della religione “che detiene il ramo principale e si insinua dappertutto” facilmente poteva degenerare in tirannide e per questo aveva stabilito, citato da Luca (22,25-27), il precetto “Vos autem non sic”[1], “Per voi però non sia così”. Un precetto che, secondo Sciascia, moltissime volte o sempre, è stato contraddetto nel corso della storia, proprio per la natura stessa del potere.
 L’illuminista Sciascia sviluppa i suoi quattro atti sulla base di un diario del canonico Antonino Mongitore, uno storico del settecento che nella controversia si era schierato col papa sposandone le posizioni anche se fra i cosiddetti “curialisti”, era forse uno dei più obiettivi. Il nostro autore non solo fonda il suo racconto su questo testo che giudica di parte, ma pubblica in appendice alla “Recitazione” un estratto di quel diario, proprio ad evidenziarne la fonte ed a invitare a verificarne la fedeltà con la storia tradotta sulla scena. Così lo scrittore di Regalmuto vuole dimostrare al lettore e spettatore moderno come la coscienza storica e civile del nostro tempo è in grado di rendere giustizia ai fatti al di là della parzialità del narratore. E se la ragione del potere ha la meglio in quel frangente storico – come a Praga - le ragioni della speranza, alla lunga, finiranno col prevalere.
L’illuminista Sciascia sviluppa i suoi quattro atti sulla base di un diario del canonico Antonino Mongitore, uno storico del settecento che nella controversia si era schierato col papa sposandone le posizioni anche se fra i cosiddetti “curialisti”, era forse uno dei più obiettivi. Il nostro autore non solo fonda il suo racconto su questo testo che giudica di parte, ma pubblica in appendice alla “Recitazione” un estratto di quel diario, proprio ad evidenziarne la fonte ed a invitare a verificarne la fedeltà con la storia tradotta sulla scena. Così lo scrittore di Regalmuto vuole dimostrare al lettore e spettatore moderno come la coscienza storica e civile del nostro tempo è in grado di rendere giustizia ai fatti al di là della parzialità del narratore. E se la ragione del potere ha la meglio in quel frangente storico – come a Praga - le ragioni della speranza, alla lunga, finiranno col prevalere.
Ma quali sono le ragioni di Mongitore e con lui, secondo Sciascia, di chi si schierò con il papa? E dall’altra quali le ragioni di chi invece vi si oppose e non in nome di una visione antireligiosa ma, sempre secondo Sciascia, sulla base della concezione di una fede più genuina e più umana come in Giacomo Longo, giudice del Tribunale della Monarchia,o in nome di una giustizia redistributiva come in Francesco Ingastone , giudice della Gran Corte, che più concretamente mira ad eliminare o ridurre i privilegi patrimoniali del clero, degli ordini e dei monasteri che gravano sulle spalle della gente?
Per il Mongitore, come si evince dal suo Diario, la ragione nella controversia sta dalla parte del Vescovo di Lipari prima e quindi del papa che le ha sostenute dando loro una valenza più ampia e generale. Il Vescovo di Lipari ha ragione perché la scomunica che emise contro i due catapani Tesoriero e Cristò non poteva essere annullata dal Tribunale della Monarchia di Palermo ma solo dal papa giacchè la Diocesi di Lipari non era soggetta alla Legazia Apostolica siciliana ma immediatamente alla S.Sede per una concessione ancora più antica di quella della Legazia. La reazione dei “ministri di Sicilia con molte e gravi vessazioni” all’opposizione del Vescovo che si rifiutava di riconoscere la competenza giurisdizionale di detto Tribunale diede vita ad un’escalation che superò i confini diocesani e si propagò a tutto il Regno di Sicilia. Qui non era più in gioco il privilegio della Chiesa di Lipari ma prima l’autorità del papa su materie che egli riteneva di carattere dogmatico e quindi sottratte alla Legazia, poi la Legazia stessa che da un papa era stata concessa sei secoli prima e quindi solo un altro papa poteva togliere.
Una nuova "classe dirigente"?

Dall’altra parte, quella dei “regalisti” - come venivano chiamati i sostenitori delle tesi siciliane in opposizione ai “curialisti”, sostenitori delle tesi romane – sembrano ignorare il privilegio della Chiesa liparese e cioè la sua esclusione dalla Legazia e il suo legame diretto con la S.Sede e tendono a ridurre la controversia, se non ad un arbitrio, ad un eccesso di reazione del vescovo di Lipari ed a una impuntatura priva proprio di carità cristiana. La competenza del Tribunale della Monarchia in materie ecclesiastiche ma non dogmatiche viene fatta risalire “alla remunerazione concessa da Pontefici a quel Gran Ruggero che nel conquistare a se stesso la Sicilia, si rese tanto benemerito della Sede Apostolica, per avere discacciati da quel Regno i Saraceni Nemici della Fede, e per haver indi donata a le molte Chiese da lui fondate la terza parte dei Redditi di tutto il Regno[2]”. Questa peculiarità di cui gode la Sicilia – continua il documento dal titolo “Veridica Relatione” che si rifà chiaramente alle posizioni regaliste – non può destare meraviglia se si pensa che essa è totalmente separata dal Continente e quindi consente ai cittadini di non fare uscire le loro cause fuori dal Regno con aggravi intollerabili di spese e col rischio di dover viaggiare per mare spostandosi a Roma per chiedere ed ottenere riparazioni alle ordinanze e sentenze dei loro prelati[3].
Quanto alle motivazioni più idealiste e radicali tendenti ad una riforma della fede o delle istituzioni ecclesiastiche che Sciascia attribuisce a personaggi come Longo, Perlongo e Ingastone - facendone una sorta di pool riformista-illuminato, simboli in qualche modo di una nuova “classe dirigente” venuta fuori in quel frangente[4], nel conflitto fra regno di Sicilia e curia romana, anticipatore di visioni che matureranno, fra i cattolici, nei secoli XIX e XX - bisognerebbe quantomeno articolare il discorso. Dei tre personaggi, alla luce delle conoscenze storiche, quello che in qualche modo potrebbe essere all’altezza del ruolo che gli fa giocare lo scrittore di Regalmuto è il Longo. Avvocato, giudice, filosofo e letterato apparteneva a “quella scuola che sulle orme di Cartesio tendeva, tra la fine del XVII e il principio del XVIII secolo, a rompere in Sicilia i ceppi aristotelici”[5]. Al culmine di una carriera accompagnata da onori e generale rispetto, improvvisamente decide di dedicarsi alla vita religiosa ed entra in un convento dell’ordine dei Teatini dove va a trovarlo Vittorio Amedeo – che indubbiamente lo conosceva di fama – appena giunge a Palermo. Ma se una figura chiara e priva di ombre era quella del Longo, circondata da generale rispetto anche da parte di chi era su tutt’altro fronte[6], non altrettanto si può dire del Perlongo e dell’Ingastone. Del Perlongo gli storici annotano che girava per i conventi della Sicilia indagando sul comportamento dei religiosi per poterli denunziare e perseguire[7]. Ancora più ambigui sono i riscontri che riguardano l’Ingastone e il contributo che questi diede nella persecuzione degli osservanti le disposizioni di Roma servendosi dell’opera di un figuro come Matteo Lo Vecchio. Quel LoVecchio che Sciascia cerca in qualche modo di nobilitare attribuendogli, alla vigilia del suo assassinio, una crisi di coscienza e la manifestazione di scrupoli religiosi che non hanno riscontro nelle cronache dell’epoca[8].
 Anche volendo ammettere che il Longo facesse parte di un nuovo tipo di clero “che credeva in Dio e propugnava il diritto dello Stato”[9]ci sembra azzardato sostenere che esso fosse l’emblema di una nuova classe dirigente che la “restaurazione” del 1719 disperse. Una classe dirigente alla quale, in qualche modo, Sciascia sembra assimilare persino il Lo Vecchio dedicandogli idealmente una rosa – come Faulkner la dedicò ad Emily che dorme nel suo letto accanto al cadavere dell’uomo amato[10]- “per questo cadavere che da un secolo e mezzo dorme in fondo ad un pozzo secco, accanto al cadavere dello Stato”[11].
Anche volendo ammettere che il Longo facesse parte di un nuovo tipo di clero “che credeva in Dio e propugnava il diritto dello Stato”[9]ci sembra azzardato sostenere che esso fosse l’emblema di una nuova classe dirigente che la “restaurazione” del 1719 disperse. Una classe dirigente alla quale, in qualche modo, Sciascia sembra assimilare persino il Lo Vecchio dedicandogli idealmente una rosa – come Faulkner la dedicò ad Emily che dorme nel suo letto accanto al cadavere dell’uomo amato[10]- “per questo cadavere che da un secolo e mezzo dorme in fondo ad un pozzo secco, accanto al cadavere dello Stato”[11].
Comunque lo scontro, soprattutto in Sicilia, non fu allora fra una parte illuminata ed un’altra retriva e codina ma fra due sistemi di potere che cercavano di difendere o accrescere le proprie prerogative.
[1] “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande fra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve “, Luca 22, 25-27.
[2] Da “Veridica Relatione, e confronto de’ procedimenti delle due Corti di Roma e Sicilia nelle note vertenze per fatto del Tribunale della Monarchia”, testo a stampa, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St.St. D2 d bis, pag. 4.
[3] Idem.
[4] In uno scritto del 1969 intitolato “Una rosa per Matteo Lo Vecchio ( in La corda pazza, L. Sciascia, Opere 1956-1971, Classici Bompiani, Milano, 1990, pag. 1017) Sciascia parla di “uomini nuovi, una vera e propria classe dirigente xhe mai la Sicilia aveva avuto ( e mai, purtroppo fino ad oggi, avrà). Corsero venature gianseniste, si ebbero più stretti rapporti conla cultura francese. Un clero che credeva in Dio e propugnava il diritto dello Stato contro la temporalità deella Chiesa veniva affermandosi contro il vecchio clero isolano sostanzialmente ateo, avido di benefici, intento a scrutare ed avallare prodigi e superstizioni”.
[5] I.LA LUMIA, Storie siciliane, IV, Palermo 1870, pag. 233.
[6] A. MONGITORE, Biblioteca sicula, Tomo I, pag.302; G.B. CARUSO, Discorso istorico apologetico della Monarchia in Sicilia, Palermo 1863, pag. 165, I. LA LUMIA, op.cit., pag. 232-233.
[7] I. LA LUMIA, Storie siciliane, IV, op.cit., pag. 237.
[8] I. LA LUMIA, op.cit., pag. 237; pag. 254. Si veda anche G. IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, Quaderno III a, man. cit., pag. 138.
[9] L. Sciascia, Una rosa per Matteo Lo Vecchio,
[10] W. Faulkner, Una rosa per Emily, Milano, Adelphi, 1997.
[11] L. Sciascia, Una rosa per Matteo Lo Vecchio, op. cit., pag. 1017. Precisiamo che quando Sciascia il 21 giugno del 1969 andò a cercare a Palermo la via intitolata a Matteo Lo Vecchio e scoprì che si trattava di “un vicolo corto e stretto, fatto di tristissime case; e una piuttosto antica, forse appunto quella del Lo Vecchio” erano trascorsi due secoli e mezzo e non uno e mezzo dalla sua morte. Inoltre anche volendo prendere le distanze dal canonico Mongitore che, nel suo diario, a proposito del vilipendio fatto al cadavere parla di “divina giustizia”, ci sembra azzardato sostenere che , in fondo al pozzo secco, accanto al cadavere di Lo Vecchio dorma il cadavere dello Stato di Sicilia stroncato dalla restaurazione prima spagnola e poi austriaca.(Archivio storico eoliano.it)
Matteo Lo Vecchio
La lenta conclusione di una lunga vicenda
Il Papa toglie l'interdetto
Così il 2 settembre 1719 Clemente XI tolse l'interdetto col quale aveva colpito la diocesi di Lipari. La controversia liparitana esplosa il 22 gennaio 1711, può dirsi così conclusa. Nell’esperire le pratiche relative al sollevamento dell'interdetto della città di Lipari pare abbia avuto un ruolo importante il canonico Hurtado che fu insignito del titolo di Protonotario Apostolico. Mentre l'Hurtado faceva immediato ritorno all'isola il vescovo Tedeschi rimase a Roma e seguitò nella carica che il pontefice gli aveva conferito di Segretario della S. Congregazione dei Riti ed esame dei vescovi.
“Quindi, restituita a Lipari la primeva pace, si aprirono le Chiese, si ripigliò il primiero pubblico divino culto, con disumarsi i cadaveri de’ fedeli sepolti nelle campagne fuori le Chiese in tempo del suddetto Interdetto, e con pie esequie e funerali si portarono dentro le sepolture delle Chiese già benedette, ove si fecero dalli rispettivi parenti li suffraggy per l’anime de’ loro defunti[1]”.
Nel 1722 i liparesi cominciarono a protestare per l'assenza prolungata del loro vescovo anche perché la soldataglia austriaca aveva occupato il Palazzo vescovile a fianco alla Cattedrale riducendolo ad una sudicia caserma e si lasciava andare ad ogni sorta di prevaricazione.
Tranquillizzatasi un po’ la situazione politica in Sicilia il vescovo fu messo di fronte all'alternativa se tornare a Lipari o rinunciare al vescovado. Tedeschi preferì rinunciare al vescovado confermando così, in qualche modo, il giudizio che di lui aveva dato l’abate del Maro scrivendo al re Vittorio Amedeo II il 10 dicembre 1713 e cioè che oltre ad essere “cabalista, astuto, ambizioso, maligno” ma anche “dotto, disinvolto e cortegiano all’usanza di Roma in grado supremo”, questo vescovo non poteva “ridursi a vivere nello scoglio di Lipari, e crede con accender fuoco , come ha fatto fin hora, di fare gran sbalzi, e di riuscir Cardinale”[2] . Non divenne però cardinale ma si contentò della posizione in Vaticano, di una pensione di 500 ducati a carico della mensa vescovile di Lipari e del titolo del tutto nominale di Arcivescovo di Apamea.
Papa Innocenzo III, succeduto a Clemente XI. nominò, al suo posto, mons. Pietro Vincenzo Platamone[3]che fu accolto con onori trionfali alla marina e dopo qualche giorno accompagnato in pompa magna in Cattedrale.[4]


A sinistra il Papa Innocenzo III. A destra mons. Platamone
Un nuovo statuto della Legazia
Per quanto riguardava la Legazia Apostolica, alla fine gli intransigenti delle due parti furono isolati e si pervenne alla normalizzazione dei rapporti tra la Santa Sede e la corona di Sicilia, e alla conseguente pacificazione religiosa dell’isola.
Benedetto XIII, divenuto papa il 29 maggio 1724, con la bolla “Fideli ac prudenti dispensatori” del 1728, chiamata per questo “concordia benedettina”, diede nuove basi all’istituto. Si riaffermava, con qualche limitazione, la giurisdizione del Tribunale di Regia monarchia sulla Chiesa siciliana anche se il Tribunale veniva presentato come una concessione pontificia non direttamente collegato col privilegio della Legazia Apostolica.[5].
Era rimasto irrisolto il nodo di Lipari: circa l'inclusione o l'esclusione dalla Legazia Apostolica. Così nel 1729 si verificò un nuovo incidente quando il giudice della Monarchia nominò un suo delegato a Lipari per controllare che l'uso delle immunità ecclesiastiche non favorisse il contrabbando del tabacco. Alla nomina si oppose il vescovo Platamone che scomunicò il delegato. Per fortuna, questa volta, il governo cedette revocando la nomina del delegato e imponendogli di chiedere l'assoluzione dalla scomunica[6].
Nel 1749 il re Carlo III di Borbone riconobbe la competenza del Tribunale della Monarchia per un ricorso contro il Vescovo di Lipari presentato dai fide-commissari dell'ospedale S. Bartolomeo e dispose l'istituzione a Lipari di un delegato della Regia Monarchia[7]. Poiché non si ebbero reazioni né da parte del Vescovo, né dalla S. Sede, da quel momento le Eolie furono sottoposte alla giurisdizione della Legazia Apostolica.
Ad indicare che gli anni della controversia non furono un fenomeno che colpì ed interessò solo i ceti dominanti vi è un canto popolare che ricorda questo periodo. Esso recita:
Lu Santu Patri ni livau la missa,
lu Re conza la furca a li parrini,
la Sicilia è fatta carni di sasizza,
cca c'è la liggi di li saracini[8].
La “concordia benedettina” se mise fine ai conflitti sulla Apostolica Legazia non chiuse però le discussioni su di essa e le dispute fra regalisti e curialisti. Inoltre all’inizio del XIX secolo gli stessi vescovi, anche se tutti di nomina regia e leali nei confronti del sovrano, chiesero, con una Memoria rivolta al re Borbone, una serie di riforme dell’istituto fra cui l’ applicazione meno rigida della Regia monarchia e la possibilità di trattare con la Santa Sede le riforme in ambito ecclesiastico ma questa perorazione non ottenne praticamente nessun risultato.
Comunque nessuno si dichiarava contrario alla Legazia e persino Garibaldi, quando arrivò in Sicilia nel 1860, fu salutato con tutti gli onori previsti per il legato: fu accolto dai canonici all’ingresso della cattedrale e accompagnato a sedersi sul trono regale più alto di quello episcopale. Può sembrare strano questo volere mantenere delle prerogative in materia ecclesiastica da parte di governanti che erano massoni ed anticlericali. Ma, probabilmente, al di là della logica dei principi, ebbe la meglio il ragionamento politico che intendeva sottrarre ad una Santa Sede fortemente contraria al nuovo regno prerogative e funzioni che certamente incidevano significativamente nella vita civile della nazione.


A sinistra, Garibaldi a Palermo. A destra Cavour.
Così, probabilmente per queste ragioni, quando la Sicilia entrò a far parte del Regno d’Italia in un primo tempo il governo italiano, sentendosi pienamente erede dei privilegi legaziali esercitati dal governo borbonico, per la Sicilia reclamava non solo l’exequatur come per il resto del paese, ma anche l’esercizio libero del diritto di nomina dei vescovi.
Di fronte a questo atteggiamento Pio IX decise di abolire definitivamente la Legazia Apostolica di Sicilia e il Tribunale della Regia monarchia con la bolla Suprema universi dominici gregis e il breve Multis gravissimi. Bolla e breve erano del 28 febbraio 1864 ma furono pubblicati solo il 12 ottobre 1867 dopo che fu raggiunto l’accordo col governo per la nomina dei nuovi vescovi e consumata la frattura con l’approvazione delle leggi eversive.
Finalmente il 13 maggio 1871, con la legge delle Guarentigie, anche il governo italiano rinunciava, come abbiamo accennato, al diritto di Legazia Apostolica in Sicilia rendendosi conto che essa contrastava nettamente con i principi liberali riassunti da Cavour nella celebre frase:”Libera Chiesa in libero Stato”[9] . Questo istituto medioevale era durato quasi 800 anni[10].
Bisogna osservare che può sembrare incredibile che per 800 grammi di ceci si sia scatenata una vicenda che ha sconvolto tutta la Sicilia e coinvolto, oltre la Santa Sede, anche diverse potenze europee, creando problemi a tanta gente compreso esili e carceri. Eppure non si tratta di una reazione abnorme ad un fatto estremamente modesto, una sorta di follia collettiva esplosa non si sa come e non si sa perché. Ma uno scontro duro fra due ordini di potere che avevano confini di competenza molto labili e quindi facilmente tracimavano, forse perché è proprio del potere non porsi limiti e confini.
 Pio IX
Pio IX
Un conflitto - prodotto scientemente - legato ad istituti paradossali quale quello della Legazia Apostolica e dell'exequatur. Ma la Legazia Apostolica e l'exequatur esistevano perchè esisteva la commistione fra potere politico e potere religioso che era il vero nodo perverso. Da una parte il re che oltre ad avere il potere politico poteva vantare, proprio in nome della Legazia, funzioni di ordine religioso e dall’altra un vescovo che ricopriva in se la funzione di signore politico e di capo religioso che era strattonato fra il Sovrano ed il Papa, fra le ragioni delle istituzioni politiche e quelle delle istituzioni ecclesiastiche. In più a questo problema si aggiungeva – complicanza nella complicanza - la questione della diocesi di Lipari direttamente soggetta alla Sede Apostolica. E' questa la miscela a cui Clemente XI e la Santa Sede decidono di dare fuoco scegliendo un vescovo ambizioso e battagliero – Mons. Tedeschi – ed inviandolo a Lipari col preciso incarico di fungere da detonatore. Missione che Tedeschi compie puntualmente[11].
[1] G. LA ROSA, op.cit., vol.I,pag.267.
[2] “Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’Isola di Sicilia dall’anno MDCCXIIII al MDCCXIX. Documenti raccolti e stampati per ordine della Maestà del Re d’Italia VittOrio Emanuele II”, Torino, Tipografia Eredi Botta, MDCCCLXII, ( a cura di V.E.STELLARDI), pag. 131.
[3] Pietro Vincenzo Platamone, domenicano, nato a Cammarata il 15 febbraio 1666, fu eletto vescovo di Lipari il 23 marzo 1722 ottenendo l’exequatur dal Tribunale della Monarchia di Palermo. Morì il 22 febbraio del 1733.
[4] La processione che si snodava dal Palazzo vescovile della villa vedeva prima il clero regolare e secolare quindi il vescovo “a cavallo dritto sopra una bianca mula, condotta con briglia in mano dal Giurato Seniore, e sotto baldacchino portato con aste a mano dall’intiero Magistrato Civico, seguitato dal Populaccio tutto con gridi di giubilo, che vedevano la loro Chiesa decorata con la presenza del suo Pastore che , per ott’anni circa [per la verità erano dieci] era stata priva per l’allontanamento del predecessore Monsignor Tedeschi, che gli la interdisse”. G. LA ROSA, op.cit., pag.268.
[5] G. ZITO, op. cit., pag.81.
[6] Se non esplose un'altra “controversia liparitana” fu solo perché le corti di Roma, Vienna e Palermo si preoccuparono immediatamente e il governo di Palermo volle gettare acqua sul fuoco. Se tutto invece fosse dipeso da Lipari probabilmente la vicenda non si sarebbe chiusa tanto in fretta perché lo scontro fra il vescovo ed il delegato del Tribunale della Monarchia –che poi era lo steso canonico Diego Hurtado che era stato vicario al tempo di mons. Tedeschi ed uno dei protagonisti della grande “controversia” – si sviluppò violentissimo e la scomunica aveva coinvolto non solo l’Hurtado ma anche i giurati, i loro segretari, il mastro notaro dell’Hurtado ed un altro sacerdote. Ai protagonisti secondari il vescovo concesse subito l’assoluzione mentre lasciò l’Hurtado almeno un mese “in un cantone di mia casa privo della comunione dei fedeli e con quelle amarezze che possono imaginarsi “. La reazione durissima del Platamone che, peraltro si era sempre comportato – a sentire il La Rosa - “con fina politica e prudenza”, sarebbe stata provocata dal fatto che l’Hurtado gli comunicò la sua nomina due mesi dopo averla ricevuta e il vescovo vide in questo ritardo l’ombra della macchinazione. La ricostruzione di questa vicenda, come la documentazione che il Diego Hurtado in questione è lo stesso del tempo di mons. Tedeschi - e non un suo omonimo come asserisce Leopoldo Zagami (Lipari e i suoi cinque millenni di storia, Messina, 1960., pag.276) - si trovano in G.IACOLINO, man. cit. Quaderno IIIA, pp.152 b, 153, 153°, 154,155. v. anche G.OLIVA, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparese nei secoli XVII e XVIII, op. cit; G.CATALANO, Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia, Catania 1950.
[7] G.CATALANO, Le ultime vicende della Legazia Apostolica in Sicilia, Catania 1950, p.91
[8] “ Il Santo Padre ci ha tolto la messa/ il re prepara la forca per i preti/ la Sicilia è fatta carne da salsiccia / qui vige la legge dei saraceni”in Brigantino. Il Portale del sud . Storie di Sicilia di F. MISURACA, www.ilportaledelsud.org.
[9] S. FODALE, op. cit., pag. 44.
[10] G. ZITO, op. cit., pag. 94-105.
[11] S. FODALE, Stato e chiesa: la prima controversia liparitana, in “Dal ‘constitutum’ alle ‘controversie liparitane’, op. cit.pp.115- 126. Anche se è stato fatto osservare che quello che si verificò soprattutto a partire dalla “controversi liparitana” fu “tanto strepito per nulla..”Il funzionamento dell’Apostolica Legazia non avea giammai intaccata l’autorità della Chiesa; il suo tribunale, che era presieduto da un ecclesiastico che si dava il titolo di Monsignor Giudice della Monarchia, limitavasi all’ingerenza di esso in poche quistioni riguardanti la disciplina, mai la fede, e soprattutto a conoscere le cause degli esenti ed in terza istanza quelle state decise dalla Curia Metropolitana; e ciò non che pregiudizio, talvolta di sommo vantaggio era tornato alla Chiesa, tanto che il Cattolicesimo in nessun luogo della terra ebbe mai più fervidi e convinti seguaci delle popolazioni siciliane”. G. OLIVA, Le contese giurisdizionali della Chiesa Liparese nei secoli XVII e XVIII, Messina 1905, pp. 91-93.(Archivio storico eoliano.it)
La "controversia": il conflitto si estende
La “controversia” investe tutta la Sicilia


A sinistra il duomo di Catania. A destra il palazzo vescovile di Girgenti
Ma ormai la vicenda stava uscendo dalle mura diocesane. Ai primi di febbraio del 1712 a tutti i vescovi della Sicilia pervenne – tramite il vescovo di Catania secondo quanto afferma il documento “Veridica Relatione” - una lettera circolare della S. Congregazione, datata 16 gennaio, con ordine di affiggerla in tutte le cattedrali. In essa si ribadiva la nullità della sentenza assolutoria in favore di Tesoriero e Cristò e, più velatamente, si mettevano in discussione gli esorbitanti poteri di giurisdizione ecclesiastica che la Monarchia soleva esercitare. Ci vollero due mesi per tirare le somme di come era stata accolta dai vescovi siciliani questa iniziativa. I vescovi di Messina, Siracusa e Cefalù rappresentarono alla Santa Sede le loro preoccupazioni, i vescovi di Palermo, Patti e il vicario generale di Monreale chiesero l'exequatur al Tribunale della Monarchia che lo negò, solo i vescovi di Girgenti, Catania e Marsala – e cioè mons. Francesco Ramirez, mons. Andrea Riggio e mons. Bartolomeo Castelli - pubblicarono nello stesso giorno , il 21 marzo 1712, il documento senza nemmeno chiedere l'exequatur[1] . Il vicerè finse di credere che si fosse trattato, per questi presuli, di un caso di omissione involontaria e richiamò cortesemente i contravventori. Questi all'unisono risposero che trattandosi di materia dommatica, di fede, concernente la salute spirituale dei fedeli e non di pura e semplice giurisdizione, ne avrebbero risposto solo al Sommo Pontefice.
Della vicenda cominciò a parlarsene anche all'estero. In Spagna uscì un libello anonimo polemico contro i vescovi di Lipari, Girgenti, Catania e Mazara dove - rifacendo in qualche modo la storia della “controversia” - si giustificava l'agire del Tribunale della Regia Monarchia contro la diocesi di Lipari[2]. In Sicilia invece il viceré cercava di mantenere la calma e reagì convocando a Palermo una consulta di cinquantanove teologi – di cui parla Sciascia nel secondo atto della sua Recitazione - per sottoporre al loro esame la circolare della S. Congregazione dell'immunità ecclesiastica. Il responso fu, naturalmente, che non si trattava di materia di fede ma giurisdizionale e quindi non intaccava né la fede né il dogma.


A sinistra il palazzo vescovile di Marsala. A destra una raffigurazione di Mons. Riggio, arcivescovo di Catania
Intanto a Lipari il canonico Hurtado, che teneva i contatti col vescovo, - forte del fatto che il Sant’Uffizio di Lipari era riconosciuto direttamente dipendente dal Sommo Tribunale del Sant’Uffizio di Roma - decise di convocare, nel maggio del 1712, nel Palazzo vescovile della Lipari bassa, un consiglio di ecclesiastici liparesi, “con sopravveste di Sant' Uffizio”, per definire le opportune sanzioni canoniche contro l'Aucello e gli altri ecclesiastici che continuavano a celebrare messa alle Grazie che era stata interdetta. Il consiglio spiccò un monito di scomunica che fu recapitato al delegato speciale del Tribunale della Monarchia con tutti i requisiti formali.
La reazione dell'Aucello fu dura e scomposta. Fece imprigionare il povero prete che gli aveva consegnato il monito e anche l'altro che gli portò l'ultimatum di Hurtado. Non solo, ma messosi a capo di un manipolo di una cinquantina di soldati spagnoli circondò il Palazzo vescovile , vi entrò con la forza e mise agli arresti domiciliari Hurtado e il confessore del vescovo. Cercò gli altri ministri della corte vescovile e del tribunale dell'inquisizione e incarcerò anche loro mentre lanciò minacce verso tutti quei sacerdoti che si erano dichiarati ubbidienti al papa.
Quindi presentò al vicario una parcella per le spese sostenute da lui e dalla sua scorta nella missione a Lipari e, di fronte alla obiezione, che la mensa vescovile non possedeva quella somma, fece sequestrare i beni personali del vicario minacciando la loro vendita all'asta per cui il malcapitato si vide costretto a cercare prestiti personali per far fronte alla richiesta.
Soddisfatto il problema economico l’Aucello decise di tornarsene a Palermo e di portarsi dietro prigionieri l'Hurtado ed altri importanti ecclesiastici di Lipari. Ma, a suo scorno, l’Hurtado poté opporgli una lettera del Segretario di Stato Vaticano, giuntagli proprio in quei giorni, che gli comandava di non abbandonare Lipari per qualsiasi motivo. Così Aucello se ne partì da solo con la sua scorta intimando però agli ecclesiastici liparesi di raggiungerlo a Palermo entro due mesi. Partì, abbandonando Lipari in una confusione maggiore di quella che aveva trovato al suo arrivo[3].


A sinistra,Papa Clemente XI. A destra ritratto del canonico Mongitore
Roma non poteva lasciar passare sotto silenzio quanto era accaduto. Il 17 giugno 1712 papa Clemente emanò una lettera apostolica nella quale ribadiva che la Chiesa di Lipari era immediatamente soggetta alla Santa Sede e scomunicava l’ Aucello e tutti quelli, di qualsiasi grado e condizione, che gli avessero comandato, eseguito, consigliato e approvato gli atti che questi aveva compiuto contro la diocesi di Lipari. Naturalmente contro questa scomunica l’Aucello fece ricorso al giudice della Monarchia. Della risposta di Aucello e di Palermo ce ne parla il can. Antonino Mongitore nel suo Diario:”Ricorsero al giudice della Monarchia, allora D.Francesco Miranda, spagnuolo, il quale ordinò al canonico che celebrasse, andasse al coro e passeggiasse come al solito; e così ordinò agli altri. E in fatti, senza curarsi di essa, seguitò come se non fosse stato scomunicato, con pubblico scandalo; così fecero gli altri con manifesto disprezzo della scomunica”.[4]
La scomunica dell'Aucello questa volta papa Clemente la comunicò con due Brevi anche al Vescovo di Palermo ed al viceré mentre qualche settimana prima aveva avviato una forte opera di pressione nei confronti dei vescovi che si erano dimostrati pusillanimi mancando di affiggere la lettera circolare della S. Congregazione, lodando invece quelli di Girgenti, Marsala e Catania. Finalmente il 30 giugno 1712 i vescovi renitenti – dopo due mesi di titubanza – si decisero a pubblicare il foglio della S. Congregazione.
Più tempo impiegò il Vescovo di Palermo che pubblicò la lettera insieme alla bolla di scomunica dell'Aucello il 22 febbraio 1713. Ma c'era voluto, per convincerlo, la minaccia di “sospensione a divinis “ da parte del papa.
Il viceré pazienta diverse settimane e il 22 marzo 1713 emana una ordinanza con la quale si riaffermavano i diritti dei sovrani della Sicilia e si dichiarava nulla la lettera della S. Congregazione dell'Immunità e qualunque altra disposizione provenienti da “corti estere” che venissero rese pubbliche senza il preventivo regio exequatur. Si scatena una forte contesa fra il potere della Regia Monarchia ed i vescovi costretti ad abbandonare le loro diocesi e rifugiarsi a Roma. Si cominciò col vescovo di Catania il 18 aprile 1713 – ed è quanto rappresenta Sciascia nell’Intermezzo fra il II ed il III atto – che dichiara di partire cedendo alla violenza. Mons. Riggio - di temperamento rude e focoso tanto da vantarsi delle ventotto liti che aveva in corso ma che non gli toglievano né il sonno , né l’appetito - aveva contrapposto all’ordinanza del viceré un suo editto a stampa nel quale bollava l’ingiunzione come “temeraria, orrida, scandalosa e perniciosa”. L’editto appariva come l’ennesima provocazione di questo vescovo nei confronti dell’autorità del viceré fra le quali spiccava la riesumazione di una vecchia scomunica inflitta al capitano d’arme e di giustizia di Catania, barone di Ficarazzi, annullata dal giudice della Monarchia, sentenza che di fatto il Riggio aveva accettata. Ricevuta l’intimazione a lasciare Catania, il vescovo “ bel lontano dal pentirsi di quel che haveva fatto, trascorse più oltre, fino a fulminare nell’atto della sua partenza l’Interdetto nella Diocesi, col pretesto d’essere stato espulso per pura violenza; e nello stesso tempo Scomunicò i due Officiali militari, dai quali gli era stata fatta l’intimatione dello Sfratto”[5]
All’espulsione del vescovo di Catania fa seguito quella del vescovo di Messina il 29 luglio, quindi il vescovo di Girgenti che partì il 28 agosto, il 27 febbraio del 1715 se ne partì il vescovo di Palermo A questo turbine di espulsioni – spesso scientemente provocate e ricercate[6] -i i vescovi reagivano con interdetti e scomuniche. Dovette partire anche il can. Hurtado[7] che abbandonò Lipari il 24 gennaio del 1714 lasciandosi anche lui alle spalle un editto di interdetto per l'intera diocesi.
Gli effetti sociali di scomuniche ed interdetti
Questo susseguirsi di scomuniche, interdetti, sfratti, arresti e quant’altro non lasciavano il popolo e molti degli stessi protagonisti indifferenti. La scomunica, come abbiamo visto, colpiva il singolo individuo e aveva effetti nelle relazioni sociali e se c’era chi non li rispettava c’era però chi li metteva in pratica ed anche chi, colpito, se ne faceva un tormento. Più grave. Come si è detto, era l’interdetto che praticamente impediva che nella comunità che ne veniva colpita potessero celebrarsi alcune funzioni religiose ed alcuni sacramenti e non solo la messa in pubblico ma soprattutto i funerali e anche la benedizione nuziale nei matrimoni ed il battesimo poteva avvenire in forma semplice e privata per non parlare dell’impossibilità di seppellire i morti i terra consacrata per cui i familiari dovevano trovare una collocazione provvisoria della salma in qualche giardino o podere.. Cioè la gente veniva colpita in momenti cruciali della vita che in una società com’era la Sicilia del 700 – ancora scarsamente secolarizzata – finivano coll’avere un risvolto sociale, alla lunga, traumatico.
Certo, era possibile trovare preti che ubbidivano alla Regia Monarchia e non tenevano conto di scomuniche ed interdetti ma non erano molti e spesso finivano con l’aumentare nel popolo confusione e disagio. Come accadde a Catania quando mons. Riggio partì, fu subito mandato nella diocesi il canonico Gaetano Buglio di Messina, in qualità di delegato del Tribunale della Monarchia e col compito di convincere i fedeli a disattendere scomuniche ed interdetto. Ma presto lui stesso fu raggiunto dalla scomunica pontificia e il popolo non sapeva più cosa pensare.
Fu il periodo in cui nelle zone di Catania, di Girgenti, di Mazara, di Messina ed anche di Lipari - cioè dove la gente era più frastornata da opposte sollecitazioni ad obbedire al re o al papa - cominciò a diffondersi una “cultura religiosa e pseudo teologica” di cui un anonimo[8] ci ha lasciato qualche memoria. Così la consacrazione da parte dei sacerdoti inosservanti non produceva nell’Ostia la venuta del “Sacrosanto Corpo, anima e divinità di Nostro Signore” ma quella di un demonio; “ si niega lecitamente il debito coniugale dalle mogli osservanti alli loro mariti inosservanti”; non si può pigliarsi nella Chiesa l’acqua benedetta perché in Chiesa inosservante e benedetta da sacerdote parimente inosservante, anzi stimano a grave peccato segnarsi con essa la fronte” e così via.
Per di più la stessa polemica che si diffondeva attraverso la stampa non lasciava indifferenti le autorità e la Regia Monarchia. Quando nei primi mesi del 1713 uscì il libretto “Difesa della verità” attributo a mons. Tedeschi, subito non produsse alcuna reazione, forse si pensò che l’avrebbero letto in pochi e quindi dimenticato. Ma non dovette essere così se Filippo V, nel febbraio del 1716, ordinò al Consiglio di Stato di farlo valutare da esperti per suggerire come farvi fronte. Ma gli esperti consigliarono al re di non prendere nessuna decisione per non provocare l’autore stimolandolo a procedere nella polemica con quella penna “tan empeinada y ensangrentada” cioè tanto corriva e infuriata[9].
Trovare una mediazione o abolire la Legazia?


A sinistra, Vittorio Amedeo II. A destra, il card. Tommasi.
Intanto il 10 giugno 1713 ad Utrecht, Filippo V di Spagna sottoscriveva la cessione della Sicilia al duca del Piemonte Vittorio Amedeo II di Savoia che veniva ad assumere il titolo di re. Nella disfida fra la Spagna e l'Austria il Piemonte, che in un primo tempo era schierato con la Spagna, era passato con l'Austria e, quando fu firmato il trattato, ottenne la Sicilia grazie alla volontà dell'Inghilterra che lo preferì ai Borboni ed all'Austria. Il nuovo re indugiò a prendere possesso della Sicilia e lo fece solo il 10 ottobre 1713. Egli per cercare di pacificare la situazione agì su due fronti. Da una parte confermò viceré e ministri e li esortò a tornare in lizza mentre intimò a preti, frati e fedeli di disattendere i moniti e i consigli di Roma minacciando carcerazioni, esili e confische. Dall'altra però cercò di intrecciare col Vaticano trattative diplomatiche tentando di fare intervenire anche l'ambasciatore di Francia.
Le attese della corte di Palermo dopo il cambio di regnante, sono espresse chiaramente nella seconda parte de la “Veridica Relatione”[10]: “Credevasi da ogni persona di buon senso, che la Corte di Roma, trovandosi sciolta verso del nuovo dominio, da quell’impegni, che haveva presi col precedente governo, non solamente si sarebbe astenuta dal far nuovi procedimenti ne’ primi mesi dell’acclamatione, ed incoronazione di Sua Maestà, ed in tutto quel tempo, che fusse necessario al nuovo Rè, per informarsi di questa contesa, ma di più havrebbe ricercate in ogni occasione le aperture, che potessero darle qualche speranza d’adequamento”.
Papa Clemente però non era disposto ad accomodamenti anzi, valutando che l’Inghilterra, sostenitrice dei Savoia, fosse poco interessata alle questioni religiose pensò che la nuova congiuntura gli permettesse finalmente di venire a capo di questo istituto della Legazìa che aveva creato tanti problemi. Così il 25 gennaio emise solenne scomunica contro il giudice della Regia Monarchia e contro tutti quelli che si erano adoperati a sfrattare i vescovi dalla Sicilia. Non era questo che l’ennesimo attacco che da Roma veniva al Regno di Sicilia dopo l’avvento di Vittorio Amedeo II. La “Veridica Relatione” li elenca tutti uno per uno.
Questa scomunica ebbe come effetto le dimissioni dalla carica di giudice del conte di Miranda perchè preso da scrupolo religioso e probabilmente colse anche l’occasione per sfilarsi da una realtà incandescente e tornarsene in Spagna . Fu messo al suo posto un dotto e pio canonico messinese, don Giacomo Longo forse con intenti di pacificazione. Il nuovo giudice però si manifestò determinato ed intransigente. E di questa sua determinatezza ed intransigenza se ne resero conto subito i Liparesi.
Il vicario generale don Diego Hurtado prima di partire da Lipari per via dello sfratto il 24 gennaio 1714, aveva predisposto, senza dare nulla a vedere, certo d’accordo col suo vescovo che era sempre a Roma, una sorta di bomba ad orologeria. Intrattenendosi in cordiale e familiare conversazione col luogotenente Giovanni Battista Castaldi, attendendo il mercantile che doveva portarlo a Civitavecchia, il canonico sembrava avere accettato con tranquillità e rassegnazione il provvedimento di espulsione. Ma la sera stessa della sua partenza, quando furono le otto, improvvisamente le campane della Cattedrale presero a suonare a morto e il mesto rintocco durò una buona mezz’ora. Ai curiosi ed alla guardia che raggiunsero la chiesa apparvero, affissi sulla porta, i “cedoloni” contenenti la scomunica per il luogotenente ed il suo aiutante e l’editto di interdetto per l’intera diocesi[11].
Uno dei primi provvedimenti del nuovo giudice don Longo fu quello di inviare a Lipari, quale delegato del Tribunale, il cappellano del Real Palazzo, don Giuseppe Marotta, col compito di convincere il clero a non tenere conto dell’interdetto e di garantire il normale esercizio del culto. Giunto a Lipari il 10 febbraio gli atti che il delegato compì non furono certo distensivi. Non solo mise in carcere i sei sacerdoti che apparivano come i più radicali e intransigenti del partito pontificio ed imprigionò i responsabili dell’affissione dei cedoloni della scomunica e dell’interdetto ed il sacrestano che aveva suonato le campane a morto, ma se la prese, mettendoli agli arresti, anche con quanti avevano negato il saluto ai due catapani per adeguarsi alle norme della scomunica.
Nello stesso tempo che usava il pugno duro, Marotta proclama “nullo, ingiusto, illegittimo, insussistente, irrito e di nessuna forza e valore” l’interdetto lanciato dal vicario Hurtado e minaccia di “scomunica maggiore riservata al Monsignor Giudice della Monarchia” chi si fosse comportato come se fosse ancora in vigore[12].
Quindi convoca il Capitolo della Cattedrale e pretende che si elegga il nuovo vicario episcopale in sostituzione dell’Hurtado. Risultò eletto il can. Emanuele Carnevale che si adoperò per riportare la tranquillità nelle isole. Ma era una pia illusione.
Il 17 settembre 1714 veniva pubblicata a Lipari la scomunica pontificia contro i militari che avevano espulso Hurtado, contro Marotta e i componenti la Curia di costui, contro il guardiano dei cappuccini e coloro che avevano officiato nelle chiese già interdette. Era l'atto che lasciava Lipari, per alcuni anni ancora, priva di funzioni religiose.
Il rincrudirsi del dissidio a Lipari si estese subito a tutta la Sicilia e innumerevoli furono le contestazioni tra i rappresentanti della Chiesa e le autorità governative, cui fecero seguito esili, carcerazioni e confische che si protrassero per tutto il tempo in cui Amedeo II di Savoia fu re di Sicilia.
Il lavoro in sordina della diplomazia
Intanto proprio nel 1714 mentre lo scontro si diffonde sul territorio dello stato, dietro le quinte, la diplomazia continua ad operare per trovare una soluzione. L’iniziativa forse più significativa, in questo periodo, fu quella che partì il 24 dicembre del 1713, il giorno della cerimonia dell’incoronazione del re nella Cattedrale di Palermo. Ce ne parla una fonte di parte regalista[13]. L’iniziativa prese le mosse da un gruppo di vescovi e prelati siciliani lì presenti fra i quali quelli di Siracusa, Cefalù, di Palermo e di Mazzara. Non era possibile, ragionavano questi, che se al papa fossero state presentate, nel modo adeguato, le ragioni del Tribunale della Monarchia non si sarebbe potuto trovare una soluzione. E si convenne d’accordo monarca e vescovi che questi ultimi avrebbero scritto alla Corte di Roma sollecitando un chiarimento. Ma le lettere non ebbero risposta ed allora il re pensò di mandare a Roma un suo informatore ed incaricò di questa incombenza l’abate Barbara di Santa Lucia. Questa volta il cardinale Paulucci, segretario di stato del papa, scrive, il 4 marzo, al Cardinale della Tremoille che allora era ambasciatore a Roma di Luigi XIV e si era assunto il ruolo di mediatore nella vicenda, facendogli presente che l’abate Barbara non poteva essere ricevuto perché stava per essere scomunicato essendosi compromesso nella diocesi di Catania dopo l’interdetto del vescovo Riggio e l’insuccesso del canonico Buglio. Quanto alla possibilità di un accordo bisognava prima consentire a delle richieste preliminari e cioè: “1. che si rimuovino, e revochino gli impedimenti frapposti all’osservanza dell’Interdetto nelle Città, e Diocesi a quello sottoposte; 2. che si cessi da ogni vessazione contro di quei, che hanno ubbidito, & ubbidiscono agli ordini della Santa Sede; 3. che si scarcerino tutti quei, che restano carcerati per tali cause; 4. che si richiamino i vescovi espulsi, come altresì il Vicario di Lipari, e tutti gl’altri Ecclesiastici sì Secolari, come Regolari sfrattati per le medesime cause, e che detti Vescovi siano lasciati nel libero esercizio della loro ordinaria giurisdizione”[14].
Una dichiarazione di rottura vera e propria che il cardinale di Tremoille cerca di mitigare con una sua memoria del 4 aprile 1714, indirizzata all’abate del Maro che rappresentava il re al corte pontificia. Il porporato francese affermava che, al di là di quanto era scritto nel documento, egli aveva potuto raccogliere dal papa, dal cardinale Paolucci e dal cardinale Albani, nipote del papa, che Clemente XI potrebbe mostrarsi più disponibile se “il Rè di Sicilia le aprisse una porta per uscire dal suo impegno”[15].
Ma era proprio questa “porta” che era difficile trovare e lo sarà per molti anni, tutti quelli in cui Vittorio Amedeo rimane re di Sicilia. Il fatto era che per il papa, quello della Legazia apostolica e del suo Tribunale, era divenuta una vera e propria fissazione che si era radicalizzata col peggiorare del suo stato nervoso. Tutte le notti – aveva confidato – gli appariva in sogno lo spirito del cardinale Tommasi – siciliano, della famiglia dei Tommasi di Lampedusa – morto l’anno prima in fama di grande dottrina ed in odore di santità che lo sollecitava, “sotto pena di dannazione, a distruggere detta Regia Monarchia”[16]. Probabilmente una via d’uscita per il papa sarebbe stata quella che – in un’altra lettera del 4 gennaio 1714 scritta dall’abate del Maro al re[17] - viene riportata come una confidenza del cardinale Paolucci al cardinale La Tremoille: il papa avrebbe fatto intendere al suo segretario di stato, “in maniera enigmatica”, che avrebbe potuto accogliere alcune richieste del re a condizione che Vittorio Amedeo, “com’era di dovere, si determinasse a levare le Investiture dalla Santa Sede”. Clemente XI cioè cercava di alzare la posta e faceva riferimento ad una pretesa sovranità della Santa Sede sulla Sicilia per cui il re, per essere riconosciuto tale, avrebbe dovuto ricevere l’investitura da parte del papa[18].


A sinistra , la corte di Luigi XIV. A destra, il card. Paolucci
E’ un tema che tornerà ripetutamente negli anni a seguire nelle varie trattative che cercheranno un “aggiustamento” della vertenza, ma mai questo tema dell’”investitura” sarà preso in considerazione dal Savoia il quale non poteva concepire che in pieno settecento, il secolo dei lumi, si venisse a riproporre una stagione delle investiture di stampo prettamente medievale. Per quanto debole fosse il nuovo sovrano, vaso di coccio fra i vasi di ferro delle grandi potenze europee, e per quanto bisogno potesse avere dell’appoggio pontificio, Vittorio Amedeo aveva però una dignità ed una cultura a cui non poteva abdicare. Inoltre proprio il trattato di Utrecht lo obbligava a tenere in vigore tutte le norme e prerogative del regno che andava a governare.
Così mentre il difficile lavorìo dei mediatori andava avanti il papa preparava bolle e costituzioni apostoliche che avrebbe rese pubbliche all’inizio del 1715.
L'11 gennaio del 1715 emetteva la costituzione “Accepimus super” in cui condannava la pratica dell'exequatur giudicato un “temerario attentato a quella sublime potestà di legare e di sciogliere che a Noi e al Romano Pontefice pro tempore esistente è stata trasmessa dal Signore, e che non è serva ma libera dalla soggezione della secolare potestà”. Il 20 gennaio dello stesso anno pubblicava la costituzione “Romanus Pontifex”che aveva già pronta dall'anno prima in cui metteva fine alla Legazia Apostolica giudicandola ingiuriosa del primato della Chiesa Cattolica e usurpatrice dei diritti del Santuario. Vi si diceva anche che il presunto privilegio, a suo tempo concesso da Urbano II al re Ruggero, era un falso o, quanto meno, un documento alterato; ed anche ammesso che fosse veritiero non si poteva ritenere trasmissibile in perpetuo. Infine si accusava il Tribunale della Monarchia di avere introdotto un altro capo della Chiesa diverso da quello venerato in tutto il mondo. Alquanto roccambolesco il modo in cui si fece entrare in Palermo questo documento eludendo il divieto e la sorveglianza: furono inserite cinquanta copie della bolla dentro fiaschi che sembravano pieni di vino.
Il Tribunale della Monarchia se era il più importante non era però l’unico contenzioso esistente fra le due corti. Vi era anche in discussione, per esempio, la riconferma della Bolla della Crociata: un atto pontificio che autorizzava i sovrani a raccogliere fondi per la lotta agli infedeli in cambio appunto di benefici spirituali o esenzione da astinenze e penitenze. Un privilegio istituito, probabilmente, fin dai tempi della prima crociata e di cui godevano i sovrani spagnoli da oltre un secolo per ricavare proventi nella lotta contro i Turchi. Ora, però, Clemente XI non voleva concederlo a Vittorio Amedeo se non in cambio dell’investitura.
Ma se nel corso del 1714, mentre procedevano i contatti diplomatici, il papa affilava le armi di guerra non da meno faceva il re. Il 7 febbraio di quell’anno, infatti, istituì la Giunta stabile per gli Affari ecclesiastici, dotata di poteri illimitati, per la difesa dei diritti regali contro gli attentati della corte di Roma. Presto la Giunta si rivelò una sorta di inquisizione politica che si distinse per la sua aggressività ed efferatezza e soprattutto, a partire dal 1715, quando si conoscono le costituzioni pontificie contro l’exequatur e la Legazia, in Sicilia si diffonde un vero e proprio clima di terrore nel quale si distingue appunto quel Matteo Lo Vecchio che Sciascia ci presenta nell’atto quarto della sua Recitazione.
Il papa sperava che assumendo una posizione rigida nei confronti di Vittorio Amedeo e della Legazia avrebbe incontrato il favore delle potenze europee e del popolo siciliano che si sarebbe ribellato al sovrano. Invece gli stati stranieri, salvo l’Austria, si disinteressarono della questione ed il popolo non sapeva se prendersela col re o col papa, si lamentava per le restrizioni e le difficoltà che scomuniche e interdetti gli procuravano, ma aveva altre cose a cui pensare che alla ribellione. Il soli a mobilitarsi furono il clero ed i religiosi. In questa protesta si distinsero in particolare le suore come quelle di Girgenti che dopo aver murato le porte del loro convento esponevano sul campanile l’immagine del crocifisso coperta di veli neri in segno di lutto[19] o quelle di Palermo che rifiutarono il confessore straordinario Marotta e il loro cappellano perché erano stati a Lipari per conto del Tribunale della Monarchia e quindi scomunicati dal papa[20]. Ma la confusione nel popolo – quella confusione che già imperversava fin dai primi anni della “controversia” – ora cresceva di livello ed era sempre più difficile distinguere fra il clero patriottico su cui pesava la scomunica ed il clero di osservanza pontificia. E se più numerosi erano forse questi ultimi non mancavano nemmeno gli altri come quel padre Agostino Campanella, frate domenicano, che nella cattedrale di Palermo predicava che la gente ed il pontefice avevano tradito il Signore e faceva pregare “acciocché Dio illumini il Papa”[21],
Col tempo la situazione precipitò ulteriormente e numerosi furono gli ecclesiastici e i frati che abbandonarono la Sicilia. Nell'anno 1717, si è detto, nella sola Roma circolavano oltre millecinquecento sudditi siciliani perseguitati e sfrattati. Il 5 aprile furono scacciati da Palermo un centinaio di Cappuccini, altrettanti agostiniani e numerosi parroci e cappellani mentre il popolo appariva sempre più perplesso e confuso: si negavano i sacramenti a molti, si seppellivano i morti in luoghi non consacrati, matrimoni e battesimi si celebravano in fretta ed in una cornice di squallore, le processioni si tenevano con finti frati. Il re ed il viceré si videro costretti a richiamare la Giunta suggerendo maggiore moderazione, ma non la si volle fermare. Il re si limitò a ordinare che “i religiosi che debbono imbarcarsi non escano processionalmente dai loro conventi “ per evitare “le emozioni”.[22]


Lo scrittore Leonardo Sciscia che nella sua Recitazione sulla Controversia Liparitana fa di Matteo del Vecchio un personaggio quasi positivo. Il vicolo di Palermo intestato a questo "sbirro"
Il primo luglio 1718 gli spagnoli occuparono di nuovo la Sicilia e. Filippo V il 7 aprile del 1719 stipulò col papa un “trattato di accomodamento” nel quale, fra l’altro, si riconosceva l'efficacia delle scomuniche e si riammettevano i prelati esuli. Nel trattato non si diceva niente della “Legazia apostolica” e le cose sembravano andare come prima perché rimaneva il vigore il Tribunale della Monarchia. Il 1718 ed il 1719 furono due anni drammatici in cui gli “osservanti” a lungo repressi cercarono la loro rivincita nei confronti dei “patriottici”. Fu in questo clima che venne assassinato Matteo Lo Vecchio. Questo “sbirro” si era reso particolarmente odioso perché “passava di sacrestia in sacrestia, intimando e minacciando preti , e, senza distinzione, insultandoli tutti”[23]. Si appostava lungo le strade e fermava i passanti minacciandoli e questi per sottrarsi alle sue pressioni erano costretti a pagare. Ma intascati i soldi il Lo Vecchio riprendeva le sue vessazioni. Una volta si finse malato a morte e chiese un confessore. Accorsero i cappellani della vicina parrocchia e si dissero pronti ad assolverlo se si fosse dichiarato pentito di quello che aveva fatto contro la Chiesa. Ma a quel punto, il falso moribondo, balzò arzillo dal letto ed acciuffò i preti intimando loro lo sfratto dalla Sicilia.[24] Le sue angherie poterono andare avanti fino alla notte del 21 giugno del 1719 quando all’una, gli spararono due colpi di carabina proprio di fronte alla cattedrale. “Condotto a seppellire – racconta il La Lumia – nel giorno seguente, la plebe con fischi e dileggi accompagnò il cadavere, che, respinto da’ frati della chiesa di Santo Antonio, fu gettato in un pozzo secco fuori del sacrato di un antico cimitero suburbano”.
Nel maggio del 1719 gli austriaci subentrano al governo savoiardo e spagnolo in Sicilia e il Vaticano fiutando questo cambiamento cercò di rilanciare la bolla “Romanus Pontifex” ma la cosa , ora che comandava a Palermo, non piacque a Vienna. Il papa allora cambiò strategia e decise di applicare il “trattato di accomodamento” facendo pervenire i decreti abolitivi degli interdetti.
[1] “Veridica Relatione…”, doc. citato, pag. 8.
[2] Il libello senza data né luogo di stampa, pubblicato anonimo ma attribuito ad un certo don Francisco Amiglier recava un titolo chilometrico ed altisonante: “Propugnacolo dela real jurisdicion, protection de las regalias del regio exequatur y de la real Monarquia, patrocinio de la jurisdicion de los metropolitanos y de los privilegios del Reyno de Sicilia en respuesta de las rappresentaciones esparcidas por los illustrissimos Senores Obispos de Catania, Girgenti y Mazara, sobre la execution de las Cartas cuirculares de la Sagra Congregacion de la Immunidad, tocantes a recursos, ò Apelaciones de las declaratorias de censuras reservadas à la S. Sede Apostolica, y su assolucion à cautela, ò relaxacion por via de nullidad, ò injusticia”.A questo libello, aveva inteso rispondere il libretto di oltre 100 pagine, anch’esso anonimo e senza luogo di stampa, intitolato “Difesa della Veritè…” attribuito a mons. Tedeschi.
[3] Su questa vicenda della reazione dell’Aucello al monitorio di scomunica, della presentazione della nota spese, delle minacce ed in fine della sua partenza si fa riferimento al libretto più volte citato: Anonimo, Difesa della verità…., pp.28-29 ed al manoscritto di G. IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, quaderno IIIA, man. Cit., pp.104- 105.
[4] “Dal “Diario”del Canonico Mongitore”, Appendice, in , L.SCIASCIA, L’onorevole, Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D.. I mafiosi, Adelphi, Milano, 1995, pag. 147.
[5] “Veridica Relatione…”, doc. cit., pag.10.
[6] Mons. Riggio scriveva al vescovo di Girgenti in quei giorni:: “Che sorte di consolazione si è la mia di questa santa unione di queste Colleghe non può crederla! Brillo, giubilo, e salto pieno di giubilo e di contento. Viva V.S. Ill.ma, autore d’ogni bene, viva monsignor Vescovo di Mazzara che col suo zelo ci ha posto la sputazza al naso e sfida l’Inferno” in G.IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, Quaderno IIIA, man. cit., pag. 106.
[7] La ragione dell’espulsione di Hurtado è da ricondurre ad un episodio specifico. Un tale Alfonso Mercorella volendo sposarsi ed avendo un impedimento chiede la dispensa alla S.Sede. Una volta ottenutala, la sottopone all’exequatur del Tribunale della Monarchia ma, a questo punto, quando si presenta a Hurtado se la vede rifiutare proprio perché aveva l’approvazione governativa. Proteste del Mercorella al governatore e ordine del viceré di espulsione del vicario.
[8] Manoscritto, già citato, “Delle Vertenze fra la Corte di Roma e il Governo della Sicilia”, Tomo Primo, Parte Quarta, pag. 127° e ss.
[9] Il documento si trova nell’Archivio General di Simanca, Legaio 6124, n. 34 e 38 citato da G. IACOLINO, nel dattiloscritto “La chiesa cattedrale di Lipari”, Quaderno IIIA, pagg. 107 a e b.
[10] “Veridica Relatione”, doc. cit. pp.12 e ss.
[11] “Delle vertenze fra la Corte di Roma e il Governo della Sicilia”, manoscritto cit., Tomo I, Parte II e III, pp.98-99°.
[12] “Delle vertenze…” manoscritto cit., pag. 99.
[13] “Veridica Relatione…”, doc. cit., pag.20 e ss.
[14] “Veridica Relatione…”, doc. cit., in allegato: “Nota delle memorie cennate nella veridica Relatione, e confronto de’ procedimenti delle due Corti di Roma e Sicilia nelle note Vertenze per Fatto del Tribunale della Monarchia”, “Memoria rimessa dal Cardinale Paulucci al Cardinale della Tremoille, continente le pretensioni della Corte di Roma per un adeguamento. Li 4 marzo 1714”.
[15] Memoria del Signor Cardinale della Tremoille rimessa al Signor Abate del Maro, li 4 Aprile 1714, in appendice alla “Veridica Relatione…”doc.cit.,.
[16] Lettera dell’abate del Maro al Rè del 24 dicembre 1713, in Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell’isola di Sicilia, a cura di V.E. STELLARDI, vol. II, Torino, 1862, pagg. 27-28.
[17]Il Regno di Vittorio Amedeo II…., a cura di V.E. STELLARDI, vol.II, pagg. 135-137.
[18] I. LA LUMIA, op.cit., pag. 206.
[19] I. LA LUMIA, op.cit., pag.241.
[20] G. IACOLINO, La Chiesa Cattedrale di Lipari, Quaderno IIIA, datt. Cit., pag. 116.
[21] I. LA LUMIA, op.cit., pag. 241.
[22] G. IACOLINO datt. cit. pag. 124.
[23] I. LA LUMIA, op. cit., pag.254.
[24] I. LA LUMIA op. cit., pag. 254. A. MONGITORE, Diario, VIII, pag. 251 e ss.(Archivio Storico Eoliano.it)
La "controversia" ; il fatto scatenante e il formarsi di due opposte visioni
Due versioni a confronto

Una veduta di Marina corta dell'Arciduca d'Asburgo.
Il fatto accade, come abbiamo detto, nella Marina San Giovanni di Lipari il 22 gennaio del 1711, dinnanzi al negozio Nicolò Buzzanca dove erano in mostra, fra le altre merci, anche una modesta partita di ceci che aveva fatto recapitare il procuratore generale della mensa vescovile. Quando passano i catapani Battista Tesoriero e Jacopo Cristò prelevano, dalle merci esposte e quindi anche dai ceci. il “diritto di mostra”.
Di questo episodio abbiamo diverse versioni sia di parte regalista[1], sia di parte curialista.
Una versione, di parte regalista, ci rende edotti che i ceci che i due catapani prelevano non sono più di 800 grammi e i due non sapevano nemmeno che si trattasse di ceci della mensa vescovile perchè il bottegaio glielo avrebbe taciuto. Tanto è vero che quando il giorno dopo il Buzzanca glielo comunicò, Tesoriero e Cristò, per cortesia e rispetto verso il vescovo, restituirono immediatamente l'equivalente in denaro dei ceci che avevano prelevato. Tutto risolto? Niente affatto.

Un'altra immagine di Marina corta
Quando a Mons. Tedeschi raccontarono l'accaduto questi si infuriò, montando in escandescenze. “Parve che le due bocche d’Inferno, Stromboli e Vulcano…, soffiato avessero nel cuore del Santo Vescovo incendi di sì vehemente furore che, divenuto Mongibello di eccidi, eruttar parea fiamme di orrende minacce. Accorsero, per tranquillizzare la mente cos’ agitata, dal Vescovo l’accatapani medesimi protestandosi prima d’ogni altro ignoranti di essere quei ceci robba propria del lor Prelato, e in oltre pretesero tranquillarlo adducendo l’antico et inveterato costume de i loro antecessori soliti esigere simili paghe su le robbe degli Ecclesiatici.., protestandosi parimenti con enfasi di umiltà avere il dimani restituito…il prezzo delle due libre e mezzo di ceci”[2].
Accorsero anche i giurati ed il governatore che cercarono di spiegare al vescovo che egli poteva liberamente vendere a chi volesse i prodotti della sua terra nel proprio palazzo ed essi avrebbero chiuso un occhio, come era avvenuto con i suoi predecessori, ma se ricorreva alle botteghe pubbliche si sarebbe dovuto sottomettere alle regole annonarie della città.
Questa dichiarazione fece infuriare il vescovo ancora di più e pensò che era il momento in cui tutti i nodi dovessero venire al pettine e soprattutto che fosse venuto il momento di dichiarare guerra al Tribunale della regia Monarchia ed alla Legazia Apostolica adempiendo alla missione che gli era stata affidata.
Mons. Tedeschi “che avea fisso nel cuore valersi anche da così tenue congiuntura per devenire al disegno già preventivamente comminato col Vescovo di Catania e Girgenti, non poté lasciarsela scappare dalle mani; onde, sordo alle umiliazioni delli accatapani ed otturato l’orecchio alle rispettevoli rappresentazioni così de’ Giurati come del Governatore, senza mica riflettere agl’inconvenienti ed agli scandali che potean produrre le minacciate pubblicazioni di censure negli animi di quei naturali...” e ”senza badare alle circostanze del tempo e del luogo, del luogo, perché in Isola assai esposta all’invasione dei nemici, del tempo, perché così costituivasi quell’Isola in prossima disposizione di un Popolare sollevamento, con evidente pregiudicio del Ré cattolico…” chiamò il vicario generale, don Emanuele Carnevale, ed ordinò di imbastire il processo contro i due catapani. Di più, credendo con questo di tirarsi la gente dalla propria parte, ordinò al parroco di predicare in chiesa che la pena, per chi entrava in contesa con il vescovo, era la scomunica e questa sarebbe stata estesa anche a chi avesse solidarizzato con i contendenti. Una tale affermazione fu accolta da forte sdegno da parte del pubblico che fece “dalla Chiesa togliere le loro sedie per non più intervenirvi”[3].
“Ricorsero gl’Accatapani per riparo di questa strana Scomunica al Tribunale della Monarchia, ed ottennero primieramente, per poter comparire in giudicio, la necessaria assoluzione con reincidenza, ò sia la Sospensione delle Censure, ed indi poscia rapportarono la giustissima dichiarazione della loro nullità . Ma il Vescovo subito ch’ebbe la notitia del ricorso, portossi a Roma per sollecitare quella Corte a non perdere l’opportunità da lui procurata; ed ottenne per tal effetto dalla Congregazione dell’Immunità due lettere, una del 15 Agosto 1711 diretta à se medesimo, e l’altra del 16 Gennaro 1712 circolare a tutti i Vescovi del Regno, nella quale si dichiara non spettare né a’ Cardinali né a’ Legati à latere, né ad altri di qualsisia dignità l’autorità d’assolver con reincidenza, né di conoscer l’ingiustizia delle Censure dichiarate dagl’Ordinarj, e riferire al Papa per causa di lesa Immunità Ecclesiastica”[4].
La “verità del processo”
La mattina del 26 gennaio si tiene il processo[5] a porte chiuse, sotto la presidenza del vicario generale don Emanuele Carnevale e l’assistenza del procuratore fiscale don Bartolomeo Bongiorno, ed i punti che emersero nelle sette testimonianze delinearono un racconto diverso e per molti punti contrastante con quello dato dai magistrati locali e fatto circolare nel regno. Queste testimonianze furono raccolte e sottoscritte quasi tutte il 26 gennaio salvo due che portano la data del 30. Il canonico don Gaetano Cirino, liparense dichiarò di trovarsi la sera precedente nella piazza di Marina S. Giovanni e di avere sentito il Tesoriero ed il Cristò riconoscere che i ceci erano frutto della Mensa vescovile e malgrado ciò pretendere il diritto di “mostra”. Lo stesso negoziante Nicola Buzzanca, nativo di Gioiosa Guardia, testimonia di avere avuta una discussione con i catapani che prima volevano fargli abbassare il prezzo e poi, convalidato quello esposto pretesero la “mostra” dicendo che non importava che fosse “robba del Vescovo”. Alla conversazione, riferisce il Buzzanca, era presente Francesco Conti di Giovanni, pubblico pesatore. Iacopo Panitteri, liparese di 56 anni circa affermò di essere stato per nove anni pesatore e certificatore delle decime quando era vescovo mons. Ventimiglia ed i legumi riscossi come anche le pere, le prugne, le mele i carciofi ecc. venivano venduti nei negozi cittadini senza mai pagare alcun diritto di mostra ai catapani. Anzi per alcuni anni egli esercitò anche l’ufficio di catapano e “mai si prese mostra delli frutti e legumi che solia vendere questa Mensa vescovale alle pubbliche apoteche”. Pasquale Benenati, liparense di 76 anni circa riferisce come negli anni scorsi avesse macellato alcuni vitelli dentro il Vescovato e li avesse venduti senza licenza dei giurati e dei catapani e senza diritto di mostra, come diritto di mostra non ha mai pagato per la vendita dei legumi raccolti nei terreni del vescovo, né ha saputo di altri che li hanno pagati. Antonino Picone di anni 83, mastro Gaspare Matracia e il canonico Antonino Gauteri, questi il 30 dicembre, dichiarano cose simili a quelle emerse nelle precedenti testimonianze. Il canonico Giacomo Zichitelli, infine, anche lui in una deposizione del 30 gennaio, riferisce che per quattordici anni fu procuratore della mensa vescovile col defunto mons. Ventimiglia, ed afferma che “ non si pagò mai alli mastri di piazza di suddetta Città, vulgo Acatapanij, dritto alcuno per ragione di mostra tanto nella vendita del formaggio quanto di qualunque cosa commestibile; anzi, quando si macellavano, d’ordine di Monsignore Ill.mo, nel suo Palazzo le vitelle, i mastri di piazza non s’ingerivano mai a tastare il prezzo d’essi quantunque si vendevano pubblicamente quanto in città quanto nel borgo, né a loro si dava cosa alcuna per detta causa”.
Bastarono le dichiarazioni del giorno 26 perché il vescovo ed il vicario generale giudicassero che ci fosse materia sufficiente per emettere, lo stesso giorno, nei confronti dei catapani un “monitorio[6]”, nel quale erano chiamati, entro 24 ore, a discolparsi dell’accusa di aver ritirato “una aliquota – che dicesi di ragione di mostra –sui legumi che loro sapevano essere della Mensa Vescovile” pena la scomunica prevista per i violatori dell’immunità e della libertà ecclesiastica.
La risposta[7], stesa da mani esperte, presentata entro i termini previsti, aveva tono di supplica, ma produceva delle affermazioni che contrastavano decisamente con le testimonianze raccolte dalla Corte vescovile. In essa i catapani riferiscono di essere stati chiamati dal Buzzanca per verificare e fissare il prezzo a “tumini dui di ciciri” e fu stabilito, tenendo conto delle spese, il prezzo di “grani otto il rotulo” e fu lo stesso bottegaio a richiamarli perché si pigliassero “ la mostra secondo il solito ed antichissimo costume dandoci ad ogn’uno mezzo rotulo di detti ciceri”. Solo la sera dello stesso giorno il Buzzanca disse al Tesoriero che i ceci erano del vescovo, il quale, “per atto di venerazione” pagò al bottegaio grani quattro per la mostra ricevuta e lo stesso fece il Cristò, per cui del tutto inaspettatamente il giorno 26 ricevettero il “monitorio”. I supplicanti affermano che non era loro intenzione portare pregiudizio al vescovo, non sapevano che i ceci fossero suoi e, saputolo, restituirono la mostra “per atto di venerazione, stante che tutti l’antecessori di V.S. Ill. delle robbe commestibili che hanno fatto vendere alle Piazze pubbliche sempre hanno ricevuto le mostre competenti alli Capitani passati per ragione di meta così di carne pecorina, formaggi, come pure di frutti si come V.S. Ill. dalli decimieri passati e da’altri antichi Mastri di Piazza si potrà informare, come pure dallo hortolani delli Predecessori di V.S. Ill. sempre si ha pagato tarì uno alli Catapani per aggiustarci la bilancia e pesi, ed anche le mostre delle robbe che vendevano, essendo tutto ciò fatto di verità spettandoci pro iure laboris e non per dazio”. Così hanno seguitato a fare i firmatari dell’esposto, ignari del diritto, seguendo “il solito ed inveterato stile e costume”.
Conclusione, gli scriventi non hanno commesso ombra di peccato e, non essendoci peccato, “non può giammai cascare Scomunica” da qui la supplica di compatire la loro ignoranza e di cancellare il monitorio.
Come si può ben notare i punti maggiormente controversi risultano, come si è già fatto cenno: il fatto che i catapani sapessero o non sapessero che i ceci erano della mensa vescovile; la restituzione o meno da parte dei catapani del diritto di mostra in natura o in denaro una volta appreso che i ceci erano del vescovo; l’affermazione che era costume che si pagasse il diritto di mostra ed altre prestazioni sui prodotti della mensa vescovile e che così avevano fatto tutti i predecessori del vescovo Tedeschi.
A leggere la risposta di Tesoriero e Cristò non può non emergere che il tentativo che si fa – e nemmeno tanto nascosto – è di fare apparire il vescovo non come colui che difende una prerogativa della sua diocesi sancita dalle consuetudini se non dalle leggi, ma come l’arbitrio di chi vuole imporre una norma nuova mai esistita e di volerla fare passare sulla pelle di due malcapitati che accetterebbero questa sopraffazione solo “per venerazione”. Cioè un vero e proprio capovolgimento delle ragioni e delle responsabilità. Infine, sembra di scorgere dell’ironia in quel: non c’è peccato e, non essendoci peccato, non ci può essere quindi scomunica. Un’ironia ed una impostazione che non poteva essere opera dei due catapani, modesti artigiani, ma svelava che vi era la mano sicuramente dei giurati che potevano avere, se non ideato, almeno cavalcata questa vicenda con l’obiettivo di colpire i privilegi della mensa e di costringere il vescovo, da quel momento in avanti, a sottostare agli obblighi fiscali comuni a tutti i cittadini.
Le controdeduzioni della corte vescovile[8] arrivano a tamburo battente, lo stesso 27 gennaio. La supplica contiene – è detto – molte cose false o del tutto inconsistenti nella sostanza. Le cose false riguardano l’accaduto perché sono smentite dalle testimonianze; quelle inconsistenti riguardano le consuetudini a cui i catapani si appellano sostenendo che non è mai esistita una esenzione per i beni della mensa vescovile. “Nel caso che potesse pur esserci qualche normativa o una qualche pretesa consuetudine, i Giurati o i Magistrati locali sarebbero tenuti – sotto la medesima pena di Scomunica latae sententiae – ad abolire immediatamente o, quanto meno, a dichiarare che ne restano escluse le persone ecclesiastiche e le loro cose”.
Quanto all’ignoranza che i catapani chiamano in causa a propria discolpa “il Vescovo fa sapere ad essi ed ai loro conniventi che questa pretesa ignoranza non li favorisce in alcun modo. Infatti dal processo e dalle testimonianze risulta evidente che, se ignoranza ci fu, questa fu chiaramente un’ignoranza grossolana, premeditata, supinamente accettata e recitata, che non può assolutamente sottrarsi alla censura”.
La sentenza venne prorogata di tre giorni – come è detto nel comma conclusivo delle controdeduzioni - perchè, essendo giunta la notizia della vittoria dell'esercito di Filippo V, l'indomani si sarebbero tenute cerimonie pubbliche; inoltre perché il vescovo sperava ancora che gli accusati fossero in grado “ di addurre altri elementi più rilevanti senza che debbano essere ulteriormente ammoniti né ascoltati “.
Dei tentativi fatti dal vescovo per cercare di fare cambiare posizione ai catapani cercando di distaccarli dai loro “conniventi” se ne parla i in quel libretto anonimo – di cui abbiamo già fatto cenno – intitolato “Difesa della Verità a favore di Monsignor Tedeschi, Vescovo di Lipari” attribuito allo stesso vescovo. Un messaggero del vescovo andò dai catapani perché recedessero dalla loro posizione . Ma essi risposero che non potevano perché “li Giurati cel proibivano[9]”. Altrettanto inutile risultò il tentativo di un canonico della Cattedrale di fare intervenire il governatore sui giurati.
Falliti questi tentativi, la mattina del 31 gennaio il vescovo fece suonare le campane a morto significando che era stata emesse la sentenza di scomunica “vitandi” contro i due catapani per avere “violato l'immunità e libertà ecclesiastica”. Questa sentenza – oltre che letta dal pulpito della Cattedrale in una chiesa gremita di folla curiosa -fu affissa, alla porta della stessa chiesa e della Madonna delle Grazie nella città alta e, nel borgo, alla porta di San Giuseppe e nella pubblica piazza di Marina San Giovanni. Era la più dura censura canonica che si potesse comminare ed escludeva, chi ne era colpito, dalla conversazione, dal consorzio e persino dal saluto degli altri cristiani. E per lo stesso suono delle campane la curia volle tutelarsi mettendo agli atti due dichiarazioni, di un frate cappuccino e del canonico sagrestano della Cattedrale, che il ricorso alle campane era usuale per annunciare una scomunica.
La controversia dinnanzi al viceré ed a Roma
L'avvenimento ebbe grande ripercussione e clamore in tutta la Sicilia. Il giudice criminale d'intesa con il governatore e capitano d'armi ed i giurati – cioè tutte le autorità giudiziarie, militari e civili dell'isola – pensarono di ragguagliare subito il viceré don Carlo Antonio Spinola marchese di Balbasés. che, in quel tempo, risiedeva a Messina - accusando apertamente il vescovo di avere creato disordine nell'isola proprio in un momento così delicato giacché il regno era in guerra. Anche Mons. Tedeschi scriveva al viceré il 3 febbraio affermando che la scomunica non aveva creato il minimo disagio e rincarava le rimostranze nei confronti dei catapani e dei magistrati liparesi giudicati avversari della sua chiesa. Lo informava inoltre che avrebbe inviato don Giuseppe Todaro che, a voce, avrebbe meglio spiegato i fatti.
La risposta del viceré non si fece attendere: convocava il vescovo a Messina e autorizzava i catapani a ricorrere al Tribunale della Monarchia per farsi sciogliere dalla censura. Ma ancora prima che fossero giunte a destinazione queste disposizioni il can. Todaro si mobilita. Decide di partire per Messina la sera del 5 febbraio con un gruppo di preti e di chierici.

Messina, primi del Settecento
Siccome a Lipari – essendo periodo di guerra – c'è il coprifuoco e non si può lasciare l’isola di notte senza un permesso del capitano d'armi, i passeggeri si fanno passare per pescatori. Ma i magistrati di Lipari mangiarono la foglia e così quando il nostro canonico si presentò al viceré questi era già stato informato del suo comportamento e dopo averlo rimproverato lo fece mettere agli arresti nel carcere della cittadella di Messina. E’ la scena che Sciascia descrive nell’atto primo della sua Rappresentazione.
In carcere il can. Todaro ci rimase poco perchè fu subito scarcerato, non appena il vescovo Tedeschi andò a Messina ed ebbe modo di dimostrare al segretario del viceré che a Lipari era consuetudine che gli ecclesiastici potessero allontanarsi anche senza autorizzazione e d'altronde il canonico era andato a Messina per presentarsi al viceré, cosa che aveva fatto immediatamente . Così il vescovo convinse il segretario anche della inconsistenza di quelle accuse che sostenevano aver lui arrecato, con i suoi provvedimenti, disordine nell'isola e quindi pericolo per gli abitanti.
Ma se l'atmosfera fra Mons. Tedeschi e il Viceré si rasserenò, tanto che l'incontro che poco dopo avvenne si aprì in un clima di cordialità, questo non indusse il vescovo ad essere più morbido ed a fare un passo indietro sul tema della scomunica. Ed il viceré dovette contentarsi di lasciare il vescovo “nella sua ostinata durezza[10]”.
Intanto a Palermo il Giudice del Tribunale della Regia Monarchia, conte Francesco Miranda, il 6 marzo 1711, accogliendo il ricorso dei catapani, firmava un decreto assolutorio “ ad cautelam” in attesa della sentenza definitiva. Furono gli stessi catapani a recapitare questo decreto alla Gran Corte Vescovile di Lipari con l'ordine di rimettere a Palermo l'intero carteggio del processo. In assenza del vescovo il can. Emanuele Carnevale ritenne di dovere ottemperare alla richiesta. Bastò questo perchè Mons. Tedeschi lo sollevasse dall'incarico ed al suo posto nominasse il can. don Diego Hurtado.
Il vescovo respinse il decreto assolutorio considerandolo nullo ma non si appellò al Tribunale della Monarchia perchè lo riteneva illegittimo. Anzi, a suo avviso, l’assoluzione cautelare dei catapani da parte del Tribunale della Regia Monarchia rappresentava una ulteriore prevaricazione nei confronti della chiesa liparese perché ignorava o fingeva di ignorare che questa dipendeva direttamente ed esclusivamente dalla S.Sede.
Scrisse invece al papa ed al re di Spagna sperando in un intervento di sostegno e di difesa. Ma il tempo passava e risposte alle sue lettere non ne giungevano. Che non rispondesse il re poteva anche comprenderlo pensando che questi era stato informato già dal viceré e quindi non fosse ben disposto nei confronti delle sue ragioni. Ma il papa? Il papa che si era raccomandato con lui di non transigere sui diritti della Chiesa…. Sicuramente la lettera non gli era pervenuta.
E’ a questo punto Mons. Tedeschi fa due passi decisivi: prende contatti con gli altri vescovi della Sicilia per valutare insieme gli sviluppi futuri della vicenda; attende di ottenere un passaggio in nave per recarsi a Roma di persona dal papa. Ha così contatti epistolari con i vescovi di Girgenti, Mazara e Catania ed ai primi di giugno, col permesso del viceré, si imbarca su un galeone pontificio diretto a Civitavecchia.
Intanto il 31 maggio il Tribunale della Monarchia di Palermo aveva emesso la sentenza definitiva che aveva annullato la scomunica contro i due catapani e il 15 agosto, mons. Tedeschi, si fa rilasciare dalla S. Congregazione dell'Immunità ecclesiastica un rescritto di annullamento di questa sentenza “per difetto di giurisdizione”. Il rescritto va però oltre l'annullamento della sentenza ed afferma che “non è permesso né a Cardinali legati a latere, ne alli Arcivescovi, Vescovi, Ordinari de' luoghi, né a qualunque altro Tribunale... di concedere assoluzione alcuna, anche con reincidenza e a cautela, delle censure riservate al Sommo Pontefice”. In discussione non c’era più solo il caso di Lipari e lo speciale statuto di questa diocesi ma, di fatto, lo stesso Tribunale della Monarchia.
Copia autentica del foglio venne spedita al canonico Hurtado a Lipari perchè l'affiggesse alla porta della Cattedrale e “ai cantoni soliti”. Il povero vicario capì subito quali sarebbero state le conseguenze e tentennò molto ad eseguire la disposizione. Finalmente si convinse la notte del 2 novembre 1711. L'affisse di notte ed al mattino non c'era più perchè il capitano d'arme lo fece ritirare osservando che era privo del regio “exequatur”. Ci riprovò il successivo 2 dicembre e non ebbe miglior successo.
Il 4 dicembre fece sospendere la celebrazione della Messa perchè in chiesa c'erano i due catapani scomunicati e la stessa cosa ripetè il 25 dicembre, giorno di Natale, facendo per giunta ammantare a lutto la porta di S. Maria delle Grazie.
Fino ad allora, tutto sommato, la sfida fra istituzioni era rimasta circoscritta alla diocesi di Lipari e fu per questo che a Palermo si pensò di recidere il male alla radice intervenendo drasticamente nell'isola. Il giudice della Monarchia inviò un suo delegato speciale, il canonico don Vincenzo Aucello col preciso mandato di procedere contro coloro che avevano violato “le Regalìe Sovrane e ...ridare la tranquillità seriamente turbata in quelle isole”e, quindi in pratica, dimostrare e convincere i liparesi che, con l’assoluzione del Tribunale della Monarchia, i catapani non erano più scomunicati.
Il 21 gennaio del 1712 Aucello giunge a Lipari e non essendo riuscito a trovare il can. Hurtado il giorno 24, seguito da famigli venuti con lui da Palermo e da una discreta folla di curiosi isolani, andò alla chiesa di S. Maria delle Grazie e vi celebrò messa alla presenza di Tesoriero e Cristò. Poi cominciò a fare pressioni sul clero. Il giorno dopo costrinse il guardiano dei cappuccini a celebrare messa nella stessa chiesa alla presenza ancora dei due catapani.[11] Ma la maggior parte del clero si mostrò fedele al vescovo.
E così a Lipari nacquero due partiti anche se c’è da dire che il popolo osservava questi eventi più con curiosità che con turbamento, ed anzi ci prendeva gusto al dissidio ed ironizzava su di esso. Chi stava col vescovo era chiamato – con convinzione, ironia o disprezzo a seconda di chi lo pronunciava - osservante, curialista o pontificio mentre chi stava con Palermo – e fra il clero erano pochissimi – inosservanti, o regalisti o patriottici.
Alla sfida di Aucello rispose Hurtado interdicendo la chiesa delle Grazie in attesa di altri provvedimenti che avrebbero preso il vescovo e Roma.


Chiesa della madonna delle Grazie al Castello
In quei giorni i Liparesi poterono assistere a sfide inconsuete fra l'Aucello e l'Hurtado che passavano per le strade di Lipari, ciascuno con un codazzo di sostenitori, preceduti ognuno da un mazziere in livrea che teneva in bella vista la mazza d'argento simbolo del potere.
[1] Di parte “regalista” abbiamo in particolare la già citata “Veridica Relatione e confronto de’ procedimenti delle due corti di Roma e Sicilia nelle note vertenze per fatto del Tribunale della Monarchia”, pag. 7 e seguenti , e il manoscritto “Delle Vertenze fra la Corte di Roma ed il Governo della Sicilia” che si trova nella Biblioteca Universitaria di Messina e che parla del fatto di Lipari proprio all’inizio della Parte Seconda del Tomo Primo, pp.56 e seguenti.. Per la parte “curialista”, oltre al già citato libretto “Difesa della Verità…”, anonimo e senza luogo e data di pubblicazione ma attribuito a Mons. Tedeschi stesso, vi sono i documenti del processo che insieme al decreto assolutorio del conte Francesco Miranda, giudice del Tribunale della Regia Monarchia, si trovano nell’Archivio Vescovile di Lipari, Carpetta 25 Processi Civili.
[2] “Delle Vertenze fra la Corte di Roma et il Governo della Sicilia”, Tomo Primo Parte Seconda, pag.57. Anche “Veridica Relatione…”, pag. 7
[3] “Delle Vertenze...”, pag. 58-59.
[4] ”Veridica Relatione…” pag. 7
[5] L’originale del verbale di 12 fogli è conservato nell’Archivio Vescovile di Lipari, carpetta 25, Procedimenti Civili.
[6] Il monitorio presente nel verbale è in latino, noi abbiamo fatto riferimento ad una traduzione del prof. Giuseppe Iacolino nel dattiloscritto “La Chiesa cattedrale di Lipari” Quaderno IIIA. Da Mons. Tedeschi e la Controversia Liparitana fino alla morte di Mons. Platamone (1733), pag. 98g.
[7] Nel verbale dell’Archivio Vescovile manca l’originale di questa risposta ed essa risulta solo in copia priva di destinatario, di firma e di data.
[8] Le controdeduzioni nel verbale presente in Archivio vescovile sono presenti solo in minuta.
[9] Anonimo, Difesa della verità a favore di Monsig. Nicolà Maria Tedeschi, pp 11-12.
[10] Anonimo, Difesa della verità, op.cit., pp. 15-16.
[11] Vedi documento pontificio a stampa su un solo foglio del 18 giugno 1712. “Clemens Papa XI. Ad futuram rei memoria”, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St. St. D2 d bis.(Archivio storico eoliano.it)
La controversia liparitana: le premesse
Perché la “Controversia liparitana”?
Dipinto del 700 di Marina corta
Era la mattina del 22 gennaio 1711 quando nella piazzetta di Marina Corta di Lipari, che allora si chiamava di San Giovanni ed oggi Ugo di Santonofrio, due vigili annonari che allora erano detti “catapani” o “accatapani”, entrano nella bottega, che allora si chiamava “apoteca”, di Nicolò Buzzanca per verificare la merce in vendita e riscuotere il cosiddetto “diritto di mostra” cioè una piccola parte di ciascuna di esse al fine di testarne la qualità e fissarne il prezzo e garantire che la qualità non sarebbe stata adulterata nel corso della giornata. Poi, a fine giornata, questo “diritto di mostra” veniva diviso fra i catapani visto che il loro era un servizio volontario che si aggiungeva gratuitamente alla loro professione. Cose di tutti i giorni. Ma quella mattina fra le merci in vendita c’è anche una partita di ceci che veniva dalla mensa vescovile e che per prassi consolidata – così sosterrà la curia ma la cosa (come altre di questa vicenda) non sarà così pacifica – era esente da ogni tassa o balzello o diritto di mostra che fosse. I due catapani che fanno l’ispezione nella bottega di Buzzanca sono Battista Tesoriero e Jacopo Cristò , due artigiani, fabbro ferraio il primo e argentiere il secondo. Sapevano i due che si trattava di merce della mensa vescovile? E’ questo uno dei nodi della questione su cui si creano due schieramenti con posizioni contrapposte. Come emergono due verità contrapposte anche a proposito della restituzione da parte dei catapani al commerciante se non dei ceci almeno del loro prezzo una volta conosciuta la loro provenienza. Come si formano ancora schieramenti contrapposti a proposito dell’esistenza o meno sui beni della mensa vescovile di un diritto di esenzione. La tesi dei catapani come dei giurati – gli amministratori comunali di allora – e poi del Tribunale della Regia Monarchia di Palermo sarà a favore dei catapani: non sapevano, restituirono l’equivalente, non era mai esistito un diritto di esenzione. Del tutto opposto il giudizio del Tribunale della curia vescovile che aveva competenza su tutta una serie di questioni che in qualche modo toccassero la religione, la morale e le strutture ecclesiastiche, persone o beni che fossero. E sulla base di sette testimonianze scritte, i cui verbali si trovano ancora nell’Archivio della curia vescovile di Lipari, viene emesso prima un “monitorio” cioè una sorta di “avviso di garanzia” come si chiamerebbe oggi, ingiungendo ai due malcapitati di discolparsi e dopo alcuni giorni – giudicata inconsistente la risposta – la sanzione e cioè la scomunica che allora non era solo una pena di carattere religioso ma aveva rilevanza anche sociale perché di fatto tagliava fuori dalle pubbliche relazioni, in una società ancora non secolarizzata, chi ne fosse colpito.

Il palazzo vescovile nel borgo dove risiedeva il tribunale ecclesiastico.
Dal Tribunale della curia e dal Tribunale della Monarchia il conflitto investe direttamente il Vescovo e lo Stato di Sicilia che allora era governato da un viceré per conto del re Filippo V di Spagna. In questione non ci sono solo una partita di ceci e la situazione di due catapani ma molto di più. La Diocesi di Lipari era ritenuta, per un privilegio che veniva fatto risalire ad una bolla del Papa Urbano II del 1091, direttamente dipendente dalla Sede Apostolica per cui i giudizi del Vescovo, nelle questioni in cui aveva competenza,potevano essere sindacati solo dal Papa. Il Regno di Sicilia però poteva vantare un altro privilegio, sempre risalente ad Urbano II, ma di alcuni anni più giovane di quello di Lipari, e cioè del 1098, che riconosceva il Re di Sicilia legato apostolico del papa per diritto di nascita e quindi con competenza non solo a nominare i vescovi di Sicilia ma anche a decidere, in sede di appello, sui temi riservati al giudizio dei vescovi e questo attraverso un apposito organo che si chiamava appunto Tribunale della Monarchia. Ora avveniva che il Regno di Sicilia ignorava o fingeva di ignorare la particolare situazione di Lipari e pretendeva di trattare questa come una qualsiasi diocesi siciliana. Da parte sua la Santa Sede mal tollerava l’ingerenza del re e di un tribunale civile nelle sue competenze e, in particolare papa Clemente XI, aveva come obiettivo quello di abolire la Legazia Apostolica. Il caso dei ceci del vescovo di Lipari diventa quindi il detonare di un conflitto più ampio e più subdolo. Più ampio perché investe due stati: quello di Sicilia e quello Pontificio e tramite loro il delicato e complesso equilibrio degli stati europei praticamente sempre in guerra fra di loro ed impegnati in una sorta di partita a scacchi dove lo spostamento di una pedina aveva ripercussione su tutto lo scacchiere. Più subdolo perché investiva questioni di potere in una zona controversa dove la politica si intrecciava con la religione ed era difficile tracciare una chiara linea di laicità: laicità dello stato e libertà della chiesa.
 E tanto è nodale questo conflitto che finisce con andare al di là degli stessi protagonisti infatti proseguirà anche quando il Regno di Sicilia passa da Filippo V a Vittorio Amedeo II di Savoia e poi ancora a Filippo e quindi agli Austriaci.
E tanto è nodale questo conflitto che finisce con andare al di là degli stessi protagonisti infatti proseguirà anche quando il Regno di Sicilia passa da Filippo V a Vittorio Amedeo II di Savoia e poi ancora a Filippo e quindi agli Austriaci.
Un conflitto che da Lipari si estenderà a tutta la Sicilia dove lo stato combatte con le armi dell’espulsione e del carcere e la chiesa con quelle della scomunica e dell’interdetto. Lo sfratto colpirà innanzitutto i vescovi che continueranno a pubblicare e fare osservare le scomuniche e quindi saranno costretti all’esilio lanciando, prima di partire, non solo scomuniche, che sono sanzioni che toccano singoli cittadini, ma anche interdetti che investono l’intera comunità diocesana con diverse ripercussioni, anche qui, sul piano sociale come l’impossibilità di celebrare pubblicamente matrimoni, battesimi, funerali e seppellire i morti in terreno consacrato quali erano praticamente tutti i cimiteri nella Sicilia del settecento. Nell'anno 1717 nella sola Roma circolavano oltre millecinquecento sudditi siciliani perseguitati e sfrattati.
Tutto questo andrà avanti fino al 1719 quando a Palermo giungeranno gli Austriaci ed il papa applicherà quel “trattato di accomodamento” che aveva firmato qualche settimana prima con Filippo V.
Il privilegio della Diocesi di Lipari di fatto si estingue nel 1749 quando il re riconosce senza reazione alcuna, la competenza - per un ricorso contro una decisione del vescovo di Lipari - del Tribunale della Monarchia. Mentre la Legazia Apostolica si trascinò fino al 1871 quando finalmente anche il governo italiano rinunciava ai diritti che da essa derivavano in Sicilia, rendendosi conto che contrastavano nettamente con i principi del separatismo liberale. .
Il nodo della Legazia Apostolica
Uno dei punti della Controversia è l’istituto della Legazia Apostolica e se la Chiesa di Lipari facesse parte o meno di essa. La cosiddetta “Legazia Apostolica”[1], da cui discende il Tribunale della Monarchia, si vuole fare risalire a Urbano II che il 5 luglio del 1098 per ringraziare Ruggero d’Altavilla di aver sottratto l'isola agli arabi e di averla restituita al culto della Chiesa di Roma, emette la bolla Quia propter prudentiam tuam. In essa si afferma: “Noi non stabiliremo, nel territorio di vostra pertinenza, alcun legato della Chiesa di Roma senza il volere ed il consiglio vostro. Che anzi tutte le cose che Noi intendiamo fare tramite un legato vogliamo che siano fatte dalla vostra opera come vice legati quando dal Nostro lato le commetteremo a voi per la prosperità delle Chiese che sono sotto la vostra potestà, ad onore di San Pietro e della Santa sua Sede Apostolica alla quale sino ad ora tu hai fedelmente obbedito e che, nelle sue occorrenze, hai aiutato con valore e fedeltà”.
Fosse o meno nella volontà di Urbano II, Ruggero interpretò queste parole come il diritto di nominare e trasferire, a suo piacimento, vescovi e prelati nelle terre sottoposte al suo dominio cosa d’altronde che aveva già cominciato a fare anche prima del 5 luglio 1098 a cominciare dalla nomina del vescovo di Troina nel 1080 costringendo, prima Gregorio VII e poi Urbano II a dare il riconoscimento canonico alle sue decisioni[2]. Su questa linea il Gran Conte istituì il “Tribunale della Monarchia” cui attribuì l’esclusiva competenza a deliberare, senza appello o ingerenze della Curia romana, su tutte le questioni ecclesiastiche siciliane, con esclusione delle materie che riguardavano dogma o che afferivano la salute dell’anima.
I contenuti e l’efficacia della bolla non rimase limitata a Ruggero di Altavilla, a cui il papa l’aveva indirizzata, ma venne ritenuta una prerogativa che si estendeva ai successori di Ruggero ed a tutti i sovrani di Sicilia, anche di diversa dinastia. Questi cercheranno di accrescere a loro vantaggio le implicazioni di questo documento definendosi “legati apostolici” per “nascita” mentre la Santa Sede farà di tutto per restringerne i termini e frenarne gli abusi, fino a definire falsa la bolla di Urbano II che invece era sostanzialmente vera.
Dopo il sec. XIII, in base alla documentazione nota, la politica ecclesiastica successiva alla dinastia normanna e fino al sec. XV pare sia stata determinata più dai tratti generali delle relazioni dei sovrani con il papato che dal privilegio della Legazia Apostolica[3] . Non scompare però l’ingerenza dei sovrani nella vita della Chiesa nei territori siciliani soggetti alla loro autorità.
Proprio sul finire del XV secolo viene introdotto in Sicilia il Tribunale dell’inquisizione spagnola con inquisitori nominati dal sovrano Ferdinando II il Cattolico re di Spagna, d’Aragona e, dal 1479 anche di Sicilia. Questo sovrano, oltre alla libertà di scelta degli inquisitori ottenne dalla Santa Sede la facoltà di nomina di vescovi e di prelati. Ed è in quegli anni che il giurista siciliano Giovan Luca Barberi, nella stesura del trattato De Regia Monarchia, riesuma la bolla di Urbano II[4] e con essa il privilegio della Legazia Apostolica – di fatto cadute nell’oblio[5] - affermando, sulla base di una artificiosa lettura della storia dell’isola, che non solo questo privilegio non era mai stato abolito dai pontefici, né vi avevano rinunciato i sovrani ma era stato sempre applicato e riconosciuto da tutti i successori di Urbano II[6]. E’ stato osservato che il Barberi diede al documento “nuova vita, creandogli attorno il grande edificio della Monarchia Sicula”[7].
L’avventurosa interpretazione del Barberi trovò numerose opposizioni e critiche soprattutto da parte della Santa Sede e fu allora che si tentò di accreditare la falsità della bolla attribuita ad Urbano. Comunque la tesi di Barberi si affermò e generò, fino all’Unità d’Italia, “uno stabile e singolare privilegio che ha determinato rapporti unici, intricati e litigiosi tra il potere statale e il potere ecclesiastico, con l’innegabile condizione di subordinazione del secondo al primo”[8]. In Sicilia, in forza del privilegio di Legazia, per nascita e non per nomina, perpetuo e irrevocabile e non a tempo definito, “il sovrano ha esercitato la giurisdizione civile iure proprio e la giurisdizione ecclesiastica e spirituale iure legationis”[9]. Era il giudice della Regia monarchia, le cui competenze erano stabilite unilateralmente dal sovrano, che aveva potestà sulle cause ecclesiastiche e sul controllo della vita della Chiesa siciliana. Un giudice che se inizialmente era un laico, nella seconda metà del Cinquecento divenne un ecclesiastico, con ufficio stabile e magistratura apposita chiamato Tribunale della Regia monarchia (1579). La finalità di questo Tribunale non era quella di contrapporsi alla Santa Sede affermando una propria ecclesiologia ma di tutelare delle prerogative locali.
L’istituto della Apostolica legazia andò, nel tempo, arricchendosi di competenze. Già sotto Carlo V fu istituito il visitatore regio che era un ecclesiastico che aveva la facoltà, tramite le sacre regie visite, di esaminare la lecita proprietà dei beni ecclesiastici e la loro corretta amministrazione, controllare gli arredi e le suppellettili sacre, vigilare sul servizio ecclesiastico in ciascuna diocesi.
Col moltiplicarsi di questi compiti all’interno della teoria legaziale si aveva una crescente ingerenza del potere laico esercitato dal viceré in nome del sovrano che incideva significativamente nella sfera di giurisdizione dei vescovi.
Deciso assertore della Legazia fu il viceré Giovanni de Vega che operò sotto il regno di Carlo V. La tesi del de Vega era che i vescovi erano feudatari del sovrano e dovevano comportarsi da buoni vassalli nel quadro della preminenza regia sull’isola che andava difesa e rispettata anche dai vescovi e da tutti gli ecclesiastici. Da qui il privilegio della Legazia inibiva al papa l’invio in Sicilia di legati apostolici con il potere di esercitare giurisdizione ecclesiastica ed obbligava i vescovi ad ottenere il regio placet e l’exequatur prima della pubblicazione ed esecuzione di documenti ecclesiastici prodotti in Sicilia, o provenienti dalla Curia romana[10].
Non è che questa ingerenza del potere regio nella sfera ecclesiastica fosse accettata di buon grado dai vescovi di Sicilia. Ed infatti la questione fu discussa al Concilio di Trento ( 1545- 1563) dove proprio sui canoni che prevedevano di demandare al pontefice l’esame e il giudizio delle cause criminali più gravi riguardanti i vescovi sottraendoli al potere regio, quale ne fosse l’origine, scoppiò uno scontro violentissimo in particolare fra vescovi francesi [11]che difendevano le prerogative regie ed i vescovi siciliani. Alla fine prevalse la posizione che sosteneva l’autonomia della Chiesa nei confronti della corona ma le decisioni del concilio tridentino ebbero scarsa efficacia in Sicilia dove fu dichiarato che la giurisdizione della Regia monarchia era superiore ai decreti tridentini[12]. Questa “prammatica” del re oltre a salvaguardare l’istituto della Legazia ebbe anche l’effetto di rendere più difficile in Sicilia la riforma della vita del clero e dei religiosi che era proprio l’obiettivo principale del Concilio e questo grazie al fatto che ogni ecclesiastico poteva ricorrere al giudice della Regia monarchia sfuggendo alla giurisdizione episcopale e dei legittimi superiori[13]. Unico effetto del Concilio fu che il sovrano Filippo II stabilì che il Tribunale della regia monarchia fosse un istituto stabile e che il giudice fosse un ecclesiastico costituito in dignità e non nominato dal vicerè caso per caso.
Comunque la polemica sulla Legazia continuò dopo il Concilio sotto i pontificati di Pio V e Gregorio XIII ma la corona spagnola rispose sempre con grande fermezza non manifestando, su di essa, nessun cedimento sostanziale ed il potere regio sulla vita della Chiesa siciliana andò sempre più consolidandosi e finì col manifestarsi anche plasticamente. Infatti in tutte le cattedrali siciliane fecero la comparsa due troni: a destra per il vescovo e a sinistra, in posizione più elevata, quello per il sovrano legato apostolico che, in quanto tale, riconosceva superiore a sé soltanto il pontefice[14]. Sul piano dei contenuti, oltre al diritto del sovrano di nominare i vescovi per ogni diocesi che lasciava al pontefice solo il compito di ratificare la nomina attraverso la consacrazione, si aveva – nel tempo – una crescita delle competenze del Tribunale della regia monarchia che si aggiudicò il diritto di assolvere dalle censure ecclesiastiche e di sospendere e dichiarare nulle le scomuniche. Il Tribunale inoltre mentre fungeva da appello per le sentenze emesse da vescovi ed arcivescovi relative ad ecclesiastici, nelle cause relative al matrimonio e per i cosiddetti reati di “misto foro”(usura, simonia, ecc.), impediva il ricorso alla Curia romana per la gran parte delle cause ecclesiastiche. In questo clima che perdurò per tutto il Seicento i conflitti di giurisdizione furono numerosi e la tensione fra Santa Sede e sovrano divenne esplosiva fino a culminare, nei primi anni del Settecento, nella cosiddetta “controversia liparitana”.
Una Diocesi tutta speciale
Come mai la periferica diocesi di Lipari diventa l’epicentro di uno scontro durissimo fra potere politico e potere religioso? Se il nodo era l’Apostolica Legazia non vi erano altri contenziosi di maggiore spessore che una disputa sui diritti nella vendita di una partita di ceci e diocesi di maggiore importanza e significato che non quella liparese? Il fatto è che la chiesa di Lipari, come abbiamo detto, riteneva di avere, sostenuta dalla Santa Sede, a proposito della Apostolica Legazia, uno statuto tutto particolare. La diocesi infatti vantava una particolare bolla, sempre di Urbano II, emessa il 3 giugno 1091, cioè sette anni prima di quella salernitana a cui si fa risalire la Legazia.
Il documento è rivolto all’abate Ambrogio che era sbarcato nell’isola qualche anno prima condottovi dai normanni ed aveva avuto, da Ruggero, la potestà politica e quella religiosa sull’arcipelago. In esso, il papa - dopo aver ricordato che tutte le isole occidentali furono donate in proprietà a San Pietro e ai suoi successori in forza del privilegio del pio Imperatore Costantino[15] ed aver riconosciuto il ruolo del monastero nel ripopolamento dell’isola - afferma che “questo monastero, cui la fraternità tua per volere del Signore, presiede, e che è intitolato a San Bartolomeo, noi lo prendiamo nel grembo della Sede Apostolica e intendiamo favorirlo con speciale protezione”.
La soggezione alla Santa Sede rimane in vigore anche dopo la bolla del 1098, tanto che l’antipapa Anacleto II quando nomina vescovo l’abate Giovanni con bolla del 14 settembre 1131, per venire incontro ad un desiderio dei re normanni, ribadisce che il monastero di Lipari, uno dei più grandi monasteri della Sicilia, “dipende dall’autorità della Chiesa Romana”anche se aggiunge che la diocesi di Lipari dipenderà dalla chiesa Messinese come propria chiesa Metropolitana, “fatte salve tutte le concessioni e i privilegi della Chiesa Romana elargiti al glorioso Nostro figlio Ruggero ed ai suoi eredi”. Comunque fino al vescovo Pietro ( 1171) i vescovi di Lipari venivano eletti dal capitolo del monastero ma non ratificati da Roma per cui nei documenti figurano non come episcopi ma come electi[16].
All’interpretazione che viene data della bolla di Urbano del 1091 da parte degli abati benedettini di Lipari e poi dei vescovi della diocesi e ancor più negli anni di forte tensione e polemica a proposito della Legazia si aggiunge il fatto che le Eolie non sono sempre appartenute politicamente alla Sicilia. Tra il XIII ed l’inizio del XVI secolo esse cambieranno diverse volte appartenenza passando da Palermo a Napoli e viceversa. Certamente nei periodi in cui dipendevano da Napoli la Legazia non si applicava. Quando il 30 maggio1610 le Eolie vengono rincorporate nel Regno di Sicilia staccandole dal Regno di Napoli cui erano appartenute fin dal 1458 e prima ancora dal 1357 al 1423, dal 1339 al 1347, dalla seconda metà del XIII al 1302, Filippo III lo fa venendo incontro ad una richiesta dei Liparesi che vedevano in questo passaggio un possibile incremento dei traffici e i vantaggi derivanti dall’avere una capitale più vicina. Ma se queste erano le motivazioni dei Liparesi e del loro vescovo che ne fu il più fiero propugnatore, il re Filippo ne aveva almeno altre due: tenere meglio sotto controllo questi isolani – fra cui vi era chi si dedicava alla pirateria – e ricondurre la Chiesa di Lipari, com’era per le altre chiese di Sicilia, nell’ambito della Legazia[17]. Probabilmente Filippo non conosce al Bolla del 1091 o non attribuisce particolare importanza a questa rivendicazione della diocesi liparese e della Santa Sede[18]. E come Filippo III, lo stesso faranno i suoi successori e questo spiega perché nel 1712 la Congregazione per l’Immunità si impegnerà a trovare le ragioni, il fondamento storico e il riconoscimento costante nel tempo di questa peculiarità della chiesa liparese in un documento inedito che pubblichiamo, corredato degli allegati, in appendice a questo libro[19].
Per tutto il corso del Sei e Settecento, la diocesi di Lipari, dai pontefici dichiarata “immediatamente soggetta alla Santa Sede” diverrà il terreno di scontro tra i sovrani di Sicilia, che sosterranno le loro prerogative anche sulla Chiesa Liparese, e i papi che le osteggeranno. E sarà allora che la vicenda registrerà i momenti di più drammatica conflittualità”.
La “controversia liparitana” nasce dal sequestro dei ceci ma lo scontro viene da lontano ed era stato voluto e preparato da tempo soprattutto dalla Santa Sede che voleva usare Lipari come un grimaldello per fare saltare tutto l’istituto della Apostolica Legazia, approfittando anche del fatto che la Spagna era impegnata in una difficile guerra per la successione (1700- 1713) nella quale avrebbe potuto soccombere e perdere quindi, come poi avvenne, il possesso della Sicilia.
Il primo scontro circa l’autonomia della diocesi di Lipari dalla Legazia avviene a pochi giorni dall’incorporazione e il pretesto è l’introduzione del Sant’Ufficio dipendente dalla Inquisizione spagnola, com’era d’uso in Sicilia, ed al deciso rifiuto del vescovo mons. Vidal forte, a questo proposito di una lettera del cardinale Gallo a nome del papa. E’ allora che scatta la minaccia della destituzione del prelato dalla dignità episcopale e della soppressione della sede Cattedrale[20].
Così per un intero secolo si sviluppa questo conflitto fra vescovato e curia romana da una parte e regno di Sicilia dall’altra dove tutto, anche le cose più banali, diventano occasione di contrasto giungendo perfino allo scontro fisico fra un vescovo ed un governatore durante il quale ci scappò il morto[21].
A dire il vero lo scontro non fu sempre così acceso e cruento. Vi furono vescovi che seppero destreggiarsi come mons. Giuseppe Candido ed altri che volendo essere ubbidienti a Roma e rispettosi verso il sovrano si trovarono tra due fuochi, come mons. Arata che per la sua intransigenza dovette patire anche il carcere a Palermo.
Il secolo XVIII in Sicilia si avviò con grandi mutazioni sul piano politico con il passaggio dell’isola dagli Spagnoli ai Savoia, agli Austriaci, ai Borboni mentre la Chiesa registrava una realtà tutto sommato vivace sul piano pastorale e spirituale anche se la società era flagellata da carestie, pestilenze, terremoti, guerre e tumulti popolari. Ma proprio questi gravi flagelli misero in risalto la nuova coscienza religiosa con la fondazione di un nugolo di opere pie a favore dei poveri, vecchi, ammalati, ragazze e bambini. Forse fu il contrasto fra questa nuova maturità pastorale e la debolezza del potere politico che rinvigorirono in alcuni prelati della chiesa siciliana, probabilmente sollecitati dalla Santa Sede, il desiderio di autonomia nel campo religioso.
 Infatti, all’inizio del XVIII secolo si vengono a trovare a capo delle diocesi di Catania e Girgenti vescovi che mal tolleravano l’ingerenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche ed erano sempre pronti ad emettere scomuniche o a minacciarne. Così, quando la sede di Lipari diventa vacante, nella curia romana si pensa di nominarvi un prelato erudito, energico, determinato e magari anche aggressivo da affiancare a questi vescovi, di modo che, da una posizione tutta speciale, potesse opporsi alla Corte di Palermo, rivendicando l’autonomia ed i diritti della Chiesa. Per questo venne scelto Nicolò Maria Tedeschi, catanese ma che si trovava a Roma priore del monastero di S.Paolo fuori le mura, cavaliere gerosolimitano.
Infatti, all’inizio del XVIII secolo si vengono a trovare a capo delle diocesi di Catania e Girgenti vescovi che mal tolleravano l’ingerenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche ed erano sempre pronti ad emettere scomuniche o a minacciarne. Così, quando la sede di Lipari diventa vacante, nella curia romana si pensa di nominarvi un prelato erudito, energico, determinato e magari anche aggressivo da affiancare a questi vescovi, di modo che, da una posizione tutta speciale, potesse opporsi alla Corte di Palermo, rivendicando l’autonomia ed i diritti della Chiesa. Per questo venne scelto Nicolò Maria Tedeschi, catanese ma che si trovava a Roma priore del monastero di S.Paolo fuori le mura, cavaliere gerosolimitano.
Mons. Tedeschi viene nominato vescovo il 10 marzo 1710 con bolla di Clemente XI e, sembra, con la raccomandazione del papa di non permettere alcun abuso da parte della Monarchia[22].
E la prima occasione si presenta al vescovo non appena giunge a Lipari. Il Palazzo Vescovile, quello “ufficiale”, collocato nella città alta, a fianco alla Cattedrale, è occupato da una guarnigione di soldati franco-ispani. A Mons. Tedeschi non rimane che occupare la villa della città bassa che allora era praticamente in campagna, isolata dal centro abitato, e constava dei magazzini e una parte dell’attuale primo piano. Lo fa di malavoglia, lamentandosi col papa ed il papa a sua volta si rivolge a viceré lamentando che i soldati violano, “con non pochi scandali proprii della licenziosità soldatesca, il decoro e la sacralità del luogo, mentre il Vescovo, con suo grave incomodo e con maggiore affronto alla sua dignità, è costretto a risiedere altrove”[23]. Ma nemmeno le lamentele del papa ebbero effetto ed il vescovo dovette ingoiare questa “usurpazione”.
Come dovette accettare che fosse la giustizia dei giurati – e non quella ecclesiastica come lui sosteneva - a perseguire le frodi nei commerci dei Liparesi che danneggiavano la mensa vescovile ed il suo “jus dogane” fingendo di esportare, vini ed altre derrate prodotti nelle isole, in Sicilia dove vigeva la franchigia mentre, in realtà, questi raggiungevano località fuori del regno[24]. Mesi di arrabbiature e frustrazioni furono quindi per Mons. Tedeschi i primi del suo governo e probabilmente andava crescendo in lui la tensione ed il desiderio di rivalsa. E la causa scatenante non tardò a manifestarsi.
[1] Circa la disquisizione relativa all’autenticità dell’atto pontificio e sulla interpretazione da darvi si veda S. FODALE, L’Apostolica legazia e altri studi su stato e chiesa, Messina 1991;G.CATALANO, Strudi sulla Legazia Apostolica di Sicilia, Reggio Calabria, 1973; L. CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina, 2007..
[2] G. ZITO, Storia delle Chiese di Sicilia, Città del Vaticano, 2009, pag.43.
[3] G.ZITO, Storia delle Chiese, op.cit.,, pag. 46.
[4] S.FODALE,L’Apostolica legazia…, op. cit., pp.10-14. Secondo Salvatore Fodale il Barberi non avrebbe recuperato la bolla dagli archivi pontifici, né sarebbe venuto in possesso dell’originale o di un suo trascritto autenticato, bensì da un manoscritto del XIV secolo contenente la cronaca di Goffredo Malaterra o da un suo volgarizzamento redatto nel 1358 da Simone da Lentini.
[5] S. FODALE, op. cit., pag.13-14.
[6] Idem, pag. 57
[7] S. FODALE, op. cit., pag12.
[8] Idem, pag.58.
[9] Idem, pag.58
[10] Idem, pag.60; S.VACCA (a cura), La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medioevale e moderna, Caltanissetta- Roma 2000.
[11] L’interesse dei vescovi francesi nei confronti della Legazia derivava dal fatto che anche in Francia esisteva una sorta di privilegio dei regnanti nelle cose ecclesiastiche chiamato “gallicanesimo”.
[12]S.SARPI, Istoria del Concilio Tridentino, Torino 1974 ; G. MARTINA, La chiesa nell’età della riforma, Brescia 1988; M. VENARD, Il Concilio Lateranense V e il Tridentino, in Storia dei Concili Ecumenici, a cura di G. ALBERIGO, Brescia 1990 ; E. ISERLOH - J. GLAZIK - H. JEDIN, Riforma e Controriforma, vol. VI della Storia della Chiesa, Milano, 1975.
[13] L.LORENZINI,Catechismi e cultura nella Sicilia del Settecento, Soveria Mannelli, 1995;
[14] G. ZITO, op-cit. pag. 66.
[15] La “Donazione di Costantino” è il documento secondo il quale l’imperatore avrebbe donato a papa Silvestro la città di Roma e l'Occidente, spostando a Costantinopoli la sede del potere imperiale. In base a questa donazione i papi consideravano legittimo il loro potere temporale; non solo, pretendevano di avere autorità anche sui sovrani dell'Occidente. Nel XV secolo Nicola Cusano e Lorenzo Valla (De falso credita et ementita Constatini donatione declamatio) hanno dimostrato che la "Donazione" non poteva essere stata scritta all'epoca di Costantino, nel 313, ma alcuni secoli dopo; la dimostrazione di falsità si basava su argomenti di carattere storico e linguistico.
[16] L.CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194), Messina 2007
[17] M. GIACOMANTONIO, Navigando nella storia delle Eolie, Marina di Patti, 2010, pag183; G. ARENA, Popolazione e distribuzione della ricchezza a Lipari nel 1610. Analisi, elaborazione statistica e sintesi dei riveli conservati nell’Archivio di Stato di Palermo, Messina, 1992; G.ARENA, L’economia delle Isole Eolie dal 1544 al 1961, Messina, 1982. C’è da dire a questo proposito che nella lettera che il Re di Spagna Filippo III scrive, il 22 novembre 1609 al viceré di Sicilia per comunicargli il passaggio della Città ed Isola di Lipari dal Regno di Napoli alla sua giurisdizione, non si fa alcun cenno alla condizione particolare della diocesi di Lipari, anzi si dice chiaramente che in detta isola valgano le disposizioni ed i costumi “ che si osservano alle altre Città, Isole, Luoghi Sudditi miei di questo detto Regno” anche per “le nomine di persone per gli offizij e cose Ecclesiastiche”. Inoltre quando il 10 maggio del 1610 questo passaggio è portato formalmente a conoscenza della autorità dell’isola – vescovo, giurati e governatore – il viceré di Sicilia è rappresentato proprio dal vescovo di Lipari, mons. Alfonso Vidal. Il testo della lettera di Filippo III e l’atto notarile della formalizzazione a Lipari del passaggio dell’isola al Regno di Sicilia si trovano nel documento manoscritto“Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa della Monarchia di Sicilia”,Allegato n. VII, Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, St.St. D2 d bis. Ora in appendice di questo libro.
[18] La Bolla cui la S.Sede e i Vescovi di Lipari fanno riferimento è quella del 3 giugno 1091 scritta da Mileto e che confermerebbe un rescritto di Ruggero il normanno del 26 luglio 1088. Entrambi i documenti in latino in L.CATALIOTO, Il Vescovato di Lipari-Patti…, op.cit., pagg.173-175.
[19] L’appunto manoscritto “Ragioni della Chiesa di Lipari contro la pretesa della Monarchia di Sicilia”,redatto per la Congregazione dell’Immunità di martedì 5 aprile 1712 e consultabile presso la Stanza Storica del Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede ( ora in Appendice di questo libro), di ragioni ne elenca cinque corredate da 12 documenti a supporto. I primi due sono infatti il rescritto di Ruggero e la Bolla di Urbano II del 1091, emessa – come dice l’appunto – “ nove anni prima all’asserto privilegio della Monarchia”, cioè della Bolla del 1099 che riconosce al re normanno la apostolica legazia; v. anche. G. IACOLINO, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Il primo millennio…, pag.84.
[20] Archivio Vescovile di Lipari, carpetta Civili 7. Lettera del 7 maggio 1610 del Card.Gallo; M. GIACOMANTONIO, op.cit., pag. 191-192
[21] Il vescovo mons. Caccamo al culmine di una violenta discussione colpì con un coltello il governatore don Pedro Malpasso, ferendolo mortalmente. La notizia è riportata da diversi storici locali. Nell’Archivio Vescovile di Lipari esistono numerosi riferimenti a questo scontro fra il Vescovo e il Governatore in particolare nella busta denominata Processi criminali, n.3,1, carp. 33. f.408 e ss.; M. GIACOMANTONIO, op.cit, pp.194-197
[22] Nel libretto “Difesa della verità a favore di Monsig. Nicolò M.Tedeschi Vescovo di Lipari e della Libertà ed Esenzione della sua Chiesa contro le Calunnie e gl’Errori dell’Autore di una scrittura spagnola intitolata ‘Propugnacolo de la Real Jurisdicion etc”, anonimo, senza luogo di stampa e senza data di pubblicazione, dagli storici locali, sempre attribuito allo stesso Mons. Tedeschi, si dice che il papa “si degnò comandarli… che operasse viriliter, né permettesse in Lipari novità alcuna per parte della pretesa Monaschia, ma che ostasse costantemente ad ogni tentativo della medesima”(p.71). Una copia del libretto di Mons. Tedeschi si trova a Lipari nell’archivio personale del prof. Giuseppe Iacolino; M. GIACOMANTONIO, op. cit. pag. 232-237.
[23] La lettera è riportata nel libretto anonimo attribuito allo stesso Mons. Tedeschi a favore di Monsig. Nicolò Tedeschi, Vescovo di Lipari, senza data e senza luogo di stampa, pag. 87.
[24] “Delle vertenze fra la Corte di Roma e il Governo di Sicilia” manoscritto di autore anonimo presente presso la Biblioteca Universitaria di Messina, Tomo primo, Parte prima, pag.5.(Archivio storico eoliano.it)
Un vescovo illuminato e una borghesia retriva
Una particolare attenzione alla condizione femminile
 Monumento funebre in Cattedrale del Mons. Coppola.
Monumento funebre in Cattedrale del Mons. Coppola.
Quando mons. Coppola arrivò a Lipari sul finire del gennaio del 1779 la prima impressione che ha della nuova diocesi è di forte delusione. Questa le apparve “come un quadro nel quale non si presentava alcunché di dipinto né alcunché di segnato” e lui si sentiva come un soldato disarmato o un artigiano senza gli attrezzi per lavorare[1]. Ma non per questo si abbatte. Individua immediatamente due punti forti per il suo programma: la formazione del clero, e “veggendo la deplorevole educazione delle donzelle e la sfrontata prostituzione delle donne di quella populazione che cagiona infiniti disordini[2]” l’educazione morale delle fanciulle perché diventino “ottime madri di famiglia” .
Sul primo punto comprese subito che a niente serviva ricorrere alle censure ed alle scomuniche perché non sarebbero servito ad altro che farli ricorrere al giudice della Monarchia che avrebbe concesso loro l’assoluzione e in attesa di creare quel Seminario che rimaneva l’obiettivo indispensabile, bisognava ricorrere al dialogo ed alla persuasione riproponendo quella disciplina, a cominciare dall’obbligo dell’abito talare ed al rispetto dei sacri canoni, a cui non erano più abituati[3]. Con questo scopo fondò la “Congregazione dei preti di Santa Maria del Fervore” che teneva raduni periodici sui temi della disciplina ecclesiastica e della liturgia, esercizi spirituali e dai cui dovevano uscire i predicatori, i catechisti ed i confessori della diocesi[4].
L’educazione delle fanciulle era, come si vide, il primo passo di una strategia più vasta nei confronti della condizione femminile. A questo scopo destinò il vecchio palazzo vescovile al Castello e fece venire dalla Sicilia della maestre che in quell’edificio presero alloggio ed, a titolo gratuito, dovevano insegnare alle ragazze “il timor di Dio, la sensibilità per i buoni costumi, il Catechismo e i lavori donneschi”[5] .
Una grande opera a cui mette mano è la costruzione, vicino al Palazzo vescovile del Borgo, di “un magnifico edificio per cui ha erogato molte migliaja di scudi[6]”, realizzato in tre elevazioni, tutto dedicato alle donne ma con tre distinte categorie di ospiti: le orfane, le donne che volontariamente “vogliono ritirarsi dal cattivo costume[7]” e che venivano allora chiamate “repentite” cioè’ “ree pentite” e le vere e proprie educande. A dirigere l’istituto – denominato Collegio di Maria o Conservatorio femminile - il vescovo chiamò alcune suore[8].
Un altro edificio che il Coppola realizzò per le donne inferme e l’infanzia abbandonata[9]fu l’”Ospedale femminile dell’Annunziata” riprendendo il nome del piccolo ospedale che era al Castello e che era ormai insufficiente e malandato[10].
Ancora, dedicate alle donne lavandaie, furono le cisterne, ciascuna con due lavatoi ai fianchi, che il vescovo fece costruire sulla Marina S. Nicolò per evitare che le massaie e le lavandaie di mestiere fossero costrette a fare il bucato sui sassi della riva e ,dovendosi alzare le gonne per non bagnarle, erano oggetto della morbosa curiosità dei giovani bellimbusti.
Una particolare attenzione il vescovo la dedicò alle “monache di casa”giudicandola una distorsione sia dal punto di vista sociale che religioso. Molte ragazze di famiglia agiata e benestante erano costrette a prendere il velo restando in famiglia di modo che non solo evitavano la dispersione del patrimonio, ma oltre ad assicurare il decoro della famiglia rappresentavano una garanzia per l’assistenza dei genitori in tarda età. “Le malelingue, – annota lo scrittore francese Jean Houel che visitò Lipari fra il 1778 e il 1780 - che in particolare si accaniscono contro le persone pie, non mancano di affermare che molte giovani donne prendono l’abito solo per godere di maggiore libertà. Il Vescovo ha pubblicato una pastorale per ovviare a questo abuso. Quando soggiornavo nell’isola, si diceva che volesse costruire un convento per farvi ritirare tutte quelle donne che sentissero un’autentica vocazione”[11]. Intanto mons. Coppola aveva emesso un decreto per regolamentare queste vocazioni richiedendo, a chi decideva di incamminarsi lungo questa strada, di dare buone referenze sulla propria vita, di essere dotate di un congruo patrimonio per evitare di rimanere sulla strada alla morte dei genitori, che a quarant’anni emettessero la “professione” e che si obbligassero a convivere con parenti di primo grado “ab omni suspicione alienis[12]” .
Toccò al suo successore, mons. Santacolomba chiudere definitivamente questo capitolo[13]
L’attenzione ai problemi sociali

L'edificio che Mons. Coppola dedicò alle donne.
Provvedimenti realizzati perché “della pudica modestia amatissimo[14] ” ma come aspetto di un più generale problema sociale di cui la moralità faceva parte. E fu per questo che si impegnò sul fronte della promozione culturale, dell’ammodernamento dell’agricoltura, dell’irrigazione e della fornitura di acqua potabile, del problema ospedaliero, dell’assistenza dei bambini abbandonati.
Quello dell’acqua è sempre stato un problema nodale per le isole ed è lo stesso Houel che ci racconta di avere assistito, durante il suo soggiorno, a due processioni con l’obiettivo di invocare la pioggia. “La prima processione era formata da una ventina di ragazzini, la testa cinta di una corona di spine e al collo una grossa corda che pendeva sino all’ombelico. Si flagellavano le spalle con aria divertita, e parevano più bambini che giocavano che piccoli santi che si mortificavano. Una ventina di preti, che cantavano le litanie, li seguivano stringendo con noncuranza una corda che di tanto in tanto si davano, con deboli colpi, sulle ampie spalle. I borghesi, i contadini e il popolo facevano seguito alla rinfusa, immersi nella preghiera con tutte le forze e con molta concentrazione…La pioggia non venne, fecero un’altra processione e a questa si partecipò con maggiore fanatismo; vi assistettero Cappuccini e Francescani, e la loro presenza accrebbe il fervore. Nove o dieci persone nude fino alla cintola si flagellavano duramente con catenelle di ferro dalle maglie sottili e taglienti, e il sangue scorreva sulla schiena e sui fianchi, tanto che il terreno ne era macchiato”[15].
Ma ad uno studioso di agricoltura come era mons. Coppola le processioni non potevano bastare e per questo “ordinò la costruzione di tre ampie e profonde gisterne; due avanti la gran porta del palazzo; l’altra innanzi la Chiesa del Rosario. Altre ne fece discavare sull’erta della Fossa Filici di Salina, ed in Filicudi ove stabilì un bel castagneto, come un grande oliveto piantò in Panarea[16].”
Lazzaro Spallanzani che visitò le Eolie fra dal 12 settembre al 17 ottobre del 1788 ed ebbe modo di conoscere il Coppola scrisse di lui “che parea nato fatto per ridur que’ Paesi, ancora mezzo salvatici, a stato migliore. E’ indicibile il numero degli olivi, che vi ha fatto piantare. Alla sola Panaria ve ne trovai più di tremila piedi. Vi ha pure introdutti i gelsi che assai bene vi allignano. Ne vidi uno nella sua bassa corte, piantatovi da otto anni che per la grossezza, e pel vigore non la cede punto a’ nostri di pari età, dove il terreno a tal pianta più si confà. I nominati fichi d’india portano il frutto, che sgusciato che sia, è giallognolo. Ha egli arricchita l’Isola d’una altra specie, fatta venir da Palermo, che li produce rossi, e che sono deliziosissimi[17]”.
Del programma sociale di questo vescovo faceva parte anche la cultura e così, nel 1782, trasferì nel borgo, “nel recinto del Vescovile Palazzo[18]”, il “Seminario delle Lettere” che i suoi predecessori avevano istituito sul Castello. Costruì cinque aule a piano terra – proprio di fronte al conservatorio delle donne - ed in esse fece altrettanti seminari di insegnamento aperti al pubblico. Si studiava – stando almeno alle intestazioni marmoree che ancora si scorgono all’esterno - grammatica, letteratura e retorica, filosofia tomistica e laica e, solo per i candidati al sacerdozio, teologia dogmatica, ma può darsi che in altri locali si insegnassero anche le scienze esatte. Oltre alla scuola aprì al pubblico la sua biblioteca con un bibliotecario e creò un “antiquarium” dove raccolse diversi reperti archeologici che aveva trovato negli scavi fatti per realizzare le aule del Seminario delle lettere: frantumi di statue di marmo, pavimenti a mosaico di pietre laviche, lapidi con iscrizioni greche[19].
“Io fui felice – scrive Houel - di scoprire, qui in mezzo ai rottami che andavo assiduamente rovistando, la statua di un console. Giaceva in terra, e il Vescovo ebbe la bontà di farla rizzare onde consentirmi che io potessi ritrarla. La sua grandezza è gigantesca, però le manca la testa ed è mutilata da tutte le parti[20]”.


I due grandi quadri di San Calogero e Sant'Agatone.
Dedicò anche attenzione e fondi alle chiese, al loro restauro ed al loro abbellimento. Nella Cattedrale in particolare diede gli ultimi ritocchi e sistemò alcuni altari e sistemò dei dipinti dei quali vogliamo ricordare i grandi quadri di S. Calogero e S. Agatone, realizzati nel 1779 da pittore palermitano Antonio Mercuri, che si trovano oggi su due altari delle navate laterali, ispirati a due episodi della nostra storia eoliana. Il primo con il santo che indica ai poveri malati che erano andati a curarsi alle terme il re Teodorico mentre – secondo quanto scrive il papa Gregorio magno nei Dialoghi - precipita nel cratere di Vulcano mentre, da una nuvola, il papa Giovanni I e il patrizio Simmaco, due sue vittime, lo osservano; il secondo ritrae il primo vescovo di Lipari che vestito dei paramenti pontificali indica alla gente in processione, prostrata a terra, la cassa di S. Bartolomeo a Portinenti.
Volle visitare tutte le isole. “Ho voluto rendermi conto di ogni cosa - annotava - senza risparmiare alle fatiche e ai disagi derivanti dal sito stesso, dall’angustia delle abitazioni e dalla povertà degli abitanti. Mosso appunto da cotanta miseria, ho attinto abbondantemente dalla Mensa, non ho dato neppure un soldo agli Assistenti che avevo portato con me e ai servitori che avevano qualche speranza, ma ho distribuito elemosine, proporzionatamente alle mie possibilità, sia alle Chiese che ai poveri, e ho fatto tenere tela e lino per vestire gli ignudi[21]”.
Il conflitto con i giurati
E fu proprio questo vasto programma sociale da una parte e dall’altra l’esigenza di dovere sostenere – integrando gli oboli raccolti fra i fedeli - le cappellanie in tutte le isole e le frazioni[22] - a fronte di una Mensa che non offriva più i guadagni di un tempo - che portò mons. Coppola a prospettare – a partire dal 1780 - all’Amministrazione locale, prima, l’esigenza di farsi carico dei bambini “projetti” e, poi, di concedere una sovvenzione pubblica per le chiese e le cappellanie a cominciare da quelle della città di Lipari.
Le richiesta del vescovo fece scalpore e non solo a Lipari ma anche a Palermo e Napoli e vennero ritenute quasi delle stranezze. In realtà dietro questa iniziativa di mons. Coppola – avanzata dopo lunga riflessione e consultazioni varie – vi era la riflessione che se la Real Monarchia avanzava nuove pretese sulla diocesi di Lipari negandole l’autonomia e la dipendenza diretta da Roma, doveva farsi carico anche di nuove incombenze a cominciare dalle attività sociali quali si potevano considerare l’assistenza dei bambini abbandonati e la cura d’anime. La sua prima richiesta che riguardava i “projetti” fu respinta sulla base di due sentenze del 1769 che facevano obbligo al vescovo di alimentare i bambini e di pagare le nutrici mentre ai giurati spettava solo il compito di cercare queste nutrici. Il vescovo certamente mal digerì questa decisione ma – dopo essersi consultato con i suoi esperti di Palermo – ritenne di non insistere oltre “prevedendo – come osserverà Giuseppe La Rosa che in questa vicende fungeva da consulente ordinario dei giurati e quindi aveva contrastato la legittimità della richiesta - il poco onore che si faceva a sé stesso in portare avanti tale indecorosa sua pretenzione”[23].
Comunque il vescovo reagisce male e risponde negando ai giurati alcune usanze di cerimoniale che danno luogo ad una nuova disputa e a nuove sentenze ancora una volta sfavorevoli al vescovo[24]. A questo punto mons. Coppola fa avanzare, nei primi mesi del 1782, dal vice parroco della cattedrale e dai cappellani curati della chiesa filiale di San Giuseppe, prendendo lo spunto dal fatto che era stata proibita la riscossione dei diritti mortuari che per il passato si era soliti pagare, la richiesta di “un congruo assegnamento annuale per cui potersi sostenere nel loro impiego Parrocchiale[25]”.
Il lungo memoriale che argomenta la posizione della civica amministrazione fu, ancora una volta, redatto da Giuseppe La Rosa. Esso concludeva sostenendo che il vescovo, essendo il parroco universale ed unico delle isole, dovesse sostenere con le entrate della “decimazione prediale[26]” il vice parroco della cattedrale e i cappellani della città e delle isole e quindi il loro ricorso dovesse essere rivolto al vescovo e “non mai essere tenuta questa università e suoi popoli a fare nuovo assegnamento di congrua prebenda a’ medesimi[27]”.
I giurati non si limitavano a respingere le richieste vescovili in punta di diritto ma tentavano di fargli i conti in tasca dicendo che dalle decime annualmente gli pervenivano “pinguissime somme” che nel 1782, annata sterile, erano di circa mille e cinquecento onze ma che nelle annate fertili si aggiravano sulle due mila onze. Contrapponevano così le pretese di un “Vescovo ricco” e la povertà di una Università costretta a litigare con lui per rintuzzare le sue pretese. Da parte sua il vescovo ribatteva che come i pubblicani del Vangelo i liparesi ed i loro amministratori civici erano avari ed ipocriti.

Disegno di Houel delle monache di casa di Lipari.
Il problema vero era che la borghesia e la nobiltà liparese non intendevano farsi carico dei bisogni dei ceti inferiori. Allora l’assistenza sociale e sanitaria come l’istruzione non era affidata alla pubblica amministrazione ma alla Chiesa e sostenere che il ricavato di millecinquecento o duemila onze fosse sufficiente per fare fronte alle esigenze sempre crescenti dei poveri era veramente incredibile. Inoltre Lipari proprio negli ultimi decenni del 700, oltre ai residenti, contava una guarnigione del presidio che fra soldati e loro familiari ammontava a circa tremila persone che aveva la funzione di controllare un numero consistente di “relegati provenienti dall’una e dall’altra Sicilia[28]”. E la presenza di una tale guarnigione e di così tanti “relegati” non doveva migliorare la condizione sociale soprattutto a Lipari[29].
Comunque, anche con tutte le difficoltà che dovette affrontare, rimane incredibile il volume di lavoro e di iniziativa che riuscì a realizzare mons. Coppola nei dieci anni che governò la diocesi. Come ci riuscì? Come riusciva a passare per un “Vescovo ricco” mentre le risorse della Mensa erano modeste? Ce lo spiega lui stesso in una nota alla S. Congregazione del Concilio del 24 settembre 1787: “Nell’assolvere a tutti questi impegni non ho potuto chiedere aiuto ai fondi della Mensa Vescovile che sono scarsi, bensì l’ho chiesto al poverissimo tenore di vita che mi sono imposto sin dal principio del mio Episcopato e che ancora, con l’assistenza di Dio, tengo”[30].
Nobili e personaggi eminenti della Lipari di fine secolo
Sul finire del settecento i borghesi che avevano fatto fortuna economicamente cercarono di consolidare la loro immagine col fregiarsi di un titolo nobiliare. Fu così che Giovanni Rodriquez, console di Francia, dopo aver acquistato terre ed essersi costruito una buona base economica, richiese ed ottenne, con decreto del 21 luglio 1784, dal re di Napoli il titolo di barone su una terra nel Vallone del Ponte[31]. Oltre al Rodriquez vi furono altre due famiglie borghesi, Monizio e Parisi, trapiantatesi nelle Eolie dove avevano acquisito poderi sia a Lipari che a Salina e avevano fatto fortuna col commercio dei cereali che chiesero ed ottennero da Ferdinando IV il titolo nobiliare. Don Francesco Monizio divenne così barone di Santa Marina e si costruì due dimore, una a Lipari nella campagna interna alla Marina di San Nicolò che da allora si chiamò “u Baruni” ed una a S. Marina nella zona che porta lo stesso toponimo. Don Domenico Parisi divenne invece barone di S. Bartolomeo e il 25 maggio del 1780 sposò Claudia, figlia del Monizio la loro abitazione era in un bel Palazzetto sopra la terra adiacente alla chiesa di S. Giuseppe[32]. A Lipari esisteva un’altra famiglia insignita del titolo baronale ed era la famiglia Tricoli che si era costruita una bella casa sul Timparozzo[33] .
Ma oltre ai nobili blasonati non dovevano mancare nella Lipari di fine settecento anche personaggi dotati nobiltà cultura e morale anche se, quelle di cui ci è arrivato a noi il ricordo sono pochi non solo rispetto alla realtà ma anche alle potenzialità. Infatti lo Spallanzani osserva che “qui i talenti non mancano, manca ad essi la coltivazione. I Liparesi sono in genere d’ingegno pronto e svegliato, presti nell’apprendere, acuti nel penetrare, e vogliosissimi di sapere. Quindi se qualche forestiero erudito approda alla lor terra, il domandano, lo interrogano, amano d’istruirsi. Prestansi volentieri a condurli ovunque più gli aggrada, gli mostrano con diletto le loro Stufe. I loro Bagni; né vi è alcuno che ignori, che quel Paese sia stato una volta prodotto dal fuoco”.
Comunque, fra le persone “coltivate” – oltre ai vescovi che provenivano però dall’eterno -, almeno due emergono dalle carte: un laico ed un prete. Il primo, lo abbiamo già incontrato. E’ Giuseppe La Rosa, avvocato, autore della “Pyrologia Topostorigrafica dell’Isole Eolie seu Lipari sacro” in quattro volumi di cui i primi due non ci sono pervenuti, il terzo raccoglie una serie di documenti relativi alla storia di Lipari, il quarto fa la storia cadenzandola sui vescovi da S. Agatone a mons. Coppola che governava la diocesi nel 1783 quando il manoscritto si ferma. La Rosa era un cristiano ma non un clericale. Un “cristiano adulto” diremmo oggi anche se era profondamente calato nel suo tempo e la sua religiosità era fortemente contraddistinta da atteggiamenti devozionali e credenze miracolistiche. Ma forse proprio per questo uno dei momenti di maggiore sofferenza nella propria esistenza fu quando, avendo dovuto difendere la civica amministrazione in qualità di consultore ordinario dei giurati e di avvocato dell’Università, vide che il vescovo – che nella disputa era la controparte – rimase irritato ed offeso nei suoi confronti. Non poteva darsi pace di questo, ripetendosi che un Prelato prudente avrebbe dovuto comprendere che non avrebbe potuto mancare al suo dovere professionale, inquinando così la sua onestà morale[34]. Eppure non per questo cambiò il suo giudizio su mons. Coppola e scrisse, a conclusione della sua opera, che “a se stesso niente pensa, sprezzante di ogni fasto mondano, e poca cura si piglia di sua salute, trattandosi di terminare l’opere da lui cominciate con il profitto di questo suo Gregge”[35].
 Un altro personaggio che spicca per le sue qualità e di cui ci parla Lazzaro Spallanzani, è l’abate Gaetano Maria Trovatini, uno dei centoquaranta o centocinquanta preti che vi erano a Lipari in quegli anni. Il Trovatini era medico[36] e coltivava le scienze. Di famiglia antica dove la ricerca era abitualmente di casa tanto che il padre Domenico aveva redatto una relazione “sopra i Bagni di S.Calogero nella Città di Lipari” ora andata perduta. Doveva essere nato nel 1752 il nostro abate, visto che era divenuto sacerdote nel 1752, quindi al tempo della visita di Spallanzani era ancora un giovane anche se non più giovanissimo. Comunque dovette fare una buona impressione sul grande naturalista che lo definisce “dotto” e ci informa che il Trovatini aveva redatto un lavoro di 72 pagine dal titolo “Dissertazione chimico-fisica sull’analisi dell’acqua minerale dell’Isola di Vulcano nel Porto di Levante detta volgarmente Acqua del Bagno” stampato a Napoli nel 1786. Quest’acqua sgorgava da una grotta ad un miglio dal Porto di Levante ed era, a parere del giovane ricercatore, importante ai fini medici ed a questo fine compilò anche un elenco”de’ morbi ne’ quali efficacissime si sperimentano le virtù della sorgente[37]”. Lo Spallanzani fu molto interessato da questa ricerca e portò con se, partendo, una riserva di questo liquido e sappiamo che continuò le ricerche sino al 1790. Non sappiamo però con quali risultati, inoltre di quella grotta oggi si è persa ogni traccia. Rimane il fatto che Trovatini, estraneo all’ambiente universitario e con pochi mezzi a disposizione abbia dimostrato, in quegli anni, una preparazione ed una sensibilità veramente apprezzabili[38]. Verso il 1788, ancora l’abate liparese venne nominato dal re, insieme al barone Bivona, soprintendente a lavori di scavo per individuare vene di zolfo e sorgive d’acqua entro la fossa del cratere di Vulcano. Si interessò anche di agricoltura e scrisse una dissertazione “Sulla maniera di coltivare le viti e il grano alla maniera del Sig.r Duhamel” che era un botanico francese famoso nel XVIII secolo.
Un altro personaggio che spicca per le sue qualità e di cui ci parla Lazzaro Spallanzani, è l’abate Gaetano Maria Trovatini, uno dei centoquaranta o centocinquanta preti che vi erano a Lipari in quegli anni. Il Trovatini era medico[36] e coltivava le scienze. Di famiglia antica dove la ricerca era abitualmente di casa tanto che il padre Domenico aveva redatto una relazione “sopra i Bagni di S.Calogero nella Città di Lipari” ora andata perduta. Doveva essere nato nel 1752 il nostro abate, visto che era divenuto sacerdote nel 1752, quindi al tempo della visita di Spallanzani era ancora un giovane anche se non più giovanissimo. Comunque dovette fare una buona impressione sul grande naturalista che lo definisce “dotto” e ci informa che il Trovatini aveva redatto un lavoro di 72 pagine dal titolo “Dissertazione chimico-fisica sull’analisi dell’acqua minerale dell’Isola di Vulcano nel Porto di Levante detta volgarmente Acqua del Bagno” stampato a Napoli nel 1786. Quest’acqua sgorgava da una grotta ad un miglio dal Porto di Levante ed era, a parere del giovane ricercatore, importante ai fini medici ed a questo fine compilò anche un elenco”de’ morbi ne’ quali efficacissime si sperimentano le virtù della sorgente[37]”. Lo Spallanzani fu molto interessato da questa ricerca e portò con se, partendo, una riserva di questo liquido e sappiamo che continuò le ricerche sino al 1790. Non sappiamo però con quali risultati, inoltre di quella grotta oggi si è persa ogni traccia. Rimane il fatto che Trovatini, estraneo all’ambiente universitario e con pochi mezzi a disposizione abbia dimostrato, in quegli anni, una preparazione ed una sensibilità veramente apprezzabili[38]. Verso il 1788, ancora l’abate liparese venne nominato dal re, insieme al barone Bivona, soprintendente a lavori di scavo per individuare vene di zolfo e sorgive d’acqua entro la fossa del cratere di Vulcano. Si interessò anche di agricoltura e scrisse una dissertazione “Sulla maniera di coltivare le viti e il grano alla maniera del Sig.r Duhamel” che era un botanico francese famoso nel XVIII secolo.
Lazzaro Spallanzani
Echi della rivoluzione francese
Pochi mesi dopo la morte di mons. Coppola a Parigi veniva presa la Bastiglia che è l’evento emblematico di quella rivoluzione francese che inciderà profondamente sulla storia del mondo. Ma ancora prima che scoppiasse questa rivoluzione fra il regno di Napoli e la Santa Sede si creò un duro braccio di ferro – che in qualche modo corrispondeva all’ostile isolamento praticamente nei confronti di tutti i sovrani europei - contro le prerogative e le ingerenze del papato e del clero in generale nella vita politica e nel’amministrazione dello Stato che qualche volta però sconfinava nell’invadere la sfera religiosa. A portare avanti questa lotta nel nome del re Ferdinando IV era soprattutto la regina Maria Carolina che si avvaleva dell’aiuto di alcuni ministri fra cui il viceré di Sicilia Caracciolo e più tardi l’amico sir John Francis Acton. Il papato – in una visione ispirata dalla massoneria che aveva a Napoli uno dei suoi punti di forza - fu visto come la causa di ogni arretratezza. Il principio della Apostolica Legazia che esisteva in Sicilia si volle estendere a tutto il regno e si voleva avere il diritto di presentare i vescovi da nominare. Aumentarono così le sedi vacanti. Ed anche Lipari subì questa sorte perché la S. Sede non voleva rinunciare a quella dipendenza diretta della diocesi da Roma che rappresentava l’unico punto di influenza diretta in Sicilia.
Tutti i nomi che Ferdinando proponeva il Papa li ricusava così il re si vide costretto a trovare una soluzione, in qualche modo transitoria, nominando, il 2 aprile del 1796, vicario capitolare mons. Carlo Santacolomba che era prelato ordinario di S. Lucia del Mela ed aveva il titolo di vescovo di Anemuria[39] .
 Quando giunse questa nomina non solo la rivoluzione aveva dispiegato i suoi effetti e vi erano state le esecuzioni di Luigi XVI e di Maria Antonietta che era sorella di Maria Carolina, ma Napoleone si apprestava a scendere in Italia. Il re cercava ora di arginare il potere della massoneria perché aveva compreso come i nemici della S. Sede stavano divenendo anche i suoi nemici[40] e si stava entrando ormai in anni di grandi turbolenza.
Quando giunse questa nomina non solo la rivoluzione aveva dispiegato i suoi effetti e vi erano state le esecuzioni di Luigi XVI e di Maria Antonietta che era sorella di Maria Carolina, ma Napoleone si apprestava a scendere in Italia. Il re cercava ora di arginare il potere della massoneria perché aveva compreso come i nemici della S. Sede stavano divenendo anche i suoi nemici[40] e si stava entrando ormai in anni di grandi turbolenza.
Santacolomba[41] non era un personaggio qualsiasi. Uomo di cultura avvertiva il clima di cambiamento che maturava in quegli anni nella società e lui stesso lo aveva in qualche modo interpretato celebrando nella primavera del 1783 nel duomo di S. Lucia del Mela, i funerali solenni, insieme all’intero capitolo, di un povero, umile, onesto, laborioso contadino pubblicando l’elogio pubblico[42] che aveva letto dal pulpito contrapponendolo ai ricchi possidenti, ingordi, oziosi, sfruttatori e sprezzanti. Queste sue idee,che gli erano valse l’accusa di “giacobino[43]”, dovette proclamarle anche a Lipari nelle sue prediche in Cattedrale e va sicuramente in questa direzione anche il decreto riguardante le “monache di casa” di cui abbiamo detto.
Ma più che impegnato a divulgare queste idee di rinnovamento e di innovazione sociale il vescovo dovette dedicarsi, come ogni altro vescovo del regno, negli ultimi mesi del 1796, a fare incetta di oro e di argento[44] per finanziare la guerra contro Napoleone che avanzava sul territorio italiano e presto una repubblica autonoma sarebbe sorta anche a Napoli e il re costretto a rifugiarsi in Sicilia chiedendo protezione agli inglesi e facendo ricorso a contribuzioni straordinarie. Anche nelle Eolie le chiese e i conventi furono spogliati di tutto quanto potesse avere un valore mentre venivano requisite per le truppe le chiese di S. Caterina e S. Maria delli Bianchi.
E dopo gli ori e gli argenti fu la volta anche dei metalli vili e persino delle coperte da letto dei due monasteri. Ma questa volta il guardiano dei Minori Osservanti protestò. Questa è una comunità poverissima, disse, e abbiamo solo i mantelli per coprirci. Ma è proprio vero che il re vuole fare morire di freddo noi poveri religiosi? “Se però il Sovrano la comanda così stracciosa come si trova, tutti i miei religiosi saranno pronti ubbidire”.[45]
Nel giugno del 1799 il re torna a impossessarsi di Napoli e la reazione contro i giacobini sarà durissima in tutto il regno. Anche mons. Santacolomba viene fatto oggetto di critiche e sospetti ricordando l’omelia per la morte del contadino a S. Lucia del Mela. Forse per reagire a queste voci, forse sollecitato dal governo di Napoli, forse anche perché se anche odiava lo sfruttamento e l’arroganza della nobiltà non per questo condivideva le idee e soprattutto gli eccessi dei repubblicani e dei rivoluzionari, mons. Santacolomba scrisse una lettera pastorale, di una sessantina di pagine, dal titolo :”Istruzione Pastorale sulla divina origine della Sovranità in questa terra, diretta agli Ecclesiastici delle due Diocesi di S.Lucia e di Lipari in Sicilia da Carlo Santacolomba Vescovo d’Anemuria”.
Mons.Carlo Santacolomba
La società ed il suo sistema civile – afferma il Prelato – non si fonda, come sostiene Rousseau, sul contratto sociale ma prendono impulso da una disposizione divina. Il potere non deriva da un patto fra il sovrano e i sudditi ma da un espresso mandato divino. “Istruite i popoli, alzate al par di tromba la voce, - esorta concludendo rivolto agli ecclesiastici – e fate conoscere agli ignoranti il sacro glutino che stringe in vincolo di unione divina l’Ara ed il Soglio, il Vangelo e la Maestà. Con le dottrine che vi ho proposto si sciolgono e si dileguano, qual nebbia al sole, i due incantatori vocaboli di Liberté ed Egalité”.
[1] ASV. Cass. 456 B, f. 166v.
[2] Memoria per l’Università dell’Isole di Lipari,p.61 cita, da G. Iacolino, manoscritto cit, Quaderno V, pag. 337.
[3] G. La Rosa, op. cit. ,vol.I, pag. 303
[4] ASV. Cass. 456 B, f. 165.
[5] ASV. Cass. 456 B, f. 162 v.
[6] G. La Rosa, op. cit. vol. I. Oggi questo edificio, che verrà inaugurato nel 1787, e si trova all’inizio, sulla destra, del Viale mons. Bernardino Re è chiamato Seminario o anche “centro sociale”.
[7] Memoria per l’Università… op.cit.
[8] G. Iacolino , manoscritto cit., Quaderno V, pag. 237
[9] I “projetti” erano i bambini abbandonato di cui a Lipari si curava solo la Chiesa.
[10] Ricordiamo che a Lipari esisteva un altro ospedale dedicato agli uomini, chiamato di S. Bartolomeo a Marina S. Nicolò che però in quel tempo era molto malandato e stava per chiudere i battenti.
[11] J.Houel, op. cit.
[12] “Lontani da ogni sospetto”. ASV. Cass. 456 B , f. 163.
[13] Mons. Carlo Santacolomba, vescovo di Anemuria e abate di S.Lucia del Mela gestì la “sede vacante” di Lipari dopo la morte di mons. Coppola, col titolo di vicario del Capitolo di Lipari. In una lettera dell’1 maggio 1797 diretta a don Giuseppe Moscuzza, canonico della Regia Cattedrale di S. Lucia “Travai qui [in Lipari] uno stuolo innumerevole di donzelle, che senza i canonici requisiti prescritti dalle leggi di S.Chiesa vestivan l’abito religioso di terziarie Pinzochere, ed in sostanza erano vere laiche perché di laica convivenza ed alla potestà secolare immediatamente soggette. La maggior parte di freschissima età e di vistoso aspetto compariva di questa maschera; giacché maschera può chiamarsi l’indossare una veste che mostri al di fuori diversa persona di quel che sia nell’interno, anzi potea chiamarsi una rea profanazione dell’abito religioso. Queste poi vagavan sole per la Città portando il costume che le ragazze così velate non avessero più bisogno di compagnia, ed era volgare adagio che ‘legavano il capo e scioglievano il piede’. I rispettivi lor padri godevano di questa sacra comparsa delle figliuole, ed imprimevan loro la falsa idea che un tal travestimento fosse già una stabile situazione per così allontanarle dallo stato coniugale, risparmiarne le doti ed impinguare i primogeniti. Crescevano le fanciulle, si sviluppavan naturalmente le lor macchine: avrebbero desiderato cambiare e vesti e professione, ma non potendo resistere al paterno reverenzial timore, non avendo il coraggio di vincere il rossor proprio del sesso per svelar il natural desiderio di andare a marito, e trovando qualche fanatico direttor di coscienza che faceva veder loro chiuso il Paradiso e aperto l’Inferno qualora abbandonassero l’intrapresa carriera, seguivane che marcivano, invecchiavano, ed internamente costernate sacrificavano loro stesse ad uno stato di violenza. Si aggiunga ancor un più maturo politico riflesso di buon governo che il Superiore ecclesiastico non dee trascurare. E’ questo un picciol paese, ha un territorio di vasti poderi non coltivati per mancanza di agricoltori; abbonda il ceto nobile e contadino; mancan gli artisti e i villani che sono i principali costituenti di una popolazione ben ordinata; ed ecco l’origine della pubblica povertà che, nascendo dalla scarsezza de’ prodotti e delle manifatture, produce un pernicioso languore in tutto il corpo dell’inferma società. Come por rimedio ad un tal male se non facilitando con i maritaggi l’accrescimento delle braccia alienate dalle campagne e dalle arti? E come facilitarlo se non con l’esterminio di tante beatine che tutte sarebbero per diventar madri feconde di numerosa figliolanza? Credetemi, o caro Amico, mi sarei recato a coscienza di gravissima colpa se, dietro a tutte le esposte riflessioni da me seriamente meditate, avessi lasciato correre un disordine sì mostruoso. Grazie alla carità dell’Altissimo lo riparai. Pubblicai l’editto proibitivo delle Pizzochere ed ordinavo di svestire le attuali. Per maggiormente avvalorarlo, implorai l’autorità del Governo, e (…) fu comunicato al mio editto il valore di legge perpetua con Viceregio Biglietto, ond’è che sono già cinque anni che rimangon libere tante in felicissime prigioniere. Porzion di loro, quelle cioè che volesser restar Vergini nelle paterne lor case, vivon più santamente in abito secolare che non vivan sotto le prime mentite bende consacrando al Signore il lor candore elettivo da libere e non da schiave; e le altre, che formano il maggior numero, fra le quali coloro che forse men si credevano, oggi son mogli e madri, e benedicono quelle mani che impiegarono a sciogliere le lor crudeli catene” G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno V, pp 249 a,b,c
[14] C. Rodriquez, Breve cenno sulla Chiesa liparese, Palermo 1841, p.47.
[15] J. Houel, op.cit.
[16] C. Rodriquez, op. cit., pp.46-47. Oggi di queste tre cisterne è rimasta solo quella della Chiesa del Pozzo che è conglobata nella sacrestia, mentre quelle di fronte al cancello del viale vescovile rimasero fin verso il 1960.
[17] L. Spallanzani, Destinazione Eolie, Lipari 1993, p.380.
[18] C. Rodriquez, op. cit., pag.46.
[19] C. Rodriquez. Breve cenno storico sull’isola di Lipari, Palermo 1841, p.11.Corpus Inscriptionum graecarum, Berolini 1853, p. 683, n. 5757.
[20] J. Houel, op.cit.
[21] ASV. Cass. 456 B. f. 161 v.
[22] Al tempo di mons. Coppola a Filicudi vi erano due cappellani ( uno a carico della Mensa), a Salina vi erano sette chiese , una per frazione, con sette cappellani; a Stromboli tre ( S. Vincenzo, S. Bartolomeo e Ginostra) con tre cappellani, una chiesa e un cappellano ad Alicudi. A Panarea vi era una chiesa ma senza cappellano perché la popolazione non poteva mantenerlo.
[23] G. La Rosa, op. cit., vol. I. pag. 303-306.
[24] G- La Rosa. Op.cit., vol. I, pag. 347-348
[25] Idem, pag. 349.
[26] Sarà lo stesso La Rosa a spiegare che per decime prediali si intendono quelle che derivano per i frutti ed i proventi della terra che si producono annualmente ed in ogni stagione indifferentemente da qualsiasi podere sia di campagna che urbano. Esse si distinguono dalle decime personali e da quelle miste. Le personali sono quelle che prima si pagavano con l’ingegno e la fatica delle persone ( commercio, pesca, caccia ecc.).Infine le miste sono quelle che partecipano delle prediali che del lavoro delle persone come la lana, il latte, i parti delle pecore e delle mucche (op. cit. pp.370-371).
[27] Idem, pp. 349-364. Buona parte del materiale dell’Antiquarium di mons. Coppola fu recuperata o acquistata tra il 1878 e il 1879 da James Stevenson che lasciò alla sua morte i reperti al Museo di Glasgow.
[28] Da una lettera di mons. Coppola. ASV. Cass. 456 B, f. 163 .
[29] Nel 1788 un prete medico che aveva assistito per dieci anni gratuitamente i militari e le loro famiglie scrive al re chiedendo di potere avere un pezzo di terreno a Vulcano dove fare delle sperimentazioni agrarie che se dessero frutto potrebbe aiutarlo a vivere avendo tre sorelle a carico. La lettera di don Giuseppe Cubeta è in Archivio Vescovile di Lipari. Car. Capitolo Cattedrale 1772-1972.
[30] ASV. Cass. 456 B ff. 165v -166.
[31] Registri del Protonotario del Regno, vol. 914, 1783-84, ff.57 e ss. Arch. Di Stato di Palermo, sez. II.
[32] Oggi sede dell’Hotel Meligunis.
[33] Era un edificio ad angolo fra le attuali via Garibaldi e via Umberto I che, divenuto di proprietà dell’Amministrazione comunale, intorno al 1965 fu demolita e ricostruita senza alcun pregio divenendo sede della Pretura ed oggi di alcuni uffici comunali.
[34] G. La Rosa, op. cit., vol.I, pag. 364
[35] G.La Rosa, op. cit., vol.I, pag. 297.
[36] A metà del settecento a Lipari su sei medici quattro erano sacerdoti. G.Iacolino, Il settecento liparitano, in L: Spallanzani, Destinazione Eolie, op. cit., pag. 429.
[37] G: Iacolino, idem, pag. 436.
[38] P. Manzini, Lazzaro Spallanzani, Gaetano M. Trovatini e l’analisi dell’acqua dell’isola di Vulcano” in “Bollettino Storico Reggiano”, a. XIII, vol. XLIV, 1980, pp 15-26. citato in G.Iacolino, idem, pag.436.
[39] Antica città nella Cilicia i cui vescovi venivano nominati in partibus infidelium.
[40] L. Von Pastor, Storia dei Papi, Roma, 1955, vol.XVI, parte III, p.97 si veda anche G.Iacolino, manoscritto cit. Quaderno V pp.244-246-
[41] Carlo Santacolomba era nato a Palermo intorno a 1728. Aveva ottenuto la prelatura ordinaria di S.Lucia del Mela nel 1780 ed il 2 aprile del 1786 era stato consacrato vescovo di Aremuria. Morirà a Lipari il 14 luglio del 1801.
[42] “Ne’ solenni funerali di Marco Trifirò vecchio contadino celebrati da Monsignor vescovo d’Anemuria Carlo Santacolomba. Omelia da lui recitata nella sua regia cattedrale”, Siracusa, 1787.
[43] A.Di Giovanni, La vita e le opere di Giovanni Meli, Firenze 1938, p. 233.
[44] Gli inventari della Chiesa di S. Bartolomeo in contrada Lingua di Salina, della Chiesa di S. Giuseppe in Lipari, e quello complessivo della diocesi in G. Iacolino, manoscritto cit., quaderno V, pp.251-253.
[45] La lettera di fra Giacomantonio da Lipari, guardiano dei Minori Ossservanti rivolta al Vescovo si trova in G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno V, pp.253-254. Questa come una lettera simile del guardiano dei Cappuccini, e gli inventari della diocesi e delle chiese in, Archivio Vescovile, Scritture varie e visite date. Miscellanea, vol.9 rispettivamente ai ff.11,22,31 e 7.(Archivio storico eoliano.it)
Fra illuminismo del secolo e paura dei terremoti
L’intraprendenza di mons. De Francisco
 Questo vescovo oltre che persona caritatevole[1]fu anche uno spirito molto intraprendente. Approfittando del fatto che gli introiti della Mensa erano cresciuti significativamente e Lipari era una realtà in grande trasformazione, ampliandosi in continuazione la città bassa, cominciò a pensare in grande ad alcune attività edilizie che sino allora non si erano potute compiere. Innanzitutto pensò di dare decoro alla cattedrale realizzando la torre campanaria, mettendo mano al prospetto e impostando la ristrutturazione globale dell’edificio verso quella chiesa a tre navate che conosciamo oggi. Inoltre pensò di realizzare l’antico sogno del seminario e per questo – mentre ristrutturava il palazzo vescovile della città bassa – metteva mano alla riparazione ed ampliamento di quello della città alta che voleva destinare proprio a questo scopo. Cosciente che il futuro di Lipari stava sempre più nella città bassa autorizzò la costruzione della chiesa della Madonna del Rosario al Pozzo che avrebbe dovuto affiancarsi a San Pietro e San Giuseppe.
Questo vescovo oltre che persona caritatevole[1]fu anche uno spirito molto intraprendente. Approfittando del fatto che gli introiti della Mensa erano cresciuti significativamente e Lipari era una realtà in grande trasformazione, ampliandosi in continuazione la città bassa, cominciò a pensare in grande ad alcune attività edilizie che sino allora non si erano potute compiere. Innanzitutto pensò di dare decoro alla cattedrale realizzando la torre campanaria, mettendo mano al prospetto e impostando la ristrutturazione globale dell’edificio verso quella chiesa a tre navate che conosciamo oggi. Inoltre pensò di realizzare l’antico sogno del seminario e per questo – mentre ristrutturava il palazzo vescovile della città bassa – metteva mano alla riparazione ed ampliamento di quello della città alta che voleva destinare proprio a questo scopo. Cosciente che il futuro di Lipari stava sempre più nella città bassa autorizzò la costruzione della chiesa della Madonna del Rosario al Pozzo che avrebbe dovuto affiancarsi a San Pietro e San Giuseppe.
In quegli anni, anche a Lipari, cresceva la consapevolezza degli artigiani e dei piccoli proprietari terrieri che andavano considerando con spirito critico le speculazioni della nobiltà terriera e dei mercanti esportatori che sfociavano nella cattiva gestione dell’annona e che portarono a Palermo alla rivolta popolare del 1773[2]. Ed al fatto che questa consapevolezza si tradusse nella creazione di una forma di vita associata a carattere religioso certamente non fu estraneo mons.De Francisco. Ben 104 artigiani si riunirono nella “Congregazione di Nostra Donna del SS.mo Rosario” ed il vescovo approvò lo statuto degli “Onorati Artisti della Nobile e Fedelissima Città di Lipari”[3].
Tanta intraprendenza non poteva non condurre il presule a cimentarsi anche lui con la spinosa questione di Vulcano. Forse reputava intollerabile che della gente andasse a rischiare la vita fino ad Ustica quando vi era un’isola deserta e abbandonata, oppure pensava che con le decime che ne sarebbero derivate avrebbe potuto realizzare il sogno del seminario che pretendeva risorse per essere mantenuto, il fatto è che ripropose il problema dello “scampamento e semina” e puntualmente scoppiò il dissenso anzi l’aggressione. Partirono contro il vescovo ricorsi calunniosi e anonimi sia alla S. Sede , sia alla Corte reale di Napoli, sia al governo di Sicilia. Così egli fu costretto nel 1769 ad andare a Palermo per difendere il proprio onore.
Di queste calunnie, una la conosciamo. Forse quella che più fece male a mons. De Francisco, perché lo accusava “che facea perire in diverse maniere moltissimi bambini projetti unicamente per non corrisponder loro gli alimenti”ed è lo stesso viceré, marchese Fogliani ,che era stato incaricato dal re di indagare sulle accuse, che fa giustizia di questa calunnia affermando, parlando del vescovo, “lo troviamo degno di tutta la lode per la carità con la quale prende cura di tali bambini, non solo dopo nati, ma puranche, con vero pastoral zelo, prima di venir alla luce”. Non si ferma qui il viceré ma giudicando che simili ricorsi, prodotti “ per lo più dalla gente più scellerata, non dubitano di deturpare ed attaccare con false accuse gl’uomini più degni ed onorati di tutte le virtù”,ritiene che sia necessario rintracciarne l’autore e “castigarlo come convenga proporzionalmente alla sua scelleragine”
Ma la vicenda per il povero vescovo, malgrado il riconoscimento del viceré, fu ugualmente devastante, nel morale e anche nel fisico tanto che il 19 luglio di quello stesso anno morì.[4]
Al di là delle calunnie comunque qualcosa stava cambiando nel Regno nei confronti dei privilegi ecclesiastici e quindi anche circa le pretese dei vescovi di Lipari sulla proprietà delle isole. L’illuminismo del secolo ma forse anche la lezione riformatrice di Maria Teresa d’Austria, suocera del re, spingevano verso una secolarizzazione dell’amministrazione statale. Ed infatti nel 1767 si espulsero i gesuiti dal regno ed il 5 giugno 1768 si interdisse la lettura annuale nelle chiese della bolla pontificia “In Coena Domini”[5] che avveniva nel corso della celebrazione del giovedì santo – da qui il nome della bolla – in cui si affermavano i diritti , non sempre legittimi, di libertà e immunità della Chiesa e degli ecclesiastici nei confronti dei pubblici poteri mentre si pretendevano, da questi, gravi limitazioni. Probabilmente a Lipari, le velenosità di alcuni nobili e borghesi nei confronti dei vescovi, si alimentava a questo clima e secondo una consuetudine, che si trascina fino ai nostri giorni, non avendo il coraggio e gli argomenti per esprimersi a viso aperto, ricorreva alle calunnie e all’anonimato.
Il Corpo dei Liparotti
Nel 1772 il re Ferdinando nel formare il corpo dei Reali Volontari della Marina, ordinò che in esso fossero in prevalenza reclutati isolani delle Eolie. Sicuramente convinsero il giovane sovrano a compiere questa scelta due avvenimenti che si erano succeduti nel breve volgere di qualche anno e nei quali aveva potuto apprezzare il coraggio e la generosità dei marinai eoliani. Il primo episodio accade sul finire del luglio del 1768 e si svolge nei pressi di Tunisi. Una galeotta liparese di proprietà del mercante Antonio Tricoli e al comando di don Giuseppe Maggiore era stata costretta a ricoverarsi, per sfuggire ad una grande tempesta, nell’isola di Zembra che è all’imboccatura del golfo di Tunisi. Dopo qualche tempo venne a ricoverarsi nei pressi del naviglio liparese una galeotta tunisina che aveva a bordo, come preda, undici marinai sardi. Ci fu un breve scontro ed i liparesi ebbero la meglio. Si impadronirono della galeotta e di tutto l’equipaggio e liberarono i sardi.
 Ufficiali della Real Marina Borbonica
Ufficiali della Real Marina Borbonica
Tornarono quindi in Sicilia e si recarono a Napoli dal re Ferdinando che si complimentò con i liparesi.
Due anni dopo, sul finire del novembre del 1770 re Ferdinando ebbe modo di tornare a complimentarsi con lo stesso capitano e con marinai liparesi che erano tornati da lui a riverirlo raccontandogli una nuova storia. Il 22 di quello stesso mese di novembre una barchetta di S. Marina Salina era attraccata al porto di Lipari portando la notizia che la notte prima una galeotta turca si era ancorata dinnanzi al villaggio. Subito da terra cominciarono a sparare, ferirono alcuni pirati e costrinsero la barca a salpare dirigendosi verso ponente. Sentendo questo racconto subito un gruppo di marinai eoliani al comando del capitan don Giuseppe Maggiore, armarono una galeotta del signor Tricoli e si diedero all’inseguimento della nave pirata. Arrivarono ad Alicudi senza scorgerla e decisero di pernottare nell’isola. Il giorno dopo, preso il mare per tempo scorsero la galeotta turca verso Cefalù. La inseguirono e dopo qualche ora la raggiunsero, le spararono contro e se ne impadronirono. La mattina del sabato la portarono a Lipari e dopo aver scontato la contumacia a Messina si recarono dal re Ferdinando[6].
Quindi re Ferdinando conosceva bene il valore ed il coraggio dei marinai liparesi e doveva trovarli anche simpatici perché volle che la loro base di addestramento e caserma di appoggio fosse nel sobborgo di Portici dove aveva una bella villa in cui andava a rilassarsi. E la vicinanza fra la casa reale e questi giovani sviluppò un clima confidenziale e di complicità dando vita a momenti di convivialità fuori da ogni etichetta. Qui Ferdinando riscopriva la verve scanzonata della giovinezza e cercava di coinvolgervi anche la moglie Maria Carolina figlia dell’austera regina d’Austria Maria Teresa. Nelle belle e tiepide serate il re e la regina si vestivano da bettoliere e da ostessa e, il loro seguito di cavalieri e di dame, da garzoni e fantesche ed improvvisavano, con i marinai liparesi, una festa con vino e cibi in abbondanza, grida, battute salaci, fino a sconfinare nell’orgia[7].
Eppure questi marinai, dopo qualche anno, non speravano che tornare alla loro isola e chiedevano di potere diventare soldati del presidio appena si fosse reso disponibile un posto.[8]
Fra fenomeni vulcanici e terremoti
Non si era ancora cancellato dalla memoria dei più vecchi, se non la memoria di ciò che avevano visto con i loro occhi, i racconti che avevano sentito dai loro genitori del terremoto del 1693 che nel 1771, per quattro lunghissimi mesi, l’isola di Vulcano tornò improvvisamente in attività. Un manoscritto anonimo[9] così ci descrive l’evento: “ Ai 15 di febbraio Vulcano fece una orribile eruzione, vomitando fiamme, pietre e globi di cenere, con procedere forti scosse di terra. Ripeté l’eruzione per la seconda volta ai 21, ed eruttò tanta quantità di zolfo che oscurò tutto il nostro orizzonte, piovendo tutta l’intera giornata gran quantità di cenere; e, benché quest’anno fosse stata fertile la campagna. Pur nondimeno ne seguì gran mortalità di animali”.
La gente reagisce come sa. La domenica successiva, che era il 24 febbraio, si organizza una grande processione penitenziale con in testa il clero, i frati ed il magistrato, l’immagine dell’Addolorata , la reliquia di S. Bartolomeo e poi ancora le immagini di S. Agatone e S.Calogero e dietro tutto il popolo. Ci si reca nella contrada del Salvatore, probabilmente dove oggi vi è il cosiddetto Semaforo, da cui si può vedere bene l’isola di Vulcano, e lì ci si ferma a pregare ed implorare . Ma le eruzioni e le scosse non finirono e andarono avanti per mesi sin quasi alla metà di maggio.. “Il 13 di detto mese crepolò si fortemente che spaventò la città di Lipari spezzando le vitriate quasi tutte, ed eruttò tanta cenere che il vento furioso di Ovest la trasportò in Costantinopoli, secondo le notizie da ivi provenienti”.
Ma mentre nei liparesi si rinfocolavano le preoccupazioni per i fenomeni vulcanici e tellurici , Lipari aveva un nuovo vescovo, mons. Bonaventura Prestandrea[10], che riprese i progetti del suo predecessore a cominciare dall’investire i 24 mila scudi che questo aveva lasciato soprattutto nel grande progetto di ristrutturare e riqualificare la Cattedrale di Lipari portandola da una a tre navate con la sua torre campanaria e l’orologio.
 La torre campanaria della Cattedrale
La torre campanaria della Cattedrale
Nel suo breve governo della diocesi – praticamente per la gran parte concentrato nel portare a termine i grandi lavori alla Cattedrale – toccò a mons. Prestandrea prendere atto di un altro segno del cambiamento dei tempi, l’istituzione a Lipari, il 26 giugno del 1776, della corte del delegato ordinario della Regia Monarchia del regno di Sicilia[11].Quella che era sotto attacco era l’autonomia della diocesi di Lipari e la dipendenza di essa direttamente dalla S.Sede. E questo lo si vide anche alla morte di mons. Prestandrea e al braccio di ferro che si creò fra la corte di Napoli e la S. Sede per la scelta del nuovo vescovo di cui, appunto, la corte di Napoli voleva appropriarsi. Per questo la diocesi rimase senza vescovo per un anno ed alla fine si superò l’impasse accordandosi nell’affidare la nomina all’arcivescovo di Palermo e la scelta cadde su un canonico della Cattedrale di Palermo, don Giuseppe Coppola.[12]
Ma erano anni quelli che più che le vicende politiche ciò che angustiavano i liparesi era la paura dei terremoti. Ai primi del febbraio del 1783 una serie infinita di scosse con epicentro alcune a nord e altre a sud di Messina sconvolsero questa città e numerosi centri della Calabria. La prima scossa fu avvertita il 5 febbraio alle 19 e un quarto con l’orario di allora paragonabile alle 12 e tre quarti circa dell’ora contemporanea. Durò 2 minuti e poi ne seguì un’altra il 6 febbraio e poi un’altra e un’altra ancora…Fra il 5 ed il 7 febbraio furono contate ben 949 scosse Per mesi si susseguirono scosse di intensità sempre decrescente, ma le più forti furono quelle del 1 marzo 1783 e quella del 28 marzo. Questa devastante sequenza sismica, formata da cinque terremoti ben individuabili, causò danni elevatissimi in una vasta area comprendente tutta la Calabria centro-meridionale dall’istmo di Marcellinara allo Stretto, e, in Sicilia, Messina e il suo circondario. Il quadro cumulativo dei danni è vastissimo e di gravità straordinaria paragonabile al terremoto di novant’anni prima: agli effetti distruttivi sugli edifici si accompagnarono estesi sconvolgimenti dei suoli e del sistema idrogeologico. Oltre 180 centri abitati risultarono distrutti totalmente o quasi totalmente; gravi distruzioni interessarono anche centri urbani importanti per la vita politico-economica e militare del Regno di Napoli e di Sicilia, quali Messina, Reggio Calabria, Monteleone Calabro e Catanzaro. Secondo le stime ufficiali, nella Calabria meridionale le vittime furono da 30 a 50 mila su una popolazione di quasi 440.000 abitanti. Nel Messinese i morti furono circa 630. Va inoltre tenuta presente l’alta vulnerabilità di un patrimonio edilizio, non solo di scarsa qualità costruttiva, ma anche fortemente indebolito da scosse numerosissime e ravvicinate. Si può dedurre che la gravità del fenomeno, più che nell’elevata intensità del sisma, stia nella rapidità con cui si sono succedute le scosse, che quindi non hanno permesso agli abitanti di provvedere alla riparazione dei danni, ed allo stesso tempo gli edifici che rimanevano in piedi ad un primo sommovimento, spesso crollavano al secondo. Quindi andò distrutto gran parte del patrimonio architettonico della regione Calabria. L'unica zona della Sicilia invece ad essere colpita dal terremoto fu Messina. In una relazione del tempo si legge: “Molti furono i feriti, molti tratti dalle rovine, ma nella confusione e disordine niente può dirsi di più sicuro se non se essere stato un vero prodigio per coloro che scamparono la morte. Ecco brevemente descritta l'infausta tragedia accaduta in Messina, la destruzione delli cui Edificii supera il valore di cinque milioni, e la devastazione, e perdita de'Mobili, Mercanzie, Ori, Argenti e Danari fu un grave Oggetto di spavento, e di considerazione”[13].
Ancora una volta Lipari salva dal terremoto: si parla di miracolo
Una cronaca di come Lipari visse quella terribile esperienza la dobbiamo a Giuseppe La Rosa[14] che ne fu testimonio diretto. Naturalmente il La Rosa parla di miracolo: “Solamente questa nostra Città di Lipari con le sue Isole di territorio, mercé il padrocinio ed intercessione del valevole nostro Santo Protettore Bartolomeo Apostolo e della Santissima Vergine Madre Maria Addolorata, per tutt’oggi si è venuto un continuo miraculo restare esenti di ogni danno”.
Il 5 febbraio, la notte seguente e il giorno sette dello stesso mese si sentirono nella città e nelle isole – racconta il La Rosa – “orribilissime le scosse de’terremoti vacillando le fabbriche visibilmente come una fragile canna battuta da’ venti, ma per grazia d’Iddio senza lesione alcuna né di gente, né di fabbriche che hanno seguitato e seguitano tutta via ogni giorno le continue scosse de’ terremoti, essendo già tre mesi circa che continuano, senza mai cessare, più o meno due, tre e quattro volte il giorno, e non si sa come aderà a terminare…Egli è vero, che ciascuno è uscito dalle proprie case, con pigliare cautela, ed asilo nelle baracche di tavole sparse per le pianure, e per le campagne, ma a che valgono tante preservate cautele, se non si scaccia fuori il peccato, il rancore, la mala volontà, dico l’offesa di Dio?”.
Il vescovo, fin dal primo giorno, - conclude La Rosa terminando così la sua cronaca - ha promosso processioni di pubblica penitenza, ha esposto il Santissimo ed, a turno, nelle chiese si svolge la pubblica adorazione tramite la devozione delle “quarant’ore”. Lo stesso vescovo è andato per le strade di Lipari a predicare la penitenza ed ha mandato nelle isole preti a predicare gli esercizi di Sant’Ignazio. Da parte loro i giurati l’11 maggio segnalavano al viceré che, pur non avendo subito danni catastrofici, “non mancano però delle fissure sì nelle Chiese che in alcune case, e specialmente nelle Reggie muraglie, e nella casa del Governatore” che vanno riparati prontamente come è necessario provvedere ai rifornimenti “per restare ben provvista in qualunque caso (che Dio non voglia) di sinistro accidente” . E dopo aver pensato alle preoccupazioni del corpo non nascondendo che i liparesi vivono“esanimi ed intimoriti di poter morire improvvisamente e sotto le rovine delle fabbriche[15]” i giurati il 7 luglio chiesero al viceré di Palermo di autorizzare , come adempimento di un voto del popolo eoliano per lo scampato pericolo, che il cinque di ogni mesi si esponesse con solennità in Cattedrale il Santissimo[16].
[1] G.La Rosa, op. cit, vol.I, p. 286.
[2] A.Giuffrida, Palermo, Specchio di civiltà. Economia e società, pag. 43.
[3] G. Iacolino manoscritto, cit., pag. 196 a 3. Archivio Vescovile, Scritture varie e visite date (Miscellanea) . secoli XVII –XIX – vol. 9, pp.320 e 322.
[4] G.La Rosa, op. cit., vol.I, pp. 286-287; G. Iacolino, manoscritto cit., pp203-204.
[5] La bolla risaliva a Pio V che l’aveva promulgata nel 1567 sulla base di documenti antichi e di pretese nuove. Fra le altre cose si vietava ai governi cattolici di tenere rapporti con stati non cattolici, di operare con il fisco senza il beneplacito della S. Sede e si comminavano censure a chi pretendeva di esercitare un controllo sull’attività e gli ordinamenti ecclesiastici.
[6] Entrambi questi racconti in G. Iacolino, manoscritto cit. Quaderno IV, pag. 186 c e pag. 201 a. Anche questi due episodi Iacolino li ha ricavati dal manoscritto di Luigi Mancuso di cui abbiamo detto.
[7] Sul corpo dei Liparotti si veda L. Radogna, Storia della Marina Militare delle Due Sicilia, Milano 1978,p.37. Sulle serate di Portici si veda G. La Cecilia, Storie segrete di Borboni di Napoli e di Sicilia, Palermo 1860, pp.30-31.
[8] Giuseppe Iacolino nel suo manoscritto più volte citato (Quaderno IV) riporta due lettere di questi marinai, Giuseppe Serra e Biaggio Buongiorno, pp. 201c 1,2,3.
[9] E’ il manoscritto di cui si è detto di proprietà della famiglia del dott. Luigi Mancuso citato da Iacolino.
[10] Il nuovo vescovo, appartenente all’ordine dei frati minori francescani conventuali, era nato a Messina il 2 novembre del 1705 ed era stato nominato vescovo di Lipari con bolla del 24 novembre 1769. l’11 gennaio del 1770 prese possesso tramite il vicario capitolare e poi direttamente l’1 marzo successivo. Morì il 12 dicembre del 1777.
[11] G. La Rosa, op. cit. , vol. I, pp. 288-292.
[12] G. Iacolino, manoscritto cit, Quaderno V, pp. 231,231 a. Vedere anche il manoscritto anonimo di proprietà della famiglia Mancuso, p.569. Mons. Giuseppe Coppola, nato a Bronte l’1 marzo 1720, nominato vescovo di Lipari il 14 dicembre 1778. Prende possesso della diocesi tramite il vicario capitolare il 14 gennaio 1779 ed il 21 gennaio indirizza al popolo ed al clero di Lipari una lettera pastorale. E’ la prima lettera pastorale dei vescovi di Lipari di cui si ha conoscenza. Il testo in L. La Rosa, op. cit., vol.I, pp. 299-303. Morì a Lipari il 16 febbraio del 1789.
[13] “Il terremoto di Messina del 1783”, dai documenti dell’Archivio di Stato di Torino a cura di Alberico Lo Faso di Serradifalco in www.storiamediterranea.it ; Genovese F. La Malaria nel Mezzogiorno d'Italia. Ed. Ass. Naz. sugli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, Roma, 1927; Baratta M. I Terremoti in Italia. Felice Le Monnier, Firenze, 1936; Mercalli G. I Terremoti della Calabria Meridionale e del Messinese. Accademia dei Lincei, Roma, 1897; Augusto Placanica, Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del settecento, Einaudi, Torino, 1985
[14] G.La Rosa, op.cit., vol.I, pp383-384.
[15] Archivio vescovile. Carp. Capitolo Cattedrale 1772-1972, da una nota dei giurati al vicerè di Palermo in data 11 maggio 1783. G: Iacolino, manoscritto cit,.Quaderno V, p.241 d
[16] A.V. , Scritture varie e visite date (Miscellanea) vol.9, f.162. G.Iacolino, idem, p. 241 c.(Archivio storico eoliano.it)
Un vescovo caritatevole e lo scontro su Vulcano
A Lipari, la città bassa prende forma
Il settecento in Sicilia prende il via fra repentini cambiamenti politici che rendevano ancora più precario uno scenario fatto di povertà e di guerre vicine e lontane. Come abbiamo visto nel 1713 gli spagnoli furono sostituiti da Vittorio Amedeo II di Savoia, nel 1720 fu la volta degli austriaci, nel 1735 arrivarono i Borboni che rimasero fino al 1860 quando prima Garibaldi e poi i piemontesi di Vittorio Emanuele II li scacciarono per costituire il Regno d’Italia.
Durante uno di questi passaggi, ai primi di ottobre del 1718, Lipari fu coinvolta in un episodio di guerra. Mentre una flottiglia inglese, venuta in appoggio agli austriaci, percorreva la rotta da Napoli a Messina per dare l’assedio a questa città, i liparesi intercettarono due grosse tartane cariche di vettovaglie e se ne impossessarono. La cosa non piacque agli inglesi che inviarono un battello con l’ambasciata che o Lipari prestava omaggio all’Arciduca o sarebbe stata bombardata. La risposta fu pronta :”Lipari aveva giurato fedeltà a Filippo V e non avrebbe tradito. Piuttosto avrebbero combattuto”. Gli inglesi cominciarono così a bombardare la città ma i liparesi risposero per le rime. Questo scontro durò poche ore durante le quali mentre i danni subìti dalla città furono minimi e senza morti, le navi inglesi che scortavano la Palandra che bombardava furono costrette ad allontanarsi lasciando questa isolata. Immediatamente i liparesi ,armate delle feluche, corsero verso questo battello per catturarlo. Vista la manovra gli inglesi mandano un lancia per difendere la Palandra, ma anch’essa fu catturata. Mentre i liparesi trainavano i due battelli in porto, le navi nemiche puntarono su di esse e così si dovette abbandonare la Palandra che aveva la poppa fracassata e si faceva fatica a portarsela dietro. Comunque i liparesi tornarono in porto avendo sequestrato la lancia e fatto prigionieri gli uomini, mentre gli inglesi andarono via scornati avendo perso le bombe ed una lancia con gli uomini a bordo.[1]
Lipari intanto, via via che andava diminuendo la paura delle incursione barbaresche, andava espandendosi fuori dalle mura del Castello. Cominciarono gli strati sociali più poveri che non trovavano spazio nella città alta a costruire le loro case, per lo più anguste, di uno o due vani, realizzate con materiale economico e quindi per lo più scadenti, con una piccola cisterna e prive di servizi igienici con pavimenti sconnessi per lo più di semplice battuto,le une accostate alle altre disegnandolo vicoli strettissimi in terra battuta perennemente sporchi e maleodoranti perché vi si vuotava di tutto persino i pitali con le orine e gli escrementi della notte.
La borghesia si trasferisce alla Marina S.Giovanni

Marina corta vista da Veuiller
Poi fu la volta delle famiglie borghesi che cominciarono ad avvertire gli effetti di una globalizzazione crescente dei commerci e delle idee e che, oltre ad un benessere crescente, si traducevano in una evoluzione nei gusti e nelle esigenze. Così cominciarono a trovare troppo anguste le abitazioni al Castello e non potendole ampliare – introducendovi i servizi igienici e i nuovi spazi di convivialità e di rappresentanza - pensarono di costruire nella città bassa. Soprattutto i commercianti e gli armatori avvertirono la necessità di risiedere nei pressi della marina mentre la nobiltà terriera ed altri borghesi sperimentarono l’importanza di potere disporre, dietro la loro abitazione, di uno spiazzo di terreno da destinare ad orto e a giardino con un pergolato sotto il quale passeggiare e sostare all’ombra per conversare .
Realizzarono così le loro abitazioni, anche su due piani, nella Marina di San Giovanni proprio di fronte al mare, sul lato destro della salita di S. Giuseppe, lungo il Timparozzo, nella strada di S. Pietro che si chiama oggi via Maurolico, lungo la strada dei Bottài , oggi via Roma, e qualcuna più in su nel vallone Ponte. Abitazioni – annota Iacolino – dai “caratteristici prospetti ad intonaco colorato, spezzati da bianchi rifasci orizzontali, i sobrii cornicioni correnti alla sommità, i portali ad arco, di pietra, i balconi, anch’essi di pietra, con ringhiere a ‘petto d’oca’ onde consentire alle donne di affacciarsi agevolmente sulla via nonostante indossassero le ingombranti crinoline a campana”[2].
La Marina di San Giovanni che arrivava fin dove oggi c’è il vicolo di Sant’Antonio e l’omonima chiesetta dominava la spianata e il mare, venne ridotta dalle costruzioni delle famiglie La Rosa, De Pasquale, Carnevale.
L’odierno corso Vittorio Emanuele, che si chiamava strada del Pozzo, era il greto di un torrente su cui si aprivano orti e botteghe di artigiani. Lungo l’attuale Marina lunga che allora si chiamava Marina San Nicolò, vi erano poche casupole di pescatori con le loro barche tirate a secco dinnanzi, ed in fondo, un po’ distaccata dal resto la chiesetta di San Francesco di Paola che verrà poi rinominata Maria SS.di Porto Salvo con a fianco l’ospedale di San Bartolomeo per soli uomini che aveva voluto il facoltoso commerciante don Bartolomeo Russo morto nel 1712[3]. L’ospedale di S. Bartolomeo sorse intorno al 1730 mentre un altro ospedale, quello dell’Annunciata, era al Castello[4].
Nel 1737 Lipari fu inclusa fra le cento città di Sicilia che ebbero le prime “officine postali” segno che i rapporti di scambio dovevano essere abbastanza rilevanti[5].

Mons. Platamone
Ancora nel terzo decennio del secolo, al vescovo Platamone la massa dei poveri appariva grande rispetto alle risorse della Mensa vescovile che probabilmente per la lunga vacanza vescovile e per le vicende della “controversia”, mancando un attento e continuo controllo sulla produzione dei campi e della pesca, si era di molto contratta. Tremila scudi, è quanto il vescovo dichiara che aveva riscosso l’anno precedente e desunte tutte le spese dovute rimanevano a disposizione solo 1.685 scudi con i quali doveva fare fronte ai poveri ed allo “stato di bisogno della Chiesa”[6]. Con questi fondi, ma anche con risorse proprie, Platamone doveva rendere agibile la residenza di villeggiatura ospitando anche la curia ed il tribunale ecclesiastico giacchè il Palazzo vescovile vicino alla Cattedrale era “quasi del tutto crollato, a causa della recente guerra di Sicilia, non è in atto abitabile[7]”. Oltre alla sopraelevazione del primo piano ricavandone sei vani, egli realizzò un bel vialetto colonnato, ombreggiato da viti che andava verso la via di S. Lucia[8].
Anche vescovo e municipio lasciano il Castello
Così intorno al 1725 il vescovo andrà ad abitare nel palazzo di villeggiatura a Diana[9] mentre il “Tocco”, cioè la sede municipale, dovette allora essere trasferita sul Timparozzo che col tempo fu chiamata strada del Municipio. Sempre dalle relazioni di mons. Platamone riusciamo ad avere anche informazioni sulle altre isole. Certamente la più popolata è Salina che conta ben sei chiese distribuite a S.Marina, Lingua, Capo dei Fichi, Malfa, Pollara e Val di Chiesa. Anzi è la prima volta che nella relazione di un vescovo si parla del “miracolo”[10] . Delle altre isole si parla solo della chiesa di S. Stefano a Filicudi e di quella di S.Pietro a Panarea; ma nel 1730 sorgerà la chiesa di S. Vincenzo a Stromboli.

S. Marina con la sua chiesa che svetta sulla cittadina.
Nelle nuove abitazioni, soprattutto della nobiltà terriera ma non solo, non era difficile trovare una stanza dedicata a cappella giacchè , in queste famiglie, vi era sempre un ecclesiastico come non mancavano una o due figlie che prendevano il velo in privato. Soprattutto per le donne, le cosiddette “monache di casa”, la ragione era quella di evitare la frantumazione della proprietà mantenendola concentrata in una ristretta cerchia di eredi, per i maschi che intraprendevano la carriera ecclesiastica vi era anche – in particolare nella borghesia che aspirava ad entrare nel giro dei “gentiluomini” – la propensione ad una promozione sociale per sé e per la propria famiglia.
Numerosi erano divenuti gli ecclesiastici che vivevano nelle Eolie: 95 sacerdoti, 8 diaconi, 5 suddiaconi, 5 accoliti e due lettori. Venti - venticinque erano i frati che risiedevano nei due conventi dei Minori e dei Cappuccini [11]. Ma per la maggior parte si trattava di un clero culturalmente povero tanto che il vescovo dovette fare venire da fuori il suo vicario generale. E questo anche perché , durante il tempo della “controversia”, nel Seminario delle lettere le lezioni non si tennero più con continuità ed alcune cattedre, come quelle di filosofia e teologia, rimasero vacanti. Per rimediare il vescovo obbligò tutto il clero a frequentare corsi tenuti da un suo confratello domenicano.
Comunque nel 1754 il vescovo De Francisco annota che i preti della Cattedrale e di San Giuseppe attendono scrupolosamente ai loro doveri “come pure anche gli altri Cappellani nelle Isole, dove risiedono, impartiscono con buon esito i rudimenti della Fede ai fanciulli”[12].
La paura della peste e la contesa su Vulcano
Nel giugno del 1739 una grande allarme si diffuse per le isole. Si era saputo che nei Balcani si erano verificati casi di peste e siccome le isole erano territorio aperto, sul transito di tante barche e vascelli, appena si seppe di questo pericolo subito la fibrillazione salì alle stelle. Già vi era stato un allarme ed una mobilitazione nel 1720 quando si era parlato di casi di contagio a Marsiglia, ora il problema si ripresentava. I giurati subito si mobilitarono e con i deputati di sanità tennero un pubblico consiglio. All’ordine del giorno le precauzioni da prendere negli scali delle isole. E come diciannove anni prima si decise di fare presidiare notte e giorno tutti gli scali dalla gente delle isole, dando loro le stesse istruzioni di allora.
Il governatore fu però di diverso avviso. D’accordo sul presidio notte e giorno ma in tutte le isole si dovevano mandare gente di Lipari, probabilmente perché ritenuta più affidabile. Incurante delle proteste dei giurati che reclamavano che non si potevano ignorare le risoluzioni ufficialmente già adottate, il governatore ordinò subito al Capitano dei quartieri delle milizie urbane di recarsi a Salina con 20 uomini da collocare nei vari scali, all’alfiere delle stesse milizie di prendere altri dieci liparesi e di recarsi a Stromboli ed al governatore del porto di Lipari di individuare altre 30 persone per gli scali dell’isola principale. Naturalmente tutte queste persone che erano comandate non erano militari ma gente del popolo che aveva un lavoro a cui accudire e tutti si lamentarono con i giurati perché queste decisioni recavano loro un grave danno visto, per di più, che non si sapeva quanto tempo sarebbe durata la mobilitazione.
Così i giurati si appellarono al viceré ed il viceré diede loro ragione affermando che fossero essi investiti dei più ampi poteri per l’emergenza predisponendo le guardie per le isole, procedendo alle ispezioni sanitarie a bordo dei bastimenti in arrivo, ordinando le opportune quarantene per gli equipaggi e quant’altro occorresse con l’obbligo di coinvolgere il vescovo nelle decisioni “per maggior accerto della comun salute[13]”.
Per fortuna il contagio non raggiunse le isole ma lo stato di allarme durò a lungo, almeno sei mesi. La paura della peste però non abbandonò le Eolie. Solo quattro anni dopo, nel 1743 essa esplose a Messina e in 3-4 mesi si contarono ben 40 mila vittime. Si mise in atto uno stretto cordone di vigilanza intorno alla città e si impedì che il contagio si propagasse nel circondario. Probabilmente misure di sicurezza scattarono nuovamente nelle Eolie ma per quello che se ne sa anche le isole non furono immuni dall’infezione di questo male anche se probabilmente in misura non allarmante. A Val di Chiesa ( Salina) vi è infatti una lapide che ricorda questo evento[14]
Difficilmente il vescovo partecipò con i giurati alla valutazione dei provvedimenti sanitari da prendere come voleva il viceré perché proprio in quel tempo era scoppiata una controversia fra i giurati ed il presule a proposito delle competenze di giurisdizione nel concedere autorizzazioni o proibire l’estrazione dello zolfo e dell’allume. Si ripeteva cioè quanto era accaduto al tempo del vescovo Ventimiglia, solo che, questa volta, furono i giurati a compiere il primo passo.

Huel, Vulcano visto da Lipari
Si sapeva che di notte, di nascosto della gente di Lipari senza lavoro e per cercare di racimolare qualche soldo si recava a Vulcano dove, scavando, raccoglieva zolfo e allume che poi vendeva a forestieri. Protestarono di questo fatto i benestanti di Lipari proprietari di terre sostenendo che le esalazioni di questi scavi danneggiava i loro campi e le loro culture e chiesero ai giurati di intervenire. Il vescovo si sentì toccato nelle sue prerogative e prevenendo i civici amministratori emise lui l’ordinanza di divieto. Scoppiò un forte dissidio e i giurati ricorsero al viceré. La sentenza del Tribunale del Patrimonio fu molto dura per il vescovo. Richiamandosi a quanto accaduto al vescovo Ventimiglia sentenziò che l’isola di Vulcano, come le altre isole dell’Arcipelago eoliano erano di pertinenza del dominio del re, per cui il vescovo era invitato a revocare subito il suo editto[15].
Un vescovo caritatevole
Il vescovo se la prese e quando si accorse che i giurati avevano rinnovato il panno rosso del loro scranno in Cattedrale avendolo realizzato “di scelto damasco con un suo guarnimento all’intorno di una frinzettina d’oro e seta” andò su tutte le furie.
“Troppo superbo, lo bollò, e più eccellente, e ricco del suo baldacchino Vescovile”. Il vescovo proibì che si collocasse questo drappo in Cattedrale e la questione fu portata a Palermo dove si discusse per oltre un anno. Alla fine mons. Beamonte, prevedendo che il risultato della sentenza non gli sarebbe stato favorevole, desistette dal suo divieto e la controversia si compose[16].
Questi episodi potrebbero fornire una immagine errata di questo vescovo che invece ci viene tramandato come fortemente caritatevole verso i poveri della diocesi, “eccedendo le sue elemosine oltremisura, né vi era mai bastante denaro, che potean dare le entrate annuali di sua Azienda vescovile, per saziare le calde brame della sua carità” . Proprio per questa sua prodigalità gli amministratori della Mensa dovettero tagliargli i fondi e gli impedirono di ingerirsi nella gestione finanziaria. Così per fare beneficenza egli ricorreva a vari sotterfugi.
Quando rimaneva senza denari e non riusciva a corrispondere alla richieste di un povero, si rinchiudeva nel suo ufficio si toglieva la tonaca del suo ordine e si liberava dei vestiti che portava di sotto quindi si rimetteva la tonaca sulla biancheria intima mentre i vestiti li consegnava al poveretto dicendo “ Pigliate queste vestimenta, andate a venderle e servitevene per i vostri bisogni, mentre io non tengo denaro pronto per soccorrervi, ma guardate di farvi vedere con queste robbe dai miei familiari, ne dite cosa a nessuno che l’avete ricevute da me”. Il prelato rimaneva così per diversi giorni senza abiti sotto la tonaca fino a che non veniva scoperto dai suoi familiari che provvedevano a rifornirlo di nuovi vestiti.
“Altre volte arrivò di notte tempo, a segno di gettare dà balconi del suo appaltamento, che corrispondevano in strada, li matarazzi dove egli soleva dormire dandoli a qualche povera donna, che li ricorreva per bisogno di non poter maritare qualche figlia per mancanza di matarazzi. Onde la mattina poi veniva trovato dà suoi familiari coricato sopra le nude tavole del letto; e bisognava provederlo di nuovi matarazzi”[17].
Comunque al di là della carità spicciola un segno importante sul piano sociale il Beamonte riuscì a dare agli eoliani, infatti, riuscì a dare vita a quello che era stato il sogno di mons. Arata e di altri vescovi: la creazione di un Monte di Pietà che potesse finanziare le attività economiche del popolo ed in particolare i contadini ed i pescatori[18].
Vulcano non si tocca
I terreni ed i giacimenti di Vulcano che erano stati oggetto di contesa al tempo di Ventimiglia e di Beamonte, tornarono a creare problemi al successore di questi, mons. Francesco Maria Miceli[19]. Anche Miceli si chiese come si poteva venire incontro alla massa dei poveri che viveva a Lipari. I terreni a Lipari e Salina erano tutti occupati e coltivati, delle altre isole minori – Filicudi, Alicudi, Panarea e Stromboli – diceva che “non sono altro che montagne scoscese protette da dirupi inaccessibili; non abbondano di comodità, né sono fertili di granaglie; in esse molti conducono una vita stentata”[20] . Così puntò gli occhi su Vulcano e andò di persona a vedere che cosa era possibile fare e si convinse che buona parte di essa poteva essere coltivata.
Reso edotto dei problemi che avevano bloccato i suoi predecessori pensò che fosse prudente coinvolgere nell’iniziativa i maggior enti dell’isola e così, nei primi mesi del 1748, ne parlò col governatore e i giurati. Li trovò d’accordo tutti tranne un giurato, Giacomo Bonanno ma probabilmente si pensò che prima o poi anche lui si sarebbe convinto e così fu dato il via all’operazione mandando i contadini a “dar principio allo scampamento”.
Invece il Bonanno – che, per disposizione governativa, aveva il compito di badare a che non si producessero zolfo e allume nell’isola di Vulcano[21] - non si convinse ma riuscì a portare dalla sua altri liparesi che non volevano che la lottizzazione compromettesse l’antico diritto di pascere e di legnare e ricorsero al viceré[22].
E il 10 maggio arrivò la risposta , direttamente al vescovo, che era decisamente negativa. L’idea di mandare gente a Vulcano a zappare e seminare le terre era di impedimento a chi voleva andarvi per pascolare o per fare legna, ma era anche di grave pregiudizio “alla reale giurisdizione di S. Maestà, a cui unicamente appartiene detta isola, ne già mai si potea un tal permesso di scampare e seminare dette terre accordare né dalli riferiti Giurati”. Il vescovo viene diffidato dal compiere qualsiasi passo in quella direzione, “ne ingerivi per l’avvenire in cosa alcuna, attinente a detta isola di Vulcano[23]”.
Nessuno disse allora che lo “jus pascendi” e lo “jus legnandi” consistevano in una aggressione selvaggia al manto boschivo dell’isola che nel giro di qualche decennio lo distruggerà irrimediabilmente.
Si costruisce l'Immacolata

La Chiesa dell'Immacolata
E’ nel periodo in cui mons. Miceli regge la diocesi che si realizza la costruzione di quel gioiello che è la chiesa dell’Immacolata al Castello ad opera della confraternita che portava questo nome. La confraternita si riuniva in una chiesina che si trovava assieme ad altre due piccole cappelle nel sito dove ora sorge l’Addolorata. Quando fu realizzata l’Addolorata le cappelle vennero incorporate e scomparvero e la confraternita fece capo ad una chiesetta, all’entrata del Castello, subito dopo il corpo di guardia che era detta della Concezioncella ma che tutti chiamavano di S. Caterina. Ora erano trascorsi cento anni da quando era stata restaurata, vi pioveva dentro e spesso dal soffitto si staccavano dei calcinacci. Per questo la confraternita ,che vantava un patrimonio ragguardevole, chiese al vescovo di potere realizzare una sua chiesa, grande e spaziosa, nel terreno fra la Cattedrale e la chiesa dell’Addolorata dove vi erano vecchie casupole che si erano liberate perché chi vi viveva era andato ad abitare nella città bassa.
Vi era anche un’altra ragione non dichiarata per cui la confraternita desiderava costruire una bella e grande chiesa al Castello e questa stava nella competizione che si era venuta sviluppando fra confraternita dell’Addolorata e confraternita dell’Immacolata.. La prima infatti raccoglieva la nobiltà terriera sempre più insofferente verso il diritto del vescovo di riscuotere censi e decime e gli ufficiali del presidio militare che nel tempo avevano avuto spesso degli attriti con il vescovo ed avevano fatto della confraternita e della chiesa un centro autonomo di culto posta sotto il Regio Patronato per cui il rettore non veniva nominato dal vescovo ma da Palermo; nella seconda confraternita confluivano invece la borghesia agiata formata da padroni di barche, mercanti, bottegai ed artigiani ed erano devotissimi al vescovo.
La richiesta di autorizzazione al vescovo è della fine di dicembre del 1746 e nell’arco di pochi giorni mons. Miceli ordina che si proceda allo studio della questione con gli esperti, esamina le relazioni e rilascia il suo benestare. Occorsero sette anni per realizzare l'opera e nel 1754 la chiesa, benchè non rifinita in ogni sua parte, venne aperta al culto[24].
La colonizzazione di Ustica e le difficoltà economiche
Si è detto come via via che ci si inoltra i questo secolo i segni di benessere e le esigenze di qualità della vita vanno crescendo nelle due classi benestanti dell’isola: la nobiltà terriera e la borghesia mercantile. Questo a fronte di una condizione della grande maggioranza della popolazione che doveva faticare per vivere. Eppure non è corretto descrivere la situazione sociale delle Eolie come fortemente polarizzata: i benestanti da una parte i poveri e gli emarginati dall’altra. Fra la gente che ogni giorno doveva porsi il problema della sopravvivenza propria e della famiglia vi era indubbiamente chi, come i contadini, i pescatori proprietari di una piccola barca e gli artigiani, che avevano un mestiere che in qualche modo – a meno di disgrazie improvvise - rappresentava una garanzia per l’esistenza; vi era invece chi e forse erano la maggioranza viveva nella precarietà andando a giornata a lavorare nei campi o offrendosi sempre a giornata nei lavori servili, facendo il facchino o lo sguattero, arrangiandosi a raccogliere pomice, legna da ardere, vendendo i pochi pesci che riusciva a pescare, ecc.; ed infine c’era anche chi non poteva contare sulla proprie braccia e viveva praticamente solo di elemosina. Può stupire che i tentativi di vescovi come Ventimiglia e Beamonte di valorizzare le terre o i giacimenti di Vulcano per cercare di offrire lavoro a chi a Lipari non ne aveva, vengono contrastati in nome proprio dei “poveri mendichi, i quali con l’uso quotidiano di far legni secchi si procacciano il miserabile vitto”[25]. Ed è questo che convince come alla base di questa opposizione non ci sia un intento sociale ma piuttosto l’egoistica posizione di chi vuole garantirsi un mercato di braccia a basso costo.
E che questo problema esista lo dimostra l’esodo per popolare Ustica che si verificò fra il 1762 ed il 1764. Il 4 aprile del 1759 il re Carlo di Borbone autorizzava la colonizzazione dell’isola ed agli immigrati venivano promesse due salme di terra - circa 5 ettari - per ogni famiglia di 5 individui e l’esenzione delle imposte per 10 anni. L’idea di avere un proprio pezzo di terra fu il motivo che convinse una sessantina di capi famiglia eoliani – di Salina e Filicudi in particolar modo – a salpare – nel 1762 probabilmente nel mese di giugno - con quattro barche dette “paranzelle” rifornite di commestibili e piccoli cannoni “senza che si fosse ancora provvisto a quanto il Tribunale di Commercio stabilito aveva per la difesa dell’isola e per il comodo dei nuovi coloni”[26]. Tutto andò bene nel viaggio e giunti all’isola subito i nuovi immigrati cominciarono a costruire baracche per ripararsi e probabilmente provvidero a fare arrivare anche altri membri delle proprie famiglie. Ma dopo qualche tempo si fanno vivi i pirati turchi che i liparesi però riescono a respingere decimandoli. Purtroppo nella notte dell’8 dicembre i pirati ritornano con cinque galere ed ebbero ragione dei nuovi coloni: le baracche furono bruciate, molti furono uccisi, settanta furono portati via come schiavi e solo pochi riuscirono a nascondersi su una barca e, non visti, giunsero a Palermo. Dopo che a Ustica furono fatte le fortificazioni, si organizzò una nuova spedizione, quasi tutta di eoliani, questa volta di 85 famiglie per circa 399 persone, marinai e contadini, nell’ottobre del 1763, portando con loro pecore, asini, buoi, vanghe zappe e rastelli, arnesi per pescare, masserizie d’ogni sorta, commestibili e vestiti[27].
Si trattò indubbiamente di un viaggio della speranza come quello che decenni dopo, altri eoliani affrontarono verso l’America. Un viaggio dettato dalla precarietà della situazione e dalle condizioni di vita difficili. Tanto difficili, da fare accettare i disagi di una destinazione disabitata e selvaggia. con la difficoltà aggiuntiva di dover superare la paura per nuovi attacchi dei pirati.
Certo i pirati non erano una novità per i liparesi ed anche a Lipari avevano, come abbiamo visto, spesso a che fare con loro anche se negli ultimi decenni sempre meno. E qualche volta, spinti dalla necessità, anche i liparesi dovettero ricorrere alla forza ed all’epediente della pirateria per cercare di procurarsi il necessario per vivere.

L'isola di Ustica vista dall'aereo
Quegli anni, in cui emigrarono per Ustica un buon numero di eoliani ed altri si apprestavano a partire, la carestia imperversava in tutto il regno ed in Europa e frequentemente giungevano notizie di gente, che nelle città, moriva di fame. Per fortuna non era questa la situazione delle isole dove se non si arrivava col lavoro a provvedere a tutti ci pensava la carità del vescovato. Ma comunque non era una situazione facile per cui, quando in un giorno di forte tempesta, una grossa nave carica di frumento proveniente da levante e diretta a Palermo, entrò nel porto per ripararsi ed attraccò al molo subito i deputati della sanità, alcuni magistrati e lo stesso vescovo si recarono dal capitano pregandolo di sbarcare una parte di grano perché la popolazione ne aveva bisogno. Ma il capitano non voleva saperne e a nulla valse nemmeno il fatto che il vescovo gli si mettesse dinnanzi in ginocchio scongiurandolo con pianti e preghiere. Ad un certo punto, visto tutto inutile i soldati della guarnigione si disposero sulla banchina con i fucili puntati mentre altre imbarcazioni impedivano alla nave di prendere il largo. Vedendosi imprigionato il capitano “ fu costretto a dare forzosamente il frumento che con preghiere non aveva voluto cedere[28]”.
[1] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale di Lipari, manoscritto cit., Quaderno IIIA, pp. 138 a,b,c. da un foglio a stampa il cui originale è conservato presso la Biblioteca Ursino di Catania ed intitolato” Distinta relazione dell’attentato de’ Vascelli Inglesi contro la Città di Lipari, e del Fedele, Magnanimo, e Vittorioso Operato di quei Cittadini nella lor difesa”, Palermo 1718.
[2] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale.., manoscritto cit., Quaderno IV, pag. 171.
[3] Queste notizie sulla nuova topografia di Lipari sono tratte dal saggio di G.Iacolino, Il settecento liparitano, in L. Spallanzani, Destinazione Eolie, Lipari, 1993, pp 407-453.
[4] “Qui c’è un ospedale di cui non ci pesa tenere l’amministrazione. Raramente vi si ricoverano degli infermi, sebbene esso non difetti di tutto il necessario per la salute dell’anima e del corpo”, così scriveva nel 1722 il vescovo Platamone alla S.Sede, per cui giudicava inutile un secondo ospedale e avrebbe preferito devolvere il lascito di Russo alla costruzione di un Seminario.(ASV, Cass. 456 B f.36v e 33v). Ma malgrado il Platamone chiedesse l’autorizzazione per effettuare questo storno dopo qualche anno l’ospedale di S.Bartolomeo si realizzò. Comunque si cercarono di differenziare i due nosocomi indirizzando quello di Marina S.Nicolò per malati forestieri, di sesso maschile che soffrissero di febbre persistente e quindi con possibili malattie endemiche. In seguito fu destinato ad ospizio per soldati veterani poveri e soli. Infine tornerà ad essere adibito a nosocomio generico per uomini e donne e tale resterà per tutto l’ottocento circa. (G.Iacolino, manoscritto cit. Quaderno III A pag. 146 e). Nel 1755 il vescovo De Francisco dava però un ritratto della situazione sanitaria preoccupante: il vecchio ospedaletto dell’Annunciata era cadente e inagibile e l’ospedale San Bartolomeo non accettava altri degenti se non fossero “malati di febbre”.( G. Iacolino,manoscritto cit. Quaderno IV, pag. 106 a2.
[5] G.Iacolino, La Chiesa Cattedrale di Lipari, manoscritto, Quaderno IV, pp. 162- 162 a.
[6] Relazione ad Limina del 15 marzo 1723, ASV, Cass. 456 B, ff.31v-32.
[7] ASV. Cass. 456 B, f. 31v.
[8] Secondo lo spirito del settecento il vescovo amava la convivialità sposata con conversazioni erudite come appare da questa pagina di G.La Rosa:”Voleva il Prelato che ogni giorno i Gentil’Uomini, li Sacerdoti cospicui nel decoro e Canonici del suo Capitolo avessero frequentato la loro conversazione nel suo palazzo Vescovale e nel suo appaltamento ove s’intratteneva a circolo con tuti piacevolmente, senza perdere la sua naturale sostenutezza, discorrendo di cose erudite; e si significavano le notizie che percorrevano dell’affari del gran Mondo e delle guerre d’Europa. Volendo uscirer a fare qualche caminata per esèlo e divertimento, era associato col séquito di tutta la Conversazione…; intratteneva al pranzo della sua tavola, quasi ogni giorno, quattro sogetti, cioè due Ecclesiastici e due Gentil’Uomini, che invitava a circolo, di quei che frequentavano la sua Conversazione, e nelle giornate solenni dava pasti molto esquisiti con invito di moti Canonici e Gentil’Uomini principali della Città”(op.cit. vol. I, pp.269-270). Questi modi cordiali e conviviali non evitavano che qualche volta il vescovo assumesse delle posizioni estreme nei confronti di chi lo contrariava o non gli pareva sufficientemente raffinato. Un esempio del primo tipo l’abbiamo già verificato quando si scontrò con il canonico Diego Hurtado e stava facendo riesplodere una nuova controversia liparitana. Un esempio del secondo tipo ce lo fornisce Giuseppe Iacolino ( La chiesa cattedrale di Lipari, manoscritto, cit. Quaderno IIIA, pag. 152) e riguarda un suo servente di Bronte, Ignazio Capizzi, che nel 1726 venne a Lipari a lavorare nella casa del vescovo e contemporaneamente voleva studiare per diventare prete. Era un giovane che si applicava negli studi e qui a Lipari imparò latino, filosofia, teologia ma, malgrado questo non riusciva a superare –come riconoscerà lui stesso - una “natural ruvidezza, rusticità e tratto villano” che non si conciliavano con la raffinatezza del Platamone che lo apostrofava dandogli del villano e chiamandolo “testa d’asino”. Per questo nel 1731 lo licenziò. Il poveretto accettò di fare lo sguattero presso l’ospedale di Palermo ma continuò a studiare e divenne medico nel 1734 e prete nel 1737. Si distinse per la sua cultura e la sua carità e Pio IX lo definì nel 1858 il S.Filippo Neri della Sicilia avviando il processo per la canonizzazione. Mons. Platamone morirà il 12 febbraio 1733 all’età di 66 anni.
[9] Ma non sarà una scelta stabile perché il suo successore, mon. Beamonte, quando nel settembre del 1736 prese possesso – a tre anni dalla nomina – della diocesi – tornò ad abitare al Castello anche se il palazzo era malandato.
[10] Descrivendo la Chiesa il vescovo arriva a parlare della cappella che contiene il quadro della Beata Vergine Maria. “Circa questa Cappella si tramanda che accadde un fatto straordinario. Si racconta che un abitante, di nome Alfonso Mercorella, mentre tagliava alberi per dare spazio alla coltivazione, nel fitto del bosco udì con suo gran stupore il suono di una campana. Direttosi, benché intimorito, verso quel richiamo, in un tempietto diruto e coperto di rovi e sterpaglie vide, con la guida della campana che Ella teneva in mano, l’immagine della Beata Maria sempre Vergine. Questo fatto infiammò soprattutto gli abitanti alla devozione della Beata Maria Vergine, e in quel luogo poi fu eretta per venerazione la Chiesa di cui qui si parla.”( Visita Pastorale di mons. P.V. Platamone del 1722, in Archivio Vescovile di Lipari ff. 22-22v)
[11] L’elenco di tutti gli ecclesiastici si trova nell’Archivio Vescovile di Lipari nella cartella “Visita Pastorale di mons. V.P. Platamone del 1722, primi f.f. non numerati).
[12] ASV, Cass. 456 B, f. 94. In questa epoca tutte le isole dovevano avere una loro chiesa ed un loro cappellano.
[13] Libro delle Corrie, foglio 226.
[14] “In perpetuam saevissimae pestis memoriam / anni 1743/ sodalitas nativitatis B.V. / Mariae/ novum hoc monumentum posuit”in G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno IV, pag. 169 ( nota a margine in rosso).
[15] G.La Rosa, op.cit., vol I, pp. 276-277
[16] Purtroppo di queste controversie ne risentì il fisico del vescovo che si ammalò e gli fu consigliato di andare a Palermo dove probabilmente l’aria natia gli avrebbe giovato. Ma ormai il suo fisico era minato ed il 19 luglio del 1742 spirò.
[17] G. La Rosa, op.cit., vol. I , pp. 274-276.
[18] C.Eubel, Hierachia Catholica etc, vol.VI, Padova 1958, p.263, in nota:
[19] Mons. Francesco Maria Miceli, messinese, fu nominato vescovo di Lipari l’11 marzo 1743 a 65 anni di età. Ma siccome a Messina c’era la peste e la città era isolata, poté prendere possesso della diocesi solo negli ultimi mesi del 1744. e morì il 2 gennaio del 1753.
[20] ASV, Cass. 456 B, f. 82v.
[21] G.A.M.Arena, L’economia delle isole Eolie dal 1544 al 1951, op.cit. pag. 29 nota 77. v. anche Genuardi, Siciliano, Scaduto e Garufi, “Il dominio del Vescovo nei terreni pomici feri dell’isola di Lipari” Acireale 1912.
[22] Il procuratore del vescovo nel processo sostenne che il giurato Bonanno, definito “torbido ed insolente” aveva concesso a tale Francesco Berrio un “pezzo di terra” nell’isola di Vulcano e costui aveva fatto “scampare detto pezzo di terra di detta isola”, seminandovi orzo.
[23] G. La Rosa, op. cit. vol. I pp 282-283. Comunque la sentenza del tribunale che giunse un anno dopo (Archivio di Stato di Palermo, Corte del Tribunale del Real Patriomio, anno 1749 v. G.A.M. Arena, op. cit. pp29-30) fu meno drastica: essa riconobbe l’isola di Vulcano e le altre isole dell’arcipelago di pertinenza della Mensa vescovile unicamente sulla base dei documenti esibitigli dal vescovo, peraltro non contestati dai giurati; lasciò all’Università la possibilità di opporsi alla contribuzione di censi e decime, cioè la possibilità di dimostrare che le isole non erano di proprietà della Mensa vescovile. Concretamente a Vulcano non si poteva fabbricare zolfo ( e quindi il Bonanno doveva continuare a sovrintendere che questo non avvenisse) mentre doveva continuare ad essere permesso ai singoli di raccogliere legna e quindi praticamente il terreno non poteva essere dissodato e coltivato.
[24] Gradatamente si fecero eseguire le tele dipinte e le statue e, infine, intorno al 1790-92, giunsero i marmi della balaustra, dell'altare maggiore e del pavimento. Nell'aula centrale, vicino al coro, i membri della confraternita si fecero scavare l'ipogeo per le loro sepolture. L'organo, della fabbrica Mancini, fu collocato in cantoria nel 1792.
Comunque nel 1755 il fatto che non si sia riusciti a realizzare anche le rifiniture sembra dovuta a due problemi convergenti. La prima : “la mala cautela avuto nel concerto dell’opera marmorea tra i Rettori della Congregazione dell’Immacolata con Mastro Santo d’Antoni e Mastro Pietro Muscarella”; la seconda: “sebbene li suddetti già decaduti Rettori con efimeri pretesti non intendessero rilasciare sudetta amministrazione, forse per essere scoverti di quelle positive mancanze”(Archivio Vescovile, Visite delle Chiese fatte da mons. Bon. Attanasio, 1851- 1859, ff. 439-440).Sul fatto che nel 1754 la chiesa venne aperta al culto esistono dei dubbi giacchè nel 1755 il vescovo Gerolamo Giovanni De Francisco - palermitano, dell’ordine dei Dominicani, eletto vescovo il 9 aprile del 1753 – in uno scritto alla S.Sede dice che, dentro le mura della città, oltre a quattro grandi chiese (la Cattedrale, la Concezioncella, delle Grazie e della Purificazione o S. Maria delli Bianchi), si “ha inoltre un’altra Chiesa , incominciata, sotto il medesimo titolo della Concezione, che per la sua imponenza e per la scarsezza dei suoi proventi sino ad ora non è stata portata a compimento.” in ASV, Cass. 456 B, f. 92 v..
[25] Dalla comparsa del Giurato Giacomo Bonanno in G.A.M. Arena, op. cit., pag.30 in nota.
[26] G: Tranchina, L’isola di Ustica, Palermo 1982, pag. 26.
[27] Più tardi sembra che altri eoliani siano partiti per Ustica e Arena dice che in totale si trattò di seicento persone. Iacolino da una cifra superiore.
[28] G.Iacolino, manoscritto cit. Quaderno IV pag. 186 a 5. Questi come altri episodi Iacolino li ha ricavati da un manoscritto, anonimo, di proprietà della famiglia del dott. Luigi Mancuso . Il manoscritto per la prima parte ripropone l’opera del Campis ed invece nella seconda parte contiene una documentazione originale.(Archivio storico eoliano.it)
I vescovi alle prese con i problemi sociali
Riesplodono i conflitti sopìti

Vulcano con i suoi fenomeni geologici: le fumarole e il mare che bolle.
Potrebbe sembrare che quelli di mons. Castillo e mons. Ventimiglia siano due episcopati tranquilli, privi di conflitti, sia per mancanza di contenzioso, sia per capacità e prudenza dei presuli. Eppure nel periodo di mons. Castillo per quanto breve e fortemente caratterizzato dal terremoto, qualche problema di giurisdizione con i giurati si era pure presentato per la proibizione di “vendere le cose commestibili innanti alla chiesa cathedrali in tempo che si celebra la messa cantata” e soprattutto circa la competenza di dare permessi per raccogliere legna – jus lignandi – e pascolare – jus pascendi – nell’isola di Vulcano che il vescovo riteneva fosse sua giacché del vescovo era la potestà sull’isola mentre i giurati la rivendicavano asserendo che l’isola era nel dominio del re. Problemi che si erano sorti quando il 26 febbraio ed il 9 marzo del 1693 il vescovo aveva emesso gli editti. Così i giurati erano ricorsi al vicerè che li aveva affidati al Real Patrimonio. La sentenza di questo Tribunale del 3 novembre 1693 lodava il vescovo per avere difeso il “decoro divino” mentre per lo jus lignandi e jus pascendi affermava che non potevano regolarlo né il vescovo né i giurati ma che dovesse – a determinate condizioni – rimanere libero[1].
Al verdetto di Tribunale di Palermo mons. Castillo non replica non sappiamo se perché gliene fosse mancato il tempo o perché avesse ritenuto che non valeva la pena aprire un conflitto per una cosa di scarsa rilevanza.
Quanto a mons. Ventimiglia abbiamo visto come è lui steso a toglier l’occasione quando sorge un conflitto sull’industrializzazione di Vulcano.
Ma una vicenda insidiosa è quella provocata dall’arcivescovo di Messina mons. Giuseppe Migliaccio che ha l’obiettivo di mettere in cattiva luce mons. Ventimiglia alla corte di Spagna. Il Migliaccio scrive una lettera al re dove accusa il Ventimiglia di volersi abusivamente affrancare dalla suffraganeità a Messina e di essere un perturbatore della Regia Giurisdizione perché costringeva gli appellanti di Lipari a rivolgersi alla curia romana come se la diocesi di Lipari fosse esente dalla Giurisdizione di Messina e soggetta immediatamente alla S. Sede.
Questa lettera doveva essere del settembre del 1699 ma mons. Ventimiglia ne viene a conoscenza solo dopo la Pasqua del 1700 quando finalmente riesce ad andar a Palermo ad incontrare il viceré che gli aveva chiesto un colloquio già dall’autunno precedente. Non è difficile per il Ventimiglia discolparsi: l’arcivescovo di Messina non aveva mai convocato nessun sinodo al quale sarebbe dovuto intervenire il vescovo di Lipari e nessun liparese aveva mai fatto appello alla curia di Messina perché a Lipari tutti conoscevano la bolla di Urbano VIII che esentava la loro diocesi in perpetuo da ogni Giudice Metropolitano. E qui il vescovo ricordò la vicenda di mons. Arata, suo predecessore.
Questa vicenda si concludeva qui perché il vicerè rispondeva al re che “l’Arcivescovo senza ragione alcuna andava seminando zizzania tra il Papa e il Re, giacché spetta al Romano Pontefice dare leggi ai Metropolitani e ai Suffraganei, e far sottostare questi ultimi ed esimerli da qualsivoglia giurisdizione, come è avvenuto per la Chiesa di Lipari nei confronti di quella Messinese, mentre i diritti del Re, che sono di altra natura, restano salvi”.
Ventimiglia assicurava la S. Sede che la grave offesa arrecatagli l’avrebbe ignorata in nome della carità cristiana ma sarebbe stato bene che, per evitare in futuro questioni di questo genere magari con un diverso vicerè meno comprensivo, si intervenisse per chiarire la vicenda. Inoltre ogni anno alla vigilia dell’Assunta l’arcivescovo chiama all’appello il vescovo di Lipari e mancando questo, gli applica una multa. Si potrebbe chiedergli – suggerisce mons. Ventimiglia – sulla base di qual diritto egli si comporta in questo modo e, sulla base della sua risposta “si potrebbero adottare una volta per tutti gli opportuni rimedi[2]”.
Ben più grave è invece quanto accade nel 1709. Nel 1700 era morto il re di Spagna Carlo II d’Asburgo che non aveva eredi. Il trono se lo contesero il re di Francia Luigi XIV in favore del nipote Filippo e l’imperatore d’Austria Leopoldo I in nome del figlio Carlo. Il trono andò a Filippo che fu chiamato Filippo V ma scoppiò una guerra fra la Spagna da una parte e l’impero asburgico, l’Inghilterra, l’Olanda e il Piemonte di Vittorio Amedeo II dall’altra. Nel 1709 gli austro-inglesi avevano occupato il milanese, la Sardegna , il napoletano e la Calabria e puntavano alla Sicilia.
 Filippo V e la sua famiglia
Filippo V e la sua famiglia
Il rigore verso gli amici dell'Austria
La Sicilia gravata da una pressione fiscale atroce e stremata dalla fame, fu invasa da soldataglie franco-spagnole con lo scopo di presidiare le piazzeforti temendo attacchi nemici. Anche Lipari ebbe le sue guarnigioni franco-spagnole che occuparono case e chiese al Castello, deturparono la Cattedrale e si comportavano con arroganza.
Il governo di Palermo era diventato estremamente diffidente e puniva con grande rigore tutti quelli su cui cadeva il sospetto che parteggiassero per l’Austria[3]. E siccome si sapevano i rapporti che il Ventimiglia manteneva con Vienna e probabilmente anche il fatto che nutriva simpatia per una amministrazione che promuoveva le riforme e lo sviluppo economico dei territori che gli erano soggetti, qualche nobile o borghese che, nella sua miopia, non aveva dimenticato la vicenda di Vulcano pensò che era venuto il momento di prendersi una rivincita. Partì quindi l’accusa che il vescovo trattava col generale delle forze austriache in Calabria. Così la sera del 10 settembre arrivò a Lipari una feluca con un capitano e venti soldati che alle tre della notte ( le 21 attuali) circondarono il Palazzo vescovile. Il capitano fece irruzione nel gabinetto del vescovo, gli intimò l’abbandono entro 24 ore dell’isola e del regno di Sicilia e sequestrò tutte le carte.
Mons. Ventimiglia non si scompose ma chiese solo il tempo per riuscire a procurarsi un po’ di quattrini per il viaggio visto che le sue casse erano a secco. Riuscì ad ottenere “sforzatamente” un prestito di onze cinquanta dal suo vicario e l’indomani mattina partì accompagnato solo da un sacerdote. Salendo a bordo del bastimento, si rivolse a chi era sulla banchina e lo guardava con compassione, sorridendo disse : “Amato mio gregge, addio. Questa ti sia l’ultima mia benedizione. Non ci vedremo più”. E così dicendo, benedisse tutti[4]. Morì a Roma il 17 dicembre del 1709, aveva sessantacinque anni.
La ricerca di un vescovo da battaglia
A Roma, nelle Congregazioni Pontificie ed in particolare in quelle dei Vescovi e dell'Immunità ecclesiastica, la politica del Ventimiglia era stata giudicata troppo tollerante ed arrendevole nei confronti delle gerarchie civili locali e nazionali, ben diversa da quella dei Vescovi di Catania e di Girgenti che non tolleravano alcuna interferenza dello Stato nelle cose ecclesiastiche ed erano pronti a sfoderare scomuniche o minacce di scomuniche.
Per questo, alla sua morte, si pensò di trovare un prelato erudito, energico, determinato e magari anche aggressivo da affiancare a questi vescovi, di modo che - da una posizione tutta speciale quale era appunto la Diocesi di Lipari immediatamente soggetta alla Sede Apostolica – potesse opporsi alla Corte di Palermo rivendicando l'autonomia ed i diritti della Chiesa. Per questo venne scelto Nicolò Maria Tedeschi, catanese, che si trovava proprio a Roma, priore del Monastero Cassinese di San Paolo fuori le mura, Cavaliere Gerosolimitano. Nicolò Maria Tedeschi era un nobile che era fuggito di casa per farsi benedettino, si laureò in teologia e insegnò a Catania fino a quando nel 1693 il suo monastero non fu distrutto da un terremoto. Promosso abate, fu destinato prima al Monastero di San Martino delle Scale a Palermo e poi a Roma dove oltre a fare l'abate ebbe ruoli di consultore del S. Uffizio e di teologo per la Congregazione dei riti, l'esame dei Vescovi, dell'Indice e delle Indulgenze.
Nominato vescovo il 10 marzo del 1710 con bolla di Clemente XI – e pare con la raccomandazione dello stesso Papa di non permettere alcun abuso da parte della Monarchia [6] - appena giunto a Lipari, come vedremo più avanti. cominciò subito a tener fede al mandato ricevuto.
La controversia liparitana
Sotto il nome di "controversia liparitana" va una vicenda apparentemente banale (la vendita di 800 grammi di ceci) che coinvolge tutta la Sicilia e la Santa Sede e mobilita tutte le più grandi potenze europee oltre a creare problemi a tanta genete, compreso esili e carceri. Una vicenda che dura circa dieci anni e che comunque si trascinerà, in qualche modo ancora nel secolo successivo. Ad essa quindi dedichiamo una parte specifica dell'Archivio.
[1] G. La Rosa, op. cit. vol. I, pp. 246-248.
[2] ASV, Cass. 456 ff2v-4.
[3] G.E. Di Blasi, Storia cronologica de’ vicerè di Sicilia, tomo IV, Palermo 1975, p.59..
[4] G. La Rosa, op. cit. vol I, pag. 260.
[5] in “La Chiesa Cattedrale di Lipari”, manoscritto inedito, Quaderno III A
[6] Nell’opuscolo “Difesa della verità a favore di Mons. Nicolò M. Tedeschi, vescovo di Lipari”, anonimo,( 1713?) a lui stesso attribuito è detto che il papa “ si degnò comandarli…che operasse viriliter, Né permettesse in Lipari novità alcuna per parte della pretesa Monarchia, ma che ostasse costantemente ad ogni tentativo della medesima”( pag. 71).(Archivio storico eoliano.it)
Il XVIII secolo: fra progetti di sviluppo e carità cristiana
L’economia eoliana nel 700

Allo sguardo ampio dello studioso[1] l’economia eoliana nel XVIII secolo può apparire in lenta ma progressiva ripresa a cominciare da alcuni segni esteriori come la città che continuava decisamente ad allargarsi nelle zone circostanti del Castello; il disboscamento e la messa a coltura di ampie zone di Flicudi, Salina ed Alicudi; un naviglio che percorreva tutte le rotte del basso Tirreno malgrado il pericolo dei pirati; l’amalgama della popolazione gli “oriundi” ed gli immigrati del dopo “ruina”; un buon numero di artigiani; una borghesia sempre più padrona dei processi economici dell’arcipelago.
E sull’onda della crescita dell’economia cresceva anche la popolazione, anche se non con il ritmo[2] del secolo precedente. Nel 1789, data del primo censimento ufficiale, risultò essere di 12.482 abitanti[3]. Ormai le borgate sono diventate una realtà per l’isola di Lipari ed a metà del secolo abbiamo Canneto, Acquacalda, Quatttropani, Lami e Pianoconte. Mentre nelle isole Stromboli aveva raggiunto i 700-800 abitanti, circa 600 Filicudi, 1500 Salina mentre pochissimi erano i residenti ad Alicudi e Panarea quasi tutti contadini e pescatori. La borghesia continuava a risiedere a Lipari. Un discorso a parte deve farsi per Vulcano che continuava a rimanere disabitata. La gente andava a lavorare di giorno, nei campi, ma preferiva tornare a Lipari all’imbrunire suggestionata dalle storie che volevano il cratere grande come la bocca dell’inferno da cui la notte uscivano gli spiriti maligni ed imperversavano sull’isola.
Nei campi eoliani crescevano fichi d’India, fichi, gelsi, capperi soprattutto ma anche ulivi, castagni, agrumi, susini; si coltivavano le viti, i legumi, gli ortaggi dai pomodori, ai cavoli, ai carciofi, ai peperoni; si allevava il bestiame. Dei prodotti della terra si esportavano uva passa, capperi, fichi secchi e vino a cominciare dalla malvasia sulle rotte di Napoli e Venezia. E’ in questo secolo che diventa una voce importante della esportazione la pomice – da 500 a 700 tonnellate l’anno - tanto che quando arriverà a Lipari Jean Houel nel 1771 andrà ad abitare dal console di Francia, don Giovanni Rodriquez, che si interessava soprattutto della pomice che si estraeva a Canneto ed Acquacalda[4].
Si importava invece il grano, utensili vari, panni e stoffe e il sale in grande quantità che serviva per la conservazione dei pesci e dei capperi.
Una carpenteria per costruzione dei vascelli si trovava a Marina S.Giovanni ed alimentava la marineria di Lipari che contava 150 e più feluche che sostenevano il traffico con la Calabria ed il regno di Napoli[5].
Dal punto di vista sociale, all'inizio del 700 – sostiene Arena – accanto ad una massa di gente per un verso o per l'altro ben sistemata, risiedeva nelle Eolie un'altra massa di persone che aveva una vita alquanto tribolata, per poche possibilità di lavoro e insufficienti mezzi di sussistenza. Si può ipotizzare che gli indigenti raggiungessero le mille unità[6].
Ma quanti sono i poveri?
Una lettura diversa invece proprio della realtà sociale di Lipari ci è fornita dal vescovo Girolamo Ventimiglia in una lettera al papa in occasione della visita “ad Limina” del 1696: “Il numero degli abitanti nella città e nel Suburbio ammonta a circa diecimila, ma quanto grande sia la povertà di cui essi soffrono non si hanno sufficienti parole per dirlo; basti pensare che soltanto due volte la settimana – e talora una sola volta – si macella un bue o una vacca per una così numerosa popolazione che, per l'estrema povertà in cui versa si nutre di frutta, di legumi e di pesce, e non raramente senzapane”.Le abitazioni, continua il vescovo, sono anguste, speso attendamenti e tuguri coperti di canne e di paglia che sono alla base di tutta una serie di violenze domestiche e di problemi morali. “Una gran massa di fanciulli e fanciulle ogni giorno assediano il Vescovo chiedendo pane, ma non c'è chi lo spezzi loro, benchè giornalmente ai più si dia uno scudo... Io tremo e mi rattristo vedendo più di seimila perone affamate e nude”.
Quindi non mille su una popolazione di 10 mila sarebbero gli indigenti ma la grande maggioranza. Certo questa è la percezione di chi giunge nelle Eolie e trova una realtà più critica di quella che si era immaginata. Di più, siccome la lettera ha lo scopo di sollecitare il papa ad una maggiore considerazione della realtà delle isole cominciando, per esempio, a sgravare la Mensa vescovile dell’obbligo di versare annualmente una pensione di 500 scudi per un cardinale, potrebbe darsi che in mons. Ventimiglia la verve del predicatore abbia avuto la meglio sulla serenità dello studioso, ma comunque il malessere sociale doveva essere più profondo di quanto le considerazioni economiche lascerebbero ipotizzare.

Vecchia Salina e Stromboli
Guardando alle isole minori alle considerazioni sociali si aggiungono quelle morali e pastorali ed il ritratto d el presule diventa più cupo. “Ci sono abitanti in ognuna di queste isole ma, all’infuori di Salina, tutte le altre non hanno né Chiesa né Sacerdote né Messa né Sacramenti, cosiché queste isole e queste genti odono da lontano la Buona Novella di Cristo e il Suo insegnamento e, cosa che è assai dolorosa a dirsi, in mezzo a questi gruppi permangono ancora tracce di incivile superstizione mentre non vi si scorge segno alcuno della Religione Cristiana, tranne che a Filicudi dove c’è una Cappella non ancora portata a compimento”. Il vescovo riconosce che sarebbe suo obbligo andare nelle isole, predicare, portare con sè dei collaboratori. Ma a che servirebbe se non ci sono i mezzi per edificare una chiesa e per mantenervi un sacerdote? La mensa vescovile vive dei frutti delle isole e del mare che le circonda. In passato queste entrate arrivavano fino a sei- settemila scudi ora però la situazione è peggiorata. Si sono esauriti i banchi di corallo ed il mare è divenuto più avaro per cui i pescatori sono costretti a spingersi nell’Adriatico o sino in Sardegna; mentre per quanto riguarda la terra le viti sono invecchiate e non danno più vino come un tempo e dai 30 mila del passato si è arrivati a 10 mila dello scorso anno. Anche le altre entrate sono state colpite. Le esportazioni dalla guerra[7] e dal timore dei pirati; i censi per via della riduzione delle aliquote praticate dal regno di Sicilia che dal 8-10 per cento le ha portate al 5. Ma se una volta la Mensa rendeva 6-7 mila scudi, quanto pensa mons. Ventimiglia che possa rendere ora? Il suo predecessore aveva appaltato il servizio di raccolta a 5 mila scudi ma fu costretto a scendere a 4.100 scudi, mentre ora non è riuscito a trovare appaltatori nemmeno per 3.500 scudi. Con ogni probabilità si otterranno solo 3 mila scudi che corrispondono, osserva, a 2.600 in moneta romana.
Rimane il fatto che questa somma la si introita per lo più in natura ed in natura vengono pagate le pensioni dei canonici, il maestro dei chierici, il cappellano di Salina, il parroco della Cattedrale e l’uomo di vedetta su Monte Guardia, cioè tutti i carichi della mensa. E poi ci sono altre spese – olio, cera, predicatori, musica, ecc.- per il servizio della cattedrale ai quali deve praticamente provvedere il vescovo[8].
Inoltre, come il suo predecessore mons. Arena, anche il Ventimiglia era un vescovo prodigo con i poveri ed i bisognosi in genere[9].
Le iniziative di valorizzazione e sviluppo
Ma dove trovare i denari, visto che oltre alla costruzione di cappelle nelle isole si riprometteva di realizzarne anche a Lipari a cominciare dalla Cattedrale che quando la vide le parve più “una spelonca di ladri che una casa della preghiera”[10]?
Visto che noi nostri mari , per la sconfitta che avevano subito i turchi a Zenta nel 1697, si era alquanto attenuato il pericolo corsaro mons. Ventimiglia sollecitò i liparesi a colonizzare le isole minori anche Stromboli e Alicudi che erano le più lontane. A Stromboli i primi coloni giunsero nel 1702 e si stabilirono a Ginostra che era una località meno esposta ad eventuali incursioni. Anche ad Alicudi inizialmente l’abitato sorse sul pendìo della montagna.
I risultati si fanno subito vedere e nella relazione del 15 marzo 1705 il vescovo dà notizia che il gettito della mensa è cresciuto di 300 scudi all’anno e già pensa di investirli nella realizzazione del seminario e nella costruzione di una chiesa a Stromboli dove “la fertilità del suolo, che ben si adatta alle culture, a poco a poco va allettando gli abitatori, e la posizione dell’isola, che è come una stazione obbligata di transito, richiama un gran numero di marinai e di viaggiatori”[11]. Inoltre la Santa Sede gli è venuta incontro è dopo l’abolizione di una pensione già concessa all’inizio del suo mandato, ora nel 1700 ha ridotto a solo 300 scudi la seconda pensione e duecento “sono stati assegnati a beneficio delle Isole”[12].


In alto contadini di Stromboli . Sopra, antico disegno di Vulcano
Dopo la colonizzazione di Alicudi e Stromboli il vescovo pensa a valorizzare anche Vulcano. Le risorse dello zolfo, dell’allume e del boro, se estratti con sistemi razionali ed efficienti, avrebbero potuto creare occupazione e altre risorse per la Mensa.
Così nel 1696 il Ventimiglia aprì le concessioni – gli “arbitrati” si chiamavano - per lo sfruttamento dello zolfo e dell’allume e immediatamente molte persone di Lipari scelsero di andare ad operare. Ma la cosa non piacque ai nobili ed alla borghesia locale che paventavano che questa nuova occasione di lavoro facesse lievitare i salari dei lavoratori che coltivavano le loro terre a Lipari e Salina ma anche nella stessa Vulcano. La motivazione che addussero per contrastare l’iniziativa fu che i fumi emanati dalle officine per la raffinazione di prodotti danneggiavano le coltivazioni non solo dell’isola ma giungevano fino a Lipari e Salina e producevano danni soprattutto alle viti.
Si creò quindi un influente partito contrario all’iniziativa che polemizzò col vescovo e spinse i giurati ed il giudice civile di Lipari a emettere un bando che vietava di “arbitrare” nell’isola di Vulcano. Il vescovo vide in questo provvedimento una ingerenza nel patrimonio ecclesiastico e scomunicò giurati e giudice. Questi ricorsero sia al Tribunale della Regia Monarchia per essere liberati dalla scomunica ed al viceré perché sospendesse l’impresa avviata dal vescovo giudicata dannosa per l’ambiente e l’agricoltura.
Se si poteva pensare che il Tribunale avrebbe assolto i giurati riaprendo così la questione annosa dell’autonomia del vescovo e della sua dipendenza solo da Roma, più complesso era il discorso dell’inquinamento giacché l’apposita commissione di esperti che era stata istituita a Palermo per valutare il problema, a gran maggioranza negava che l’industrializzazione di Vulcano potesse produrre i danni paventati.
Ma mentre si attendevano i responsi per i due ricorsi fu lo steso mons. Ventimiglia che chiuse la partita. Assolse giurati e giudice e ritirò le concessioni date a Vulcano. La ragione? Con ogni probabilità il Ventimiglia valutò che il rischio di riaprire la controversia sulla competenza del foro di appello non valeva la partita. Lo sfruttamento industriale di Vulcano era una grande idea ma per il momento andava rimandata.
Comunque la vicenda aveva lasciato da una parte e dall’altra diffidenze e prevenzioni e certamente nella borghesia liparese, miope nelle sue vedute e dalla mentalità angusta, vi era chi pensava che questo vescovo fosse pericoloso e bisognava aspettare l’occasione buona per liberarsene.
Chi era mons. Ventimiglia
Ma chi era mons. Ventimiglia? Chi era questo vescovo che univa carità cristiana e progetti ambiziosi di sviluppo? Famoso a Roma e nelle grandi capitali del mondo, come erudito, diplomatico e grande predicatore, aveva insegnato a Parigi e tenuto conferenze a Madrid, Vienna[13] ed in numerose città d’Italia, quando venne nominato vescovo di Lipari, don Gerolamo dei Principi di Ventimiglia, era un perfetto sconosciuto proprio nell’arcipelago.
A mons. Ventimiglia si era pensato come vescovo di Lipari anche prima della nomina di mons. Castillo ma sempre aveva rifiutato. Quando accettò, volle fare il vescovo con scrupolo e si documentò coscienziosamente sulla diocesi che andava a governare. Presentò a Innocenzo II una sorta di promemoria programma dove si mettevano in risalto: la grave situazione sociale (fame e miseria) delle isole; la grave situazione ecclesiastica ( il capitolo non aveva plebenda fissa, mancava il seminario, la Cattedrale abbisogna di urgenti restauri); occorreva una piccola banca di prestito (Monte di Pietà) a favore dei contadini per sostenerli nell’acquisto delle sementi e degli strumenti di lavoro[14].
Il papa si mostrò disponibile ed immediatamente abolì - visto che il cardinale che ne beneficiava era morto – l’obbligo di versare a Roma ogni anno una delle due pensioni che erano a carico della mensa vescovile di Lipari. Cinquecento scudi che furono destinati, per esplicita volontà del papa, alle necessità più urgenti delle isole[15]. Oltre a questi, con preciso riferimento ai punti che il nuovo vescovo aveva evidenziato, il papa garantiva un assegno annuo di 294 ducati d’oro e due giulii.
Era passato un anno intero dalla sua nomina ma, con questi risultati, il Ventimiglia arrivò a Lipari il 17 luglio del 1695.



La volta della Cattedrale con i dipinti voluti da mon s. Ventimiglia
L’impegno più importante a favore delle chiese il vescovo lo riversò nella Cattedrale creando un ampio sagrato[16], rinnovando la facciata che con tre porte dava l’impressione delle tre navate, rifatto il pavimento in marmo rosso e così il coro e l’altare maggiore, realizzata una cantorìa pensile al di sopra della porta centrale e vi installò un nuovo organo. Ma sicuramente il contributo più suggestivo all’abbellimento di questa chiesa fu l’affresco della volta cinquecentesca con sedici scene bibliche realizzato fra il 1705 ed il 1708.
Questo impegno per la Cattedrale creò una spinta di emulazione che portò le confraternite ad impegnarsi nel rifacimento di altre chiese come la Chiese della Madonne delle Grazie, un gioiello di architettura barocca realizzato in soli otto anni dal 1700 al 1708[17]e la chiesa di S.Pietro nel Suburbio[18].


La Chiesa della Madonna delle Grazie. A sinistra la facciata. A destra, l'artistico coro ormai pericolante da tre anni nell'incuria generale.
Ma il suo pensiero costante – lo scrive il 20 ottobre del 1696 - è la mancanza di un Seminario per garantire una adeguata formazione del clero giacché “quasi tutti gli ecclesiastici sono cresciuti e crescono senza una soda preparazione culturale e spirituale, mentre l’indole del popolo è portata alle pratiche devote ed è aperta all’apprendimento così come lo è per la vita libertina e poco operosa”.
Le uniche due chiese che in Lipari funzionano dal punto di vista pastorale sono la Cattedrale e San Giuseppe dove “ogni domenica si spiega ai fanciulli la Dottrina Cristiana”.
Pessimo è invece il giudizio sulle altre chiese della città e fuori le mura specialmente quelle cappelle che stanno a due e tre miglia fuori, sopra le montagne o in fondo alle valli. Sono in tutto quattordici e benché “risultino erette dalla grande devozione popolare, tuttavia sono sedi di una religiosità rozza e irriguardosa” dove i canonici nelle feste dei Santi titolari arrivano correndo a dorso d’asino o in barca “ per buscarsi i legati di due scudi (talvolta anche meno)”, cantano i vespri e le messe e poi , con la stessa precipitazione ritornano di corsa in Cattedrale “per non perdere le distribuzioni corali”. Talvolta in queste chiese si cantano in fretta e furia tre o quattro messe. “Questa vergogna che non si addice affatto alla dignità capitolare, non è possibile eliminarla a causa della estrema povertà che grava sul Clero”.
Fuori della città si distinguono per vivacità e bellezza le chiese dei francescani osservanti e dei cappuccini. Ma mentre i cappuccini, pur essendo pochi, si distinguono per esemplarità di vita e cultura, i francescani non brillano per serietà di costumi e dottrina. Di più, pur essendo calabresi, per eludere l’interdetto emesso nei loro confronti dalla Curia Vescovile si sono rivolti al Tribunale della Monarchia creando problemi di competenza per cui subito il vescovo ha dovuto informare a Roma la Congregazione dell’Immunità[19].
Per rimediare alle carenze del clero il Ventimiglia teneva dei corsi di aggiornamento per gli ecclesiastici, la sera nel coro della Cattedrale. Poi, verso il 1704 decise di rilanciare e riqualificare la “Scuola di grammatica” che era stata istituita da Mons. Arata, introducendo nuove discipline ed affidando l’insegnamento a frati fatti venire da fuori. Cambiò il nome alla scuola e la chiamò “Seminario delle Lettere” o “Ginnasio” lasciandola aperta a tutti i giovani fossero chierici o laici.
Impegnato su più fronti il vescovo non trascurava i suoi contatti col mondo esterno e spesso si recava a Palermo, dove aveva un rapporto di familiarità col viceré, e a Roma dove spesso predicava i quaresimali nella basilica di S. Andrea della Valle.
Ed era proprio a Roma, in visita “ad Limina” quando il 27 settembre del 1700 muore Innocenzo XII. Ed è Mons. Ventimiglia che viene chiamato all’inaugurazione del conclave, il 9 ottobre, a parlare ai cardinali.
[1] G.A.M. Arena, L’economia delle isole eolie dal 1544 al 1961, op.cit., cap.III, pp.25- 36.
[2] Le tappe di questa crescita per il 600 si possono così stimare: 4.566 nel 1630, 6000 nel 1651, 10.000 nel 1693
[3] Nel 1761 gli eoliani, soprattutto originari di Salina e Filicudi, contribuiscono al popolamento di Ustica con duemila(dice Iacolino, invece 600 dice Arena) persone.
[4] J.Houel, Viaggio pittoresco alle isole Eolie, Lipari 2003.
[5] G. A.M. Arena, op.cit., pag. 27; G.Iacolino, note a P.Campis, op.cit., nota 32 p. 454.; Libro delle Corrie, f. 185.
[6] Idem, pag. 32.
[7] E’ la guerra della Lega di Augusta che dal 1688 è durata sino al 1697.
[8] ASV, Cass. 456A, ff. 265v-269 in G.. Iacolino, manoscritto cit., Quadermo III, pp.77a-g.
[9] G.La Rosa, op.cit., vol.I, pp 250-251.
[10] ASV. Cass.456B,f.1. Della Cattedrale mons. Ventimiglia ne parla in due relazioni “ad Limina”. Quella del 1696 dove e quelle del 1700. G. Iacolino, idem.
[11] ASV, Cass. 456B, ff.10,10v.
[12] ASV, Cass, 456 B, ff 2, 2v.
[13] Nella capitale austriaca erano circolati due libretti dedicati a Mons. Ventimiglia scritti da vari poeti e dallo stesso imperatore in cui si elogiava “l’opere ammirande e chiare/ di sua eloquenza, onde l’Italia e ‘l mondo/ stupinne”.
[14] G.M. Cottone, De Scriptoribus Domus S. Joseph, Palermo 1733, pag. 156.
[15] ASV, Cass, 456 A, ff. 266v-267.
[16] Acquistando alcune aree e radendo al suolo alcune abitazioni.
[17] Purtroppo per la realizzazione di questa chiesa dovette sacrificare la chiesetta medioevale che ricadeva nella stessa area.
[18] Un ingrandimento della chiesetta che si era realizzata all’indomani della “ruina”. Questa chiesa di S.Pietro rimarrà fino al 1929 quando verrà abbattuta per fare posto all’attuale struttura.
[19] ASV, Cass. 456 A, ff. 264-265v .(Archivio storico eoliano.it)
Le Eolie conquistate dai Romani
Dopo la rottura con Agatocle ed i Siracusani i Liparesi cercano nuove alleanze ed incontrano i cartaginesi[1] che avevano conquistato delle città in Sicilia ed erano attratti dalla posizione strategica delle Eolie e dallo spirito ardito di questi marinai. Cartagine teneva in grande considerazione l'alleanza con Lipari tanto che il generale Annibale di Giscone, nominato pretore in Sicilia, scelse l'isola, per un certo tempo, come sua residenza e lì vi dimorò con una poderosa flotta[2] Fu così che i liparesi si trovarono dentro alle guerre puniche e – fra alterne vicende – seguirono le sorti di Cartagine attirandosi la forte attenzione di Roma che giudicava indispensabile la conquista delle Eolie per sorvegliare lo Stretto e le coste settentrionali della Sicilia.
 Con la sconfitta dei cartaginesi e dei siracusani del 263 ad opera del console Marco Valerio Massimo, Roma ottenne il dominio su tutta la costa occidentale della Sicilia e quindi l'esigenza di conquistare le Eolie divenne ancora più urgente. Nel 260 a. C. Roma che fino ad allora non aveva avuto una vera e propria flotta ed era del tutto digiuna di battaglie navali, riuscì a dotarsi di cento quinqueremi e venti triremi.
Con la sconfitta dei cartaginesi e dei siracusani del 263 ad opera del console Marco Valerio Massimo, Roma ottenne il dominio su tutta la costa occidentale della Sicilia e quindi l'esigenza di conquistare le Eolie divenne ancora più urgente. Nel 260 a. C. Roma che fino ad allora non aveva avuto una vera e propria flotta ed era del tutto digiuna di battaglie navali, riuscì a dotarsi di cento quinqueremi e venti triremi.
La battaglia navale di Milazzo
La prima impresa navale ebbe come obiettivo le isole Eolie, a dimostrazione, come queste fossero in cima ai pensieri dei romani. La flotta era stata assegnata al console Gneo Cornelio Scipione mentre le truppe di terra erano al comando del console Caio Duilio. Scipione con l'avanguardia della flotta, formata da 17 navi, raggiunse Messina dove doveva concentrarsi tutta l'armata romana. Lì, a Messina,avendo saputo che le Eolie erano, in quel momento, presidiate da una guarnigione cartaginese ridotta e probabilmente invogliato da informazioni sulla presenza a Lipari di gruppi favorevoli ai Romani, decise – senza aspettare il grosso della flotta – di puntare sull'isola impossessandosi del porto. Trovò invece una forte resistenza da parte della cittadina che non riuscì ad espugnare. Intanto la notizia dell'attacco giunse a Palermo dove era il quartiere generale di Annibale di Giscone che prontamente - mentre i Romani erano bloccati in finte trattative di resa - mandò a Lipari 20 navi comandate da Boode suo luogotenente e membro del senato cartaginese. “ Questi, - scrive Polibio - compiuta la navigazione di notte, bloccò nel porto Gneo e i suoi. Quando sopraggiunse il giorno, gli equipaggi si dettero alla fuga nella terraferma e Gneo, che era terrorizzato e non poteva fare nulla, alla fine si arrese ai nemici»[3].Le navi cartaginesi, avendo catturato la flottiglia nemica e il suo comandante – che da allora fu soprannominato Asina perchè gli attribuirono come alle asine la paura dell'acqua che avrebbe causato la sua sconfitta - ritornarono a Palermo[4].
Comunque, lo stesso anno, i romani si rifecero contro i cartaginesi, nelle stesse acque di Lipari, riportando una grande vittoria. La flotta era passata sotto il comando dell'altro console Caio Duilio, forte di 130 navi armate di “corvi”, cioè delle passerelle che agganciavano le navi nemiche e permettevano così di combattere con i nemici corpo a corpo. Annibale, qui, fece lo steso errore di Scipione e credendo di avere facilmente la meglio, attaccò i romani riportando una sconfitta devastante. Infatti i cartaginesi persero un terzo della loro flotta, tremila uomini uccisi e settemila fatti prigionieri.. Annibale si salvò ma fu giustiziato dagli stessi cartaginesi[5]. I romani però non approfittarono di questa vittoria ed i cartaginesi rimasero in possesso delle isole Eolie e continuarono a dominare sull'asse strategico Lipari- Tindari.[6]
Comunque i romani non desistettero dal proposito di occupare Lipari. Nel 258 il console Attilio Calatino raggiunse Lipari e vi mise l'assedio ma senza nessun successo. L'anno successivo toccò al console Attilio Regolo – probabilmente diretto a Lipari per occuparla - attaccare i cartaginesi che, al comando di Amilcare, veleggiavano un po' in disordine nelle acque di Lipari. I cartaginesi ebbero la meglio sulle prime dieci navi che comparsero loro di fronte, ma quando credevano di aver vinto arrivò il resto della flotta romana che li sbaragliò colando a picco otto navi e catturandone altre dieci. Non riuscirono però nell'obiettivo di occupare Lipari perchè gli abitanti sostenuti dalla flotta cartaginese ancorata nel porto opposero loro una strenue resistenza e li obbligarono, per quella volta, a desistere.

Il console Attilio Regolo
Per quella volta, giacché proprio la vittoria riportata sul mare da Attilio Regolo convinse il Senato romano che la conquista di Lipari doveva essere messa fra le priorità. E certamente questo pensiero dovette essere rafforzato quando nel 253 la flotta di ritorno dall'Africa fu colta da una tempesta e non potendo riparare nelle Eolie per via della presenza della flotta cartaginese dovette dirigersi verso Capo Palinuro riportando danni notevoli.
Questo proposito venne a maturazione nel 252 quando il console Aurelio Cotta prese il comando della flotta composta da circa 60 navi e puntò decisamente sulle Eolie reputando sicura la conquista di Lipari addirittura senza bisogno di combattere ma solo attendendone la resa. In realtà Lipari resistette e non solo non si arrese ma combattè strenuamente quando il luogotenente di Cotta – in assenza del console - diede l'assalto alla città . I liparesi respinsero l'urto violento infliggendo ai romani perdite ingenti.
Appresa dal console la sconfitta mentre si trovava in Sicilia, chiese aiuto a Gerone di Siracusa, e con una flotta potenziata si diresse a Lipari deciso ad espugnarla. . Soltanto nell'aprile del 251 gli ultimi difensori della rocca - malgrado la grande resistenza ed il grande valore dimostrato negli scontri - soccombettero nel crollo delle mura della loro città. Lipari fu completamente distrutta e i pochi superstiti della popolazione sottoposti a durissime condizioni. Eppure malgrado la rabbia e la ferocia contro i liparesi che avevano così a lungo resistito, i romani non si dimenticarono di quanto aveva fatto Timasiteo nel 396 a. C. quando fece liberare la nave romana catturata che recava i doni votivi a Delfi. I discendenti di Timasiteo furono rintracciati ed a loro furono riservati particolari riguardi.[7]
Passata Lipari sotto il dominio di Roma, tutti gli edifici che sorgevano sulla rocca di Lipari furono rasi al suolo e i romani fecero dell'Acropoli una fortezza. Comunque per secoli il velo del silenzio praticamente cadde sulle isole ed i loro abitanti.
[1] L. Bernabò Brea e M. Cavalier, La ceramica policroma liparese..., op. cit. pag.38.
[2] L. Zagami,Lipari...,op.cit., pag. 75;Diodoro, XXII,15. “E Cornelio Asina, l'altro consolo, andò nell'isola di Lipara con sedici navi, ove appellato da Annibale, quasi come di pace volesse trattare, ingannato, com'era usanza di quelli di Cartagine, nelle carceri fue istrangolato”, P. Orosio. Delle storie contra i pagani, Libri VII, Volgarizzamento di Bono Giamboni, Firenze, 1849, pag. 219. Questo generale Annibale di Giscone ( nato nel 290 a.C. E morto nel 260 a.C.) non va confuso con il più famoso Annibale Barca che nacque a Cartagine nel 247 a.C e morì a Lybissa nel 182 a.C. La versione proposta da Orosio suggerisce che Scipione fu attratto a Lipari con l'inganno. La tesi dell'inganno è proposta anche da altri storici come Floro e Zonara.
[4] Quindi contrariamente a quanto sostiene Orosio il console non venne strangolato ma fu portato prigioniero a Palermo e qualche tempo dopo – forse per uno scambio di prigionieri – tornò a Roma dove venne rieletto console nel 254 a.C. Con Aulo Attilio Calatino.
[5] “ Il più vecchio Annibale, da quelli di Cartagine un'altra volta alle navi preposto, malavventuratamente co' Romani nella battaglia del mare combattendo, fue vinto; e nell'oste sua levatosi uno romore, lapidato e coperto di pietre fue morto. E Attilio console cercate Lipara e Melita [Malta? nda], nobili isole di Cecilia, disfece”.Paolo Orosio, op.cit. Pag. 221. Sempre Polibio ci dice che Annibale di Giscone qualche giorno dopo rischiò di cadere nello stesso errore di Cornelio Scipione Asina. Avendo avuto notizia che il resto della flotta romana stava avvicinandosi alla Sicilia, con venti navi si avvicinò in esplorazione.« Doppiando la punta estrema dell'Italia si gettò sui nemici [...] perse la maggior parte delle navi, mentre egli scampò con quelle rimaste in modo insperato e inatteso. »Polibio, Storie, I, 21, BUR. Milano. Per questo, essendo riuscito a fuggire alla cattura su una scialuppa, fu giustiziato dai suoi compatrioti.
[6] L. Zagami, op.cit. pag. 81.
[7] L. Zagami, op. cit., pag. 84.(Archivio storico eoliano.it)
La religiosità dei liparesi, Timasiteo e la nave dei romani, Il culto di Demetra
Particolare viva era la religiosità dei liparesi di cui ci provengono numerose testimonianze. Oltre alla devozione per Efesto e Eolo ai quali avevano eretto templi sull'Acropoli, Pausania riferisce che la stessa lotta contro i pirati etruschi era stata comandata i dalla Sacerdotessa di Delfi che officiava dinnanzi all'Oracolo ed essi obbedirono perchè erano molto devoti ad Apollo. Abbiamo anche visto come il primo pensiero, dopo il successo contro i Tirreni e la cattura di venti navi, fosse stato quello di inviare all'Oracolo di Delfi tante statue quante erano le navi catturate e ricchi doni votivi. Significativo per comprendere la religiosità dei liparesi è questo episodio[1] accaduto nel 396 a.C. e riguardante i rapporti con la piccola repubblica di Roma che come sappiamo era stata fondata il 21 aprile del 753 a.C.

Il trionfo di Furio Camillo
Il console Furio Camillo dopo lunghe lotte e un lunghissimo assedio, aveva avuto ragione della potente città di Veio. Tale era stata la durezza della prova ed il conseguente sollievo dei romani, che essi decisero di sciogliere un voto fatto ad Apollo, inviando tre ambasciatori con una nave a Delfi per offrire un prezioso cratere d'oro e altri doni al Dio. Giunta in prossimità dello stretto di Messina, la nave romana fu avvistata dalla flotta eoliana, che non cessava mai di perlustrare il mare e,da questa, catturata giacchè se i liparesi combattevano i pirati non trascuravano qualche volta di fare a loro concorrenza...
Scortata nel porto di Lipari, fu informato della cattura lo stratega in carica, Timasiteo. Costui, interrogati gli ambasciatori romani e udito che il carico d'oro e di preziosi era diretto a Delfi, come dono al Dio Apollo, convocò il popolo e così press'a poco parlò:
“ Liparesi, mio popolo, non è lecito a nessuno appropriarsi dei doni che qualunque città del mondo offre agli dei. Chiunque operi tale sacrilegio è maledetto per sempre. Oltre a ciò questi romani recano doni al grande Apollo per averli illuminati e condotti a vincere i loro nemici, come fece con noi per i nostri. E come noi, vinti i tirreni, recammo doni all'Oracolo di Delfi, così costoro, meno prosperi di noi, pure recano al dio il segno della loro gratitudine. Pertanto io vi dico che non soltanto Lipari non potrà mai macchiarsi di simile delitto, ma vi propongo che, in nome della nostra tradizionale ospitalità e del nostro rispetto per il divino Apollo, la nave romana sia scortata e difesa dalle nostre fino a Delfi e da Delfi a Roma per il ritorno”.
Dette queste cose, i liparesi applaudirono al saggio discorso di Timasiteo e lo approvarono. La nave romana partì scortata da navi eoliane per il lungo viaggio fino a Delfi e poi a Roma. Qui giunti il Senato romano, informato dell'accaduto, decise di conferire a Tisimateo l'ospitium publicum, una sorta di cittadinanza onoraria, ma molto più concreta ed operante che ai nostri giorni. Inoltre inviarono con le stesse navi eoliane ricchi doni ai liparesi[2].


In alto il tempio di Apollo a Delfi. Sopra, il tempio dei liparesi con le venti statue dedicate ad Apollo dopo la vittoria sugli Etruschi.
Oltre che per Efesto ed Eolo ed altri culti verso divinità rappresentate sull'Acropoli, a Lipari e nelle Eolie, si sviluppò – come abbiamo visto - anche il culto per Dionisio (conosciuto anche come Bacco), Demetra e Kore ( conosciute anche come Cerere e Proserpina), facenti parte delle cosiddette “religioni della salvezza”. Questo culto veniva praticato nel santuario detto di Demetra, di cui abbiamo già detto, che sorgeva in una zona extraurbana poco discosta dalle odierne scuole elementari.
Dionisio era il dio della vite, del vino, del teatro, della gioia di vivere ma anche il nume benefico che alimentava le speranze delle beatitudini nell'oltretomba; Demetra invece era la Grande Madre benigna dispensatrice di ogni fecondità; Kore, la figlia di Demetra, era divenuta la regina dell'Ade, ed era garante della sopravvivenza dell'anima e della salvezza eterna. I riti annuali dedicati a questa triade davano luogo ad una festa grande con preghiere, canti, danze, cortei, cerimonie di purificazione, estasi mistiche, offerte, pasti sacri ed anche rappresentazioni teatrali.[3] A Lipari nell'area del Santuario di Demetra sono state ritrovate circa ottomila pezzi in una grande varietà di soggetti che, oltre quelli teatrali, comprende i quadretti votivi (pinakes), le statuette con fiaccola e porcellino, i busti, statuette di donne e di sileni, bambini in fasce , ed altre terracotte votive di soggetto vario. Tutti materiali che si possono riferire ad un periodo che va dalla seconda metà del IV alla prima metà del III secolo a.C. cioè fino alla distruzione di Lipari.[4]
Questo culto e queste celebrazioni alla sacra Triade non avvenivano solo a Lipari ma anche a Salina. Solo che mentre a Lipari questa religione coinvolgeva un po' tutti gli strati sociali a Salina
 erano gli strati sociali più deboli, lì particolarmente presenti, che a Valdichiesa - come dimostra il ritrovamento di terracotte - davano vita ad una festa rurale e popolare che rappresentava una vacanza dal duro lavoro ed una aspirazione ad una esistenza più umana. Questi culti e questi riti si protrassero nelle Eolie anche lungo l'età romana e molto al di là dell'avvento del Cristianesimo[5]. E potrebbe essere non causale, osservano gli archeologi, la vicinanza di questi ritrovamenti col santuario dedicato alla Madonna del Terzito, il cui impianto originario risalirebbe all'epoca bizantina.
erano gli strati sociali più deboli, lì particolarmente presenti, che a Valdichiesa - come dimostra il ritrovamento di terracotte - davano vita ad una festa rurale e popolare che rappresentava una vacanza dal duro lavoro ed una aspirazione ad una esistenza più umana. Questi culti e questi riti si protrassero nelle Eolie anche lungo l'età romana e molto al di là dell'avvento del Cristianesimo[5]. E potrebbe essere non causale, osservano gli archeologi, la vicinanza di questi ritrovamenti col santuario dedicato alla Madonna del Terzito, il cui impianto originario risalirebbe all'epoca bizantina.
Demetra e Kore
[1] L.Zagami, Lipari ed i suoi cinque millenni di storia, op.cit., pag, 68 e ss. .Livio,V, 28, 2-3.
[2] L. Zagami, op.cit., pag. 69; De Sanctis, Storia dei Romani, Torino , 1907, vol. II, pag. 147.
[3] G. Iacolino, Raccontare Salina, op.cit., pag. 69 e ss.
[4] A. Sardella e Ma.G. Vanaria, Le terracotte figurate di soggetto sacrale del santuario dell'ex proprietà maggiore di Lipari, in Meligunis Lipara, vol.X, Roma 2000, pag.87.
[5] G. Iacolino, op.cit. Pagg. 68 e ss.(Archivio storico eoliano.it)
Una stagione felice?
Lipari, a parte qualche breve parentesi, visse in quest'epoca – sostiene Pino Paino[1] - la più felice stagione della sua storia che probabilmente non è un caso se si sviluppava in parallelo ( o in sinergia?) col glorioso secolo di Pericle che caratterizzava Atene.
“Nacquero e proliferarono superbi luoghi votivi(...); sorsero splendidi teatri all'aperto dove si rappresentavano le migliori commedie e tragedie del mondo antico, da Eschilo a Menandro, da Aristofane ad Astidamante; nonché vere e proprie botteghe d'arte nelle quali tenevano scuola eminenti maestri di pittura, scultura e decorazione, soprattutto vascolare”.


A sinistra, busto raffigurante Menandro. A destra, maschere della commedia.
Della stessa opinione sono Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier. “Rimasta fuori dalle guerre che devastarono la Sicilia e la Magna Grecia del V e del IV secolo a.C. Lipari potè godere – scrivono[2] - di una notevolissima prosperità e raggiungere, sopratutto nel IV e nella prima metà del III secolo a. C. un livello economico molto elevato di cui sicura ed appariscente documentazione è la ricchezza e la qualità degli oggetti che costituiscono i corredi delle quasi 3000 tombe messe in luce dagli scavi dell'ultimo cinquantennio. In quell'ambiente di agiatezza e diffuso benessere fiorirono la cultura e le arti. Abbiamo notizia di due scrittori liparesi Pisistrato e Pyron di cui non ci sono pervenute le opere. Prosperarono gli artigianati locali come quello della ceramica dipinta figurata che nella prima metà del III sec. a. C. sviluppò, con l'uso del caolino locale, una vivacissima policromia ad opera di una serie di maestri anonimi, il principale dei quali è conosciuto con il nome convenzionale di 'il Pittore di Lipari'”. Anzi possiamo dire che per merito del Pittore di Lipari e della sua scuola Lipari ci apparirebbe oggi come il massimo centro artigianale – in quell'epoca - di questa ceramica. Forse il centro dove questa tecnica sarebbe stata creata e perfezionata. Una scuola ed una tecnica che hanno le premesse nella ceramica dipinte a figure rosse di quello che è stato chiamato “il Pittore di Cefalù”,un artista di livello molto elevato, forse il più raffinato, il più elegante, il più classico della sua età - che operò negli ultimi decenni del IV secolo a.C.e che Bernabò Brea e Cavalier non esitano ad individuare come “il capostipite della scuola ceramica liparese”[3].


Due opere del Pittore di Lipari al Museo Archeologico di Lipari
Oltre al Pittore di Cefalù operarono a Lipari anche altri maestri della ceramica dipinta che influirono sul Pittore di Lipari e la sua scuola come, ad esempio, il pittore di Adrano, il pittore NYN, il pittore Mad-Mon tutti artisti dai nomi ignoti e così ribattezzati da A.D. Trendall che dedicò ampi studi alla ceramiche figurate della Magna Grecia e della Sicilia.
L'innovazione tecnica del pittore di Lipari e della sua scuola può essere indicata principalmente – oltre che nel materiale adoperato per i vasi formato da una miscela fra l'argilla importata a Lipari dalla Sicilia con il caolino locale - dall'aggiunta di una vasta gamma di colori applicati a tempera e non sottoposti a cottura alle figure rosse su fondo nero con ritocchi di colore bianco e giallo usati dal pittore di Cefalù. Ed il fatto che i colori fossero applicati a tempera senza cottura diceva chiaramente che questo vasellame non era destinato ad un uso pratico quotidiano perché i lavaggi li avrebbero cancellati, ma ad un uso sacrale e funerario.
La produzione della ceramica policroma liparese è intimamente connessa all'affermazione della religione misterica dionisiaca..“Ogni scena, ogni figura, ogni suo gesto, ogni oggetto che essa portava, aveva un preciso significato simbolico e allusivo e non poteva essere mutato ad arbitrio dell'artista”[4].


Statuette votive o raffiguranti personaggi illustri
Oltre ai crateri di cui se ne conservano alcuni molto belli nel Museo Archeologico di Lipari si sviluppò l'artigianato delle piccole terracotte figurate che in un primo tempo produsse splendidi modellini di maschere dei personaggi della tragedia, della commedia e dei drammi satireschi che erano più in voga, poi si specializzò nella produzione di vivacissimi statuette di attori della commedia nei più diversi atteggiamenti; infine – negli ultimi decenni del IV secolo – si cominciarono a produrre anche statuette di belle ragazze che con il teatro non avevano nulla a che vedere, ma comunque rispecchiano la vita quotidiana del loro tempo, i costumi, le mode, le pettinature, gli atteggiamenti che erano allora in voga. “Ci danno cioè – commentano i due archeologi – un ritratto immediato delle belle ragazze che si potevano ammirare nelle strade e nell'agorà di Lipari all'inizio dell'età ellenistica” [5] .
Ma anche qui, sia le statuette in terracotta di argomento teatrale trovate nella necropoli, sia le terracotte sacrali del santuario extraurbano di Demetra e Kore, sia i numerosi altri esempi di soggetto vario rinvenuti essi pure nell'area cimiteriale, nelle tombe, in fosse votive, contro le mura di cinta della città greca, sono legate alla religione ed in particolare alla religione misterica sia di Dioniso che di Demetra. In particolare le statuette che riproducono personaggi e scene del teatro rimandano a Dionisio, divinità a cui era riservato un culto multiforme, presiedendo egli alla vita delle scene, alle feste e proteggendo i defunti nel loro viaggio nell'aldilà.[6]
Erano i tempi questa della Lipara greca – segnala ancora Pino Paino[7] - “ in cui ricorreva costantemente l'occasione di incontrare per le vie della Città, intenti a disputare con altri comuni mortali, Menandro e Senofane di Colofone che non disdegnava di risiedere a Lipari malgrado avesse paura dei vulcani; o come ci riferisce Diogene Laerzio, Aristippo, il fondatore della Scuola Cirenaica, che decisero entrambi di avere qui sepoltura; e ancora Zenone di Elea, il filosofo che rispose a Dionisio che il maggior vantaggio che se ne ricava dalla filosofia è il disprezzo della morte e che proprio a Lipari, stando sempre a Laerzio, organizzò la congiura contro il tiranno di Elea, Nearco, partendo da qui, verso la fine del V secolo a.C. con una spedizione armata di aristocratici; per non parlare di Ebro di Lipari, a cui dedicò Neobule i suoi amori, come ci tramanda Orazio...”.
[1] P. Paino, op.cit.
[2] L. Bernabò Brea e Madeleine Cavalier, “Bellezza ed eleganza femminile nella Lipari greca ed ellenistica” ,Roma, 2005, pag. 21 e ss.
[3] L. Bernabò Brea e M. Cavalier, “La ceramica policroma liparese di età ellenistica”, Muggiò (Mi), 1986, pag. 15. Di grande interesse i capitoli sul Pittore di Lipari.
[4] Idem, pag. 41 e ss.
[5] Idem, pag. 22.
[6] A. Sardella, “Figure danzanti nelle scene vascolari e nelle terracotte di Lipari nel IV e nel III secolo a,C.” in G.M. Bacci w M.C. Martinelli ( a cura), Studi classici in onore di Luigi Bernabò Brea, Messina, 2003., pag. 73-89; di interesse in ordine alla qualità della vita a Lipari nel periodo greco-ellenistico anche il saggio, nello stesso volume, di M. G. Vanaria, “Specchi bronzei con manico decorato a rilievo dal Museo di Lipari” , pag. 91-101. Vedi anche G. Ancona, “Il corredo della tomba 2468 della necropoli greca di Lipari” e A. Sardella, “Statuette di figure femminili nude sedute da Lipari “ in U. Spigo e M.C. Martinelli, Dieci anni al Museo Eoliano ( 1987-1996). Ricerche e studi, Messina, 1996, pag. 103-111 e pag. 123- 139..(Archivio storico eoliano.it)
[7] P.Paino, op.cit.
La città dei cnidi, l'acropoli, la città bassa
L'Acropoli
Se quando i Cnidi giungono alle Eolie – almeno al tempo della prima spedizione (nel 627 a.C) – la rocca è ancora disabitata, cinquant'anni dopo, nel 580 quando giunge la seconda spedizione, certamente essa tornò ad essere popolata. Ma ci volle del tempo perchè si organizzasse come una vera Acropoli, ovvero come la sede degli edifici più importanti :il pritaneo cioè il cuore della città dove veniva conservato il fuoco sacro, gli ex voto,...; la zecca quando anche Lipari cominciò a coniare monete; ed i santuari delle principali divinità: Eolo ed Efesto.


In alto, la baia di Lipari prema degli insediamenti sulla rocca. Qui sopra, il Castello di Lipari al tempo dei cniti.
Ci vollero però altri anni perchè l'abitato occupasse le pendici della rocca e si andasse estendendo nell'area pianeggiante dove sono il centro storico attuale e la contrada Diana. La città venne protetta con alte mura di fortificazioni, oltre le quali, secondo il costume greco, si estendeva la necropoli.
Soffermiamoci un momento a considerare i monumenti ed i reperti di questa città. Abbiamo detto che sull'Acropoli dovevano esserci almeno i templi degli dei principali.
Efesto è il dio che presiede – osservano L. Bernabò Brea , M. Cavalier e F. Villard[1] – a quelle forze endogene della natura che nelle isole Eolie si manifestano con particolare appariscenza e a cui era sacra la vicina isola di Hierà, l'attuale Vulcano, dominata dal cratere, allora in piena attività, che la rendeva inabitabile. E' evidente che una divinità dei vulcani, assimilabile ad Efesto, sia sempre stata venerata nelle isole Eolie, fin da quando gli uomini vi si sono per la prima volta stanziati. E’ probabile anzi che sia stata la principale divinità delle Eolie. Nelle isole essa poteva rivelarsi in tutta la sua forza distruttrice durante i parossismi dei due vulcani attivi, ma si presentava anche come una divinità salutare a causa delle virtù terapeutiche di quelle sorgenti termali e di quelle zone calde fumaroliche che con queste forze endogene sono strettamente connesse( San Calogero a Lipari, il termalismo nella stessa Lipari bassa, i pozzetti della Calcara di Panarea). Il santuario di Efesto probabilmente si trovava nel luogo centrale dell'Acropoli dove oggi sorge la Cattedrale.
Il culto di Eolo dovette essere “ un punto di incontro – sostiene ancora Bernabò Brea – fra gli indigeni che si dicevano da lui discendenti e i colonizzatori cnidi, i cui capi, Pentatlo e i suoi congiunti che gli succedettero a comando della spedizione, non a caso vantavano di discendere da Ippote padre dell'Eolo omerico. Ed era forse la prima volta nel mondo greco che Eolo era considerato una divinità e riceveva un culto. Infatti nelle leggende degli Eolidi, ed in particole in quelle tramandateci da Omero (Odissea ,X, 1-16), Eolo non era una divinità, ma un personaggio storico leggendario. E' il genarca eponimo delle genti di stirpe eolica, anche se, per la sua probità, era favorito dagli dei, che gli avevano concesso di dominare i venti “.


A sinistra il coperchio del botrhos di Eolo trovato al castello. A destra la sezione del btrhos dove si raccoglievano le offerte votive.
Del santuario di Eolo ne fa testimonianza il grandioso bothros per le offerte votive, costruito a guisa di cisterna, il cui riempimento iniziò fin dalla prima metà del VI secolo a.C. poco dopo la fondazione cnida e si protrasse fino almeno al terzo quarto del V secolo. Il tempio doveva essere nelle sue immediate vicinanze e cioè nell'area dietro la chiesa dell'Addolorata ed a fianco all'ex chiesa di Santa Caterina, anche se di esso non sono state rinvenute tracce, come d'altronde – sulla rocca – oltre al bothros e la torre di ingresso, non sono rimaste tracce della città cnita segno che i romani – la cui dominazione inizia nel 251 a.C – costruirono la loro Acropoli dopo avere rasa al suolo quella greca.
Oltre al tempio di Efeso e di Eolo, probabilmente sull'acropoli vi erano altri templi o edicole dedicate ad Apollo e Afrodite e forse dei sacelli dedicati a divinità egize (Ammon Rha) se - come è stato tramandato - fra i membri della seconda spedizione che raggiunsero Lipari nel 580 vi erano anche degli egizi o greci del Delta del Nilo.[2].
La città bassa dei Cniti
Ben presto l'area dell'acropoli dovette rivelarsi insufficiente e la città si estese sulla Civita e sulle pendici dell'acropoli verso la piana e verso Marina Corta. Intorno al 500 a.C., la città bassa fu circondata da un solido muro di fortificazione in opera poligonale. E' assai probabile che esso si appoggiasse verso nord alle balze rocciose che limitano il dosso della Civita verso il porto di Marina Lunga e che costituivano una linea di fortificazione naturale. Circa un secolo dopo, fra la fine del V e la prima metà del IV a.C. la città, cresciuta notevolmente la popolazione, si estese sull'inizio della piana oltrepassando verso ovest il limite del centro urbano della Lipari attuale. Fu costruita allora una nuova grandiosa cinta di mura che sbarrava la piana con una cortina rettilinea dal torrente Ponte a sud al torrente di S.Lucia a nord, e doveva seguire poi il corso di questi torrenti fino al mare e cioè rispettivamente fino alle spiagge di Marina corta e di Marina lunga. E' da tenere presente che il corso del torrente di S.Lucia era, nell'antichità, molto più a sud di quello attuale e veniva a lambire l'attuale palazzo vescovile. Di queste mura fu messo in luce un tratto di una cinquantina di metri negli scavi eseguiti nei terreni della mensa vescovile, che oggi costituiscono il parco archeologico della contrada Diana. La struttura di queste mura è particolarmente grandiosa. Esse sono costruite interamente in elevazione con uno spessore di circa m.3,75 e prospetti sia interni che esterni in blocchi squadrati di pietra del Monte Rosa sovrapposti in filari. Una torre quadrata doveva proteggere la porta principale. Forse risale a questo periodo la costruzione della torre greca posta all'entrata dell'acropoli[3] che rappresenta l'unico pezzo – parzialmente visibile perchè inglobata nelle fortificazioni normanne o sveve ed infine in quelle spagnole - della grande cinta muraria del castello arrivato fino a noi, risalente a questo periodo.


In alto la pianta della città greca. Qui sopra, ruderi delle mura della città bassa a Diana.
Quando la città si estese nella piana dovette essere trasportato qui il pritaneo dal quale nel 306 a. C. il tiranno di Siracusa Agatocle, con una proditoria[4] aggressione contro Lipari – dimentico dell'antica amicizia e dei patti di alleanza e dopo aver imposto ai liparesi il pagamento di cinquanta talenti d'argento[5] - , asportò i sacri ex voto offerti a Eolo e ad Efesto, riempiendo ben 11 navi con gli ori sottratti. Ma mal gliene colse. Non era ancora arrivato a Siracusa che Eolo gli scaraventò contro una terribile tempesta che affondò tutte le 11 navi. Si salvò solo la dodicesima, la nave di Agatocle che riuscì a raggiungere Siracusa. Qui però trovò liti e fortissimi rancori familiari che nel giro di pochi anni sgretolarono il suo regno.
Altri monumenti della Lipara greca non si conoscono salvo due santuari esterni alla cinta delle mura: uno dedicato a Demetra nei pressi della scuola elementare,di fronte a dove oggi è il supermercato Eolo, l'altro nel parco archeologico del terreno vescovile. La necropoli si estendeva invece largamente al di fuori delle mura, nella contrada di Diana, fino al piede delle colline, ma gruppi distanziati di tombe erano a Sant'Anna e a Portinenti.
La necropoli della Lipara Cnita – osserva Bernabò Brea[6] - deve aver cominciato a svilupparsi, a partire dal momento stesso della fondazione della città, sui margini della strada che portava verso gli altopiani dell'isola e che deve essere stata in tutti i tempi una delle strade di maggior traffico irradianti dalla città. Sempre nel VI secolo a.C. un secondo nucleo di necropoli si sviluppò nei pressi del torrente di S. Lucia all'opposto estremo settentrionale della contrada di Diana. Partendo da questi due nuclei iniziali, la necropoli greca è venuta successivamente estendendosi sull'intera contrada Diana.
[1] L.Bernabò Brea, M. Cavalier, F. Villard, Meligunis Lipara, Vol.IX, Topografia di Lipari in età greca e Romana, ParteI, l'Acropoli, pg. 28 e ss.
[2] L. Bernabò Brea, Apporti egizi alla fondazione della Lipara cnida e sviluppo delle sue necropoli, in “Dieci anni al museo eoliano ( 1987-1996), Quaderni del Museo archeologico regionale eoliano, n.1, 1996.
[3] L. Bernabò Brea, M. Cavalier, F. Villard, Meligunis Lipara, vol. IX, op. cit. pag.31.
[4] Di fronte alla tesi che l'attacco di Agatocle a Lipari non avesse nessun'altra ragione se non la sete di ricchezze e di denari ,G. Tropea, Il settentrione greco della Sicilia dal 337 al 241, “Rivista di storia antica”, 4, 1901 sulla base di considerazioni di eminente carattere numismatico, avanza l'ipotesi che il gesto del generale siracusano fosse stato dettato soprattutto da un fatto politico. Dopo l'avvento di Agatocle, le Eolie, probabilmente ,avendo riacquistato durante l'età timoleontea, una più ampia autonomia da Siracusa, siano entrate a far parte, a fianco di Tindari e di Agatirno, di una lega di città greche della costa settentrionale della Sicilia realizzatasi allo scopo di fronteggiare l'aggressiva politica agatoclea di quegli anni. E sarebbe stata questo orientamento autonomistico che avrebbe attirato le ire del generale siracusano. Di una confederazione Lipara- Tyndaris parla anche L. Zagami in “Le monete di Lipara”, Messina, 1959 pagg. 30 e ss.
[5] Diodoro Siculo XX 101,1-3 anche in A. Pagliara, Fonti per la storia, op.cit. Pag. 90.
[6] L. Bernabò Brea, Apporti egizi, ecc. ,op.cit.(ARchivio storico eoliano.it)
Una costituzione comunitaria e superiorità sui mari del Tirreno
Una speciale organizzazione sociale
L’apporto dei Cnidi non rafforza solo gli insediamenti ma permette anche, finalmente, di sperimentare le idee di libertà e organizzazione sociale che questa nuova gente porta nel cuore fin dall’abbandono delle loro terre in Asia minore. Inoltre una particolare organizzazione sociale si rende necessaria per amalgamare insieme gente che fin’ora si era dedicata solo all’agricoltura e gente invece che aveva vissuto sul mare e col mare. Nasce così una originale costituzione comunitaria che all’epoca, come vedremo, dovette fare scalpore[1].
Questa costituzione non riconosceva la proprietà privata; i cittadini erano divisi in due ordini rispettivamente cooperanti: quello dei marinai e quello dei terrestri. I primi difendevano la patria sul mare e provvedevano al sostentamento del popolo con i prodotti della pesca e, probabilmente, anche della pirateria: pirateria da contrasto e pirateria diretta; i secondi erano contadini, costruttori e pastori e lavoravano a loro volta per tutta la comunità. Le navi, i campi e ogni altra cosa erano di proprietà comune. Non si sentiva il bisogno di ricorrere al denaro perché gli scambi avvenivano sulla base della distribuzione dei prodotti e delle necessità. Per questo si cominciarono a coniare monete, più tardi, negli ultimi anni del V o agli inizi del IV secolo a.C per adoperarle negli scambi con altri popoli[2].
Abitazioni, navi e terra appartenevano alla comunità e tutte le decisioni relative a nuove costruzioni come all’utilizzo ed alla distribuzione delle terre venivano prese in assemblea. La preoccupazione delle incursioni piratesche doveva rimanere alta se per secoli solo Lipari fu popolata mentre nelle altre isole si andava, a turno, per coltivarle e per la raccolta dei prodotti, sempre scortati e protetti dai marinai. Quando poi, finalmente si decise di popolarle questo avvenne mantenendo comune la proprietà e sempre con la sorveglianza della marineria.
I villaggi che lì si costruirono rappresentarono gli osservatori di una rete costantemente attiva che teneva sotto controllo i movimenti di navigli che entravano nelle acque dell’arcipelago. Sulle vette delle varie isole vi erano delle torrette di avvistamento che permettevano di vigilare ampi tratti di mare e di segnalare alla flotta liparese, che veleggiava nelle acque attorno all’arcipelago, l’avvicinarsi di un qualunque bastimento di predoni. Questo permise ai liparesi di acquistare nel Tirreno una indiscussa superiorità navale, dovuta non solo alla continua pratica, ma anche alla posizione delle isole, che consentiva di sorvegliare qualunque traffico che si svolgeva sulla costa calabra e sulla costa sicula, da Milazzo a Cefalù. L'occupazione delle isole e la creazione di una efficace rete di sorveglianza sui mari fu alla base della capacità di contrasto con la pirateria etrusca ma, allo stesso tempo, fu con la sconfitta di questa – avvenuta nella battaglia di Cuma del 473 a.C. ad opera dei siracusani di cui i liparesi erano alleati - che fu possibile la piena utilizzazione delle nostre isole minori.
Infatti è da questa età che ha inizio uno sfruttamento più organico della salina di Lingua nell'isola di Salina che doveva essere iniziato fin dal VI secolo e nel IV secolo si può parlare di un centro stabilmente abitato se pur di ridottissime dimensioni dove ora vi è Santa Marina. Nel III secolo la popolazione dell'isola probabilmente toccò i trecento abitanti: per lo più lavoratori subordinati, schiavi, gente di fatica ma anche qualche piccolo proprietario, qualche mezzadro mentre i benestanti risiedevano a Lipari. E questo spiegherebbe il fatto che nell'isola scarseggiano sarcofagi funerari di quest'età. Questi abitanti oltre che nell'odierna Santa Marina vivevano nelle campagne nella spianata del Capo, nella valle fra le due montagne che unisce Rinella a Malfa[3].
Oltre a Lipari e Salina anche Stromboli doveva essere abitata come dimostra il ritrovamento negli scavi del 1980 di una necropoli greca a Ficogrande collocabile fra gli inizi del IV secolo e la metà del III a.C.. A Filicudi vi sono “testimonianze di abitazione stabile forse fin dalla fine del V o almeno dagli inizi del IV secolo a,C.”[4] Naturalmente si trattava di abitazioni collocate nell'attuale località del porto mentre bisognerà aspettare il II secolo a.C. perchè sorgessero abitazioni in zone agricole più lontane. Alla Calcara di Panarea abbiamo evidenti tracce di frequentazione, se non di vera e propria abitazione, dalla fine del IV secolo a.C. alla seconda metà del II secolo d.C.[5]. Comunque visto la peculiarità del sito è pensabile che si trattasse di un luogo di culto magari dedicato al dio Efesto.
I punti di forza di questa fase di sviluppo che va sotto il nome della Lipara cnida ( VI -III secolo a.C.) sono soprattutto tre:
1. La forte coesione dovuta all’originale assetto sociale che la nuova comunità si da.
2. La grande perizia nella navigazione e nel combattimento in mare che li porta presto a dominare nel Tirreno.
3. La ripresa dei commerci e dei rapporti con le popolazioni limitrofe grazie all’agricoltura, alla produzione dell’allume, all’utilizzo delle acque e del termalismo in genere.
Una superiorità sui mari del Tirreno

Disegno di un naviglio etrusco del V secolo a.C.

Ricostruzione di naviglio etrusco di guerra del V secolo a.C.
Interessante è questo aneddoto raccontato da Pausania[6] e che riguarda fatti accaduti nelle prime decadi del V secolo a.C. - probabilmente nell'ambito di un attacco per l'occupazione dell'isola - quando ancora la fama dei liparesi come navigatori e combattenti non si era affermata.
I liparesi avendo una volta avvistati numerosi navigli di pirati etruschi nelle loro acque, mandarono contro di essi cinque delle loro navi. I corsari, fiduciosi della loro capacità e forza, pur essendo di gran lunga superiori per numero di navi, non vollero attaccare in massa i navigli liparesi e, sicuri della vittoria, si opposero solo con un numero eguale di navi. La destrezza dei liparesi si rivelò in pieno ed essi, non solo resistettero all’urto di quella gente, la cui lunga pratica marinaresca li aveva circondati di un’aureola d’invincibilità, ma riuscirono ad impadronirsi dei vascelli loro opposti. I Tirreni cedettero che la vittoria dei liparesi fosse dovuta al caso e non al valore, e pertanto inviarono altre cinque navi meglio armate contro le cinque liparesi. Anche questa volta la vittoria arrise ai discendenti di Eolo e la nuova sconfitta esarcebò non poco i vecchi corsari i quali, armate altre cinque navi di gente particolarmente esperta nell’arte marinara, vollero ancora ritentare la prova della loro supremazia, facendo attaccare i navigli liparesi, vittoriosi già nei due precedenti combattimenti. Per la terza volta i liparesi uscirono vittoriosi dal duro confronto, aggiungendo così altre cinque navi alle dieci già catturate.
I pirati toscani, pure rammaricati per le perdite subite, non vollero attaccare con tutte le loro navi disponibili i vascelli avversari, stimando che poca gloria avrebbero avuta con lo sconfiggere dei navigli e della gente già provate e fiaccate in tre precedenti combattimenti. Ancora una volta essi preferirono dunque affrontarli con ugual forza e pertanto, preparati cinque legni con i migliori combattenti, affidarono ad essi il retaggio della loro vecchia supremazia. L’urto fu violento ma l’ardore dei liparesi ebbe anche questa volta ragione. I Toscani sorpresi dal valore di questi nuovi audaci del mare, che avevano combattuto e vinto in ben quattro prove, ricusarono ogni altro combattimento, preferendo allontanarsi e lasciare nelle mani degli avversari i venti vascelli catturati.
Grande fu la gioia degli abitanti di Lipari, quando videro tornare nel loro porto le loro cinque navi con a rimorchio ben venti navi catturate. Ricchi donativi furono, per quella strepitosa vittoria, offerti a ringraziamento dei liparesi ad Apollo in Delfi, nel cui tempio vennero pure depositati i venti stendardi delle navi etrusche catturate.
Ma la gioia dei liparesi fu di breve durata perchè durissima fu la reazione dei tirreni compreso un episodio di sacrificio umano che creò un grande sconcerto. Infatti, non si erano ancora spenti gli echi della grande vittoria, che gli etruschi, guidati da Velthur Spurinna, attaccano e conquistano Lipari e per rispettare un voto fatto a Febo ( Apollo), gli immolano il più forte dei liparesi, Teodoto. Ma anche la dominazione dei tirreni durò poco e dopo qualche anno i liparesi liberarono – forse con l'aiuto di Ierone di Siracusa - la loro isola (480-475 a.C.) dedicando al dio delfico una grande base marmorea con dedica. Ancora qualche tempo e gli Etruschi saranno definitivamente sconfitti a Cuma[7].
Un altro momento di coinvolgimento bellico Lipari lo dovette subire nel 427 a.C. nell'ambito della guerra tra Siracusa ed Atene che si concluse nel 424 con la pace di Gela. I liparesi erano schierati a fianco di Siracusa e per questo subirono diversi tentativi di occupazione fra i quali il più duro fu quello avvenuto sul finire del 427 da parte della flotta ateniese forte di 3400 uomini. Ma Lipari resistette – come anche in una successiva incursione nell'inverno del 426 - ed agli ateniesi non rimase che depredare le campagne.[8] Un altro scontro, sempre a causa dell'alleanza con Siracusa, Lipari lo subì nel 397 a.C. da parte dei cartaginesi che avevano dato inizio alla loro politica espansionistica. Questa volta la città soccombette ed i liparesi furono condannati a pagare 30 talenti ma ricuperarono la propria indipendenza una volta partita la flotta avversaria[9].
Mutamenti istituzionali e successo del “modello”
Intorno al IV secolo la costituzione comunitaria eoliana subì un mutamento, probabilmente dovuto alla maggior sicurezza e a un certo consolidamento delle strutture sociali. Si deliberò un affidamento ventennale di appezzamento dei terreni di Lipari alle famiglie di contadini. Ogni venti anni tutta la terra veniva di nuovo unificata e si procedeva ad una ulteriore suddivisione per il successivo ventennio per sorteggio.
Le isole minori restarono invece di dominio comune, prevalentemente adibite a pascolo, finché finirono anch’esse per essere lottizzate.
L’intento di sostenere il valore del distacco dal possesso era manifesto e dichiarato; ogni 20 anni, con feste e cerimonie rituali, tornava al popolo ciò che era del popolo. L’eccezionale fertilità e ricchezza dell’agricoltura eoliana testimonia che l’affidamento della terra veniva considerato come una sacra investitura e che ciascuno si faceva obbligo di ritornare i campi al popolo più fecondi di come li aveva ricevuti.
L’introduzione di queste regole, meno draconiane delle precedenti, dimostrano che si comincia a paventare, da parte dei capi dell’arcipelago, l’attaccamento alla proprietà privata fra la popolazione, sentimento che in precedenza non esisteva. Certo questo era dovuto al maggior benessere raggiunto dagli eoliani, alla sicurezza ormai consolidata dopo la vittoria sui pirati e certamente ai frequenti rapporti con popoli che non solo avevano l’istituto della proprietà privata, ma vantavano colossali fortune personali.
Lipari inoltre era divenuta un fiorente centro di scambio fra i più ricchi commercianti del Mediterraneo e dell’Egeo. Così nella prima metà del III secolo a.C. la rotazione ventennale della terra venne abolita e , in pratica, si istituzionalizzò la proprietà privata. Fu probabilmente in quel periodo ( o forse anche qualche decennio prima) che Lipari cominciò a coniare moneta. A dimostrazione che la moneta, almeno inizialmente, più che per i rapporti interni dovesse servire per i commerci con gli altri popoli ed in particolare con gli Etruschi verso i quali non vi era solo un rapporto di ostilità ma anche di interessi, sta il fatto che le monete di Lipari non furono coniate in argento come quelle delle altre colonie greche ma in bronzo e con un certo peso, simili cioè a quelle del sistema etrusco. Comunque con l'avvento della proprietà privata il “comunismo” di Lipari era finito. Esso era durato almeno trecento anni.
Questa costituzione della Lipara greca dovette colpire la fantasia dei contemporanei e forse influenzare le utopie sulla riforma dello stato che sbocciarono in quei tempi e nei secoli seguenti. Sembra che lo storico greco Evemero da Messina, di cui gran parte delle opere sono andate perdute, abbia scritto proprio su questa costituzione comunitaria delle Eolie. Addirittura si vuole che lo stesso Platone nella stesura della sua “La Repubblica” - scritta fra il 380 e il 360 a.C. - si sia ispirato all'esperienza liparese[10] contrapponendo alle classi dei marinai e dei contadini quella dei guerrieri e dei lavoratori e prevedendo la proprietà collettiva invece di quella privata..


A sinistra, un frammento dell'originale della Repubblica di Platone. A destra, una edizione più recente.

[1] Noi la riprendiamo dalla ricerca fatta da Gin Racheli nel suo libro “Eolie di venti e di fuoco”. Riferimenti sono anche a Strasbone e soprattutto al bel saggio diTheodore Reinach, Le collettivisme des grecs de Lipari, in Revue des etudes Ggrecques”, 1890 , pgg 86-96.
[2] L. Bernabò Brea, M. Cavalier, Il Castello di Lipari e il muso archeologico eoliano, Palermo, 1979, pag. 91.Ma potrebbe essere che la moneta di conio liparese faccia la sua comparsa solo nel III secolo.
[3] G. Iacolino, Raccontare Salina, op.cit. Pagg. 73 e ss.
[4] L.Bernabò Brea e M. Cavalier, Meligunis Lipara, vol.VI. Filicudi. Insediamenti dell'età del bronzo.Palermo, 1991.
[5] L.Berrnabò Brea e M.Cavalier, Meligunis Lipara, vol. III, Stazioni preistoriche delle isole Panarea, Salina e Stromboli, Palermo, 1968, pag. 9 e ss.
[6] Riportato da Zagami nel suo “Lipari e i suoi cinque millenni di storia”.
[7] A. Pagliara, Fonti per la storia dell'arcipelago eoliano in età greca, in Maligunis Lipara, Vol. VIII, Parte II, note pagg. 74-75.
[8] Tucidite, Vi,17 e III,115.
[9] Diodoro, XIV, 56.
[10] A. Raffa ha illustrato questa suggestiva ipotesi in una conferenza tenuta a Lipari nell'estate del 2008.(Archivio storico eoliano.it)
I Cnidi

Chi sono e da dove vengono
Dopo una interruzione di alcuni secoli durante i quali le isole ed anche Lipari rimasero praticamente disabitate - salvo la presenza di piccoli gruppi che si tenevano distanti dal mare e quindi anche dalla rocca che era meta di continue incursioni di pirati provenienti dalle coste del Tirreno – Lipari e le Eolie vedono aprirsi una nuova fase di sviluppo e di floridezza ad opera dei Cnidi.
Chi sono costoro? Da dove provengono? Quando giungono a Lipari? Non sono domande semplici anche perché se ora siamo alle soglie della storia è difficile trovare documenti di prima mano e bisogna operare facendo riferimenti a storici per lo più greci e romani che scrissero, spesso con approssimazioni e contraddizioni, su quegli anni.

Pianta dei ruderi dell'antica Cnido.
Sappiamo da Diodoro Siculo che la spedizione che giunse a Lipari nel 580 a.C. era composta oltre che da gente di Cnido, probabilmente di origine dorica, che avevano abbandonato la loro terra nell’Asia minore perché non sopportavano la tirannia del loro re, anche da gente di Rodi. Inoltre dall'analisi delle tombe ritrovate e risalenti a questo periodo, emerge che della spedizione dovettero fare parte anche un gruppo di egizi e di greci provenienti dal delta del Nilo. Sappiamo anche che questa spedizione, sotto il comando di Pentatlo, non era diretta a Lipari ma al Capo Lilibeo. Giunsero nella regione dove Segestani e Selinuntini combattevano fra di loro. Qui decisero di dare man forte, forse per comunanza di idioma o addirittura di origini, forse per comunanza di sentimenti, ai Seluntini. Ma nello scontro questi ebbero la peggio ed anche il nostro gruppo subì forti perdite fra cui la morte del loro condottiero Pentatlo.
Che fare? I superstiti pensarono di tornare in patria nominando come comandanti Gorgo, Testore ed Epiterside. Ma sulla via del ritorno toccano Lipari che era ridotta ormai a circa 500 abitanti, discendenti di Eolo e, vista la buona accoglienza, si fecero convincere a restare nell’isola.
Questa versione contiene alcune contraddizioni interne e non corrisponde ad altri dati che ci provengono da fonti diverse. La contraddizione evidente è la strada che il nostro gruppo fa per tornare in patria. Perchè passare per il Tirreno? Perché non tornare dalla strada da cui erano venuti? Lo scalo a Lipari fu un fatto occasionale o una scelta voluta? Non è che fallito l’obiettivo di costruire una colonia sul promontorio Lilibeo la nostra spedizione decide per una altra meta? Lipari era del tutto sconosciuta a questi uomini?

I ruderi dell'antica Cnido
Un altro storico, Eusebio, colloca la fondazione cnida nelle Eolie non nel 580 al tempo della 50ma olimpiade ma, un cinquantennio prima, al tempo della 38 ma e quindi intorno al 627 a.C. Inoltre perché la nuova colonizzazione delle Eolie è attribuita – da vari storici (Pausania,Tucidite, ad esempio) e da una tradizione costante - solo ai Cnidi se la spedizione proveniente dal Lilibeo e formata da gente di Cnido e di Rodi? Per questo è stata avanzata una diversa ipotesi[1] che riguarderebbe proprio la gente di Cnido alla quale abbiamo aggiunte altre informazioni – da fonti diverse - circa i rapporti con Rodi prima e quindi la fondazione di Rosas in Spagna.
Una diversa versione sulla fondazione
Cerchiamo di ricostruirla così questa diversa ipotesi: prima della 38° olimpiade a Cnido si verifica una ampia secessione popolare che decide di abbandonare, perseguendo un sogno di libertà e di diversa organizzazione sociale, Cnido che era dominata da una tirannia. La spedizione raggiunge Rodi e qui pensa di stabilirsi. Anzi in buona parte stringe relazioni e rapporti con la gente del luogo tanto da dare vita, insieme ad alcuni locali, a villaggi comuni. Ma non tutti i profughi cnidi sono per una vita stanziale. Alcuni di loro partono per nuove avventure. Due probabilmente sono le mete di queste spedizioni: una a sud della Sicilia a capo Pachino[2] o Capo Passero e l’altra a nord nelle Eolie, avendo appreso che queste erano “ di nuovo e sempre più disabitate”.
Ed è allora che i discendenti di Eolo accolgono con favore i nuovi venuti esperti nell’arte della navigazione e chiedono loro di rimanere per aiutarli a far fronte alle incursioni dei pirati tirreni ( divenendo magari pirati anche loro). Quando cinquant’anni dopo si prepara una nuova spedizione da Rodi, probabilmente con a capo Pentatlo, formata dalle nuove generazioni degli esuli Cnidi che si erano mescolati con gli abitanti di Rodi, il loro obiettivo è di andare a trovare e ricongiungersi con i membri della spedizione precedente verificando quale fosse stata la loro fortuna e la loro sorte.
Dopo la sconfitta del Lilibeo e la constatazione che quel primo obiettivo non aveva avuto successo, essi non decidono di tornare in patria ma di andare a verificare che cosa ne era stato di chi aveva raggiunto le Eolie e qui si fermano anche se probabilmente qualche tempo dopo, presi ancora dallo spirito di libertà e di avventura, alcuni di loro veleggiano verso la Catalogna in Spagna, dove vanno a fondare Rhodas ( in memoria di Rodi) da cui l’attuale Rosas [3] Ma questa è un’altra storia.
Rinvigorita la gente di Lipari con l’apporto dei nuovi arrivati, non c’è più bisogno di sfuggire le coste e nascondersi all’interno. Così si torna ad occupare la rocca, un forte naturale ma a diretto contatto col mare.
[1] L. Braccesi, Cronologia e fondazioni coloniarie :Pentatlo, gli Cnidi e la fondazione di Lipari, in Hesperìa, 7, Studi sulla Grecità di Occidente.
[2] Pausania, Graeciae descriptio X II,3-4. Pausania si rifà ad Antioco di Xenofane Siracusano autore di una Storia di Sicilia. Qui si dice che i Cnidi fondarono una città presso Capo Pachino, probabilmente, aggiungiamo noi, nella spedizione del 627 a.C.: La spedizione di Pentatlo del 580 andò sulle tracce della precedente e quindi fece scalo a Capo Pachino. A capo Lilibeo parteciparono alla battaglia fra Segestani e Seleuntini. Sconfitti abbandonarono capo Pachino, forse portandosi dietro anche parte dei superstiti della spedizione precedente e puntarono sulle Eolie che era già il secondo obiettivo della loro spedizione.
[3] Il Mommsen, Storia di Roma, lib.I,cap.10,par. 12 colloca la fondazione di Rhodieae da parte dei Cnidi-Liparesi molti anni dopo quando erano già divenuti una affermata potenza nel Tirreno, mentre gli spagnoli ritengono che la colonia greca fu creata dai Rodii nel 776 a.C.).(Archivio storico eoliano.it)
La rivoluzione del 1848
"Sicilia all'armi!"
La prima a partire fu Messina. All'alba del 3 giugno 1847, nel giorno della festa cittadina della Madonna della Lettera, la statua di bronzo del re, che era in piazza Duomo, oggi in via Garibaldi, appariva con le orecchie tappate da bambagia e con la benda agli occhi, ad indicare che Ferdinando era sordo alle richieste dei siciliani e cieco perché non vedeva quale era la situazione. Era un primo segnale che qualcosa bolliva in pentola. E ciò a cui ci si apprestava era una insurrezione che sarebbe dovuta scoppiare congiuntamente il 2 settembre a Messina e Reggio Calabria. Ma l’1 settembre si presentò l’occasione di catturare tutto lo stato maggiore borbonico in un colpo solo,e quindi si decise di anticipare gli eventi. Il 1° Settembre 1847 alle ore sei del pomeriggio cinque gruppi partirono da diversi punti della città chiamando alle armi tutti i cittadini. Gli ufficiali, avvertiti tempestivamente della rivolta, erano scappati per rifugiarsi nei quartieri militari e nelle fortezze. In un primo tempo i messinesi sembrarono avere la meglio. Erano numerosi quanti dalla marina si dirigevano al forte ed avevano occupato diversi posti doganali. Ma poi l’esercito ebbe la meglio ed a sera la rivolta era stroncata. Gli insorti trovarono riparo e ospitalità sui colli della città e malgrado gli ufficiali borbonici incitassero i cittadini a denunciare gli insorti, con una taglia di 300 ducati per ogni ribelle ucciso e 1.000 ducati per ogni ribelle catturato, nessuno fece denuncia. Non solo ma lo sdegno popolare si radicò e assunse forme pubbliche di contestazione quando si cercò di far passare la rivolta per opera di alcuni pazzi.
La mattina del 9 gennaio 1848 per le strade di Palermo apparve un manifesto. Esso diceva:
“ Siciliani! Il tempo delle preghiere inutilmente passò, inutili le proteste, le suppliche, le pacifiche dimostrazioni. Ferdinando tutto ha spezzato. E noi popolo nato libero, ridotto fra catene e nella miseria, ardiremo ancora a riconquistare i legittimi diritti. All’armi figli della Sicilia! La forza dei popoli è onnipossente: l’unirsi dei popoli è la caduta dei re. Il giorno 12 gennaio, all’alba, segnerà l’epoca gloriosa della universale rigenerazione. Palermo accoglierà con trasporto quanti siciliani armati si presenteranno a sostegno della causa comune, a stabilire riforme ed istituzioni analoghe al progresso del secolo, volute dall’Europa, dall’Italia, da Pio IX. Unione, ordine, subordinazione ai capi, rispetto a tutte le proprietà. Il furto si dichiara tradimento alla causa della patria e come tale punito. Chi sarà mancante di mezzi ne sarà provveduto. Con questi principi il cielo seconderà la giustissima impresa. Sicilia, all’armi!”.
Era l’annuncio di quella rivoluzione siciliana che inaugurerà i moti del 1848. A questo ne seguono altri il giorno dopo, che invitano i cittadini a scendere per le strade all’alba del 12 con le armi. Ma è una rivoluzione improvvisata. E questo apparirà chiaro proprio la mattina del 12 quando un gruppetto di cittadini armati alla meno peggio diede inizio alla rivolta. Sulla tarda mattinata la cavalleria attacca la folla che inneggiava a Pio IX e non riesce a disperderla anzi un ufficiale rimane ferito e 10-11 soldati uccisi. Quindi è costretta a ripiegare. E’ questa la molla che fa divampare la rivolta. Battere i soldati è possibile! E come se si fosse dato fuoco ad una polveriera la rivolta dilaga nella provincia e nelle campagne. Giungono a Palermo per unirsi ai popolani rivoltosi aristocratici, intellettuali, borghesi, possidenti, contadini. Gli scontri durarono una decina di giorni e i rivoltosi si impadronirono di gran parte della città. A presiedere il Comitato Generale venne designato Ruggero Settimo dei principi di Fitalia, un anziano liberale, già brigadiere della marina napoleonica e ministro nel governo del 1812.
I Borboni tentano una contromossa facendo giungere da Napoli rinforzi con cinquemila uomini ma questi non riuscirono a collegarsi con le truppe assediate a palazzo reale e il 26 gennaio furono costrette ad abbandonare le posizioni e fuggire per Napoli.
Alla notizia dei fatti di Palermo insorsero anche Messina, Catania e via via tutte le città dell’isola.
A Messina il 28 gennaio un comitato di 300 cittadini pubblicò un proclama: "All'armi ai messinesi! ecco il giorno tanto sospirato! Siete tutti ormai armati e organizzati. Messina che diè prima il segno dell'insurrezione finisce in questo giorno la grande Rivoluzione Siciliana, trionfante per opera dell'immortale Palermo. Pronti alla difesa, pronti al fuoco, se una mano di capi pazzi e venduti, un armento di ciechi soldati, che son trascinati come vittime al macello, tenteranno di turbare la gioia cittadina del trionfo siciliano"[1].
Il giorno dopo i messinesi scesero in piazza. I soldati sparavano sulla città dai forti e alle 23 entrarono in città. Fu una battaglia feroce soldati contro cittadini. I reparti sconfitti si ritirarono scappando nel campo d'armi di Terranova, dove adesso c'è la stazione ferroviaria. I combattimenti durarono molti giorni a Messina, ma alla fine il popolo ebbe la meglio. In meno di un mese la Sicilia fu in mano al governo provvisorio meno la cittadella di Messina.
Una miccia che si propagò in tutta Europa
Quella della Sicilia fu la miccia che si propagò per tutta l’Europa. Il 10 febbraio insorse Napoli malgrado re Ferdinando - lo stesso giorno, pressato dagli inglesi -, avesse in tutta fretta promulgato una Costituzione; il 15 Firenze, il 27 Parigi, i 5 marzo Torino, il 14 Roma, il 15 Vienna e Budapest, il 19 Berlino, il 22 Venezia, il 23 Milano.
Sempre su pressione degli inglesi, e cioè degli ambasciatori Napier e Minto, Ferdinando estende la costituzione napoletana anche alla Sicilia ma il Comitato rivoluzionario la rifiutò con una motivazione che dice chiaramente come quella siciliana era soprattutto una rivoluzione per l’autonomia della Sicilia ed il vero nemico non era il re ma il governo di Napoli. Infatti i siciliani non avevano mai digerito che Ferdinando, dopo il Congresso di Vienna, avesse riunificato i regni stabilendo la capitale a Napoli ed avesse abolito il Parlamento siciliano e la costituzione del 1812.
Ecco, in sintesi, la risposta del Comitato siciliano:
“1. Che il Re avesse ripreso l’antico titolo di re delle Due Sicilie (e non del Regno delle Due Sicilie). 2. Che il suo rappresentante in Sicilia si fosse chiamato Vicerè e che fosse un membro della famiglia reale o un siciliano. 3. Che l’atto di convocazione del Parlamento, facesse parte della costituzione. 4. Che gli impieghi civili, militari ed ecclesiastici fossero appannaggio dei siciliani. 5. Che si consegnasse alla Sicilia la quarta parte della flotta, delle armi e del materiale di guerra o l’equivalente in denaro. 6. Che fossero restituiti i battelli doganali e postali acquistati per conto della Sicilia. 7. Che gli affari d’interesse comune fossero trattati e determinati dai due parlamenti. 8. Che in una lega politica o commerciale degli Stati italiani vi dovesse essere rappresentata la Sicilia come Stato indipendente. 9. Che la Sicilia potesse coniare moneta”[2].
Il 22 marzo Ferdinando respinge le proposte e provocatoriamente fa notare che con le loro richieste di autonomia, i siciliani andavano contro lo spirito risorgimentale e di fratellanza che traversava l’Italia intera. Ora il Comitato deve decidere se andare avanti o tornare sui propri passi. E decide di andare avanti dichiarando Ferdinando e la dinastia dei Borbone decaduti dal trono di Sicilia, affermando che la Sicilia si reggerà con un governo costituzionale e che sarebbe stato chiamato al trono un principe italiano dopo che si sarà definito lo statuto.
La costituzione fu emanata il 10 luglio ed era , per i tempi, fortemente ispirata ad una concezione liberal-democratica, ma la ricerca di un principe italiano disposto ad assumersi la guida di Sicilia non approdò a nulla. Intanto l’esercito napoletano il 7 di settembre dopo tre giorni di bombardamenti occupò Messina ed il 9 la fortezza di Milazzo. Il 22 aprile 1849 il governo di Ruggero Settimo rassegnò le dimissioni, il primo maggio Palermo offrì la capitolazione alle truppe napoletane al comando del colonnello Nunziante ed il 15 maggio i Borboni avevano nuovamente il pieno controllo dell’isola. La rivoluzione siciliana era durata circa 16 mesi. Il re offrì amnistia generale salvo 43 esponenti della rivoluzione. La maggior parte di loro si imbarcò per Genova e parecchi di essi , undici anni più tardi, furono alla base della spedizione dei mille. Ruggero Settimo invece riparò a Malta dove venne accolto con onori di un sovrano.[3]
La rivoluzione del 1848 a Lipari
Come vissero i liparesi i fatti di Messina e di Palermo? Non ci sono narrazioni che riguardano quei mesi ma solo degli indizi che ci fanno comprendere che anche Lipari partecipò agli eventi anche se forse senza momenti di tensioni.
Anche a Lipari, come in altre parti della Sicilia e d’Italia, si era costituito un gruppo rivoluzionario clandestino in contatto con il Comitato rivoluzionario di Palermo. La persona più attiva era certamente Giovanni Canale[4],coadiuvato da Giovanni Amendola, di quindici anni più anziano, cognato del prof. Serafino De Angelis. Del comitato dovevano far parte anche don Filippo de Pasquale e il De Angelis.
Ci fu un cambiamento di amministrazione. Decadde il sindaco don Giuseppe Milio e per due mesi, da metà luglio a tutto settembre del 1848, i poteri furono assunti dal barone avv. Leopoldo Rodriquez[5] in qualità di presidente del Magistrato Municipale quindi divenne sindaco e vi rimase fino al 1855. In città inoltre fu costituita la Guardia nazionale. Erano dei corpi militari formati da giovani di famiglie nobili e borghesi, col compito di mantenere l’ordine pubblico. Questa istituzione ereditata dalla Francia rivoluzionaria in Italia si affermò proprio in occasione dei moti del 1848, si ripresentò nel 1860 fino a quando il governo italiano la sciolse decisamente nel 1867.
La guardia urbana
Della guardia nazionale, o meglio urbana come veniva chiamata, liparese del 1848 si conoscono due nominativi del tenente Emanuele Carnevale[6], che la comandava, e del caporale Giovanni Bongiorno della classe del 1823.
Comunque alcune giornate di turbolenza Lipari dovette viverle perché questo risulta da due comunicazioni del vescovo del tempo che era mons. Bonaventura Attanasio[7]. Nella relazione del 1854 alla Santa Sede egli confessa di essersi allontanato dalla sede durante le “vicissitudini” del 1848 e più avanti aggiunge che quello fu un anno di “turbolentissima tempesta” (turbolentissima erupit tempestas”) che distrusse il lavoro fatto[8]. Ancora ad una nota del 12 novembre del 1849 del luogotenente generale di Palermo che invitava mons. Attanasio a ripristinare gli stemmi reali, questi rispondeva che si era provveduto a rimettere quelli che “n’ tempi del disordine venivano tolti”[9].
Alla rivoluzione parteciparono anche alcuni personaggi della comunità eoliana che in quel periodo erano assenti da Lipari. Vi partecipò sicuramente don Filippo De Pasquale, già sindaco di Lipari, che in quel periodo era a Palermo ed entrò a fare parte del nuovo Parlamento siciliano che si era riunito solennemente nella Chiesa di S. Domenico il 25 marzo del 1848 e che il 13 aprile approvò la dichiarazione della decadenza della dinastia borbonica dal regno di Sicilia. Il De Pasquale in quegli anni strinse rapporti e rinsaldò antichi legami con Ruggero Settimo, Giuseppe La Farina, Vincenzo Florio, Francesco Crispi, Michele e Enrico Amari e altri personaggi che avevano fatto la rivoluzione e che saranno poi al centro di vicende della nostra storia nazionale. Dovette parteciparvi anche Giovanni Canale[10] che farà parte delle formazioni garibaldine e che in quei mesi risultava assente da Lipari.
Durante i mesi della rivoluzione Lipari rimase priva dei regolari collegamenti con la terraferma giacchè alcuni battelli erano stati requisiti dal governo di Napoli ed altri, come il Giglio dell’Onde e il Vesuvio, dagli insorti siciliani.
E proprio il Giglio e il Vesuvio furono protagonisti dell’unica vicenda della rivoluzione che in qualche modo tocca le Eolie ed in particolare Stromboli. Il 12 giugno del 1848 i due piroscafi partono da Milazzo con a bordo un corpo di volontari, 624 uomini in tutto, per andare , muniti di cannoni e con dodici muli, a Bagnara a dare man forte ai liberali calabresi insorti. Ma lungo il tragitto vengono avvistati da navi armate napoletane che uscivano da Pizzo. I due piroscafi con gli insorti per non essere intercettati si rifugiano a Stromboli dove rimangono nascosti per tutta la giornata del 13. Ma ad una certa ora della giornata il comandante, che era il nizzardo Ignazio Ribotti, e gli ufficiali che si trovavano sul Giglio vengono richiamati da clamori che si levavano dal Vesuvio. Accostano e scoprono che è in corso una discussione vivace fra chi volevano procedere verso l’obiettivo, ed erano la gran parte, ed i pochi invece che volevano tornare indietro. Il comandante decide che chi vuole proseguire lo faccia con il Vesuvio e chi invece vuole tornare trasbordi sul Giglio che sarebbe andato a Milazzo. E così undici ufficiali trasbordarono “accompagnati da fischi e da urli di disprezzo[11]”.
Quando ,conclusa la rivoluzione, arrivò il momento della repressione poliziesca , questa si fece sentire anche a Lipari. Si ha notizia che furono colpiti anche dei monaci dei Minori Osservanti, come un certo padre Calcedonio da Lipari le cui responsabilità il suo superiore cercava di ridimensionare sostenendo che quello che aveva agito per “ignoranza e leggerezza” e che era uno che “aveva il vizio di parlare troppo”.
Inoltre a Lipari arrivò un nuovo stuolo di detenuti, delinquenti comuni e esiliati politici, fra cui diversi ecclesiastici che erano obbligati a dimorare nei due conventi sotto la responsabilità del vescovo.(Archivio storico eoliano.it)
[1] Rosario Baeli, http://www.messinacity.com/News/Archivio/2005/2005-09-1848.html
[2] Le condizioni per intero si possono leggere nel testo “Memorie” di Fardella di Torrearsa, riportate da Renda in Storia di Sicilia , 2° volume. Pag 932, edizioni Sellerio.
[3] Per la redazione di questo paragrafo abbiamo consultato F.Renda, Storia della Sicilia, Palermo 2003; R.Romeo, il risorgimento in Italia, Laterza, 1950; W. Dickinson, Patriotti e galeotti, Sicilia 1848. Diario di una rivoluzione, 2003. F.Misuraza e Alfonso Grasso, Il regno siculo-partenopeo tra il 1821 ed il 1848, Parte I e II in “Brigantino- Il portale del Sud”, www.ilportaledelsud.org. ; R. Baeli in www.messinacity.com .
[4] Giovanni Canale di Zaccaria e Maria Rodriquez era nato a Lipari il 28 settembre 1823. Morirà in Lipari il 26 aprile 1887.
[5] Leopoldo Rodriquez era figlio del barone don Giovanni Antonio e di donna Maria Odavene e fratello di quel can. Carlo Rodriquez che abbiamo già incontrato.
[6] Emanuele Carnevale di Onofrio e di donna Giovanna Salpietro nacque a Lipari il 25 luglio 1827 e morì il 13 novembre 1873. Abitava nella villa di S. Lucia oggi villa Lo Cascio.
[7] Mons. Bonaventura Attanasio era nato a Lucera in provincia di Foggia il 13 ottobre 1807. Fu nominato vescovo il 22 luglio del 1844 e giunse a Lipari nei primi di marzo del 1845. Notevole fu la sua attività sia sul piano della cura degli edifici di culto come del patrimonio della mensa, sia in ordine all’attività pastorale dedicando molto spazio alla visita nelle chiese sia di Lipari che delle isole e garantendo che tutte le chiese avessero almeno un prete. Aprì finalmente il seminario che era stata l’aspirazione di molti vescovi ,restaurando l’edificio destinato da mons. Coppola a Conservatorio femminile; realizzò l’ampliamento del Palazzo vescovile di Diana; fece costruire la chiesa nuova a Quattropani e quella di S. Gaetano a Rinella. Nell’ottobre del 1857 rassegnò le dimissioni da vescovo di Lipari che furono accettate purchè rimanesse a reggere la diocesi di Lipari fino all’arrivo del successore per evitare la “vacanza di Sede”. Il successore fu mons. Ludovico Ideo che venne nominato il 25 giugno del 1858. Dopo aver lasciato Lipari mons. Attanasio si ritirò a Napoli dove Ferdinando II lo nominò Presidente della Pubblica Istruzione del Regno. Collaborò inoltre con l’Arcivescovo di Napoli nelle opere caritative a favore dei malati di colera. Fondò nel 1861 la Pia unione di Gesù crocifisso per la conservazione della Fede e della Pietà. Mori a Napoli il 3 settembre del 1877.
[8] Relatio status Liparensis Ecclesiae, anno 1854, in Archivio Segreto Vaticano, Cass. 456 B, ff. 192 e 193.
[9] Archivio Vescovile, Carpetta Corrispondenza D. Circa il lavoro fatto che era andato in fumo, l’Attanasio si riferisce, fra l’altro, all’iniziativa, verso la fine del 1846, di “radunare in un’unica casa e sotto la vigilanza diretta di due donne di provata integrità, ventidue donne che vivevano nell’immoralità e nel peccato. …per lo spazio di circa sedici mesi io a quelle fornivo e gli alimenti e ogni altra cosa necessari”. Come anche all’aver fatto venire sei sacerdoti Redentoristi che per quasi sei mesi predicarono missioni nella città e nelle isole.Archivio Segreto del Vaticano, Relatio status Liparensis eccl. Cass. 456 B, ff.196 e 193.
[10] Giovanni Canale di Zaccaria e Maria Rodriquez era nato a Lipari il 28 settembre 1823 e proprio il 28 novembre del 1848 si sposa per procura con donna Marianna Favaloro. Torna a Lipari solo nei primi mesi del 1849 per dichiarare la nascita della primogenita.
[11] T. Landi, Memorie di Calabria, Ricordi della spedizione di Sicilia in Calabria nel 1848, in F.Giannetto, Memoria indedita di Tommaso Landi sulla spedizione siciliana del 1848 in Calabria, in “Messina e la Calabria”, Atti del I Colloquio Calabro-Siculo, Reggio C.- Messina, nov. 1986, Messina 1988, pp586-87.(Archivio storico eoliano.it)
Un complotto contro il vescovo che voleva riformare la raccolta delle decime
L’epidemia di colera
Comunque già il 1832 si apriva all’insegna di un ben più grave problema che doveva impegnare il nuovo vescovo, l’amministrazione comunale e la popolazione di Lipari ed era il manifestarsi anche nelle Eolie – e forse prima che in altre parti d’Italia - di quell’epidemia di colera che proprio in quegli anni terrorizzava l’Europa ed il mondo intero.
Era dal 1817 che si parlava nel mondo di questa malattia, da quando cioè era uscita dei confini storici dell’India e dalla regione del Bengala in particolare. Indubbiamente l’incremento dei traffici e dei trasporti sia per ferrovia, sia per la navigazione a vapore, favorì la diffusione anche se non si comprendeva in che consistesse questo morbo, quale ne fosse la causa e come si propagasse. Comunque nel 1831 arrivò in Inghilterra, Ungheria e Germania e nel 1832 a Parigi. Si dice che in Italia il colera si affacciò per la prima volta nel luglio del 1835 probabilmente portato per via di mare da un gruppo di contrabbandieri provenienti dai territori d’oltralpe e entrati nel Regno di Sardegna dopo aver infranto il cordone sanitario[1]. Se questo è vero, Lipari dovette vivere l’esperienza in anteprima, nel febbraio del 1832, anche qui arrivata attraverso contrabbandieri. Infatti è l’anonimo cronista che ci informa che “in febbraio per certi contrabbandi sviluppassi in questa Città una febbre epidemica contagiosa”[2] .Nel 1832 i morti furono 213 in più dell’anno precedente. E il morbo non risparmiò nessuno anche se furono colpite più le donne che gli uomini. Ma comunque tutte le classi sociali pagarono il loro tributo: morirono filandiere, contadini, operai ma anche notabili ed esponenti del clero.
E come succede quando un pericolo giunge all’improvviso ignorandone la causa ed il modo per combatterlo, il popolo chiese aiuto alla religione affollando le chiese ed aiuto alla preghiera chiese anche il governo. Infatti il vescovo di Lipari ricevette il 14 Maggio del 1832 un dispaccio a nome del re nel quale si sollecitavano i prelati “a raddoppiare nelle Chiese delle rispettive Diocesi fervide preci all’altissimo onde impetrare dalla Divina misericordia la cessazione di un tanto flagello”[3].
Nell’ottobre del 1835 quando lo scrittore francese Alexandre Dumas e il suo compagno visitano Lipari la paura del colera è ancora forte tanto che per fare verificare i passaporti li dovettero passare attraverso una inferriata ed essi “ci furono presi dalle mani con delle pinze gigantesche” e dovettero dimostrare che venivano da Palermo e non da Alessandria o Tunisi. Solo allora “aprirono il cancello e consentirono a lasciarci passare”.
E se anche le morti non toccarono più le cifre del 1832 il colera continuò a farsi sentire ad intervalli come nel 1840 con un centinaio di morti oltre la media annuale e nel 1834 con circa centocinquanta in più[4]. Comunque il 1855 fu salutato come l’anno della fine del “colera morbus” e considerato che i danni che avevano colpito i liparesi erano abbastanza contenuti rispetto a quelli di cui si diceva nel resto del mondo, il vescovo e la civica amministrazione decisero di ringraziare San Bartolomeo con una nuova statua di marmo al posto di quella collocata nel 1813, la costruzione di un piedistallo in cui vennero affisse due epigrafi in marmo, una del vescovo ed una del Comune il tutto salvaguardata da una cancellata di ferro donata da don Onofrio Paino[5].
Si supera la crittogama
Il 1855 fu salutato a Lipari come l’anno della liberazione da un altro malanno. Questo non colpiva le persone ma la vite che era una delle principali risorse dell’arcipelago. Era il male della crittogama un fungo riscontrabile come un pulviscolo biancastro e per questo si chiama anche “mal bianco”. Nella vite porta al rallentamento della crescita ed alla perdita del raccolto. Nelle Eolie questo flagello aveva imperversato a lungo, come appunto il colera. Si era manifestato nel 1831 e si era trascinato fino al 1854. A Lipari però era giunto solo nel 1853 ed aveva subito creato gravi problemi negli strati più miseri della popolazione tanto che il vescovo, proprio quell’anno, chiedeva al Governo “un soccorso” economico per far fronte agli effetti della “ sperimentata malattia della vite detta crittogama” ed otteneva in risposta 3.500 ducati che spendeva tutti in elemosina ed acquisto di cereali per i poveri[6].
Nel marzo dello stesso anno era giunta la notizia che in Italia era stato trovato un rimedio: cospargere la vite di zolfo polverizzato. Ma a Lipari, come del resto nel resto del regno, si era piuttosto scettici. Cominciò per primo don Filippo De Pasquale con molta circospezione. E visto il buon risultato fu subito seguito da alcuni mentre altri continuarono a rimanere scettici. Così si liberò del male solo parte dell’isola di Lipari. La strada però era stata tracciata[7].
Il complotto contro il vescovo
Nella storia delle Eolie i tentativi riusciti o meno di risolvere con la soppressione fisica dell’avversario delle controversie, sono piuttosto rari. Abbiamo visto il caso di un vescovo che ferì a morte il governatore della città ma dovette trattarsi di un atto inconsulto determinato dall’ira. Ma che si ordisca un complotto per uccidere il vescovo, quello che accadde nel 1840, è un caso più unico che raro. Eppure come vedremo forse non rimase isolato nei decenni che seguirono. Sarà stato il fatto che gli interessi cominciavano a farsi sostanziosi e con essi cresceva anche la propensione a tutelarli e difenderli. Sarà stata la prossimità con la delinquenza comune che rendeva più facile ricorrere alla violenza affidandola a terzi. Comunque sia, questo episodio ha diversi elementi che lo rimandano ad un’azione di tipo mafioso. C’è un notabile locale che vuole difendere i suoi interessi che vede minacciati e lo fa ricorrendo alla violenza. Può farlo perché è inserito in una rete di protezioni che arrivano sino ai pubblici poteri. C’è una manovalanza criminale che sembra a disposizione. C’è un’opinione pubblica praticamente inesistente. Non perché mancassero personalità di spicco[8] ma perché la gran massa era chiusa nel proprio “particolare” e uno dei problemi più avvertiti era quello di liberarsi dal peso dei censi e delle decime dovuti alla mensa vescovile. Di questo evento si sa quasi tutto almeno per quanto riguarda la sua programmazione. Ciò che manca, come in molti casi di stampo mafioso, è la parte conclusiva: il trionfo della giustizia. Ma andiamo per ordine.
E cominciamo dalla vittima che è mons. Giovanni Proto[9] divenuto vescovo di Lipari il 18 febbraio del 1839. Mons. Proto era un uomo inflessibile e intransigente. Lo era con il clero a cui rimproverava di essere ozioso e infingardo dimenticando il dovere della carità[10], lo era con i proprietari terrieri a cui non perdonò il fatto che avessero messo in discussione i diritti della Mensa vescovile circa i censi e le decime. Non era quindi improbabile che si attirasse antipatie ed anche odio. Ma chi pensò a sopprimerlo – almeno per quello che sembrò emergere dalle indagini -fu un personaggio importante della Lipari d’allora che abbiamo già incontrato nel nostro racconto e cioè don Onofrio Paino[11], detto “don ‘Nofriu ‘u pirata”, figlio di quell’Antonio Paino che si era arricchito con il commercio, e fratello del canonico Antonio, nominato esattore delle decime e dei censi da parte del predecessore di Giovanni Proto. E sembra che fosse proprio il fatto che il vescovo fosse addivenuto alla determinazione di revocare quell’appalto alla scadenza del contratto e cioè il successivo autunno, che fece scattare nel Paino - personaggio senza scrupoli, assai influente con amicizie altolocate e dalle risorse economiche illimitate - la determinazione di sopprimere il vescovo. Il Paino chiama il chierico Giovanni Cafarella e don Felice Franza e da loro l’incarico di trovare il sicario. E la scelta cade su un confinato coatto, tal Filippo Pucci. A questo erano stati promessi cento onze oltre l’impunità e la fuga dall’isola verso la Calabria o altre destinazione di suo gradimento. Ma il Pucci tergiversa per tre mesi, infine, messo alle strette dal Franza e dal Cafarella, forse temendo di essere scoperto, il 28 agosto preferisce vuotare il sacco denunciando mandante ed intermediari.
Don 'Nofriu u pirata
Informato, il vescovo scrive subito al Ministro di Polizia, al Ministro degli affari ecclesiastici, al Luogotenente generale ed al Procuratore generale e chiama in causa non solo Onofrio ed il can. Antonio ma anche l’altro fratello Giuseppe che ambivano, insieme, a divenire “gli arbitri della mia Chiesa”. Ed avendo – sostiene il prelato - colto le loro mire ed avendoli allontanati dall’episcopio essi adoperarono ogni mezzo per togliergli la pace e minacciarlo. Ma il più determinato è il mercante Onofrio che si è arricchito come gabelliere della Mensa ed ora non vuole lasciare questo incarico e spera o nel trasferimento del vescovo o nella sua morte. Ed è per questo che ha messo a disposizione 300 onze per il complotto. Onofrio si sente intoccabile da quando si guadagnò l’impunità per dei fatti accaduti il 5 marzo[12] usando la “via dell’oro” e la via della “protezione smodata” dell’Intendente Commendatore De Liguori lautamente foraggiato dalla “casa Paino”. E sicuramente questo Intendente farà di tutto per assecondare il Paino anche in questa situazione.[13]
La lettera provocò una serie di risposte rassicuranti. Stesse sicuro il vescovo, giustizia sarebbe stata fatta. Invece le cose andarono come lui aveva previsto. Già la nota del 16 settembre 1840 del Ministro della Polizia Generale di Lavori lasciava intravedere come la vicenda si sarebbe conclusa.
“Quantunque – si diceva in questa nota – fino a questo momento tutto sia basato sull’assertura di esso Pucci, pur troppo noto per diffamato carattere e perversa indole. Io dal mio canto ho inculcato all’Intendente medesimo di agire nel riscontro con ogni efficacia, e di dare quelle provvidenze che si convengono onde tranquillizzare quel Prelato; e poiché avea egli già disposto la traduzione in carcere del Pucci in Messina, io ho pure prescritto di farvelo rimanere, sotto il medesimo modo di custodia, fino a che non si sarebbe interamente acclarata la faccenda”.
Cosa che non avvenne mai e presto tutta la faccenda venne dimenticata.
Ma mentre mons. Proto doveva combattere su un fronte con don ‘Nofriu ‘u pirata che non voleva perdere l’incarico di gabelliere della mensa, dall’altra doveva contendere col sindaco di Lipari, don Filippo De Pasquale che propugnava il diritto dei contadini delle isole minori di affrancarsi dal peso delle decime e delle gabelle vescovili ritenute un avanzo della feudalità abolita con le leggi del 1812 e poi, ancora più chiaramente, con i decreti del 1841. Scrisse così una memoria “Su’ diritti della Chiesa di Lipari”[14]. La tesi sostenuta dal vescovo era che il diritto dei prelati liparesi non era frutto di un feudo ma di una donazione di terre che non erano proprietà di alcuno, donazione che i principi normanni avevano fatto agli abati benedettini e quindi alla Mensa dei vescovi che agli abati erano succeduti. Una donazione puramente civile senza implicanze politiche giacchè il re rimaneva il sovrano e il vescovo solo un possessore. Da qui derivava il diritto alle decime ed ai censi enfiteutici con i quali si provvedeva ai cappellani, al culto divino , ad un gran numero di poveri con onze 400 ogni anno, a trovatelli con onze 50, alle missioni nelle isole adiacenti e a tanti altri carichi della cura d’anime. Le entrate bastavano appena a questo scopo e se qualcosa avanza andava subito in beneficenza.
Comunque lo scontro divenne durissimo tanto che re e papa di comune accordo decisero di trasferire mons. Proto a Cefalù e questo avvenne con bolla pontificia del 17 giugno 1844.
[1] E. Tognotti, Il morbo asiatico. Storia del colera in Italia, Roma-Bari 2000
[2] Dal manoscritto di proprietà della famiglia di Luigi Mancuso, pag. 612.
[3] Archivio vescovile, Carpetta corrispondenze D.
[4] Dai registri dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Lipari riportati da G.Iacolino in manoscritto, cit. , Quaderno VI, pag. 294. Sull’argomento nel 1844 il dottor don Ferdinando Rodriquez pubblicò una “Lezione pratico-clinica per gli addiscenti in medicina sull’epidemia morbillosa avvenuta nel 1844 in Lipari”, Messina, Stamperia Fiumara, 1844.
[5] Manoscritto di proprietà della famiglia Luigi Mancuso, pag. 627 e ss. Quando nel 1939 si procedette al riassetto della piazza che allora era chiamata del Commercio fu spostata la statua dal centro nella posizione in cui si trova oggi, fu rifatto il basamento e venne tolta la cancellata.
[6] Dal verbale del Consiglio Comunale di Lipari dell’’11 marzo 1859. Archivio del Comune di Lipari.
[7] Manoscritto cit, idem.
[8] Fra le personalità di spicco del periodo oltre al can. Carlo Rodriquez di cui abbiamo detto; ricordiamo il giurista e principe del foro avv. Giuseppe Pisano Rodriquez che aveva pubblicato nel 1838 un’opera in più volumi dal titolo “Studio di giurisprudenza (edito dalla Real Stamperia di Palermo) e alcuni testi per il teatro; don Serafino De Angelis che insegnava retorica e filosofia nel Ginnasio vescovile di Lipari e si dilettava di poesia traducendo in versi quattro libri dell’Eneide e le Confessioni di S. Agostino; don Giovanni Amendola anche lui scrittore di testi teatrali che si rappresentavano a Lipari; don Filippo de Pasquale sindaco di Lipari dal 1837 al 1840. Queste notizie in G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag 287, 287a-c.
[9] Mons. Giovanni Proto, dell’ordine dei benedettini cassinesi, nacque a Milazzo il 15 febbraio del 1781. Prima di essere nominato vescovo di Lipari occupò diversi incarichi di prestigio e fra l’altro fu abate di San Paolo fuori le mura a Roma e visitatore generale per la Sicilia. Fu nominato vescovo di Lipari il 18 febbraio 1839 e si distinse per l’impegno profuso a restituire decoro alle chiese a cominciare dalla Cattedrale ed alle scuole che riordinò aprendo una nuova scuola , il Ginnasio vescovile .Essendo ormai disabitato il Conservatorio si adoperò perché si desse vita al Seminario giacchè una delle sue preoccupazioni maggiori era la formazione del clero. Ripristinò e ridisciplinò le cinque confraternite locali: S. Bartolomeo, Maria SS Addolorata, S. Giuseppe. S. Pietro e Maria SS del Rosario. Delle cinque feste dedicate a S. Bartolomeo ne abolì due: quella del 17 giugno per lo scampato pericolo dalla pestilenza del 1541 e dell’11 gennaio relativa al grande terremoto del 1693. Morì a Cefalù contagiato dal colera il 13 ottobre del 1854.
[10] “…l’ozio e la infingardaggine ch’esiste nei Sacerdoti dei tempi presenti li rende dimentichi di quel dovere di carità che continuamente l’invita a procurare la salute de’ Cristiani ancor in quel momento fatale da cui dipende l’eternità. Non poche querimonie, nel corso di questa santa Visitazione, sono de’ fedeli a noi portate per lo scandaloso rifiuto che danno i Cappellani ed i Sacerdoti a coloro i quali li scongiurano a correre al letto dei fratelli che agonizzano”. Raccolta di alcune notificazioni, editti, istruzioni e decreti pubblicate per buon governo della sua Diocesi dall’Ill.mo e Rev. Mo Monsignor D. Visconte Maria Proto Cassinese Vescovo di Lipari, Napoli 1840 ( se ne conserva copia nella Biblioteca Ursino di Catania); G.Iacolino. manoscritto cit., Quaderno VI, pp. 285,285°.
[11] Onofrio Paino era nato a Lipari il 28 dicembre del 1799. Utilizzò le risorse paterne e materne per farne la base di un nuovo arricchimento trafficando anche nel campo dell’usura, del contrabbando e della rapina sul mare. Aveva agenzie oltre che a Lipari a Messina, Palermo e Napoli. A Napoli aveva libero accesso alla casa reale prestando denaro allo stesso re Ferdinando II. Fu molto influente nella Lipari borbonica e determinante anche nel voto cittadino. Fu molto devoto ai santi ed alle chiese con particolare predilezione verso il convento dei Cappuccini. Ma la sua religiosità passava in secondo piano se si mettevano in discussione i suoi interessi finanziari. Grazie alla liquidazione della proprietà ecclesiastica nel primo decennio dell’Unità d’Italia incrementò notevolmente il suo patrimonio che ammontò ad un milione di lire. La sua abitazione in Strada Santo Pietro oggi via Maurolico aveva addobbi degni di una reggia. Le posate, tutte d’argento, avevano le sue iniziali come le cristallerie e le tazze da caffè. Sotto casa, nei magazzini vi era il deposito dell’abbondanza. Gli appartenevano anche i magazzini che erano a fianco e sotto la chiesa delle Anime del Purgatorio ed erano sempre stracolme di mercanzie in arrivo destinate ad essere esportate. Morì a Lipari il 30 luglio 1872. (G. Iacolino, manoscritto cit,, Quaderno VI, pp. 299 a-b.(Archivio storico eoliano.it)
[12] Il Proto non dice e noi non sappiamo quali fatti siano quelli accaduti il 5 marzo e citati nella lettera.
[13] Tutta la documentazione su questa vicenda si trova nell’Archivio Vescovile , Corrispondenze, Carpetta H.
[14] Tipografia Francesco Lao, Palermo 1842, pagine 38.
Un imprenditore coraggioso e un vescovo lungimirante
Intanto l’Europa assisteva. parte attonita e parte preoccupata, alle imprese di Napoleone Bonaparte. Sopratutto gli stati italiani si trovavano in grandi turbolenze politiche e il regno di Napoli era, insieme alla S. Sede, uno dei più travagliati. Ferdinando che era tornato a Napoli vedeva nuovamente in pericolo il trono e aveva messo completamente da parte le idee massoniche che lo avevano caratterizzato in passato. Ora si affidava ai vescovi perché gli garantissero preghiere e consenso sociale. Ed in questo senso scrisse anche il 23 settembre del 1805 al vescovo di Lipari e il vescovo, che era mons. Antonio Riggio[1], nell’ottobre del 1805 informava il re di avere dato vita ad una serie di iniziative - processione, prediche in Cattedrale e nelle chiese e nei conventi della città – per far “comprendere alla popolazione la spietata persecuzione cui soggiace l’attuale Sommo Pontefice” e “l’avvilimento cui è ridotta la Chiesa per opera di uno irreconciliabile inimico” e pregare “per ridurre i traviati al giusto sentiero e placare lo sdegno del Sommo Dio nell’attuale oppressione in cui languisce il Capo Visibile della Chiesa Cattolica, per la sicurezza dello Stato e conservazione della Maestà Vostra e dell’augusta Real famiglia[2]”.
Ma l’”irreconciliabile nemico”qualche mese dopo costringeva il re a fuggire nuovamente in Sicilia mentre a Napoli Napoleone insediava il proprio fratello Giuseppe. Il re a Palermo vive sotto la protezione degli inglesi ma anche nel timore che i francesi tentino un colpo di mano per prendere la Sicilia. E quale migliore base d’appoggio che quella delle Eolie per una operazione di questo tipo? E’ questa la paura che si vive a Palermo sul finire del 1808. E così il re incarica il sergente Vito Nunziante che comandava la guarnigione di Milazzo di andare a Lipari per consegnare al vescovo una sua missiva.
Che cosa chiedeva Ferdinando? Che il vescovo si adoperasse per creare quattro o sei compagnie di cento persone ciascuna di volontari e riferisse, nel contempo sulle idee politiche dei liparesi. Vescovo di Lipari era divenuto nel frattempo mons. Silvestro Todaro[3], un monaco conventuale, mite e prudente, che prima di rispondere si guarda intorno, chiede, ascolta e poi prende la penna e scrive. Ci sono 8-900 giovani liparesi, la gioventù più robusta è coraggiosa, impiegata nella Regia Marina che, essendo impedito il commercio marittimo, è rimasta l’unica risorsa dei locali. Per il resto nelle isole si soffre una grandissima povertà e la gente, lavorando tutto il giorno, riesce a racimolare appena di che vivere. Quindi vi è molta ritrosia ad assumere impegni che possano distogliere da questo compito anche perché vi è il sospetto di essere poi spediti nella Sicilia e nelle Calabrie. Quanto alle “velenose massime che tanto hanno perturbato e perturbano l’Europa”, il re stia tranquillo, esse non sono approdate nelle Eolie e il popolo è fedele ed attaccatissimo al re.
Anzi per evitare qualsiasi rischio, visto che i mosaici delle terme erano continuamente visitati da turisti curiosi e da esperti anche forestieri che potevano dar luogo a qualche contagio con le “velenose massine” il vescovo aveva pensato bene di fare risotterrare le terme romane e così evitava anche le seccature di quelli che continuavano a disturbarlo per visitarle.
Finalmente si valorizzano le risorse di Vulcano
Non sappiamo se la missione di portare il messaggio del re al vescovo, fu anche l’occasione per conoscere le Eolie o Nunziante[4] già le conosceva. Il fatto è che da quel momento esse entrano nella sua vita di prepotenza e lui nella vita delle Eolie. A Lipari conosce una “leggiadra e ricca donzella”, forse di origine napoletana, Camilla Barresi ed il 4 agosto 1809 la sposa. Probabilmente mette casa a Lipari perché quando nel 1813 il vescovo Todaro, su autorizzazione del vicario regio in Sicilia, gli concederà un terreno in enfiteusi a Vulcano, nel contratto il Nunziante risulta “domiciliato in questo suddetto Comune di Lipari in questa medesima Marina di San Giovanni”[5].
Questo terreno consiste in ventidue salmate e mezza di terra - che dal porto andava sino al cratere grande - con licenza di estrazione di minerali e dell’erezione di una cappella per la messa domenicale dei lavoratori. E alla conoscenza di Vulcano, delle sue risorse, e delle potenzialità di queste – nei quattro anni che vanno dal 1809 al 1813 il nostro tenente generale aveva dedicato diverse visite, diverse escursioni[6] magari anche con degli esperti magari provenienti dall’Inghilterra – visti i rapporti che aveva con gli alleati inglesi ed in particolare con il Lord William Bentick - dove vi erano industrie che producevano acido solforico e soda artificiale e usavano lo zolfo come materia prima.
Fino allora, come abbiamo visto, sempre i tentativi di creare attività estrattive o di coltivare i terreni di Vulcano da parte dei vescovi, erano fallite, anche se nell’isola, abusivamente, risiedevano alcune famiglie di contadini. Ora l’operazione a favore di questo importante personaggio apre la strada anche ad altre concessioni ed infatti il vescovo assegna dei lotti di terreno in contrada Gelso perché si mettano a coltura. Si piantarono così viti, fichi e legumi e qualcuno fece anche sorgere delle “carcere” per la produzione della calce viva.[7]
Sempre nel 1813 e precisamente l’8 aprile, il vescovo, su autorizzazione reale concede a Nunziante anche la possibilità di impiantare una fabbrica per l’estrazione e la purificazione dello zolfo e di altri minerali.
Avute le autorizzazioni il novello imprenditore sa che deve vincere la paura che vi era a frequentare Vulcano ed a vivervi perché altrimenti sarebbe stato difficile avere manovali. Così decise di organizzare un pranzo nell’isola invitandovi militari inglesi e gentiluomini eoliani e finalmente chiamò il chimico che aveva contattato e cominciò l’estrazione e la lavorazione dei minerali - zolfo e allume, sale ammoniaco e acido borico – che occorreva depurare perché non si trovavano in natura “belli e schietti” ma mischiati fra loro o “con altre mondiglie[8]”.
Nei primi tempi – sebbene l’impegno del chimico e le risorse che vi profondeva Nunziante – i risultati erano alquanto deludenti. Ma la perseveranza era propria di quest’uomo che si fece costruire nell’isola “una capannuccia con pali e frasche” e “molti mesi ci dimorò selvaticamente”[9].
La riforma delle poste
E finalmente la spuntò. Cominciò a fabbricare alloggi per i lavoranti, a piantare alberi per fare legna da ardere necessaria come combustibile per le macchine. Intagliò persino nella montagna una strada perché i carri potessero andare a caricare fino in cima i materiali e costruì un villaggio per chi ci lavorava. e cioè una colonia di coatti che erano relegati a Lipari, ed una chiesa che volle intitolare a san Vito con l’alloggio per il prete. Quando Dumas visiterà Vulcano nel 1835 ed incontrerà i figli di Nunziante così descrive questo villaggio dei forzati che lavoravano alle miniere: “costeggiammo una montagna piena di gallerie; talune erano chiuse da una porta e anche da una finestra, altre sembravano più semplicemente delle tane di animali selvaggi”; “circa quattrocento uomini abitavano in questa montagna e secondo l’indole più o meno industriosa lasciavano abbruttire la loro dimora oppure cercavano di renderla un pochino più confortevole”[10]
L’impresa di Vulcano non fu che la prima dell’intraprendente napoletano perché si dedicò alle miniere di ferro in Calabria, di piombo e carbon fossile in vari siti, alle cave di marmo in Basilicata,e così via. Nelle Eolie acquistò poderi a Stromboli e a Salina nella contrada di Malfa dove diede prova anche di buone doti di imprenditore agricolo. Ma sotto questo aspetto l’opera sua più imponente fu la bonifica di una piana nei pressi di Rosarno dove realizzò un villaggio che chiamò San Ferdinando. Per la costruzione di abitazione fece arrivare grossi quantitativi di pietra lavica e di tufo da Lipari, Stromboli e Vulcano avvalendosi di padroni di barche eoliani e molti marinai delle isole decisero di rimanere a San Ferdinando vivendo di agricoltura e di pesca.[11] A Lipari, ancora, trovò “un reniccio vulcanico” con cui fece una pasta e fabbricò delle stoviglie “che belle riuscirono come quelle di porcellana[12]”.
Innovazioni nell’amministrazione e nei servizi
Il vescovo mons. Todaro intanto entra di diritto nella Camera dei Pari che era uno dei due rami del nuovo Parlamento siciliano, quello in cui facevano parte baroni ed ecclesiastici e praticamente risiede quasi ininterrottamente a Palermo dal 13 maggio 1813 al 14 maggio 1815. Il 4 ottobre 1816 viene trasferito alla diocesi di Patti e Lipari rimane per 19 mesi sede vacante[13].
Ma nel periodo in cui rimane vescovo di Lipari tre sono le notizie che vogliamo ricordare. Il 30 gennaio del 1812 gli viene comunicato che, per decisione del re, viene tolta la santabarbara[14] che il governatore Mensingher aveva collocato in una cisterna proprio dietro la Cattedrale e che tanto preoccupava soprattutto i canonici che quando si riunivano nel coro temevano di poter saltare in aria da un momento all’altro.
Il 19 agosto dello stesso anno, probabilmente nel clima della nuova Costituzione siciliana che era stata approvata giusto il mese prima, giunge al vescovo una lettera che riguarda le “projette” che giunte ai sette anni, rimanevano senza assistenza e finivano per le strade. Ora il governo si raccomanda al vescovo che questo non accada più. Le ragazze devono essere collocate o “ne’ Reclusori, o di tenerle presso oneste Donne alimentandole coi frutti delle loro Mense e con i legati di genere incerto assegnati ad essi a quest’oggetto”[15].
Infine, in quegli anni, nelle isole, vennero istituite ben otto scuole elementari pluriclasse con un maestro e cinque o sei allievi ciascuna. Non si sa di chi fosse l’iniziativa, né fino a che periodo andarono avanti ma quando venne a Lipari lo Smith esse erano ancora attive ed anzi il capitano inglese si disse molto sorpreso di trovare a Quattropani “una scuola molto ben condotta, sotto la guida di un uomo di considerevole intelligenza, giacché il luogo in sé sembra selvaggio e pochissimo civilizzato”[16].
Il 9 giugno 1815 il Congresso di Vienna restaurò a Napoli il Regno dei Borboni e l’anno successivo Ferdinando unificò i due regni costituendo il Regno delle Due Sicilie. Viene dichiarato decaduto il Parlamento siciliano mentre viene sostanzialmente preservato l’ordinamento amministrativo che i francesi avevano introdotto a Napoli e lo estende anche alla Sicilia. Finisce così l’era dei giurati e comincia quella dei sindaci. Infatti così d’ora in poi si chiamerà il capo della civica amministrazione e questa, invece di “università”, prenderà il nome di “municipalità” con l’obbligo di tenere i registri anagrafici A fianco al sindaco, nominato e non eletto[17], era istituito il “decurionato” che aveva funzione di consiglio. A Lipari i decurioni erano dodici.
Il primo aprile 1820 in Sicilia entra in vigore anche la riforma dell’Amministrazione postale. Vengono istituite 115 “officine di posta” fra cui quella di Lipari che fu aperta nel 1822 e venne inserita nel cammino principale”Palermo-Messina per via delle marine”. Quando l’anno successivo l’officina di posta verrà chiusa il servizio dovette essere affidato – secondo quanto previsto dalla stessa riforma – alla Cancelleria comunale che provvedeva ad assemblare la corrispondenza locale e consegnarla a qualche veliero che periodicamente svolgeva il percorso fra Lipari e Messina o Milazzo
Nella prima metà dell’800 c’è da registrare il miglioramento dei collegamenti delle isole con la Sicilia e con Napoli. Infatti intorno al 1830 le isole vengono toccate – con frequenza quindicinale -dalle prime navi a vapore che facevano regolare servizio di linea fra Napoli, Messina e Palermo[18] ed alle quali venne affidato anche il trasporto della corrispondenza postale. Inoltre nel periodo estivo queste navi effettuavano delle brevi crociere nel golfo di Napoli, nelle Eolie con particolare riferimento a Stromboli ed a Taormina. Fuori dalla frequenza quindicinale chi aveva necessità di viaggiare doveva profittare di battelli privati da carico, di passaggio.
Un approdo regolare a Lipari
Un approdo[19] regolare a Lipari, con imbarco e sbarco dei passeggeri, sulla linea Napoli-Messina avvenne però solo intorno al 1837 e grazie all’impegno di un giovane e dinamico sindaco, don Filippo De Pasquale[20].
In questo clima di novità una esigenza di decoro per il prestigio della pubblica amministrazione fu avvertita anche dal Sindaco e dai “decurioni” che da qualche tempo avevano anche loro abbandonato il Castello e trovato sede sul Timparozzo in un edificio dai tratti signorili vicino all’abitazione del barone Tricoli[21]. Ma questa collocazione non appariva ai loro occhi soddisfacente forse perché troppo a ridosso dalle mura del Castello costretta fra due stradine strette se non anguste. E fu così che il Sindaco, don Giuseppe Natoli, prendendo lo spunto da un memoriale regio di qualche mese prima che invitava a verificare se vi erano conventi e case religiose inutilizzate per destinarli ad uffici municipali, saputo che le monache avevano abbandonato il Conservatorio nei pressi del Palazzo vescovile, pensò che quella potesse essere la sede più degna ed adeguata per l’amministrazione comunale per la cancelleria e per gli uffici. Inoltre, da qualche tempo, gli amministratori comunali non erano proprio in sintonia con il vescovo e l’ambiente ecclesiastico perché praticamente tutti appartenenti alla massoneria e comunque per lo più ostili alla Mensa vescovile da cui, tutti più o meno, dipendevano per i censi e per le decime che vivevano come una sopraffazione.
La diocesi di Lipari era sede vacante dal 1827 quando mons. Tasca fu trasferito a Cefalù ed era retta dal vicario generale can. Giovanni Portelli[22]. E toccò al can. Portelli – che diventerà vescovo in agosto – scrivere il 3 luglio del 1831 all’Intendente di Messina sostenendo che l’edificio nasceva nei recinti del Palazzo vescovile e non in terreno comunale, che era stato destinato dal mons. Coppola per l’educazione delle ragazze e ad altre finalità connesse con la dignità della donna[23]. E’ vero che al momento non c’erano più le suore nel Conservatorio ma vi erano ugualmente diciassette conviventi che si mantengono a proprie spese, oltre alla portinaia, che vivono nella osservanza dei valori religiosi sotto la guida dell’Ordinario ecclesiastico. Distogliere l’edificio dalle sue finalità voleva dire far gravare sul Comune il costo di chi attualmente vi alloggia oltre a privare la comunità eoliana di un centro di formazione per le ragazze che numerose ogni giorno partecipano ai corsi di formazione domestica. Comunque, concludeva il Portelli, se l’edificio non dovesse essere più adibito a Consultorio femminile la sua destinazione più propria sarebbe stata a Seminario per l’apertura del quale vi era già la regia approvazione.
[1] A mons. Santacolomba era succeduto mons. Domenico Spoto eletto vescovo di Lipari il 9 agosto 1802 ed il 28 giugno 1804 viene trasferito a Cefalù. A mons. Spoto succede mons. Antonio Riggio, messinese, nominato vescovo il 29 ottobre 1804 e giunto a Lipari il 12 febbraio 1805. Di lui si ricorda che abolì il “conservatorio femminile” e consegnò lo stabile alle suore Cappuccine di S. Benedetto fatte venire da S.Marco d’Alunzio e che riordinò il materiale archeologico raccolto dal Coppola e fece di nuovo riportare alla luce i mosaici a fianco del Conservatorio che il Santacolomba, per cautela, aveva fatto interrare. Così ci fu un certo flusso di amatori dell’arte italiani e stranieri, soprattutto inglesi. Morì il 14 dicembre 1806.
[2] Archivio Vescovile, In scritture Varie e Visite Date ( Miscellanea) vol 9, f. 605. Si tratta di una minuta che non ha né data, né firma, in G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag. 264.
[3] Mons. Silvestro Todaro era nato a Messina il 29 dicembre 1752 era stato nominato vescovo il 22 marzo 1808 ed un mese dopo il Papa lo nominava Assistente al Soglio Pontificio.. Fu trasferito a reggere la diocesi di Patti il 4 ottobre 1816 e morì a Messina il 21 aprile del 182. Morendo lasciò un legato per la chiesa di Lipari di 3 mila onze, buona parte delle quali da destinare ai poveri.
[4] Vito Nunziante nacque a Campagna (Salerno) il 12 aprile 1775 e muore a Torre Annunziata il 22 settembre del 1836. Militare, politico ed imprenditore. Diventa ufficiale dell’esercito napoletano nel 1798. Dopo la fuga del re in Sicilia nel 1798 si unisce all’armata sanfedista del cardinale Ruffo. Al rientro del re a Napoli rientra nell’esercito napoletano col grado di colonnello. Nel 1806 quando il re fugge in Sicilia lo segue e gli viene dato l’incarico di tenere Reggio. Nel 1808 viene messo a capo delle forze di Milazzo. Nello stesso periodo, essendo rimasto vedovo dalla prima moglie Faustina Onesti, sposa una ragazza di Lipari da cui ha otto figli che con i quattro del precedente matrimonio fanno dodici. Nel 1815 ha l’incarico di nominare la corte che deve condannare a morte Giacchino Murat che gli procura il titolo di marchese. Dal 1821 ottiene diversi incarichi di governo ed infine il comando supremo dell’esercito continentale. Fu anche imprenditore e la prima attività fu nell’isola di Vulcano. In Calabria si occupò della bonifica di una piana di Rosarno e fondò il borgo di San Ferdinando. Si occupò anche di miniere di ferro e di piombo, di ricerche per il carbon fossile e avviò una cava di marmo in Basilicata
[5] In Titoli e documenti di provenienza …di terre nell’isola di Vulcano vendute dagli eredi di Nunziante ecc. presso il comm. Francesco Vitale f. 29v, in G. Iacolino, manoscritto cit. , quaderno VI pag. 265f .
[6] “E spesso ci andava, e con meraviglia di quelle genti, calava giù nel vano della montagna. Di dove avendo raccolto e zolfo e altre misture, tornato che fu in Sicilia. Diè a saggiare a un chimico, per sapere se fosse cosa da ridurre commerciabile: e avuto di sì, incoltamente chiese al vescovo di Lipari in censo Vulcano: il quale ebbe con agevolezza, e a sottil costo, perché nulla rendeva”in “Vita e fatti di Vito Nunziante”, di Francesco Palermo, Firenze 1839, pag. 79.
[7] Questa comunità fu formata dalle famiglie dei Bongiorno, Carnevale, Amendola, Trovatino, Basile e Ferlazzo. Qualche anno dopo l’insediamento costruirono una chiesetta nei pressi di Punta ‘a Sciarazza della quale non esiste più traccia. G. Iacolino, manoscritto cit., pag. 266°.
[8] F. Palermo, op. cit., pag. 80.
[9] Idem, pag. 81.
[10] A. Dumas, op. cit., pag.41.
[11] B. Polimeni, Rapporti sociali ed economici tra Sanferdinandesi ed Eoliani…, in “Messina e Calabria “, atti del I convegno calabro-siculo del novembre 1988, pp. 627 e ss.
[12] F. Palermo, op.cit., pag. 85.
[13] A mons. Todaro succederà mons. Carlo Maria Lenzi nato a Palermo l’1 febbraio 1761, appartenente alla congregazione degli Scolopi. Nominato vescovo di Lipari il 25 maggio del 1818 fece il suo ingresso in diocesi solo il 13 febbraio 1819 perché proprio qualche giorno prima della sua nomina era stato eletto alla guida della congregazione e occorse un certo tempo per poter rassegnare le dimissioni. Giunto a Lipari, rispettando la sua vocazione,si dedicò in maniera particolare a ristrutturare i programmi di studio delle scuole vescovili. Una particolare attenzione la dedicò alla formazione delle giovani per cui abolì il Collegio di Maria che era nell’edificio del Conservatorio femminile e istituì, al suo posto, una casa di Educazione sotto la direzione di due suore benedettine fatte venire da Palermo. Sperava il vescovo che un monastero delle benedettine oltre a suscitare vocazioni fra le fanciulle poteva convogliare quelle “monache di casa” che erano rimaste dopo l’editto promosso da mons. Santacolomba. Purtroppo mancando i finanziamenti il monastero non ebbe lunga durata e mons. Lenzi dovette tornare sui suoi passi ricostituendo il collegio di Maria cioè una gestione più modesta e familiare ( Archivio vescovile, Scritture varie e visite Date, Miscellanea, vol. 9 ff 272.272v.) G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pp. 262 a-d. A seguito del terremoto del 5 marzo 1823 accettò la richiesta della gente delle campagne di istituire una nuova festa dedicata a S. Bartolomeo che divenne la quinta. Morì il 5 aprile del 1825 all’età di sessantaquattro anni. Venne ricordato come un uomo di “straordinaria saggezza e fermezza che riuscì a sedare le discordie dei cittadini” come si legge nella epigrafe sulla sua tomba in Cattedrale.
A mons. Lenzi successe mons. Pietro Tasca nominato vescovo il 13 marzo del 1826 ma trasferito a Cefalù il 27 settembre del 1827. Durante il suo governo della diocesi si verificò, nel 1826, una eruzione di Vulcano che preoccupò i liparesi per alcune settimane. Partito mons. Tasca la sede rimase vacante per quattro anni, dal 1827 al 1831, ed affidata al vicario generale don Giovanni Portelli.
[14] Archivio Vescovile, Carp. Corrisp. D.
[15] Idem.
[16] W.H.Smith, op. cit., pp 262-263.
[17] Lipari aveva perso il privilegio di eleggere i giurati già dal 1673 a seguito della repressione della rivoluzione di Messina e la loro nomina era stata riservata al viceré ( Manoscritto anonimo di proprietà della famiglia di Luigi Mancuso, pag. 506).
[18] L' Italia descritta e dipinta con le sue isole di Sicilia, Sardegna, Elba, Malta, Eolie, di Calipso, ecc. : secondo le ispirazioni, le indagini ed i lavori de' seguenti autori ed artisti : Di Chateaubriand ... [et al.] per cura di D. B, 2: Regno di Napoli. - Torino : presso Giuseppe Pomba e C., 1837. pag. 280. Nel Regno delle Due Sicilie le navi adibite al trasporto dei passeggeri erano state introdotte con decreto del 2 dicembre 1823 n. 876 ed il servizio era gestito dalla società “Amministrazione privilegiata di pacchetti a vapore delle Due Sicilie”. Si ricorda il famoso Real Ferdinando, bastimento di legno con propulsori a ruota costruito a Glasgow ed apparso per la prima volta a Messina nel giugno del 1824. Poteva trasportare duecento passeggeri ed il viaggio in prima classe fra Napoli e Messina costava 27 ducati e comprendeva la mensa, il letto e il trasporto di un bagaglio. B. Villari, Collegamenti pubblici e privati sullo stretto di Messina, in “Messina e Calabria” Atti del I Colloquio Calabro- Siculo, Reggio C.-Messina, nov. 1986, Messina 1988p. 526.v. anche L. Radogna, La marineria mercantile delle Due Sicilie, Milano 1982, p.58. G. Iacolino, manoscritto cit., quaderno VI, pag. 270a,b.
Dal 1831 in poi andò ampliandosi la rete di corse marittime in partenza da Napoli. I battelli oltre al Real Ferdinando furono il Francesco I, il Maria Luigia, il San Venefredo, il Veloce e il Nettuno. Nel 1842 verrà immesso il Duca di Calabria che compirà la Napoli- Messina due volte alla settimana.Nel 1847 l’”Amministrazione della navigazione a vapore nel Regno delle Due Sicilie” si unirà alla “Società Vapori Sardi” e metterà in servizio il Capri e il Vesuvio che nel 1847 serviranno la Napoli- Messina – Palermo.(G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag. 270d.
[19] In realtà si trattava di un accostamento e il carico e scarico dei passeggeri e delle merci avveniva con le barche.
[20] Filippo De Pasquale fu sindaco di Lipari dal 23 marzo 1837 a soli 26 anni fino al gennaio 1840. Si era laureato in legge a Napoli ed aveva mantenuto nella capitale del Regno delle amicizie importanti che seppe mettere a frutto durante la sua amministrazione. Morì nel 1886.
[21] L’edificio che oggi si incunea tra via Garibaldi e via Umberto I, che è stato completamente ristrutturato, non era tutto dedicato a Municipio. Questo era collocato nella parte centrale. Il settore nord apparteneva agli Scolarici, mentre il settore sud, lussuosissimo, era del barone Tricoli.
[22] Giovanni Portelli era nato a Lipari ai primi di novembre del 1768 da Antonio e Giovanna Megna. Anche se era privo di diplomi accademici aveva maturato una buona esperienza giuridica-amministrativa e furono diversi i vescovi della Sicilia che lo vollero come vicario generale e visitatore. Dopo il trasferimento di mons. Tasca egli rientrò a Lipari per assumere la reggenza della diocesi con il titolo di vicario capitolare. Venne eletto vescovo di Lipari l’8 agosto 1831e consacrato vescovo dal Metropolita di Messina che ritornava a svolgere questa funzione sebbene ancora il 25 maggio 1818 in occasione della nomina di mons. Lenzi la bolla pontificia ribadisse la esclusiva dipendenza della chiesa di Lipari dalla Santa Sede. Mons. Portelli durante il periodo della sua reggenza affrontò il problema della esazione delle decime che fino ad allora veniva eseguita a cura di un ecclesiastico. Il vescovo – soprattutto per i modi duri e rudi con cui operavano gli agenti preposti all’esecuzione e la natura fortemente fiscale fino ad apparire inumana dell’azione degli operatori – dispose che l’esazione delle decime non fosse più di competenza di un prete ma di un laico e scelse per questo Onofrio Paino( Archivio Vescovile, Mensa, secc.XVI,XVII.XVIII, XIX,XX, ff. 127-28).. Portelli morirà a Lipari il 28 gennaio 1838.
[23] La prima finalità afferma il can.Portelli era “far apprendere alle ragazze le arti donnesche e i principij della Religione Cristiana”. Quindi esso serviva anche come “rifugio alle orfane, asilo per le vergini, per custodia a quelle figlie che non potevano convivere sotto il tetto paterno, e per scampo alle mogli che non conveniva coabitare con il marito e, di mezzo a’ Magistrati, per depositare quelle donne che temporaneamente dovevano allontanarsi dalla famiglia mancando in Lipari altra casa che potesse avere lo stesso destino”. E questo sotto la cura di una direttrice e la dipendenza e la sorveglianza del vescovo.(Archivio Vescovile, Scritture varie e visite Date (Miscellanea) ff. 275v, 272, 272v.(Archiio storico eoliano.it)
XIX secolo. Fra segni di crescita ed eventi rivoluzionari
Il volano dei commerci e dei traffici marittimi
L’800 si apre con un intensificarsi dei rapporti commerciali marittimi in tutto il Mediterraneo e le Eolie vengono a trovarsi al centro di una rete di rapporti e di scambi sia fra la Sicilia e la penisola soprattutto la costa tirrenica ma anche con la Sardegna, la Corsica , la Spagna e la Francia. Sono soprattutto Lipari e Stromboli a essere sulle più importanti rotte ma oltre a Lipari è Salina a saper cogliere le opportunità che si aprono attraverso queste relazioni e questi scambi e a cimentarsi in attività commerciali di un certo respiro e a in attività artigianali ad esse collegate come la lavorazione del legno e la costruzione di barche e di paranze. Ed anche all’inizio dell’ottocento cominciano ad attivarsi attività industriali come l’estrazione della pomice, la raccolta e la lavorazione dello zolfo e dell’allume che fino allora erano state del tutto marginali o addirittura inesistenti perché non autorizzate.
Le terre pomicifere, considerate da sempre terre comuni, oltre al fatto che su di esse pesava la rivendicazione della Mensa vescovile che le riteneva sua proprietà, erano anche oggetto di appropriazioni indebite da parte dei privati. L’una e l’altra ragione frustravano – come vedremo - i propositi della civica amministrazione di darle in concessione, percependone il dazio sull’escavazione. Esse erano così meta di cavaioli, sia singoli sia a gruppi, che prendevano ciò che potevano, alimentando comunque un discreto commercio di esportazione che nel 1825 era di ben 700 tonnellate.
Questo lento ma progressivo emergere dell’economia sotto l’impulso del commercio e dei traffici trova soprattutto nell’agricoltura e nei prodotti della terra una sponda capace di offrire beni per l’esportazione. Certo non il grano, i legumi, l’olio, la stessa frutta che o venivano tutti assorbiti dal consumo interno ed anzi risultavano insufficienti e dovevano essere importati, ma prodotti che si indirizzavano verso un consumatore più esigente attento alla qualità ed alle specialità e quindi , oltre ai capperi, innanzitutto i prodotti dell’uva a cominciare dai passoli e dalla passolina che derivavano dalla sua essiccatura e quindi il vino sia quello rosso corposo ad alta gradazione, sia quello bianco aspro e leggero, sia in particolare la malvasia di cui le aree di eccellenza erano a Malfa, nell’isola di Salina, ed a Stromboli. Nel 1800 gli eoliani smerciarono 18 mila barili di vino pari a 6.190 ettolitri a Napoli, Palermo, Messina e persino a Roma, Livorno, Marsiglia e Trieste.[1] Nel 1834 si ha una flessione nella esportazione di vino dal porto di Lipari perché - come sostiene il can. Carlo Rodriquez[2] - si sostituirono viti che davano uva da vino con viti per passolina[3] o piuttosto, più credibilmente, perché fin dal 1820 comincia a funzionare una postazione doganale a S.Marina Salina e quindi il vino in partenza da quest’isola viene imputato a questa nuova postazione evidenziando “la perdita dell’egemonia commerciale di Lipari sull’isola minore”[4]. Ma sono da diversi anni che S. Marina ha assunto un ruolo importante nello smercio della malvasia. Da quando cioè a Messina, a partire dal 1806, si è insediata una guarnigione britannica che diventa commissionaria di vino e malvasia proprio dell’isola di Salina[5]. Comunque, con prevalenza di un’isola o dell’altra, - di Lipari per quanto riguarda la passolina, di Salina per il vino e la malvasia - per larga parte dell’800 la vite sarà la caratteristica del paesaggio agricolo eoliano.
Ed è proprio questa monocultura, secondo il Rodriquez, che rende l’economia povera. “Qui si è generalizzata la piantagione di viti di uva passolina; ma tal genere, per lusso e per l’abbondanza, fa talvolta che rimanga invenduto o a minimo prezzo si smercia; e quando politiche circostanze non permettono che i Russi, i Germani, i Polacchi, gl’Inglesi ne acquistino, la miseria in questo paese diviene più grande e più universale”[6].
Non era ancora assurta ad una vera attività economica invece la pesca. Sebbene il mare fosse molto pescoso, nelle isole essa era praticata come attività integrativa che permetteva di arrotondare le entrate dell’agricoltura. Comunque era la piccola proprietà contadina a conduzione familiare la struttura portante dell’economia che finiva col caratterizzare il modello culturale eoliano. Altri elementi caratterizzanti erano l’essere un ambiente isolato e chiuso,l’assoluta assenza di spreco, l’utilizzo di ogni bene sino all’esaurimento.
All’interno della famiglia eoliana tutto veniva consumato e ciò che avanzava dall’alimentazione delle persone diventava cibo per le galline e le capre, concime per le piante, combustibile per il forno. Era la donna la principale artefice della trasformazione dei prodotti della terra in prodotti di consumo, ad essa spettava al cura degli animali, essa tesseva, filava, rattoppava[7]
I contadini erano la categoria sociale più numerosa dei 17 mila abitanti che ora contano le isole. Erano per lo più mezzadri ( parsunala )ma c’erano anche i giornalieri che andavano a giornata nelle proprietà. Ogni contadino di Lipari possedeva la sua casa e il suo podere – ma erano poche le famiglie che arrivavano ad avere una salma di terra, molte dovevano contentarsi di poche pergole[8] - quindi solitamente questo era insufficiente per tenere fronte ai bisogni della famiglia e il contadino doveva lavorare anche per altri divenendo così mezzadro.
Sull’agricoltura delle isole nella prima metà del secolo ha scritto pagine di grande interesse e di critica sui metodi di conduzione dei campi, il can. Carlo Rodriquez che fu certamente la figura culturalmente più eminente di quel periodo.
Se il commercio e i traffici marittimi furono il volano della crescita delle isole questo lo dovette anche ad alcuni personaggi che seppero sfruttare la situazione e divenire infaticabili creatori di collegamenti e di relazioni ad ampio raggio fin oltre i confini del Regno. Uno di questi fu don Antonio Paino[9] che dopo aver sposato una donna di uno dei più ricchi casati, vide crescere in misura notevole il suo volume di affari e da modesto commerciante divenne il titolare di una fortunata ditta di spedizioni intestata a lui ed ai figli. I frutti dei suoi guadagni venivano investiti in barche, case e terra nelle varie isole. La sua attività fu continuata poi dal figlio Onofrio.
Un altro mercante liparese che teneva rapporto con diverse piazze, spingendosi fino a Trieste fu Giovanni Bongiorno[10] che insieme al fratello commerciava soprattutto in capperi, passolina, malvasia e vini. A Salina, all’inizio del secolo, è Domenico Giuffré che si distingue per produrre vino, passolina, passoli, olio, capperi, fichi secchi e malafria e commerciarli con le sue barche. “Accanto alla sua casa al Barone – racconta in una intervista Vittorio Lopes,suo discendente – egli possedeva tanti magazzini quanto erano gli apostoli, sempre carichi della merce che i suoi velieri trasportavano[11]”. Domenico Giuffrè[12] come prima suo padre Angelo e con lui diversi altri commercianti e “mercanti di mare” salinari sono all’origine di quel “sorpasso” di Salina su Lipari nella produzione e nel commercio del vino ma anche nella navigazione marittima di cui parlano Saija e Cervellera e che si verifica nella prima metà dell’800.
Un passo verso la qualità nel vivere e nell’abitare
Negli ultimi decenni del 700 il governo borbonico aveva dichiarato Lipari luogo di esilio coatto ed aveva destinato proprio la città alta a luogo di abitazione degli esiliati. Così la popolazione che ancora abitava al Castello cominciò ad abbandonare il proprio domicilio e a stabilirsi nel borgo. “E talmente s’ingrandì cotesto che prese il nome di Città di Lipari”[13].
Ma il rapporto della città con i coatti non era facile. Sebbene non mancassero fra questi relegati gente condannati per reati di opinione la gran parte erano delinquenti comuni. Qualche decina era andata a lavorare a vulcano nelle industrie di Nunziante, altri erano andati a Filicudi per lavorare nei campi o terrazzare le pendici collinari, alcuni erano trattenuti nelle carceri di sicurezza del Castello, la maggior parte però circolava liberamente per Lipari creando apprensione nella popolazione. Quando il can. Rodriquez scrive nel 1840 il suo “Breve cenno storico” i coatti sono divenuti ormai 500, di cui la gran parte condannati per furti, e sostiene che essi sono all’origine di aggressioni alle persone o di assalti alle abitazioni o perché praticano direttamente queste azioni o perché in qualche modo fanno scuola ai “malnati naturali”[14].
Rodriquez suggerisce che si pensi ad illuminare Lipari proprio per evitare degli inconvenienti ed è questo un argomento che gli sta particolarmente a cuore, di cui aveva scritto qualche anno prima, affermando che dalle 24 ( le 17 di oggi) in poi, nella stagione invernale, le strade cittadine diventano impraticabili perché esposti agli urti continui “con le bestie che vengono dalle campagne e con gli uomini che vanno per i propri affari”. Ma non è solo questione di sicurezza ma anche, diremmo oggi, di decoro urbano che renderebbe più vivibile la cittadina. Per esempio, nelle ore serali, si potrebbe sviluppare il passeggio che “avvicinerebbe i singoli e li renderebbe tra loro più amici, più socievoli, ed in generale più civili”. Quindi una decisione indispensabile per “il pubblico bene”tanto che, sostiene Rodriquez, “isole di minor considerazione, come Favignana e Pantelleria, non sono mancanti di tale vantaggio”.[15]
La Lipari delle attività commerciali ed artigiane era venuta sviluppandosi nei quartieri intorno alla Marina di S.Giovanni che, da qualche tempo, avevano preso il nome di Piazza del Commercio, la salita che dalla Marina arrivava al Timparozzo, quindi la strada di Santo Pietro – l’attuale via Maurolico – e quindi la strada del Pozzo, oggi il tratto più centrale di corso Vittorio Emanuele. Il Piano del Pozzo cominciava a registrare una vivacità pittoresca con le botteghe artigiane – stagnari, fabbri, falegnami, tintori, barbieri, sarti, calzolai -, le bottegucce dei piccoli commercianti, le taverne numerose quanto sudice. E poi, fin dalle prime ore del mattino, il vocio de i rumori di facchini e di carrette che con secchie e barilotti venivano ad attingere acqua alle gibbie.
Già intono agli anni 30 la Piana del Pozzo, malgrado si trattasse di un greto limaccioso ed accidentato, andava assumendo una precisa caratteristica con alcuni edifici pubblici importanti. Vi era nell’arco di un centinaio di metri o poco più la Chiesetta del Rosario con di fronte l’ospedale dell’Annunciata; più avanti, in direzione della chiesa di San Pietro, le due gibbie con dietro le scuole vescovili da un lato e dall’altro in grande fabbricato del Conservatorio con all’angolo la cappella dell’Addolorata; sullo sfondo l’edificio del Palazzo vescovile[16].

La Chiesa di San Pietro nell'800.
La separazione della Strada del Pozzo dalle scuole e dal conservatorio femminile che si trovavano ai lati dell’attuale viale mons. Bernardino Re, con un muro orlato ed un grande cancello di ferro avverrà intorno al 1840 per volontà del vescovo Proto.
Quando Dumas visitò le Eolie
Ancora nel 1835, quando Alexandre Dumas visitò le Eolie, Lipari non aveva una locanda che potesse ospitare dei viaggiatori. “Appena sbarcati – scrive lo scrittore francese – ci mettemmo alla ricerca di un albergo: sfortunatamente era una cosa del tutto sconosciuta nel capoluogo. Cercammo da un capo all’altro della cittadina: non la più piccola insegna né alcun segno di locanda”[17]. A stare a Dumas però non mancava una sala da bigliardo che dopo le dieci di sera era ancora aperta e dove non solo riuscì a fare una partita ma anche consumare uno spuntino a base di torte e frutta graziosamente offerto dalla padrona del locale[18].
Fu per la trasformazione dell’abitato e lo sviluppo della città bassa che la chiesa di S.Pietro, il 4 giugno del 1808 divenne chiesa sacramentale e chiesa filiale come lo era già quella di S. Giuseppe e nella Marina di S. Giovanni fu innalzata una statua di marmo a S. Bartolomeo. Non era la statua che si vede ora nella piazza di Marina corta ma una di dimensioni più modeste. Negli anni ’20, l’ammiraglio inglese sir William Henry Smith che visitò le Eolie disse di questa che si trattava di “una bella statua greca che è stata trasformata in santo con l’aggiunta di un’aureola di rame; molti sostengono che sia stata fatta in onere di Timasiteo”[19]
Mentre si scavava per il fondamento della statua si trovò “una bella sorgente di acqua con sua artificiale fontana e margherita di bronzo”. Fu fatto venire da Palermo un esperto ma si constatò che si trattava di acqua salmastra per cui si costruì un pozzo “che con l’andare del tempo si disperse[20]”.
All’inizio dell’800 c’è da registrare due opere pubbliche realizzate per iniziativa del governatore del tempo, il colonnello Carlo Mensingher[21]. La prima riguarda la mulattiera che da Lipari, attraverso lo Zinzolo, porta a Pianoconte ed oggi si chiama Strada Vecchia. Fu lastricata nel 1801 per collegare le colline con la cittadina e probabilmente anche con il piccolo porto. Si era creata infatti, a Lipari come a Salina, una certa attenzione verso l’agricoltura e chi aveva capitali li investiva nel bonificare le terre nelle zone alte, piantandovi alberi e vitigni. In quel periodo si disboscarono abusivamente anche le pendici di monte Sant’Angelo creando tensioni e discussioni sulla proprietà di quelle aree, disappunto nei giurati e proteste fra i pastori di Quattropani che usavano quei terreni per il pascolo di capre e ora se lo vedevano impedito. Forse ci scappò anche il morto: tale Antonio Paino di Pietro, di 46 anni che morì “ucciso in campagna” il 10 agosto del 1804 e fu sepolto nella chiesetta di Porto Salvo[22].
La seconda opera , che il Mensingher realizzò sempre con i contributi governativi, riguardava la trasformazione del vecchio ospedale S. Bartolomeo e poi Casa degli esercizi spirituali, ormai in rovina, in casa di cura e ospizio per i malati, i poveri ed i vecchi soldati che avevano servito la patria in armi[23]. L’ospedale era dotato di un cimitero che consisteva allora in una fossa comune scavata a mo’ di cisterna. Nel 1805 questa sepoltura era approntata ed è del 14 agosto la richiesta della certificazione di agibilità da parte della Deputazione di Salute.
Ma mentre a Lipari nobili e borghesia tendevano a qualificare i loro modo di vivere nelle isole la situazione era di tutt’altro tipo. W.H. Smith che visitò Salina, che contava già 4 mila abitanti, così descrive i suoi abitanti: “gli uomini sono robusti e laboriosi ma sporchi e feroci, mentre le donne, ugualmente sporche, sono le più rozze e mascoline che abbia visto in queste zone; i due sessi sono, senza distinzione, tormentati da rogna più o meno cronica. Nonostante ciò, e nonostante i modi non troppo seducenti, ho constatato una grande ospitalità e gentilezza in tutti i ceti durante il mio soggiorno, e nel buon prete di Amalfi trovai un intelletto più colto di quanto mi attendessi in un luogo così sperduto[24]”. E la situazione delle altre isole non doveva discostarsi di molto. A proposito di Alicudi A.Dumas nel 1835 dice che “è difficile vedere qualcosa di più triste, di più tetro, di più desolato di questa sfortunata isola”. Nessun sentiero conduce sulla cima o corre lungo le sue rive: alcune sinuosità scavate dalle acque piovane sono gli unici passaggi offerti. Non un albero su tutta l’isola né un poco di vegetazione che riposi gli occhi. “Ciò nonostante su questo angolo di terra rossastra, vivono in misere capanne centocinquanta o duecento pescatori che hanno cercato di sfruttare i rari fazzoletti di terra sfuggiti alla distruzione generale”.[25]
Oltre Alicudi, Lipari e – come vedremo più avanti – Vulcano lo scrittore francese visita anche Panarea – “una decina di case corona il pianoro dell’isola”[26]- e Stromboli. Di quest’isola annota che gli abitanti sono vignaiuoli e commercianti di uva passa, che sono le due principali attività, ma sono anche ottimi marinai[27]. (Archivio storico eoliano.it)
[1] C. Rodriquez, Breve cenno storico-critico sull’isola di Lipari, in “Giornale delle Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, 1841, tomo LXXVI, p.246; G.A.M. Arena, op. cit., pag. 38.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] M.Saja e R. Cervellera, Mercnadi di Mare. Salina 1800-1953, Salina 1997, pag. 27.
[5] Idem, pp.20-25.
[6] C. Rodriquez, Breve cenno storico sull’Isola di Lipari, Palermo 1841, pp.37-38.
[7] G.A.M. Arena , op.cit., pp 37 ess.
[8] I riveli del 1815-16 delineano una proprietà molto frazionata. Archivio di Stato di Palermo, Deputazione del Regno 1815-16,; G.A. M. Arena, op. cit. pag. 39.
[9] Nacque a Lipari da Tomaso e Maria Tauro nel febbraio del 1775 Sposò donna Marianna Salpietro. Ebbe sei o setti figli di cui alcuni morirono in tenera età. Morì a Lipari all’età di 55 anni il 25 aprile del 1829. G. Iacolino, Gente delle Eolie, Lipari 1994, pp 172-175. v. anche G. Iacolino, manoscritto cit. Quaderno VI pp269 a-h.
[10] Giovanni Bongiorno di Emanuele era nato intorno al 1765 e morì il 1815. Sposato con donna Giovanna Maggiore ebbe due figli Emanuele e Giuseppa. Suoi discendenti in linea retta sono il maestro Edoardo e Leonida. G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pp 269 h2- h6.
[11] M.Saija e A. Cervellera, Mercanti di mare, op. cit. pag. 79 nota n.3.
[12] Domenico Giuffré ( 1778 – 1862) nasce a S. Marina Salina da Angelo e sposa in prime nozze Maria Lauricella da cui ha nove figli. In seconde nozze sposa Maria Famularo da cui ha un altro figlio.
[13] Dal manoscritto di proprietà della famiglia Mancuso, p.595.
[14] C. Rodriquez, op. cit., pp39-40.
[15] C:Rodriquez, Pubblica istruzione, in “Il Maurolico”, anno I, vol.II. N.4 del 10 giugno 1835, p.50.
[16] G. Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, pag. 274.
[17] A.Dumas, Dove il vento suona. Viaggio nelle Eolie, Marina di Patti 1986, pag. 21.
[18] Idem, p.30.
[19] Timasiteo come si ricorderà era il magistrato liparese che nella Lipara greca del IV secolo a. C. convinse i suoi concittadini a restituire a Roma la nave con i voti al dio Apollo destinata a Delfi che avevano rapito. W.H. Smith, Memoir descriptive of the resources, inhabitants and hydrografy of Sicily, London 1824, traduz. Ital. di G.A. Catinella e G. De Franchis dal titolo “La Sicilia e le sue isole”, Palermo 1989, p.262.
[20] Manoscritto di proprietà Luigi Mancuso, pag. 598.
[21] Mensingher desiderava che la gente lo ricordasse per quello che aveva realizzato ed infatti nella lapide che fece porre in via Zinzolo c’è scritto che la strada per Pianoconte si sarebbe chiamata “Via Mensingheriana” ma fu un nome che non entrò mai nell’uso dei liparesi. Di questo governatore la gente piuttosto ricordò anche che aveva avuto l’idea balzana di piazzare l’intera santabarbara del presidio proprio a ridosso della Cattedrale in una cisterna fuori uso e ridotta a magazzino col rischio che un qualsiasi incidente facesse saltare cattedrale e metà Castello. Il governatore morì l’11 gennaio 1803.
[22] Nel registro dei defunti dell’Archivio Vescovile, al n. 295 dell’anno 1804, è scritto “rure interfectus fuit et sepiltus est in Eccl.a Portus Salutis” in G.Iacolino, manoscritto cit., Quaderno VI, p.260.
[23] Anche qui, come all’inizio della strada per piano conte, oggi in via Zinzolo, fece affiggere una lapide e i testi delle due epigrafi furono ricopiate da Luigi Salvatore D’Austria,Le isole Lipari, vol.III, a cura di Pino Paino, Lipari 1982, p.32, e p.33.
[24] S. Mazzarella, W.H.Smith, La Sicilia e le sue isole, Palermo 1989, p.266.
[25] A. Dumas, Dove il vento suona. Viaggio nelle Eolie, op. cit. pag. 12.
[26] Idem, p.52.
[27] Idem, p.68.
La tholos micenea
Sulla via dello stagno

Mappa dell'ecumene basata su Strasbone che indica le mitiche Cassiteridi a nord della Spagna su cui sarebbero esistiti giacimenti di stagno e quindi una delle mete della "via dello stagno".
Conclusa la fase del commercio dell'ossidiana le Eolie riacquistano interesse grazie soprattutto alla loro posizione strategica. Era iniziata infatti l'”età del bronzo” e l'arcipelago era divenuto punto di passaggio, rifornimento e commercio per i navigatori – e fra questi in particolare gli Eoli e comunque navigatori provenienti dall'Egeo - che percorrendo la U“via dello stagno”U traversavano il Mediterraneo dalle coste del vicino Oriente e dal mondo miceneo ad Occidente passando attraverso lo stretto di Messina.
Attraverso questo percorso giungevano fino alle isole britanniche- dove esistevano giacimenti di questo minerale che aveva acquisito un ruolo fondamentale nella vita quotidiana -, attraverso il ponte terrestre dalle foci della Garonna alle foci del Rodano . Ma lo stagno era solo una delle mercanzie che alimentavano i traffici lungo questo percorso. Vi erano le ceramiche , tessuti, pellame, vino, olio, frutta secca e gli schiavi che dovevano rappresentare la mercanzia più richiesta.
Quanto alle Eolie, persa l'ossidiana, grandissima parte del loro interesse commerciale, ebbe il punto di forza soprattutto nella posizione strategica. Nondimeno avevano anche loro prodotti da esportare come il vasellame ma soprattutto l'allume e lo zolfo e più tardi il caolino e la pomice. L'allume in particolare lo si adoperava in tintoria, per la concia delle pelli e come astringente in medicina. Non dobbiamo dimenticare inoltre i prodotti della terra come il l'olio ed il vino.
La tholos di San Calogero
Non dovette essere nemmeno secondario l'interesse per i soffioni, i fanghi e le acque curative di cui queste isole erano famose fin dall'antichità come dimostra la stufa a forma di thòlos di San Calogero che richiama, in scala, l'architettura di tombe micenee e la cui costruzione può farsi risalire a prima del 1430 a.C.

Disegno di Jean Houel che visitò Lipari alla fine del 700

L'entrata della tholos oggi.
La scoperta del significato che questo manufatto acquista per la nostra storia, matura di fatto negli anni 80 nel corso dei lavori di ristrutturazione di tutto il complesso termale di San Calogero. In quell'occasione, per l'opera di

L'interno: i sedili e la ringhiera che circonda la pozza.

Interno della tholos.
La falsa cupola a volta.
Demolizione di alcune sovrastrutture murarie, l'antica stufa può essere osservata e studiata da Bernabò Brea e dalla Cavalier. Lasciamo a loro la parola:
“Fin dal momento in cui, penetrando nella cupola termale di San Calogero, ormai aereata ed illuminata, potemmo portare su di essa la nostra attenzione, rimanemmo colpiti dalla appariscente somiglianza, sia del tipo architettonico sia della struttura, con le tholoi micenee e la nostra impressione fu condivisa dai colleghi che subito dopo di noi, venendo a Lipari, poterono visitarla. Si trattava di una impressione, a cui peraltro davano fondamento i confronti che cercammo di istituire con altri monumenti a falsa cupola del Mediterraneo.
La falsa cupola, la volta costituita cioè da filari sovrapposti di blocchi litici aggettanti gli uni sugli altri in cerchi via via sempre più ristretti, ha antichissime origini e lunghissime tradizioni nel Mediterraneo. E' certamente molto più antica dell'età micenea, se ne ritroviamo già i lontani precedenti nelle capanne di Kirokitia a Cipro. I Micenei l'hanno portata alla più elevata espressione architettonica ed artistica, ma potremmo ricordare le innumerevoli sopravvivenze nell'edilizia rustica fino ai nostri giorni, di cui i trulli di Alberobello sono uno dei più noti esempi.( ..)
Si potrebbe quindi dire che la falsa cupola fa parte del comune patrimonio tecnologico delle genti abitanti sulle sponde del Mediterraneo fin dall'età neolitica. La tecnica con cui la nostra tholos è costruita non sarebbe dunque di per sé stessa una prova definitiva dell'antichità attribuibile ad essa. Tuttavia le analogie tipologiche e strutturali che essa presenta con le tholoi di età micenea sembrano più strette che con qualsiasi altra classe di monumenti, tecnicamente analoghi, delle nostre regioni con cui la potremmo confrontare (…) Questa serie di confronti sembra in realtà confortare l'ipotesi di una attribuzione della nostra tholos all'età del bronzo.
Senza dubbio, di tutti i monumenti costruiti con questa tecnica architettonica, quella a cui essa è più vicina sono le tholoi funerarie della Grecia micenea. Essa sembra veramente riprodurre il prototipo da esse costruito, in una scala ridotta, che è in rapporto con la sua funzione di stufa termale. La distruzione della sommità della cupola e degli stipiti della porta rendono impossibili confronti riguardanti questi dettagli e d'altronde senza dubbio le piccole dimensioni e la scarsa ampiezza delle due aperture rendevano superflui dei triangoli di scarico al di sopra degli architravi che quasi costantemente ricorrono nelle tholoi micenee(…)
Se la tholos di San Calogero è un monumento dell'architettura micenea essa riproduce esattamente, in dimensioni molto ridotte, la forma e le strutture della stessa Micene.
In modo particolare si avvicina alla più raffinata, alla più elegante fra esse: il tesoro di Atreo. Ha di questo la stessa struttura, interamente in blocchi quadrati, mentre la maggioranza delle altre tholoi la presentano solo in parte. Ma la tholos del mondo miceneo ha, per quanto conosciamo, solo una funzione sepolcrale. E' la grandiosissima tomba di un principe o di una famiglia principesca.
La nostra ha una funzione del tutto diversa. E' stata creata come una stufa termale, ed è l'unico caso finora noto di un simile adattamento del tipo. Senza dubbio in stretto rapporto con questa diversa particolarissima funzione sono le sue piccole dimensioni”.

Veduta complessiva della Tomba di Atreo

L'entrata del Tholos di Micene
Un importante emporio miceneo
Dal punto di vista storico e culturale una simile ipotesi , continuano i nostri archeologi, è in linea con le altre ricerche fato sul campo ed il rinvenimento di centinaia di frammenti di ceramiche di quell’epoca a Capo Graziano, sul Castello di Lipari, sulla Montagnola di Filicudi, a Serro dei Cianfi di Salina, e di ceramiche di stile miceneo nelle stesse località, sul promontorio del Milazzese nell'isola di Panarea e in quello della Portella di Salina. Tutti questi rinvenimenti ci mostrano che le isole Eolie erano in quell'età fra i principali empori del commercio miceneo del Mediterraneo occidentale. Empori che dovevano essere visitati regolarmente, ogni buona stagione, dalle navi micenee che ad essi facevano capo..

Volta tomba micenea
“Essa ci apparirebbe nella sua struttura - dicono ancora Bernabò Breaa e la Cavalier -come un tipico monumento dell'architettura micenea, vorremmo dire come una delle più perfette realizzazioni di questa cultura, soprattutto se noi la consideriamo per quello che doveva essere al momento della sua costruzione ed ha continuato ad essere per più di un millennio e mezzo, prima del dissesto che ne ha alterato le forme e distrutto l'armonia delle linee, nella tarda età imperiale romana.
Se noi la confrontiamo con quanto conosciamo dell'architettura indigena delle Isole Eolie dell'età a cui è attribuibile, ci rendiamo conto che essa nono potrebbe essere in alcun modo uno spontaneo germoglio sbocciato in essa ( sia pure ad imitazione dei modelli stranieri) e neppure l'opera di architetti e maestranze locali.
Essa ci apparirebbe invece come un evidente apporto del mondo miceneo, non diversamente dalle ceramiche che si rinvengono in gran numero nei livelli di questa età degli insediamenti eoliani. Apporto questa volta consistente non nell'invio di prodotti manifatturati ma nella fornitura di tecnologie, nell'invio sul posto di dirigenti e di maestranze specializzate per realizzarle“.
Una sorta di consolato greco?
Considerata sotto questo aspetto la tholos farebbe dunque parte di quel complesso di scambi commerciali che in questa età abbiamo visto esistere fra le isole Eolie e il mondo miceneo e proprio la sua esistenza permette di qualificare e valorizzare, più di quanto si ritenesse fino a qualche decennio fa, queste relazioni.
Se chi presiedeva ai grandi commerci dovette ritenere utile e necessario trasferire alle Eolie tecniche e competenze fino allora sperimentate in Grecia per realizzare un'opera di così straordinaria grandiosità per quel tempo, era perché doveva pendere a loro favore una bilancia dei pagamenti di notevole rilevanza ..
“Il fatto stesso - sottolineano Bernabò Brea e la Cavalier - che sia stato possibile ideare, programmare e realizzare un'opera di questo genere implica che fra le isole Eolie e i principati micenei dovevano esistere rapporti stretti, costanti e duraturi, implica cioè un approfondita conoscenza reciproca. E' ovvio d'altronde che se le navi micenee venivano regolarmente nelle isole Eolie ad offrire prodotti non lo facevano a titolo di dono generoso, ma le usavano come merci di scambio contro altri prodotti.
E d è ovvio altresì che questo commercio doveva essere in qualche modo organizzato. Era necessario cioè che agenti commerciali micenei risiedessero stabilmente per periodi più o meno lunghi nelle isole Eolie per preparare la raccolta di quelle merci che le navi dei loro paesi sarebbero venute a caricare alla stagione dovuta“.
Rappresentanti che dovevano avere anche una funzione più ampiamente politica e diplomatica, veri e propri consoli ed ambasciatori, il cui compito era quello di assicurare quelle buone relazioni fra i loro principi ed i principi locali e di condurre delle trattative per cui le merci che ad essi interessavano fossero incanalate verso i loro paesi e non verso stati concorrenti.
E ciò soprattutto trattandosi di prodotti di fondamentale importanza strategica quali lo stagno e gli schiavi. Ma non vi erano solo costoro. Oltre a questi doveva essere frequente che raggiungessero le nostre isole anche membri delle più eminenti famiglie locali per visitarle. E’ dunque su questo sfondo di rapporti politici, economici e culturali, che va vista la costruzione della tholos micenea di Lipari: solo così - osservano Bernabò Brea e la Cavalier - si potrebbe spiegarne l'esistenza.
“La tholos di San Calogero sarebbe dunque sorprendente - concludono i nostri archeologi - non solo come testimonianza di uno straordinario spirito di ideazione e di iniziativa nel campo delle relazioni politiche ed economiche, ma anche come la dimostrazione di una eccezionale capacità di adattamento tecnico da parte degli architetti che l'hanno progettata, sarebbe nel suo genere quale stufa termale, un monumento unico, senza confronti, nel campo dell'architettura micenea.
E' probabile comunque che essa sia il più antico edificio termale fino ad oggi conosciuto nel mondo mediterraneo, anche se l'utilizzazione a scopo curativo delle risorse termali è forse vecchia come la stessa umanità.”TP[1]PT
Oltre alla tolos di San Calogero ed ai reperti archeologici del Castello e di Capo Graziano, a testimoniare la grande vitalità di questa fase della nostra storia – in cui gli Eoli di Occidente sembrano acquisire quasi il monopolio del commercio del mondo miceneo tra il XVIII e il XVI secolo a. C. -, rimane anche un affresco trovato negli scavi di Akrotiri, antico centro dell'isola di Santorini, ed oggi conservato nel Museo Archeologico di Atene.(Archivio storico eoliano.it)
TP[1]PT L. Bernabò-Brea,M. Cavalier, Le terme di San Calogero, in Arcipelago , VII, 1983, n.3, p.5..



 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431