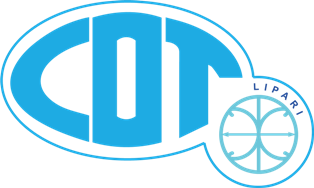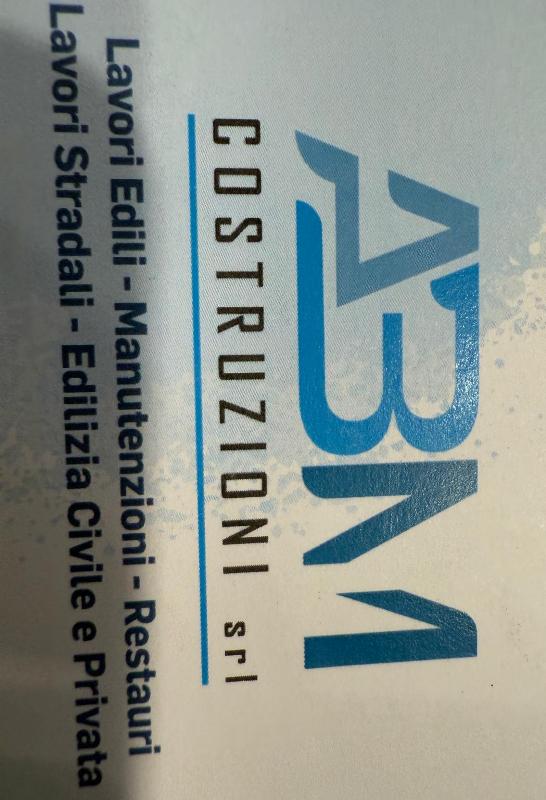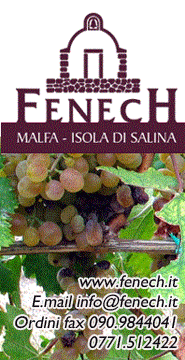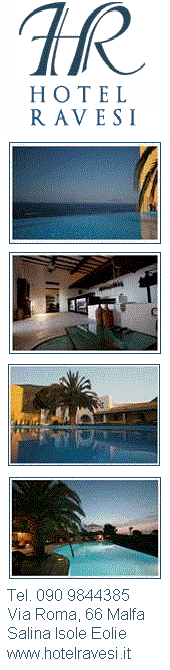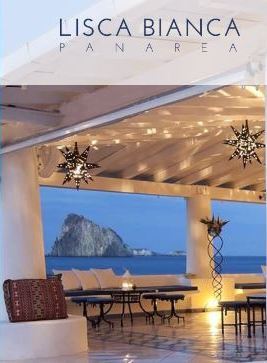di Maria Pia Farinella
Il fascismo tra noi lo cogli pure di mattina al bar. Sorseggi il caffè e se sei vintage sfogli perfino un quotidiano di carta. Nel frattempo il vicino di tavolo e di quartiere, lo conosci di vista e sai che è professore in pensione, conciona a voce alta per far lezione. “Il caffè al bar si paga col pos”, scandisce. “Altrimenti sei fascista. O leghista”. Abbassa la voce ma non troppo, si guarda attorno con circospezione e sibila: “Oppure sei mafioso”. Addirittura.
E già non sai se è maggiore l’esibizione di pubblico sprezzo del pericolo mafioso oppure del ridicolo tout court. Povero professore. Anche lui vittima del conformismo, di quella omologazione che oggi, a partire dai media e dai social, pervade tutto. Pervade qualsiasi percezione di ciò che ci circonda.
Un nuovo populismo calato dall’alto in cui la narrazione della realtà diventa essa stessa realtà. Non è l’uso del pos in discussione. Ma questo specifico, ostentato “Vorrei e pos”. Anche per sciocchezze. Urgenze minime e superflue come il caffè al bar. Che gliene importa di come si paga al vecchio professore, un tempo classe media e oggi ridotto a bracciante della cultura, reddito fisso tra i più bassi d’Europa rispetto al ruolo sociale che dovrebbe ricoprire.
Il “nuovo fascismo”. Lo aveva previsto Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. In un articolo per il Corriere della Sera del primo marzo 1975 Pasolini scrive che “come polli di allevamento, gli italiani hanno assorbito la nuova ideologia irreligiosa e antisentimentale del potere: tale è la forza di attrazione e di convinzione della nuova qualità della vita che il potere promette. E tale è, insieme, la forza degli strumenti di comunicazione (specie la televisione) di cui il potere dispone. Come polli d’allevamento, gli italiani hanno accettato la nuova sacralità, non nominata, della merce e del suo consumo”.
Non ci addentriamo nel mondo delle banche, su cosa comporta l’uso della moneta elettronica, su commissioni, annessi e connessi. Ma sarà l’euro del caffè la metafora più attuale dell’evasione fiscale? In un paese dove i veri ricchi hanno almeno sedici società off shore, non pagano tasse in Italia e ottengono prestiti per miliardi di euro dalla banche, con “formule innovative” (come scrivono i giornali di loro proprietà), le quali non sono altro che la garanzia dello Stato italiano? Un paese così arzigogolato nella metafisica delle burocrazie di governo che poi il potere fa ciò che gli pare. Come sempre.
Certo, in modo più subdolo e ipocrita del fascismo “archeologico” del ventennio, come lo definiva Pasolini. Ma con l’intento perenne del massimo consenso possibile. L’agognato pensiero unico dedito a magnificare le vesti del sovrano senza mai dire di vederlo nudo. Un pensiero omologato che non si ponga domande e, soprattutto, non le ponga, che non contesti, che non metta in relazione. Anzi, in correlazione.
Contro questo potere fatto di complicità interconnesse Pasolini affermava la sua verità. “Dire la verità è un atto rivoluzionario nel tempo dell’inganno universale”.
Negli ultimi decenni il professore avrà insegnato in scuole dove man mano non si è più studiata la geografia, la storia ridotta a poca roba. E chissà l’attenzione nei confronti dei migliori scrittori del Novecento italiano, Calvino, Fenoglio, Elsa Morante, per esempio. E soprattutto Sciascia e Pasolini, gli autori che hanno messo più a nudo la società italiana. Spesso sostituiti da figuranti “un tanto al chilo” dell’impegno civile.
Chissà se il professore ha fatto in tempo ad assegnare riassunti. Ormai trapassati di moda. Forse proprio perché insegnano l’arte di andare al nocciolo della questione. Nel segno della “consecutio temporum”, e quindi della logica.
“Ciò che il potere vuole è completamente arbitrario; o dettato da sua necessità di carattere economico, che sfugge alle logiche razionali”, affermava Pasolini in un’intervista a margine del suo ultimo film “Salò e le 120 giornate di Sodoma”, ambientato nel luogo simbolo dell’ultimo regime di Mussolini. Film terminato nel 1975, poco prima che Pasolini venisse assassinato all’Idroscalo di Ostia in circostanze ancora oggi oscure.
Ecco “la prepotenza del potere” secondo Pasolini. E le sue “necessità di carattere economico” prive di raziocinio e di logica. Un’immagine che si materializza negli attuali ritrovamenti di smodate cifre in contante (ah, se pos) nelle case di eurodeputati e assistenti italiani al Parlamento Europeo. A loro insaputa, va da sé. Lo chiamano “Qatar Gate”. Ma i giornali stranieri titolano su “The Italian Job”. Con riferimento alla consolidata tradizione nazionale di pouf da salotto imbottiti di denaro, cucce di cani, borse per la spesa, sacchi di plastica altrimenti dedicati a immondizie o alla raccolta di prodotti agricoli, nascondigli impensati e impensabili. L’immaginazione al potere.
E noi trattati alla stregua di Pinocchio “così dolce di sale da credere che i denari si possano raccogliere nei campi”. Come lo sventato burattino che nel romanzo di Collodi pianta gli zecchini d’oro che gli ha regalato Mastro Geppetto. Sperando di veder crescere un albero, l’albero degli zecchini. Ma quei cattivoni del Gatto e della Volpe hanno già arato il terreno. A loro esclusivo beneficio.
Ecco “l’anarchia del potere” pronosticata da Pasolini come tirannia della civiltà dei consumi, “come normalità; come codificazione del fondo brutalmente egoista di una società”. Un nuovo fascismo capace di trasformare e imbrigliare il paese ancora più in profondità di quanto non fosse riuscito a fare il regime di Mussolini. Un nuovo fascismo che “manipola i corpi in un modo orribile, nulla da invidiare alla manipolazione fatta da Himmler o da Hitler”, avvertiva Pasolini nel 1975.
Negli “Scritti Corsari” Pasolini descrive anche “la manipolazione artificiale delle idee con cui il neocapitalismo sta formando il suo nuovo potere”. Acquietando il senso critico, annichilendo lo spirito di ciascuno, “togliendo realtà ai vari modi di essere uomini”. Un fascismo nuovo che ha screditato il sacro. Anzi, “si è valso proprio delle conquiste mentali di laici, di illuministi, di razionalisti, per costruire la propria impalcatura di falso laicismo, di falso illuminismo, di falsa razionalità. Si è valso delle sconsacrazioni per liberarsi di un passato che non gli serviva più. In compenso però tale nuovo potere ha portato al limite massimo la sua unica possibile sacralità: la sacralità del consumo come rito, e, naturalmente, della merce come feticcio”.
Povero professore che ne è inconsapevole testimonial. Borghese minimo, forse metafora de “L’uomo di Bandung”. A cui Pasolini augurava in versi figli davvero fascisti.
NOTIZIARIOEOLIE.IT
8 MARZO 2022
L’intervista del Notiziario alla giornalista Rai Maria Pia Farinella, l’informazione senza confini
“Nimby”, si dice in inglese. L’acronimo significa: “Not in my back yard”. Cioè, non nel mio giardino. Mai nel cortile di casa mia.
In fondo è una storia semplice. Succede a Martha’s Vineyard, nel Massachusetts, Stati Uniti. Di là del mare e dell’oceano. Nel nuovo mondo. “La vigna di Marta” come suonerebbe il nome tradotto in italiano, è un luogo speciale. Lo sfondo perfetto per la saga amara dei Kennedy. E da loro in poi, l’isola pensatoio delle élite liberali americane.
Mica una Lampedusa qualunque. Mica un’appendice della Sicilia, isolata suo malgrado nel mezzo del decadente Mediterraneo, regina senza corona di un’accoglienza fatta, se va bene, di solidarietà, volontariato e di buoni propositi. Che servono a tappare falle nazionali ed europee sui flussi migratori per poi inabissarsi nell’inesorabile degrado di quella che fu definita “la culla delle civiltà” tra le due rive del Mare Nostrum.
Succede che a Martha’s Vineyard una storia di migranti non in regola col visto di ingresso negli Stati Uniti – cinquanta per l’esattezza, venezuelani o ispanoamericani – infiamma le coscienze, diventa casus belli, anima un dibattito nazionale a cui non si sottrae neppure il presidente Biden.
Cinquanta migranti fatti trasportare dal governatore della Florida Ron DeSantis sull’isola della East Coast, che è luogo a larga maggioranza wasp, “white, anglo saxon, protestant”, anche se non si può più dire a voce alta, non ci si può inorgoglire, non è politicamente corretto.
Cinquanta individui sbattuti sulle pagine dei giornali Usa come “emergenza”, come “crisi umanitaria”. Con un durissimo scambio di comunicati tra il governatore della Florida e la Casa Bianca. Che ci sarebbe già da ridire, vista l’irrilevanza numerica del drappello al tempo delle migrazioni di massa, e perfino da ridere se non ci fosse di mezzo “l’eterno monologo dell’umanità dolente”, che don Miguel de Unamuno sapeva tratteggiare come pochi. Un sentimento tragico della vita che mai come ora si è fatto carne e sangue nei migranti.
Il governatore della Florida, il quale non nasconde mire politiche alle elezioni di Midterm a novembre, ha deliberatamente spedito i cinquanta ispanici irregolari a Martha’s Vineyard perché l’isola si trova nel Massachusetts, stato che assieme a New York e alla California garantisce protezione ai migranti. Località “sanctuary”, le chiamano. In cui “sanctuary” vuol dire “rifugio” al di là delle norme federali in materia di immigrazione. DeSantis ha parlato chiaro: “States like Massachusetts, New York and California will better facilitate the care of these individuals who they have invited into our country by incentivizing illegal immigration”. Non senza ironia ha detto di favorire l’accoglienza, purché a casa loro, “purché riguardi gli stati che sostengono le frontiere aperte”.
La Casa Bianca ha risposto con una severa reprimenda “sull’uso politico di esseri umani”. Una cosa che non si fa, “non è americana”, ha tuonato in punto di etica il Commander in Chief, Joe Biden, già irritato con Greg Abbot, governatore del Texas, altro stato di frontiera. Abbot aveva cominciato per primo a spedire già mesi fa decine di autobus carichi di migranti senza carte in regola a New York, a Chicago e a Washington, perfino sotto casa della vicepresidente Kamala Harris.
Altro che: “E Pluribus Unum”, il motto inciso dal 1776, anno d’inizio della Rivoluzione americana sullo stemma degli Stati Uniti per sottolineare il valore della pluralità: “da molti, uno solo”. Meglio sostituirlo con un più concreto ed attuale: “Not in my back yard”.
Il fatto è che il tema della regolamentazione dell’immigrazione, come quello dell’aborto, e quello della riforma elettorale è tra i più spinosi del dibattito pubblico negli Stati Uniti.
Per questo Martha’s Vineyard con i suoi cinquanta migranti, mai visti prima da quelle parti, è diventato un caso. Assieme ai più di cento militari della Guardia nazionale utilizzati per riportarli sulla terraferma. Con la motivazione che ha fornito il governatore Charlie Baker: “The island communities are not equipedd to provide sustainable accomodation”. Poche storie.
Non vale neppure la memoria dei “Pilgrim Fathers”, coloni per necessità, che nel 1620 sbarcarono da quelle parti, a Cape Cod, e fondarono il New England, archetipo degli Stati Uniti.
Non c’è spazio, né lavoro per i migranti ispanici nel cuore dell’America liberal, democratica e progressista di cui Martha’s Vineyard è simbolo. “Le case qui costano troppo” – sottolineano le autorità – “dove li ospitiamo?”.
Certo, l’isola conserva intatto il fascino del New England, “the Spirit of America”. Ancora oggi la vita si snoda tra antichi fari e villaggi sul mare che serbano memoria della caccia alle balene. Enormi scogliere a picco sull’Atlantico e lunghe strisce di sabbia a contorno di poche, magnifiche abitazioni immerse nel verde. Altro che turismo di massa. Altro che McDonald e catene commerciali. Martha’s Vineyard è spazio riservato ed elitario. Si parva licet, l’isola del Massachusetts sta agli Stati Uniti come Capalbio, in Toscana, sta all’Italia.
Perché come Capalbio, Martha’s Vineyard è a vocazione dem. Caparbiamente. La chiamano “Democrats Haven”, il paradiso dei democratici. Che non sono solo un partito, ovvio. Ma una filosofia di vita. Di qua e di là dei mari. Filosofia progressista e in divenire, ci mancherebbe.
Così il paradiso perduto di Jacqueline Kennedy è oggi il luogo dove trascorre le vacanze Hillary Clinton. Dove Obama, l’eccezione che conferma la regola wasp, possiede una mega villa con sette camere dotate di altrettanti bagni
I paragoni non andrebbero mai fatti, però talvolta rendono l’idea. Un po’ come dire che l’erede di Enrico Berlinguer è Enrico Letta. Solo Oscar Wilde avrebbe avuto l’ironia necessaria per scrivere una commedia sull’importanza di chiamarsi Enrico per credere di agire alla maniera democratica.
Il finale è scontato. A Martha’s Vineyard ancora intervistano giovani donne residenti nell’isola, tutte bionde, snelle e biancovestite. Che raccontano “Their first experience with poor minorities”. Risposte da pericolo scampato. “I poveri? Not in my back yard”. Nimby.
La ballata delle vanità, ma anche quella della Cirinnà. Perché proprio la Cirinnà? E non Raciti o Cracolici? Non è un fatto di territorialità. Semmai di nazional popolarità.
Perché lo scudo biondo in campo largo della senatrice è, forse, la fotografia più netta e attuale del Partito democratico. Il partito che, con vari innesti, ulivi e margherite in primis, discende per li rami dell’epopea della sinistra italiana, un tempo la più forte in Occidente.
Non per niente Monica Cirinnà è paladina dei diritti civili. E’ la prima firmataria della legge 76 del 2016 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” che, infatti, porta il suo nome. Sull’onda di quel successo disse che “la stagione dei diritti” non era che all’inizio. Si riferiva al matrimonio egualitario, alle adozioni per le coppie dello stesso sesso e per i single, alla parità di genere, ai diritti della comunità Lgbtqi+ che la nominò più volte “madrina” in occasione di Gay Pride.
La guerra in Ucraina ha portato alla luce il business degli uteri in affitto, da tempo fiorente in quel paese. La senatrice dem, in linea col suo partito, ha auspicato una visione “il più possibile laica” sulla maternità surrogata, specificando: “dove regolamentata in modo limpido e tutelato”,
Per farla breve Cirinnà ha dimostrato di avere a cuore tutti quei diritti civili che, secondo il segretario Letta, “sono nel Dna del Pd” e fanno parte dell’odierno programma elettorale. Anzi. Assieme alla legge sul fine vita, al Ddl Zan, alla legalizzazione della cannabis, allo ius scholae per i bambini stranieri che studiano in Italia, sono priorità assolute per il principale partito della sinistra democratica e progressista. Anche a costo di sostituire nell’immaginario collettivo – ma solo nell’immaginario, però – i soliti temi sociali che riguardano tutti i cittadini italiani, a cominciare dal diritto al lavoro su cui è fondata la Repubblica.
Non solo diritti civili. Monica Cirinnà ha sfoderato “occhi di tigre”, secondo i desiderata del leader maximo pro tempore del Pd. Ma è vegetariana e si batte per la tutela degli animali. Anzi, proprio dei felini.
Un biondeggiare spavaldo, il suo: “Porto avanti temi difficili con coraggio”. Un autodefinirsi “scomoda” che fa da sfondo a una serie di cinguettanti hashtag. Parole chiave che per caso cominciano tutte per C, come #Cirinnà.
Nonostante l’amore della senatrice per i gatti, per i diritti delle colonie di gatti che popolano le rovine archeologiche di Roma, i primi hashtag a lei collegati sono #cuccia e #cane.
Non Enrico Cuccia, che pure ci starebbe. Ma proprio la cuccia del cane ai margini della “proprietà” di famiglia, un’azienda biologica vinicola ed agricola di 136 ettari a #Capalbio, nella Maremma toscana. Proprio Capalbio, luogo simbolo della superiorità morale delle élite di sinistra. Degli aperitivi a chilometro zero, ci mancherebbe. Delle chiacchiere relative agli “happy few” al calar del sole tra mare e vigne, “delle lune dolci e amici mediocri”, avrebbe detto Mastro Gesualdo Bufalino.
In quella cuccia il 21 agosto 2021 sono stati ritrovati per caso 24 mila euro, abbandonati da chissà chi e non si sa per quale ragione. Un rinvenimento insolito da parte dei lavoranti della CapalBIOfattoria – certo non sarà stato il cane ad accantonare 48 banconote da 500 euro ciascuna – con richiesta di intervento e indagini da parte delle forze dell’ordine.
Preoccupatissimi i proprietari della tenuta, Monica Cirinnà e suo marito Esterino Montino, già senatore del Pd e attuale sindaco di Fiumicino, definiti da Tommaso Labate sul Corriere: “due calibri pesantissimi del progressismo capitolino comunista prima e post-comunista dopo”. Comunque una coppia da lungo tempo votata a dare risposte democratiche ai bisogni della gente. Una vita da coniugi dove il personale si intreccia col politico. Una coppia che, nonostante il timore di trovarsi malacarne “ai margini della proprietà, in un luogo non visibile dall’abitazione” o anche solo spacciatori in transito per la Maremma, davanti agli accadimenti si ritrova a incassare striminzite solidarietà da parte dei compagni di partito e battute “fuori dal seminato” sui social. Addirittura l’azzardo del confronto tra i 24 mila euro trovati nella loro cuccia e i più famosi 24 mila baci della coppia Adriano Celentano – Claudia Mori.
Poveretti, è il caso di dire. Ritrovarsi protagonisti di un intrigo. Che Monica Cirinnà ha contribuito a ingigantire con le sue stesse dichiarazioni, creando un nuovo hashtag nazionalpopolare: #colf. Che lei chiama senza remore: “cameriera”.
Il cronista Labate registra e pubblica il Cirinnà pensiero: “Ero già nei pasticci di mio, nelle ultime settimane. Nei pochi giorni di ferie, cinque per la precisione, sto facendo la lavandaia, l’ortolana, la cuoca. Tutto questo perché la nostra cameriera, strapagata e messa in regola con tutti i contributi Inps, ci ha lasciati da un momento all’altro. Volete sapere il motivo? Mi ha telefonato un pomeriggio e mi ha detto, di punto in bianco: “Me ne vado perché mi annoio a stare sola col cane”.
E per spiegare al lettore del quotidiano le distanze tra la cuccia e l’abitazione, Cirinnà prende come esempio il Senato, il suo luogo di lavoro. “Faccia conto – dice la senatrice al giornalista – che la casa sta alla buvette come la cuccia al bar di Sant’Eustachio”. Bar tra i più fighi di Roma, che, certo, paga i contributi di legge ai dipendenti.
Ecco, le parole della Cirinnà biondeggiano dritte come spighe nel campo di grane del Pd. O per spiegarle c’è bisogno della maestria di un attor comico come Corrado Guzzanti che coi Canti dell’Olgiata, quartiere altoborghese della capitale, aveva intuito la tendenza di sistema già più di dieci anni fa? Nonsense ricchi di sottotesto da manuale di antropologia culturale. Strofe da citare a memoria: “Signora mia, la cameriera non mi fa l’argenteria. Però i contributi li ha voluti. Mica vanno a minuti”. Avete presente quando si dice: “Gauche caviar”?
E poi uno si chiede perché il Pd si trova a gestire un #caos elettorale tale che neppure Mao, che di comunismo se ne intendeva di certo, e per di più era quello di una volta, troverebbe la situazione eccellente.
Letta, che pure è stato presidente del Consiglio dei ministri fino all’agguato del #StaiserenoEnrico, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo con largo anticipo, nonostante la riduzione dei seggi, circa il 30 per cento dei parlamentari in meno, e nonostante la legge elettorale (approvata nel 2017, relatore il deputato Rosato, allora nel Pd) che non sembrerebbe aiutare questa volta i democratici.
Risultato: un campo di grane. Con antagonisti politici avvisati per tempo e in grado di preparare contromosse. Con territori e federazioni democratiche in rivolta. Tra sommersi e salvati, impresentabili e paracadutati in luoghi che ne avrebbero fatto volentieri a meno. Poi ci sono gli esclusi e i rinunciatari, perché basta farsi due conti per capire di non essere eletti.
La campagna elettorale, come la rivoluzione, non è un pranzo di gala. Per di più con un segretario che nel casting per il Parlamento si è dato una regola alla Sylvester Stallone nel film “Rocky Balboa”. Una cosa da pugili. Insindacabile da chiunque altro. Guardare tutti i possibili candidati diritto negli occhi per mettere in lista solo chi mostra “occhi di tigre”.
Pazienza se il phisique du role di Enrico Letta è assai distante da quello di uno Stallone qualunque. Ma perfino da quello dello zio Gianni, braccio destro di Berlusconi. Gianni Letta, il quale, come il Conte zio dei “Promessi sposi”, è imbattibile nell’arte machiavellica del simulare e dissimulare.
Nel falò delle verità brucia anche la percezione della realtà. Altro che coltivare “rancori che continuano a dominare i cicli politici del Partito democratico”, come denuncia l’ex segretario regionale del Pd in Sicilia, Fausto Raciti, un altro tra gli esclusi. Con un affondo sui cognomi d’arte. “Ultimo dei Mohicani – scrive Raciti – il partito mi ha permesso un percorso politico così bello senza che io venissi da una famiglia dal cognome o dal reddito importante”.
Ma torniamo alla Cirinnà, a cui è toccato un #collegio a lei non gradito. D’impulso, pensando di rinunciare alla corsa, ha dichiarato: “sono territori inidonei ai miei temi”.
Chissà, forse abitati da famiglie tradizionali che magari non avranno gradito di essere considerate “inidonee” dalla candidata progressista.
Il giorno dopo, però, la senatrice uscente ha corretto il tiro e ha twittato: “Accetto collegio difficile, come gladiatore. Non è ripensamento per interesse, è amore per la comunità. Tiro fuori gli occhi da tigre, ma lo faccio solo per loro. Combattere come l’ultimo dei gladiatori è l’unico modo per non sottrarmi alla battaglia”.
Poi, in un altro tweet: “Ho scelto la strada del coraggio. Correrò nel collegio difficilissimo che @pdnetwork ha scelto. Combatterò per ogni persona che si sente sola, invisibile, non riconosciuta”.
Chissà. Magari travolta dal redde rationem che agita le acque dem, avrà colto il suggerimento di Javier Marías, lo scrittore spagnolo di “Domani nella battaglia pensa a me”.
L’Ape Maio. L’insostenibile leggerezza della giovane ape protagonista dell’infanzia televisiva dei nostri figli che si fa soggetto politico. Con l’operoso insetto che vola nel simbolo accanto al nome del nuovo partito: Impegno civico. E sopra il cognome del ministro degli Esteri, Di Maio, a cui è riservato il corpo tipografico più grande.
Vola, vola verso l’alto, l’ape. Le alucce a formare un cuore, verso la meta contenuta in un logo rotondo più piccolo. Quasi una miniatura. Manco a farlo apposta in gergo viene chiamato “pulce”, proprio come l’insetto. La “pulce” è l’inserimento nel simbolo che verrà stampato sulla scheda elettorale dell’emblema di un partito già esistente. Un partito già esentato per legge dalla raccolta delle firme. Che, come è noto, assieme alle molte incombenze burocratiche, deve essere attuata almeno un mese prima delle elezioni, quest’anno fissate il 25 settembre. Quindi nel bel mezzo di agosto. Un problema per soggetti politici nuovi e talvolta molto piccoli.
La pulce dell’Ape Maio è il Centro Democratico, la formazione fondata dieci anni fa da Bruno Tabacci, nocchiero elettorale di lungo corso. Uno che ha studiato all’università democristiana della prima Repubblica. Non a caso la sigla CD è speculare a DC, il fulcro della vita politica italiana dal dopoguerra al 1993, quando il processo iniziato con Mani pulite ne decretò la fine invero ingloriosa.
Vola, vola, vola, dunque, l’Ape Maio, giallo verde, giallo rosso, tanto gaio. Chissà quanto il ministro degli Esteri del governo dei migliori (ma anche di quello precedente, Conte bis) abbia puntato sull’assonanza con uno dei cartoon più amati dai bambini di mezzo mondo. Un cartone animato che di certo anche lui, classe 1986, avrà visto da piccolo.
Ma non si può pensare di ridurre a un fumetto la vicenda politica di Luigi Di Maio da Pomigliano d’Arco, comune a vocazione industriale della cintura di Napoli. Ai posteri l’ardua sentenza. Se fu o sarà vera gloria. Hic et nunc, in un paese senza memoria come l’Italia, basta e avanza per presentare il conto.
Da venditore di bibite allo Stadio San Paolo di Napoli, a tecnico informatico, a webmaster, il contrappasso per uno che rivendica di avere lavorato sempre e che oggi dice di non valere uno, è che le sue attività, le sue dichiarazioni, il suo agire, coincidono con gli anni della riproducibilità digitale. Hanno attraversato la linea d’ombra degli archivi e delle teche, implacabili testimonianze di ciò che è stato.
Possiamo dunque venire a capo della favola bella del bel giovanotto che incarna “The Italian Dream”. Cioè, come diventare qualcuno partendo da zero.
Di Maio inizia presentandosi nel 2010 alle comunali del suo paese. Prende 59 voti e non viene eletto. Nel 2013, però, imbrocca le “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle di Grillo in vista delle elezioni politiche. Raccoglie 189 preferenze online. Viene candidato, eletto, e diventa il più giovane vicepresidente della Camera della storia della Repubblica e uno dei volti più noti del Movimento, la casa madre, appunto, dell’uno vale uno, del non più di due mandati in Parlamento, del vincolo di mandato invocato dallo stesso Giggino per contrastare, anche attraverso risarcimenti, cambi di casacca elettorale in corso d’opera.
Casa madre che “o’ministro” abbandona il 21 giugno scorso. Portandosi dietro più di sessanta tra deputati e senatori confluiti in un gruppo parlamentare creato apposta per l’occasione: Insieme per il futuro. Una scissione da fare impallidire quella di Saragat ai tempi di Palazzo Barberini, nonostante le malelingue abbiano subito malignato sul futuro in questione. Il futuro dei congiunti o quello dei congiuntivi? Entrambi grani dolorosi nella corona di Luigi Di Maio.
Sui “Pomigliano boys”, il cerchio vesuviano di amici, conoscenti e compagni di scuola di Giggino assunti dallo Stato e assurti a prestigiosi e assai pagati incarichi non mancano le testimonianze. Nella tradizione sintetizzata da Longanesi: “In Italia tutti tengono famiglia”.
Sull’uso della lingua italiana e sulla cultura generale del nostro ministro degli Esteri, basta lui. Ha creato da solo, da autentico self made man, uno zibaldone di spessore.
Bisogna capirlo. Uno dedito per quindici mesi di fila a sbrigare allo stesso tempo gli affari che competono al vicepresidente del Consiglio, quelli di pertinenza del ministro dello Sviluppo economico e pure quelli che riguardano il ministro del Lavoro e delle Politiche sociale, dove lo trova il tempo per applicarsi alla geografia e alla storia che ormai manco a scuola si studiano più? Beirut, dove si trova? Area Mena, ok. Ma in Africa o Medio Oriente?
E Pinochet. Chi era costui? Instaurò un regime dittatoriale in Sud America. Che è un continente vasto. Almeno dal Venezuela al Cile. E anche oltre. Perché sottilizzare?
Il meglio di sé lo ha dato agli Esteri nell’esercizio delle sue funzioni. O, forse, finzioni. Era il novembre 2018 quando, neo ministro degli Affari esteri, Luigi di Maio, da sempre innamorato della via della Seta, si recò in Cina in visita ufficiale e chiamò “Ping” il presidente cinese Jinping. Forse un’affettuosa abbreviazione del nome come si usa nei bar di Roma.
Poi, vabbè essere atlantista, europeista, allineato al suo presidente del Consiglio preferito che è Draghi e non il pentastellato Conte, di cui è stato vice. Ma andare in tv a dire che Putin è “peggio di un animale”, non è esattamente quello che ci si aspetta dal capo di una diplomazia occidentale. Se poi aggiunge “atroce” invece di “feroce”, pure i russi se ne accorgono e dicono agli italiani che il ruolo del ministro degli Esteri non è quello di andare in giro per il mondo ad assaggiare cibi esotici ai pranzi di gala.
Loro poi hanno Sergej Lavrov, il numero due del Cremlino, che è ministro degli Esteri ma anche diplomatico di carriera. Verrebbe da dire con Sciascia: “A ciascuno il suo”. Ma oggi è un azzardo. Si finisce dritti dritti nelle fila dei putiniani d’Italia.
Il fatto è che il giovane e simpatico Di Maio ha presentato al severo Lavrov un piano di pace approntato dalla Farnesina. Sembra che in Russia si siano messi a ridere. E ce lo hanno fatto sapere. Specificando: “per il livello di comprensione che gli autori di questa iniziativa hanno della situazione, per la loro conoscenza dell’argomento, per la storia di questa questione”.
Dopo aver definito il piano della Farnesina “non serio”, Lavrov ha aggiunto che “chi si augura la sconfitta della Russia non conosce la storia”. Ovviamente, nessuna correlazione con Di Maio. Anzi. Draghi durante la sua ultima conferenza stampa ha ribadito che “finora l’Italia ha avuto credibilità internazionale”.
Non abbiamo motivo di dubitarne. Di Maio è uomo d’onore. Come Bruto nel “Giulio Cesare” di Shakespeare. Se solo volesse e sapesse, potrebbe essere protagonista di un discorso sul modello di quello pronunciato da Marco Antonio in memoria di Cesare.
E’ uomo di lotta e di governo. Poco prima di diventare vicepresidente del Consiglio chiedeva l’impeachment del capo dello Stato Sergio Mattarella a cui ora dedica odi “social” nel giorno del genetliaco. Poi, sempre nel 2018, affacciandosi dal balcone di Palazzo Chigi annunciava l’abolizione della povertà per decreto. Festante e inquietante. In quel che resta della memoria collettiva del paese, i balconi dei palazzi del potere a Roma sono forieri di grandi sfortune per gli italiani. Infatti la povertà è aumentata a dismisura. Ma Giggino non poteva sapere allora che si era alla vigilia della grande crisi causata dalla pandemia e, poi, dalla guerra d’Ucraina e da un’infinita serie di emergenze che si preparano sotto i nostri occhi, dal vaiolo delle scimmie all’emergenza climatica. Emergenze da lui sposate in pieno.
Nel tenere a battesimo il nuovissimo partito Impegno civico all’inizio di agosto al Foro Italico a Roma, in un tripudio di Ledwalls e musica a tutto volume, brani come “We can be heroes, just for one day” di David Bowie, Luigi Di Maio ha specificato che la piccola ape svolazzante nel simbolo è l’emblema “della nostra coscienza ecologica, del nostro mettere al centro la transizione ecologica fondamentale nel Pnrr. Non risolveremo il problema quest’anno, ma dobbiamo portarlo all’attenzione dei prossimi tavoli internazionali”.
Nel frattempo, avendo scisso il Movimento 5 stelle, avendo creato un gruppo affollato di parlamentari alla scadenza del secondo mandato come lui, ma sarà un caso, avendo fondato un partito, Di Maio rivendica il diritto di tribuna e si candida assieme al Pd. Uno svolazzo non da poco per uno che nell’estate del 2019 dichiarava: “Mai col Pd, mai col partito di Bibbiano”, con riferimento al comune della Bassa Emiliana al centro dell’inchiesta “Angeli e Demoni” su affidi illeciti di bambini, rituali satanici e piacevolezze del genere.
Di Maio è uno che dice e si contraddice. D’altra parte solo i cretini non cambiano idea.
Lui che adesso è europeista ad oltranza voleva uscire dall’euro per tornare alla lira. O parlava di “taxi del mare” con riferimento alle Ong internazionali che operano nel Mediterraneo con i migranti.
Capita che talvolta si contraddica anche con la sintassi. Diventa ancora più simpatico, più al passo coi tempi, il sogno italiano di arrivare nonostante tutto.
Ecco, più che l’Ape Maio il nostro ministro degli Esteri ricorda un calabrone. Il mito del calabrone che vola nonostante tutto. Nonostante le leggi dell’aerodinamica e le equazioni della resistenza dell’aria sul volo degli insetti. La realtà dei fatti che contraddice le teorie elaborate dagli uomini. E ronza il calabrone. Facendo molto più rumore di un’ape.
Dai migliori il meglio. C’è un concetto antico come l’uomo che in linguistica è stato teorizzato come ipotesi di Sapir-Whorf. Secondo questa ipotesi il modo di esprimersi determina il modo di pensare. C’è una connessione diretta tra la lingua che si parla e la realtà che si percepisce. E viceversa. Fino all’incapacità individuale o collettiva, anche di un intero popolo, di sapere cogliere elementi della realtà perché mancano le parole per esprimerli. “I limiti del mio linguaggio indicano i limiti del mio mondo”, diceva Ludwig Wittgenstein, uno dei filosofi più autorevoli del Novecento.
Dopo avere messo le mani avanti con dotte premesse, desueto “introibo ad altare Dei”, confortiamoci con un florilegio di dichiarazioni del miglior governo che l’Italia abbia mai avuto, nonostante i tempi siano tra i peggiori.
Cominciamo dal migliore tra noi, il presidente del Consiglio di cui il paese non si può privare, secondo la versione di Mattarella che non ne ha accettato le dimissioni e lo ha rimandato alle Camere, da cui, peraltro, non era stato sfiduciato. Situazione surreale. Impossibile da spiegare agli italiani, giornaloni e addetti ai lavori a parte. Figuriamoci agli stranieri. Anche se, nel frattempo, tutti, dagli Stati Uniti, all’Ucraina fino alla Unione europea, dalla Chiesa ai sindacati, dai sindaci ai sanitari, hanno imbastito un cordone per salvare il soldato Draghi, “whatever it takes”. Di elezioni manco a parlarne. Un esercizio non particolarmente gradito al capo dello stato. Mica siamo come il resto dell’Occidente, noi.
Nonostante qualche sparuto seguace di Cossiga, rimasto ancorato al Britannia che incrociava le acque italiane trent’anni fa, Mario Draghi, che su quel panfilo si trovava a bordo, ha goduto sempre di una stampa che ha valorizzato il suo curriculum “internazionale”. Per questo ha destato stupore il suo esordio in politica estera, appena nominato presidente del Consiglio da “tecnico di alto profilo”, secondo i desiderata di Mattarella.
Draghi, da uomo concreto come solo un banchiere può essere, definì Erdogan “per quello che è, cioè un dittatore”. Col risultato di provocare il peggiore incidente diplomatico nella storia recente delle relazioni tra Roma e Ankara e di doverci mettere precipitosamente una pezza sopra: “Dittatore sì, ma necessario. Ce n’è bisogno”. Adesso, dopo il placet della Turchia all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, dopo un breve tira e molla sulla pelle dei curdi, Erdogan e Draghi si definiscono “amici”. Un affiatamento scattato sulla capacità di voltarsi o meno dall’altra parte secondo destini imperscrutabili e altrettanto imperscrutabili alchimie morali.
Un po’ come: “Non ti vaccini, ti ammali, muori e fai morire gli altri”, pronunciato da un Draghi rigoroso di fronte alla pandemia dilagante. Non è andata proprio così. E chi sopra i cinquant’anni non è morto, dovrà pagare ammenda.
Pazienza se qualcuno è stato discriminato e ha perso il lavoro. “My body, my choice”, vale per il gender, l’aborto e altri “diritti” spacciati per “civili” da una società non a caso definita liquida. “My body, my choice” non vale per l’inoculazione di Stato. Non in Italia.
Inoltre, vuoi mettere? Non c’è niente di meglio della vecchia, aurea regola del “divide et impera” per controllare un paese, una società. Spaccandola e fomentando discordia. Così i cittadini hanno altro a cui pensare.
Anche il super green pass – chissà perché “green”, poi – spacciato come “garanzia di non trovarsi tra persone contagiose”. Oppure, a proposito della guerra d’Ucraina e delle sanzioni alla Russia che sono cadute come tegole in capo a noi: “Preferite il condizionatore acceso in estate o la pace?”. Sul modello dello slogan: “Volete burro o cannoni” di mussoliniana memoria.
Semplifichiamo. E’ male ciò che è contrario agli interessi del paese. C’è qualcuno che si ricorda di queste frasette tanto elementari quanto banali nel frattempo che si chiede a Draghi di rimanere al suo posto, unico presidente del Consiglio possibile su milioni di italiani?
Dai migliori il meglio. Metti il ministro degli Esteri, Di Maio, angosciato dalle dimissioni del presidente del Consiglio e dalla possibilità di perdere la poltrona. Tanto da azzardare che Mosca brinda sulla testa di Draghi, manco fosse Giovanni il Battista offerto a Salomé. E riapre, Gigino Di Maio, una lunga diatriba con la diplomazia russa che, chiamata in causa, lo accusa papale papale di non avere idea del suo compito, di essere uno che intende il suo ruolo come un viaggio intorno al mondo per assaggiare cibi esotici ai pranzi di gala. Certo, lui qualche occasione gliela ha data. Non solo definendo Putin in tv “un animale atroce”, anche se voleva dire “feroce”. Ma anche localizzando Beirut in Libia, la vicenda di Pinochet in Venezuela, chiamando il presidente della Cina Ping, parlando della “millenaria tradizione democratica della Francia”. Cose così. Bagatelle che fanno curriculum.
Colonna portante di questi anni pandemici iniziati nell’inverno del 2020 è il ministro della Salute tanto malinconico da smentire il suo nome, Speranza. Lo zibaldone che lo riguarda è troppo lungo. E poi lo chiamano: “l’Innominabile”. Meglio limitarsi al libro che ha scritto nell’estate del 2020 per Feltrinelli, subito ritirato dopo la pubblicazione. Forse perché il titolo prospettava una storia mai avvenuta: “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”.
Il libro circola comunque sul web. A cifre stratosferiche. Soprattutto circola una paginetta autobiografica in cui il ministro racconta “par lui-même” che da piccolo rubava aglio crudo per mangiarselo, per cui sua madre lo schiaffeggiava e lo rinchiudeva in una verandina. Dove lui passava il tempo a contare i corvi sul filo della luce all’esterno. Verandina dei desideri e dei suoi pensieri. Leggiamo che: “Un giorno, di ritorno da scuola, seduto accanto a una bella ragazza, tentai il mio approccio. Se vuoi possiamo andare in verandina a guardare i corvi, ci chiudiamo dentro, li osserviamo, li ascoltiamo cantare”.
Il ministro ci delizia con la risposta della ragazza: “Ma tu si’ scemo assaie”. La poveretta non aveva intuito le magnifiche sorti dell’uomo a cui è affidata la salute degli italiani al tempo della pandemia. Sono già più di trenta mesi.
C’è poi la pubblica Istruzione, vero banco di prova di come un paese intende il suo futuro. Mattarella ha raccomandato agli studenti di “coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico”. Ma sommersa dalla burocrazia, gravata da lockdown, banchi a rotelle, mascherine puzzolenti fabbricate da Fca di Elkann-Agnelli, lezioni a distanza, professori sospesi, ragazzi ostracizzati, la scuola non reagisce neppure più.
Arriva il presidente del Consiglio a Sommacampagna in Veneto e si fa fotografare senza mascherina obbligatoria in mezzo a un gruppo di allievi e docenti imbavagliati. Nessuno dice nulla. Non una domanda. Non una richiesta. Con questo spirito critico il ministro ha buon gioco a dire che a scuola “la mascherina ha un valore educativo”. Educazione a che, esattamente, signor ministro Bianchi?
In molte scuole per misurare il distanziamento è stato chiesto agli studenti di munirsi di bastoni. Se il compagno si avvicina troppo, ecco impugnare il bastone per mantenere le distanze. De profundis per la creanza, prima ancora dell’istruzione.
Per le pari opportunità una citazione nello zibaldone del governo dei migliori lo merita la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, detta Zelig per capacità mimetica. Solo solo per la giustificazione data in parlamento al comportamento dell’agente in borghese filmato durante gli scontri a Roma lo scorso ottobre. L’agente infiltrato picchiava i manifestanti e, nella stessa giornata culminata con l’attacco alla sede della Cgil, li fomentava a ribaltare una camionetta delle forze dell’ordine. Spiegazione della ministra: “Stava verificando la resistenza al moto ondulatorio della camionetta assaltata”. Una lezione di fisica, insomma. Chapeau.
Tanto di cappello anche al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani che afferma con sicurezza che “il pianeta è progettato per tre miliardi di persone”. Lui che è un fisico saprà da chi, quando e perché. Ma se siamo troppi e ci sono in giro altri cinque miliardi “di parassiti”, non è detto che lui stia dalla parte giusta.
Lo zibaldone dei migliori è un racconto fantastico. “Una storia infinita” come nel best seller di Michael Ende, da cui ricavare uno, due tre, colossal.
Con un’avvertenza. “Il meglio è nemico del bene”. E’ la lezione di Voltaire incarnata da “Candido”, il protagonista del suo romanzo di viaggio e di formazione più celebre. Candido, lo studente che attraverso le avversità e i fallimenti guarisce dall’ossessione di perseguire la perfezione. “Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres?”, si chiede Candido nel capitolo VI. “Se questo è il migliore dei mondi possibili, gli altri come sono?”.
Controcanto. Letterario e non solo. Il Premio Strega 2022, forse il più ambito premio di narrativa in Italia, è stato vinto dal super favorito della vigilia, lo scrittore di Martina Franca, in provincia di Taranto, Mario Desiati. Il romanzo è “Spatriati”, pubblicato da Einaudi.
Un violento acquazzone ha funestato o – come scrive La Repubblica “baciato”, questione di punti di vista – la serata trasmessa in diretta tv su Raitre dal Ninfeo di Villa Giulia a Roma.
Gli invitati sono scappati rinunciando a tartine e bollicine, ma la conduttrice della serata Geppi Cucciari ha aperto l’ombrello imperterrita e ha continuato. Bravissima a portare a termine la serata con ironia. A dimostrazione che anche la mala sorte può diventare un’occasione. Per destrutturare un po’ perfino un mondo chiuso come quello dell’editoria italiana. Con un occhio all’attualità. “Hanno pignorato il pubblico?”, si è chiesta guardando i tavoli vuoti a Villa Giulia. E sul gesso che non riusciva a fare presa sulla lavagna bagnata per la conta dei voti: “Chi ha vinto l’appalto del gesso quest’anno?”. Altro che Mara Venier e Katia Ricciarelli che in una passata edizione, col tempo altrettanto inclemente, si erano messe a rimbrottare gli orchestrali in fuga sotto la pioggia. Premio speciale per la conduzione a Geppi Cucciari.
Andiamo allo scrittore vincitore Mario Desiati, di gran lunga il primo dei sette selezionati quest’anno. Desiati spiega sul palco il significato del titolo nel dialetto del suo paese: “Spatriato vuol dire fuori dalla patria. Intesa come modo di vivere della maggioranza. È un modo anche per insultare. E indicare una persona che non obbedisce alle regole generali. Gli spatriati sono gli irregolari”. E per sottolineare il concetto si presenta al pubblico con gli occhi impiastricciati di kajal, un collarino nero molto fetish, stile Damiano dei Maneskin, una coccarda arcobaleno Lgbtq+ nel taschino, un ventaglio rosa. Nel frattempo sullo schermo scorrono le immagini di un video introduttivo in cui lo scrittore pugliese indossa una maglietta con la scritta “Feminist”. Casomai qualcuno potesse pensare tra i frequentatori di premi letterari ci possano essere ancora uomini che si definiscano “maschilisti”.
Comunque sia, il successo narrativo di una generazione ultra quarantenne, ma che si dichiara “fluida, inquieta e libera” al paludato Premio Strega, manda in visibilio il mainstream. E già questo dovrebbe bastare a far capire il fossato che ormai separa i giornali dal popolo bue. O pecora. O anche capra, per dare a Sgarbi quel che è di Sgarbi.
La tromba, anzi il trombone, lo suona soprattutto Repubblica. “Vince l’inno agli irregolari, ai balordi, agli esiliati, a tutti coloro che hanno desiderato almeno una volta nella vita di cambiare casa e identità. Vince in uno Strega baciato da un acquazzone dopo giorni di caldo torrido romano”. Ohibò.
A noi che abbiamo studiato Semiologia nei formidabili anni Settanta torna in mente il contributo critico dello strutturalista francese Roland Barthes. Colui che più degli altri linguisti e saggisti dell’epoca indagò su “forme e significati dell’abbigliamento”, disseminando in tutta la sua opera osservazioni sul significato sociale del vestiario e del costume. In questo senso al Premio Strega 2022 ha vinto la divisa del “politicamente corretto”. Sotto mentite, coloratissime spoglie, si cela il nuovo orbace. Una pennellata “irregolare” sul conformismo culturale più becero e dilagante.
“La pressione sociale è molto pericolosa e bisogna raccontarla”, ha sottolineato Desiati sul palco dello Strega. Affermazione da condividere. Magari assumendo anche altri punti di vista. La pressione sociale del politicamente corretto che ingabbia la complessità del reale.
Chissà poi perché uno scrittore si debba conciare in quel modo e un premio letterario, che risale con sussiego e gloria al 1947 e all’idea della rinascita culturale dell’Italia del dopoguerra, si debba trasformare uno spettacolo di varietà.
Per completare tempora e mores mancava la bandiera dell’Ucraina. Fortuna che ha provveduto l’organizzazione a consegnare ai sette autori finalisti un riconoscimento speciale. Una scultura del giovane artista ucraino Taras Halaburda, allievo dell’Accademia di Belle Arti di Sassari, ispirata al mestiere di scrivere. Un’innovativa macchina da scrivere in bronzo con i tasti che riportano la scritta Premio Strega. Che, come è noto, prende il nome dal liquore Strega di Benevento prodotto dall’azienda Alberti, da sempre sponsor dell’iniziativa.
Ecco, il gesto più anticonformista che ha compiuto Desiati sul palco del Ninfeo di Villa Giulia è stato quello di non stappare, come da consolidata tradizione, la bottiglia di liquore Strega in diretta tv e di non assaggiarne neppure un sorso. “La berrò in Puglia – ha detto sul palco – in ricordo degli scrittori della mia terra”.
*Già caporedattore di Rai Mediterraneo
Una guerra per immagini. L’altra escalation in Ucraina
L’Ucraina per immagini. L’altra faccia del racconto di guerra. Mentre noi ci barcameniamo tra libertà condizionate per la pandemia e lo spegnere i condizionatori d’aria per spezzare le reni alla Russia. Come dire, “Delitto e castigo”, ma anche “Guerra e pace”, versione nostrana.
Prima foto. Il presidente dell’Ucraina Zelensky si fa ritrarre seduto su una passatoia decorata distesa sulle scale di marmo, presumibilmente nel suo palazzo a Kiev. Dietro, a schermare la finestra in controluce col drappeggio dei tendaggi, ci sono mucchi di sacchi di sabbia. Per ricordare che l’Ucraina è in guerra. Con la potenza dell’immagine che è “forma per eccellenza”. Rappresentazione della “verità di un momento che contraddice altre verità di altri momenti”, per dirla con Leonardo Sciascia.
Zelensky, il capo pensoso poggiato sulla mano, il braccio piegato sul ginocchio, è colto nell’atto di meditare. Forse sulle sorti del suo sventurato paese. Seduto su quelle scale a metà tra l’empireo del governo e l’eroica resistenza offerta dal popolo ucraino laggiù, fuori dall’uscio. Nelle città, nei villaggi, nei campi di grano, nelle verdi vallate, nelle steppe battute dal vento dell’Est.
Ma nella narrazione forma e contenuto devono stare in equilibrio, ancorate l’una all’altra. Pena lo scivolamento verso il ridicolo. Effetto virato. Luci da set. Per la sceneggiatura della tragedia che purtroppo, quella sì, è vera. Sulla pelle viva dei poveri cristi che abitano l’Ucraina.
A giudicare dai commenti sui social non si direbbe che la foto abbia riscosso consenso. Tranne giornali e politici che, chissà perché, abitano un altro piano della realtà. Gli italiani, già contrari in maggioranza all’invio delle armi in Ucraina, hanno messo a confronto la guerra nuda e cruda, la pietà per le vittime inermi, col formalismo di un set tanto sofisticato da sfiorare il trash. La caricatura della propaganda. Soprattutto dopo che è stata pubblicata anche la foto dei professionisti armati di microfoni, telecamera e macchina fotografica che riprendevano l’eroe della resistenza ucraina seduto sui gradini del palazzo presidenziale. Questa la “cabina di regia”, come si usa dire. Ma si può chiedere a un presidente, ex attore professionista, di rinunciare a una platea mondiale? Officiando dall’altare dello schermo? Che, poi, è il balcone del momento, il palcoscenico della società dello “spettacolo integrato” già intuito dal filosofo Guy Debord, protagonista del Maggio francese.
Così, tra foto e video, Zelensky ha rilasciato un’intervista in esclusiva all’Associated Press, la maggiore agenzia di stampa internazionale in lingua inglese con sede centrale a New York. Fondata nel 1846, l’agenzia americana sul sito si autocertifica come “the most trusted source of fast, accurate, unbiased news in all formats and the essential provider of the technology and services vital to the news business”. Cioé, “la migliore”, ci mancherebbe. L’agenzia ha un potenziale informativo enorme. Raggiunge 1700 giornali e 5000 emittenti radiotelevisive nel mondo. In Italia l’intervista a Zelensky viene ripresa dal Corriere della Sera col titolo: “Cerco pace coi russi nonostante le loro atrocità”.
Il presidente ucraino dichiara di non voler perdere le opportunità per una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia anche se “nessuno vuole negoziare con chi ha torturato la mia nazione”. Inoltre Zelensky dice che è “realistico” non prevedere una rapida soluzione della crisi.
Realistico e credibile. Per il continuo crescendo di parole e immagini. Per l’eccesso di guerra guerreggiata in tv. In video collegamento nei parlamenti, nelle istituzioni militari e civili di mezzo mondo, Italia compresa. Per il continuo rilancio di armamenti all’Ucraina e sanzioni alla Russia. Sempre di più, sempre più oltre. Perché “l’Europa siamo noi”. E ancora per la contestazione della via Crucis ideata da Papa Francesco, “mai porteremo la Croce con i russi”.
Putin, che coi suoi trascorsi non sembra proprio tipo da mettere fiori nei propri cannoni, ha risposto a stretto giro di posta. Ha colto l’occasione della conferenza stampa con l’alleato presidente bielorusso Lukashenko per confermare: “Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco. L’operazione militare speciale della Russia in Ucraina andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili”. “En attendant Godot”, avrebbe detto Beckett nel teatro dell’assurdo del secolo scorso. Godot che non arriva mai. Siamo alla vigile attesa intorno alla pace.
Seconda foto. L’Ansa, la prima agenzia di stampa in Italia, pubblica un lungo articolo dell’inviato in Ucraina sulle “stragi che scioccano il mondo”. Sul bilancio delle vittime civili di Bucha che si aggrava. “Sarebbero 360, compresi almeno 10 bambini, scrive la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmyla Denisova”. A corredo dell’orrore descritto, “eccidio anche a Makariv, una donna sgozzata dopo gli abusi”, l’Ansa pubblica la foto di una strada fangosa con un manichino femminile fatto a pezzi e abbandonato sui bordi.
Che poi uno si domanda se nelle redazioni guardano quello che pubblicano. Perché il contrasto tra parole e immagine è stridente. Con la seconda a contraddire, quasi a irridere, le prime. Per la cronaca, ci hanno messo in giorno per sostituire la foto con quella della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita a Bucha.
Certo, vengono in mente letture antiche. Antoine de Saint-Exupéry, aviatore, scrittore e giornalista francese, precipitato nel deserto libico e rimasto illeso, col suo “piccolo principe” che appare inaspettato e dice al superstite: “Non bisogna imparare a scrivere, ma a vedere. Scrivere è una conseguenza”. Il monito di Eschilo, il primo dei tragici greci patrimonio della cultura occidentale. “La verità è la prima vittima della guerra” avverte sulla scena il poeta che, nel rievocare la battaglia di Salamina, narra la disfatta dei persiani dalla parte dei vinti. Non poteva immaginare cosa sarebbe successo 2500 anni dopo causa infodemia. Con la menzogna moltiplicata in modo esponenziale dalle tre www della nostra esistenza. E si potrebbe oggi dire della stampa che “è il Word Wide Web, bellezza”.
Non poteva immaginare, Eschilo, l’invenzione della fotografia. Il potenziale dell’immagine a sostegno delle idee. Il suo primato sulla parola. Un’arte in cui gli americani furono subito maestri.
Terza foto. Robert Capa, fotoreporter “embedded” tra le fila delle truppe alleate durante lo sbarco in Sicilia nel luglio del ’43. Nelle campagne siciliane riarse Capa realizzò una delle sue foto più famose, quella del pastore vecchio e malvestito che indica con il bastone la strada a un giovane, aitante soldato americano.
Propaganda per immagini. Perché l’americano in quel momento era il nemico. E invece “sappiamo che sta indicandogli la strada giusta”, puntualizza Sciascia che della fotografia fu un appassionato. E spiega che il pastore nel soldato vede “il paesano, l’amico, il parente ricco comandato dal suo buon presidente a venire in Sicilia a fare una buona e giusta guerra”.
https://www.youtube.com/watch?v=2SrllVPkzhQ
Il suicidio dell’Occidente. Antologia della crisi ucraina
“Sentinella, quanto manca all’alba?”. Il grido del soldato squarcia la notte dell’Occidente. E’ la visione apocalittica della caduta di Babilonia anticipata dal profeta Isaia. “La distruzione completa verrà da una terra orribile, come un turbine di vento che si scatena nel deserto. Attacca battaglia. Assedia città. Il perfido agisce con perfidia. Il devastatore devasta. Quel che ho sentito mi ha sconvolto. Quel che ho visto mi ha atterrito. Metti sentinelle di guardia”. Nell’attesa che ciò che deve avvenire si compia, le due sentinelle del libro di Isaia si scambiano nelle tenebre la parola d’ordine: “Quanto manca ancora all’alba?”.
E’ il suicidio dell’Occidente. Il tema del momento. Una serie infinita di scritti. L’ultimo è di Federico Rampini, un saggio appena pubblicato: “Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori”. Un titolo che spiega già tutto.
Perché “Il tramonto dell’Occidente”, annunciato cento anni fa dal filosofo tedesco Oswald Spengler, come in un lungo addio si è inabissato nella notte più nera. Come se non ci potesse essere una nuova alba. Ma solo desiderio di morte e di oblio. L’autocancellazione di questo Occidente incardinato nella storia, nella cultura e nei saperi, nel sistema di valori comuni all’Europa. L’Occidente all’orizzonte degli antichi greci, quello dell’impero romano propriamente detto, si intende. Non quello a traino Usa, a partire dalla Seconda guerra mondiale, che è altra storia, diversa e controversa. Una storia più recente, figlia del mito della frontiera e da sempre divisa tra due opposte pulsioni: il desiderio dell’American dream e l’imperioso: Yankee, go home.
Rampini sostiene che “se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati è perché eravamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico era stato preceduto per anni da un disarmo culturale”. In sintesi, l’ideologia dominante, quella delle élite che governano media, cultura di massa e spettacolo, hanno imposto di “demolire ogni autostima, colpevolizzarci, flagellarci”.
Tesi seducente. Per un giornalista assai produttivo e assai visibile in tv con le iconiche bretelle rosse, forse segno dell’antica militanza anche professionale nel Pci da lui stesso certificata nei risvolti di copertina di tanti libri scritti. Un impegno poi approdato nella grande stampa borghese: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 ore. Però, nella locandina di “Suicidio occidentale” Rampini, che ormai è naturalizzato americano, sorvola su un dettaglio. L’attacco al cuore dell’Europa era annunciato da anni. Ed era stato localizzato proprio in Ucraina.
Non solo per gli antichi rancori degli ucraini che avevano tastato le purghe di Stalin e lo spietato “holodomor”, la fame per la carestia indotta dalle politiche di Mosca negli anni Trenta. Ma che avevano ricambiato “accogliendo Hitler come un liberatore e facendo gravi torti agli ebrei”, come ricorda nelle sue pillole di storia Paolo Mieli, altro giornalista onnipresente in tv.
Sono i violenti accadimenti del 2014 a segnare il punto di rottura. La crisi definita “rivoluzione” dall’Occidente e “colpo di stato” dalla Russia. Con gli scontri di Euromaidan a Kiev, la messa in stato di accusa e la fuga dell’allora presidente Janukovyč considerato filorusso, il fuoco e le fiamme ad Odessa con le vittime inermi bruciate dai nazionalisti di estrema destra filoccidentali.
Fu quando la newyorkese Victoria Nuland era vicesegretario di Stato con delega sull’Ucraina. Il presidente Usa era Obama e il suo vice Biden. Nuland al telefono col suo concittadino ambasciatore a Kiev pronunciò la frase fatidica: “Fuck the EU”, a rimarcare l’intenzione degli Stati Uniti di tagliare fuori l’Unione Europea dalle possibili soluzioni per la crisi ucraina. E fu quando l’ex segretario di Stato e premio Nobel per la pace nel 1973, Henry Kissinger avvertì il mondo sul conflitto prossimo venturo: “Una saggia politica avrebbe dovuto cercare il modo di favorire l’intesa fra le due parti dell’Ucraina: quella nazionalista e quella russofona. Non il dominio di una fazione sull’altra. Spingere l’Ucraina a far parte della Nato condurrà necessariamente alla guerra”.
La stessa previsione di Giulietto Chiesa, giornalista anche lui. Uno che non avrebbe potuto essere più diverso da Kissinger. Uno che aveva fatto il corrispondente per vent’anni da Mosca per L’Unità e La Stampa, che parlava anche il russo e scriveva cronache sulla vita quotidiana dell’Urss così irriverenti e così divergenti da quelle inamidate dell’agenzia sovietica di Stato Tass da spingere quest’ultima a chiederne la rimozione. Rifiutata dall’allora segretario del Pci Enrico Berlinguer. Altri tempi, altro comunismo.
Chiesa, “eretico” per antonomasia, morto nel 2020, aveva definito la crisi ucraina del 2014 “l’inizio della terza guerra mondiale”. A suo giudizio: “Era evidente che l’Ucraina era già nelle mani degli Usa. Da parecchi anni. Stati Uniti e Canada avevano già preso in mano tutte le leve del potere: il governo e l’esercito”.
Sul finire della sua vita, però, fu considerato “complottista”. Comunque non allineato al dominante pensiero unico occidentale. I Berlinguer capaci di libertà di vedute non c’erano più sulla piazza Dem italiana. E neppure altrove. Quindi Giulietto Chiesa fu ostracizzato secondo i canoni ormai invalsi del “politicamente corretto”.
Ma il web è davvero una miniera di memoria. Sui fatti del 2014 in Ucraina chi cerca trova. Per esempio La Stampa degli Elkann il 22 maggio 2014 avverte già nel titolo: “Ucraina, se il nuovo corso filo-Occidente include l’ultradestra neo-Nazista”. E giù col delineare la figura dell’eroe nazionale Stepan Bandera. Che fu “leggendario combattente per l’indipendenza ucraina per i nazionalisti ucraini, ma collaboratore della Germania di Hitler durante la Seconda Guerra mondiale in funzione antisovietica. La sua organizzazione fascista OUN-B contribuì all’Olocausto facendo uccidere migliaia di ebrei e polacchi. Dopo la guerra si batteva per un’Europa totalitaria ed etnicamente pura”. Nello stesso articolo viene citata Victoria Nuland, la quale aveva dichiarato che Euromaidan “incorpora i principi e i valori che sono pietre miliari di ogni democrazia”.
Le perplessità de La Stampa erano quelle dei quotidiani di mezzo mondo. Aveva iniziato il Jerusalem Post nel dicembre 2013 a notare la componente antisemitica e neonazista delle proteste in Ucraina. Il Guardian il 22 gennaio 2014 aveva titolato “Ukraine protests are no longer just about Europe”, chiedendosi se ci potesse essere “an alternative to this senseless violence” dato che “l’estrema destra si è infiltrata in un movimento che non riflette tutto il popolo”. Il 28 gennaio il Time aveva segnalato: “La protesta di Kiev sequestrata da gruppi di estrema destra”. Il 19 febbraio l’International Business Times, il quarto sito più visitato al mondo tra i quotidiani economici, aveva scritto: “Euromaidan, le ombre oscure dell’estrema destra nelle proteste ucraine”.
Ma è un altro quotidiano economico, Il Sole 24 Ore, a tirare le somme della nostra rassegna stampa. Con due articoli pubblicati il 2 e 3 dicembre 2014. Nel primo, intitolato “L’Ucraina vara un governo con ministri stranieri (selezionati da cacciatori di teste)” si dà notizia del nuovo governo filoccidentale di Kiev che ha davanti “sfide straordinarie, una situazione economica molto difficile, l’aggressione russa, il bisogno di riforme radicali e la lotta alla corruzione”, come enunciato dal presidente Petro Poroshenko. Per cui la ricerca anche all’estero di candidati per il nuovo esecutivo. Infatti, – prosegue l’articolo – “il Parlamento ha approvato la nomina di un’americana, di un lituano e di un georgiano nella compagine governativa. Il ministro delle Finanze sarà la statunitense Natalia Jaresko, che è di origine ucraina, amministratore delegato di un fondo di investimenti del gruppo Horizon Capital. Il portafoglio dell’Economia andrà al banchiere lituano Aivaras Abromavicius, partner della società di investimenti East Capital, che ha lavorato in Ucraina negli ultimi anni, dopo avere ricoperto incarichi al Dipartimento di Stato americano. Infine alla Sanità andrà l’ex ministro georgiano Alexander Kvitashvili”. Ovviamente Poroshenko ha concesso loro “a tamburo battente la cittadinanza ucraina”. Così come ha promesso di concederla agli stranieri che combattono nel sud-est del Paese “al fianco delle truppe di Kiev contro gli aggressori russi”.
Leggiamo che “la scelta dei candidati stranieri per il nuovo esecutivo ucraino è stata seguita da due società di selezione del personale, Pedersen & Partners e Korn Ferry, che hanno trovato 185 potenziali candidati tra gli stranieri presenti a Kiev e tra gli ucraini che lavorano all’estero, in Canada, Stati Uniti e Regno Unito”. Poi: “il processo di head hunting è stato sostenuto dalla Fondazione Renaissance, network globale di consulenza politica finanziato dal miliardario americano di origini ungheresi George Soros. Che avrebbe pagato più di 80mila dollari per sostenere le due società coinvolte nella selezione del personale”.
Il Sole 24 Ore torna sull’argomento il giorno dopo, il 3 dicembre 2014 con un articolo dal titolo: “Se Soros e la finanza scelgono il governo dell’Ucraina”. In cui si dà atto delle proteste del Cremlino per le ingerenze della Ue nella crisi ucraina e delle accuse alla Nato di “destabilizzare i cieli del Nord Europa”. Mentre in occasione della Conferenza dell’Alleanza atlantica a Bruxelles, i ministri occidentali si dichiarano “preoccupati per i piani russi di ulteriore rafforzamento sul Mar Nero”.
Soros è definito dal quotidiano di Confindustria “guru mondiale dei mercati, oggi filantropo” e anche “promotore di un network di fondazioni a scopo benefico e culturale presente in 25 Paesi”. Perché Soros è un benefattore? Per il criterio utilizzato nella scelta del governo. Contano “le competenze, non la nazionalità”, sottolinea Il Sole 24 Ore.
Il giornale tiene a far sapere ai lettori che “non sono notizie da sito complottista”. Anzi, lo stesso Soros ha dichiarato alla Cnn “di avere contribuito a rovesciare il regime filorusso per creare le condizioni di una democrazia filoccidentale”. Né Soros è nuovo a questo genere di attività, come riporta Il Sole che riporta la Cnn in quel gioco di incastri e verifiche che spesso è giornalismo.
Il miliardario-filantropo ungherese naturalizzato americano ha finanziato il dissenso nell’Europa orientale, in Polonia e nella Repubblica Ceca al tempo della caduta del Muro di Berlino e della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Gli si chiede: “Sta facendo lo stesso in Ucraina?”. E lui di rimando: “Ho una fondazione in Ucraina da prima che l’Ucraina diventasse indipendente dalla Russia. Questa fondazione, sempre in attività, ha giocato un importante ruolo negli eventi di oggi”. Cioè del 2014.
Il Sole 24 Ore conclude il reportage con un’affermazione: “L’Ucraina è un caso di osmosi dei metodi della finanza applicati alla politica che trova proprio in un libro di Soros, L’alchimia della finanza, (Ponte delle Grazie, 1998) la sua teorizzazione”.
Almeno non possiamo dire che non sapevamo.
Tra Putin e la Rai. La parabola dell’opinionista Orsini
Non sei allineato sul fronte del “pensiero unico”? Diventi “pifferaio di Putin”. Colpito e affondato. Non importa se l‘analisi geopolitica è il tuo mestiere.
A essere impallinato stavolta è il soldato Orsini, nonostante un curriculum esemplare da professore e non solo, tre pagine fitte fitte pubblicate dalla sua università, la Luiss di Roma, dipartimento di Scienze Politiche.
Silurato, il sociologo e saggista Alessandro Orsini, sul campo di battaglia finora più vicino, la guerra in Ucraina già apparecchiata sul piccolo schermo. Era stato ingaggiato da Cartabianca, talk show di Bianca Berlinguer su RaiTre, per partecipare in studio a sei puntate, compenso circa duemila euro a trasmissione. Neppure tanto, al confronto di quanto è stato elargito ai virologi in due anni di epidemia che per la stessa cifra garantivano non più di dieci minuti di collegamento via Skype.
Ma le analisi del professore, “eretiche” rispetto alle strategie ufficiali adottate dall’Italia e dalla Ue nel conflitto Russia-Ucraina, hanno attirato su di lui non poche antipatie politiche, soprattutto dalle parti del Partito Democratico. Un crescendo dall’invasione russa dell’Ucraina in poi. Avrà tirato troppo la corda, il professore, con quella che lui stesso ha definito “contro-narrazione”, riversata a spiovere su giornali e tv? Il sistema dei media “embedded” nella cuccia del potere lo ha ricambiato con un crescendo di gogna, fino a inserirlo nel caravanserraglio del circo televisivo tra nani, pagliacci e ballerine. E perché mai la presidenza del consiglio dei ministri avrebbe molto più che raddoppiato i fondi destinati all’editoria negli ultimi due anni, sulla base del racconto della pandemia? Certo, ogni medaglia ha il suo rovescio. La narrazione a senso unico o, come si dice ora, mainstream sta dando la mazzata finale ai giornali che perdono copie e spettatori ogni giorno di più.
Ma per tornare alla parabola del soldato Orsini, la Rai ha rescisso il contratto, anche se il professore si è dichiarato disponibile a partecipare alle trasmissioni senza alcun compenso. Che poi fare di un “dissidente”, o pseudo tale, un martire della libertà è una sonora sciocchezza. Che manco i bambini delle elementari. Da analfabeti della politica e non solo. O da “grandi dittatori” alla Charlie Chaplin. Perché significa garantire alla vittima, o pseudo tale, un posto al sole a vita.
Aveva cominciato l’accademia, la lungimirante accademia d’Italia, a prendere le distanze sull’onda delle polemiche giornalistiche. La Luiss aveva ricordato al suo docente – fondatore e direttore presso la stessa prestigiosa università dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale e dell’omonimo giornale on line, “primo quotidiano in Italia dedicato alla politica internazionale” – che “chi ha responsabilità di centri d’eccellenza deve attenersi scrupolosamente al rigore scientifico dei fatti”.
Perché Orsini nelle sue uscite mediatiche ha sempre condannato l’invasione di Putin, si è schierato con l’Ucraina, e questo va bene. Ma, sapendone più degli altri, ha debordato. Forse colto, anche lui, dalla sindrome da primo della classe. E ha condito sempre l’analisi intorno agli attori con voce in capitolo nella crisi con il ruolo assunto dall’Unione Europea, mai toccato dall’informazione mainstream. Addirittura è arrivato a chiedersi in tv: “E’ possibile che la Ue sia un’organizzazione politicamente fallita?”
La reprimenda della Luiss contro Orsini cadeva negli stessi giorni in cui l’Università Bicocca di Milano, in preda a un attacco di “cancel culture”, aveva deciso di ostracizzare, in quanto russo, il sommo scrittore dell’Ottocento Dostoevskij. Che, poi, per ironia della sorte, si percepiva come un epigono di Gogol, ucraino di nascita. Proprio Dostoevskij che amava ripetere: “Siamo tutti usciti da Il cappotto di Gogol”, con riferimento a uno dei più bei “Racconti di Pietroburgo” scritti da Gogol.
A “Piazzapulita”, la trasmissione di Corrado Formigli su La7 che gli ha offerto campo televisivo subito dopo il diniego della Rai, il professore Orsini ha denunciato, più che gli attacchi diffamatori o irridenti, la censura delle idee, “una nuova forma di totalitarismo”. Dilagante. E poi: “Sono un uomo di sinistra. Schifato. Perché penso ai valori in cui ho creduto, agli ideali per cui mi sono battuto. E vedo parlamentari che mi vogliono censurare. Proprio quelli che sostengono di provenire dalla mia stessa storia”.
Già in un’altra occasione televisiva Alessandro Orsini aveva rilevato la notte della democrazia, propriamente della “democrazia liberale italiana”. Per la necessità di dovere anteporre “in premessa” affermazioni considerate “politicamente corrette”. Senza potere esprimere altrimenti un discorso sfaccettato come la realtà, articolato da più punti di vista, magari fuori dal coro. Una sorta di “introibo ad altare Dei” rituale. In cui senza soluzione di continuità la formula: “Premesso che sono vaccinato” è stata sostituita dalla nuova massima: “Premesso che condanno senza se e senza ma l’invasione russa dell’Ucraina”.
Chi non lo fa, e non lo ripete ogni volta, sempre, rischia di essere tacciato di putinismo. Che significa collaborazionismo col nemico dell’Ucraina e anche nostro, disfattismo, “viltà”, come ha detto Draghi in Parlamento. E magari non è mai neppure stato in Russia, pur avendo viaggiato per il mondo, come ha dichiarato Orsini.
In questo paese manicheo, di guelfi e ghibellini, chi non specifica in premessa diventa, suo malgrado, uno uscito dal cappottone di Putin, quello da 12mila euro che tanto ha scandalizzato i nostri autorevoli opinionisti per “la follia del capitalismo e l’interdipendenza del mercato globale”. Altro che “Il cappotto” di Gogol che almeno tramandava letteratura.
Con queste premesse, è il caso di dire, il professore Orsini è diventato capro espiatorio. E può essere che talvolta in tv risulti esuberante e stralunato come un Don Chisciotte che combatte contro i mulini al vento. Oppure, visto che non siamo in Spagna ma in Italia, contro i consolidati muri di gomma del potere.
Comunque sia, è diventato simbolo di tutti i putinisti d’Italia. Che non si sa quanti sono. L’identikit non è stato ancora tracciato. La “cabina di regia” non ha diramato le linee guida, le caratteristiche intrinseche, come è stato fatto con quegli ignoranti dei no wax, disoccupati e con disagio abitativo. Però i sondaggi più recenti dicono che solo il 33 per cento degli italiani è d’accordo con Draghi sull’invio di armi e aiuti militari alla resistenza ucraina. E neanche l’aumento della spesa militare al 2 per cento del Pil trova tutti concordi. Neppure in Parlamento. Dove si galleggia a colpi di fiducia.
Ma se gli studi di Orsini sono riportati anche sul sito del Governo italiano alla voce “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell’Italia”, si vede che almeno al tempo di Minniti era considerato un ricercatore affidabile. Uno pagato per pensare interrogarsi, capire e spiegare, cioè semplificare. Che sono attività desuete. Ma Orsini le ha fatte anche per gli Stati Uniti; “un paese che amo perché lì mi sono formato, il paese di cui vorrei imitare la mentalità”, dice. Specificando che gli Stati Uniti sanno pensare ai loro interessi, a salvaguardare la loro popolazione, a proteggere il loro territorio.
Orsini è Research Affiliate dal 2011 presso il prestigioso Mit, Massachusets Institute of Technology. Invitato di continuo a presentare i suoi studi nelle migliori università americane. Ma anche a Madrid, in Turchia, Francia, Inghilterra, Ungheria, Lituania.
I guai (o forse le fortune) arrivano quando il professore prova a fare sintesi anche nei patri studi tv. Scatenando controversie. Anche se lui riferisce fatti avvenuti e verificabili, mai raccontati in Italia. Basta guardare i video in rete.
Per esempio, sempre a “Piazzapulita”, giorni fa, Orsini ha esposto le più recenti operazioni Nato in Ucraina. “Tre gigantesche esercitazioni militari con scenari di guerra. La prima nel giugno 2021, chiamata Brezza marina, che ha coinvolto 32 Paesi. Hanno invitato anche l’Australia che tecnicamente non fa parte della Nato, ma è come se ne facesse parte. La seconda nel luglio 2021, chiamata Tre spade. La terza nel settembre 2021, chiamata Tridente rapido”. In più aggiunge che nel settembre 2021 Putin stava per sparare su navi Nato, e ha detto: “Fermatevi, state portando questa situazione a un punto di collasso”.
Si chiede, Orsini, in tv: “Dove era Ursula Von der Leyen quando succedeva questo?” La memoria ineffabile di internet conserva anche un’audizione del professore Orsini al Senato della Repubblica il 4 dicembre 2018.
Si parla anche della Georgia che ha una situazione geopolitica “speculare” all’Ucraina. Ma diventa un’altra storia. O forse un’altra guerra.
Sul teatro della guerra ciascuno recita la sua parte
A ciascuno la sua parte. Nella commedia dell’assurdo messa in scena a Montecitorio e altrove. Nonostante la tragedia che incombe. Nonostante si annunci una notte popolata di mostri in Europa. Perché una volta calato il sipario sull’atteso collegamento video del presidente ucraino Zelensky col parlamento italiano, sulla replica del presidente del consiglio Draghi e sui discorsi di circostanza dei padroni di casa, Fico e Casellati, resta solo il desencanto. Il disgusto di continuare ad assistere impotenti a una cattiva recita, a un ipocrita gioco delle parti che più che a Pirandello rimanda a Flaiano. Ancora una volta in Italia la situazione è grave. Sempre più grave. Ma non sembra seria.
Sarà per l’evento Zelensky subito trasformato in avvento dall’informazione mainstream: ecco a voi l’eroe del momento offerto sull’altare del piccolo schermo. Sarà per i troppi applausi dedicati a uno, il presidente dell’Ucraina, che chiede agli italiani di fare di più, ancora di più, sempre più oltre, per il suo paese in guerra, annunciando al contempo fame e sventura per tutti. Noi compresi.
Sarà per il migliore tra noi, il mai eletto Draghi che scandisce: “dobbiamo rispondere con aiuti anche militari alla resistenza ucraina”, armi a cui per la verità Zelensky non aveva fatto cenno. E ripete, super Mario, una frase già pronunciata che deve essergli piaciuta: “l’Italia non intende girarsi dall’altra parte davanti all’inciviltà”. Inciviltà dei russi, si intende. Sarà per la retorica che sommerge gli scranni quando Draghi ringrazia Zelensky: “dall’inizio della guerra l’Italia ha ammirato il coraggio, la determinazione, il patriottismo del presidente e dei cittadini ucraini”. Perché “la vostra resistenza è eroica; oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza”. Per questo, aggiunge, merita “l’Italia al fianco anche nel processo di ingresso nell’Unione Europea”.
Sarà pure perché, come sempre, l’ora delle decisioni irrevocabili è priva di informazioni ma ricca di suggestioni cosicché il discorso politico, logos per eccellenza, viene svuotato di contenuti razionali per suscitare solo emozioni. Anzi, per colpire alla pancia sul minimo comun denominatore dell’umanità residua. Il pathos intorno ai bambini, alle donne, ai profughi, perfino ai “fragili” come ha ricordato Draghi, mutuando l’espressione dal linguaggio della pandemia che nel frattempo persiste infrattata.
Comunque sia, i parlamentari italiani hanno applaudito a scena aperta alla guerra. E verrebbe da chiedersi chi tra coloro che ci rappresentano, e anche tra noi che li abbiamo votati, sapesse solo un mese fa cosa succedeva o fosse successo negli ultimi decenni tra i campi di grano dell’Ucraina, nelle verdi pianure che digradano verso la steppa o verso il mare; cosa avveniva o fosse avvenuto in città dai nomi così evocativi come Odessa o Mariupol.
Mariupol, appunto. Al centro delle attenzioni del ministro della Cultura Franceschini che giorni fa ha cinguettato appagato l’approvazione da parte del governo, su sua proposta, di mezzi e risorse per riedificare il teatro distrutto dalla guerra. Perché “i teatri appartengono a tutta l’umanità”.
Che poi chi vive a Palermo medita sulla “appartenenza” del ponte Corleone, imprescindibile per attraversare la città e a rischio crollo come il ponte Morandi a Genova. Di conseguenza riflette sulla attuale distanza siderale tra governati e governanti. Con questi ultimi che sempre di più sembrano simili a Maria Antonietta, l’ultima regina di Francia dell’ancien régime, la quale non appena informata del fatto che il popolo non aveva pane voleva sopperire con le brioche. La fine è nota.
Mariupol, “città martire”, di certo distrutta, ma i morti per fortuna sono meno di quelli attribuiti ai bombardamenti. Difficile capire in questo flusso continuo di bugie, mezze verità, disinformazione, ordinaria propaganda di guerra come siano andate davvero le cose da quelle parti. Mica siamo come gli inviati mai partiti dei giornaloni mainstream, i quali scrivono del conflitto Russia–Ucraina da casa loro in accordo coi loro direttori, come ha denunciato pubblicamente un giornalista d’altri tempi, il siciliano Nicola Lombardozzi che ha trascorso lunghi anni a Mosca come corrispondente del suo quotidiano. Poi uno si chiede perché si dice, appunto, “teatro” di guerra.
Mariupol, dunque, che Zelensky vuole ricostruire assieme a Franceschini “come tutto il Paese, fino all’ultimo mattone”. Magari per questo il presidente ucraino ha molto citato Mariupol durante il discorso alla Camera dei deputati. Con un paragone da brivido: Genova, anch’essa città porto, lo stesso numero di abitanti. E chiedendo agli italiani di immaginare Genova “distrutta, senza più niente, solo rovine, tutto bruciato”. Con le case abbandonate, le fosse comuni, i profughi in fuga, i vecchi, i bambini. Centodiciassette i bambini uccisi in un mese di guerra.
Un afflato emozionale che forse trae ispirazione dal mestiere di attore, il lavoro del presidente Zelensky fino a quattro anni fa. Come è noto, recitava la parte de “Il servo del popolo”, questo il titolo della serie tv, in cui uno sconosciuto professore di Kiev, in lotta contro la corruzione endemica nel suo paese, diventa presidente dell’Ucraina. Detto, fatto, corruzione a parte. Che neppure il filosofo Jean Baudrillard nel suo saggio “La Précession des simulacres” del 1978 avrebbe saputo spiegare meglio la teoria della precessione dei modelli, dei simulacri più veri del vero, della realtà uccisa dai media.
Se sopravvivremo, avremo modo di farci un’idea sulla fiction ideata dallo stesso Zelensky, adesso acquistata anche da un’emittente italiana e prossimamente in onda. Qualcosa si può già intuire sulle sue performance da attore comico smanettando sul web. Su Youtube si trova uno show satirico in cui l’attuale presidente dell’Ucraina si esibiva anni fa, facendo finta di suonare il piano con il pene per cinque minuti. E non si tratta di ridurlo ad un attore da avanspettacolo. Anzi.
Il successo televisivo del presidente per finta, del tutto digiuno di politica, il quale, diventa presidente per davvero proprio perché la sua interpretazione piace agli spettatori-elettori, spiega la speciale competenza di Zelensky per la guerra guerreggiata sullo schermo. Che è il medium che gli si addice, il balcone dove gli piace affacciarsi. Sempre in mimetica, metafora militare dell’impegno sul campo.
Altro che l’adunata di Putin allo stadio Luzhniki di Mosca, scenografia classica e, certo, trash della dittatura osannata dalla folla oceanica come ai tempi di Mussolini o di Pinochet. Con lo zar vestito di un cappottone di design italiano, costo 12mila euro, magari un messaggio anche questo di quanto abbiamo da perdere nel non vendere e non comprare dai russi. Comunque il prezzo, di certo non alla portata di tutti, ha destato stupore e meraviglia nei commentatori italiani. Perché né loro, né le loro mogli hanno mai varcato la soglia di un luxury brand, un tempo orgoglio del Made in Italy. Da non crederci. Come la reazione dell’azienda produttrice del cappottone che si è subito dissociata dal presidente-testimonial.
Zelensky, invece, non organizza adunate ma è sempre in video. Un mezzo a cui tutti ci siamo abituati dopo due anni di pandemia planetaria. L’elenco dei collegamenti è lunghissimo. Un video tour che comprende il Congresso degli Stati Uniti a Washington e il Parlamento canadese a Ottawa, Israele e il Regno Unito, più le istituzioni civili e militari di mezza Europa. Solo in Italia, Zelensky è al secondo video collegamento. Il primo a Firenze, con i pacifisti che lo acclamavano, bandiere arcobaleno e del PD garrule al vento, mentre chiedeva di istituire una no-fly zone sull’Ucraina, come dire, dichiarare apertamente la terza guerra mondiale. Richiesta non rinnovata davanti al Parlamento italiano. Sarà mica che siamo già in guerra ma non si dice?
In compenso Zelensky, ha chiesto ulteriori sanzioni per la Russia e, ripetutamente, di continuare a congelare i beni degli oligarchi russi. “Usano l’Italia come luogo per le vacanze”, ha detto. Per esperienza personale, come ha confermato lui stesso: “Ho visitato spesso l’Italia”. Sembra che anche lui abbia un villone in Versilia. Poi sui russi ha aggiunto: “Bisogna bloccarli, congelare immobili, conti, yacht”. In totale sintonia, il nostro super Mario ha risposto di avere già provveduto per 800 milioni di euro
Chissà poi perché i miliardari russi sono oligarchi “legati a Putin”, Draghi dixit. Mentre i miliardari degli Stati Uniti, paese di lobby dichiarate, sono benefattori dell’umanità per definizione.
“Bisogna sostenere l’embargo contro le navi russe” che entrano nei porti italiani e “non prevedere eccezioni per qualsiasi banca russa”, ha raccomandato Zelensky al nostro governo e al nostro parlamento. “L’obiettivo dei russi è l’Europa”, ha sottolineato. “Influenzare le vostre vite, controllare la politica e distruggere i vostri valori: democrazia, libertà, diritti dell’uomo. L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo. Loro vogliono entrare in Europa ma la barbarie non deve entrare”.
L’Ucraina porta d’Occidente, dunque. E anche della cristianità. Dal momento che Zelensky prima di collegarsi con Montecitorio aveva parlato al telefono con Papa Francesco, l’unico forse a potere riallacciare la diplomazia amputata dalle dichiarazioni su Putin di esponenti politici, capi di stato e di governo di metà Occidente. Ché mica possiamo dire a Putin “feroce”, “criminale di guerra”, “animale” e poi auspicare che metta dei fiori nei suoi cannoni. O puntare tutto sulla speranza che qualcuno lo faccia fuori a Mosca.
Ma “bisogna garantire la pace”, afferma Zelensky a Montecitorio. Il suo “popolo è divenuto esercito” contro l’invasore russo. Ma gli ucraini “non hanno mai voluto la guerra”. Affermazione apodittica. Senza mai nominare l’invasore Putin, convitato di pietra, Zelensky ha ricordato gli orrori della guerra “commessi l’ultima volta in Ucraina dai nazisti”. Storia assai controversa.
Secondo Paolo Mieli: “Una delle cose che hanno lasciato un segno nei rapporti tra Ucraina e Russia è come gli ucraini accolsero Hitler e il suo esercito. Come dei liberatori”. Sarà stato il risentimento per le purghe staliniane o per la carestia indotta dalle politiche di Mosca, il cosiddetto “holodomor” degli anni Trenta, “ma molti ucraini si allearono con i nazisti – scrive Mieli – facendo anche gravi torti agli ebrei”. Senza contare l’eroe nazionalista Stepan Bandera, odiato dalla componente russofona dell’Ucraina e, soprattutto, il famigerato battaglione neonazista Azov, che è un reparto militare ucraino a tutti gli effetti, schierato in prima linea nella difesa di Mariupol.
Ma bisogna fermare l’innominabile invasore, “fermare una sola persona affinché possano sopravvivere in milioni”, conclude Zelensky. “Gloria all’Ucraina e grazie all’Italia”.
I deputati e senatori presenti nell’emiciclo di Montecitorio, non tutti, ma il governo è al completo, scattano in piedi e tributano la lunga ovazione. Alcuni indossano spille o mise con i colori della bandiera ucraina in omaggio all’occasione insolita. Zelensky è il terzo capo di stato straniero a parlare a Montecitorio. Prima di lui solo il re di Spagna Juan Carlos, nato a Roma, e papa Wojtyla che stava in Vaticano, dentro Roma.
Le parole della guerra. C’è del metodo in questa follia
Amleto e il discorso sulla guerra. Parole buone per tutte le stagioni. Il glossario dell’emergenza che in Italia è tempo sospeso sine die. E poiché la lingua che si parla influenza la realtà che si percepisce, verrebbe da chiedersi come Polonio, ciambellano di corte, se “c’è del metodo in questa follia”. La callida, enigmatica follia che il principe Amleto di Shakespeare mette in scena per trovare la verità sulla morte del padre nel marcio regno di Danimarca.
“Though this be madness, yet there is method in’t”. Il metodo dell’assuefazione. Perché sarà anche vero che le disgrazie non vengono mai da sole. Ma noi ci siamo trovati in un fiat (si potrebbe scrivere anche maiuscolo, Fiat) a soppiantare l’emergenza sanitaria contro il virus, nemico invisibile, con l’emergenza di una guerra guerreggiata sul fronte orientale d’Europa.
Però è rimasta tale e quale l’infodemia, che è caos, banalizzazione, entropia dell’informazione. Un accumularsi di elementi superflui che diventano impedimento alla comprensione del messaggio. Maggiore è l’entropia, minore è la quantità di informazione che “passa”. Figuriamoci in Italia, dove – dati Ocse alla mano – siamo in prima fila nel “gran teatro del mundo” per numero di analfabeti funzionali.
Fuori i virologi dagli studi televisivi dove erano stati arruolati e avevano combattuto la loro battaglia per due anni di seguito. Dentro gli esegeti della geopolitica globale. Con le stesse regole di ingaggio, la stessa narrazione martellante, le stesse parole di guerra, gravide di paura, emotività e sensazionalismi, gli stessi dibattiti logori e logoranti. Sarà che a scuola si è smesso di fare pure il riassunto, ma l’idea di argomentare seguendo un filo logico, magari scorretto, non abita più qui.
“À la guerre comme à la guerre”. Sul fronte del Coronavirus, per cominciare. Forse consapevoli, nel metodo, di quanto teorizzava Susan Sontag, filosofa e scrittrice statunitense, nel saggio “Malattia come metafora” del 1978. “Trattare una malattia come una guerra ci rende ubbidienti, docili e, in prospettiva, vittime designate”, scriveva Sontag. E aggiungeva che “i malati diventano le inevitabili perdite civili di un conflitto. Disumanizzati, perdono il loro diritto alla cittadinanza da sani per prendere il loro oneroso passaporto da malati”. Profetica Susan Sontag. Che sottolineava come la metafora del “guerriero che sconfigge il male” caricasse il cittadino di “responsabilità, aspettative e sensi di colpa individuali”.
Non importa se lo stesso concetto di salute pubblica è stato spaccato negli anni a colpi d’ascia, tagliando il possibile per inseguire il profitto, o più diplomaticamente la “razionalizzazione” perfino nei punti nascita. E trasformando gli stessi ospedali in aziende, “nomen omen”.
Il racconto univoco, l’irridere o colpevolizzare il pensiero “eretico”, senza fare e soprattutto senza farsi domande sulle responsabilità collettive legate alla sanità, sullo stesso rapporto tra individuo e società, sono chiavi per capire perché non è andato tutto bene. Coi media “embedded”, accucciati al tepore (pro tempore) dei contributi pubblici, più che raddoppiati in due anni di pandemia.
Ricordate? Ha compiuto due anni l’annuncio “andrà tutto bene”, con tanto di cuoricino incorniciato da un arcobaleno, a significare empatia, tolleranza, solidarietà, “restiamo umani”. Ma è subito naufragato non solo nella retorica ma in un colpo di tosse altrui al supermercato, in uno sguardo torvo per strada, incrociando la mascherina altrui sotto il naso, in un runner solitario scovato sulla battigia dagli elicotteri delle forze dell’ordine, in parole d’odio.
Vennero gli “untori” come ai tempi della peste ne “I promessi sposi” di Manzoni. All’inizio i più esposti alle aggressioni, non solo verbali, furono i cinesi, untori per principio, nel senso del luogo considerato – fino a prova contraria – di inizio epidemia. Poi, con l’arrivo dei salvifici vaccini, furono i reprobi all’inoculazione, gente da codice penale, colpevoli di tutto o quasi, zotici, zucconi, disadattati, disertori su cui “sparare coi cannoni, come fece il generale Bava Beccaris” o da “rinchiudere in campi di concentramento con annessi forni”.
C’è del metodo nell’autotutela del potere, nel “divide et impera”, il miglior espediente mai escogitato dall’autorità costituita, qualsiasi autorità, per governare un popolo fomentando la discordia interna e controllando il dissenso.
Fu il governo Conte a dover dichiarare guerra al virus, a fronteggiare il nemico capace di mimetizzarsi con strategie adeguate e misure d’eccezione: lockdown, coprifuoco, lasciapassare. Prima furono le autocertificazioni. Necessarie per andare a fare la spesa vicino a casa, come per gli spostamenti “autorizzati” dentro il territorio nazionale: ricongiungimenti familiari, lavoro, ritorno alla residenza abituale. Poi vennero lasciapassare più sofisticati, dotati di codice identificativo individuale in seguito all’adempimento alle misure sanitarie, non obbligatorie per legge ma di fatto sì. Permessi di lavoro, permessi per l’uso dei mezzi pubblici, permessi per le attività sociali, parrucchiere, partita al calcetto e panino al bar inclusi.
Giuseppi, l’avvocato del popolo, emanava decreti dal balcone di Palazzo Chigi o, in alternativa, da pulpiti televisivi. E la gente a orari stabiliti si affacciava sulla strada e intonava “Fratelli d’Italia”. Senza tentennamenti. Neppure alla strofa: “stringiamoci a coorte, siam pronti alla morte”, impegnativa dal punto di vista delle scelte.
Come in tutte le guerre si pose il problema dell’economia di guerra. Il primo a segnalarlo già nel marzo 2020 fu il commissario straordinario Arcuri. Il quale, infatti, un anno dopo venne sostituito dal plurimedagliato generale Figliuolo, sempre in mimetica, iconica metafora militare nella battaglia contro il virus.
Fu una delle prime investiture del governo Draghi, appena nominato. Chi meglio di un banchiere per gestire il Piano nazionale di ripresa e resilienza, un pacchetto da 750 miliardi di euro concordato con la Ue e inserito nel programma Next Generation? Un banchiere e un militare. Per centrare gli obiettivi.
Vietato o quasi dissentire. Per dire, nel luglio 2021 un analista acuto e bene informato come Marcello Sorgi intervenne sul quotidiano “La Stampa” avvertendo i politici. “A mali estremi, estremi rimedi”, scrisse Sorgi, prefigurando l’ipotesi di un governo militare nel caso in cui i partiti (quel che resta) avessero messo i bastoni fra le ruote al banchiere, “giocandosi la fiducia dell’Europa”.
Che poi il migliore tra noi, in economia e finanza e non solo, si è rivelato essere un decisionista ardito. Una rarità in un paese di Don Abbondio. Un interventista, ben oltre le ambiguità del discorso politico. Altro che “garantire i valori della democrazia contrastando il gioco degli opposti estremismi concordi nell’intaccare le basi del sistema”, come soleva dire Aldo Moro.
Così, quando è arrivata la guerra vera in Ucraina, Draghi ha subito gettato il cuore oltre l’ostacolo. Ha risposto “all’appello del presidente Zelensky, che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall’aggressione russa”, e ha scandito nell’aula del Senato la decisione irrevocabile: “l’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. Così, in un sol colpo, Draghi ha riportato in auge parole rimosse durante la guerra al virus, oltrepassate dalla priorità data all’emergenza sanitaria. Ha posto l’accento su valori occidentali non negoziabili: libertà, democrazia, diritti. Altro che Diderot, Voltaire, Montesquieu. Ovviamente si tratta di diritto internazionale, cioè della libertà e della democrazia degli altri.
Ma eravamo avvezzi. Dopo due anni di torpore casalingo, di paure oscure nei confronti di un nemico infido e invisibile, svegliarsi sotto bombe autentiche, anche solo in tv, non ha spostato di una virgola la nostra percezione del mondo. Uguali i toni. Uguale il registro linguistico dei media. Propaganda? Di certo qualche smemorataggine di troppo sulla storia e la geografia degli ultimi decenni. Sarà vero che la scuola non è più quella di una volta.
Un maestro delle elementari come Sciascia avrebbe guardato, come sempre, al “contesto”. Partendo da quando l’Urss era ancora di sinistra e mandava aiuti ai paesi membri del Patto di Varsavia. Aiuti “fraterni”, venivano definiti. Che si concretizzavano in carri armati a Budapest o a Praga. Con il plauso del Partito comunista italiano, da Togliatti a Napolitano.
E avrebbe guardato alle bombe su Belgrado, su Baghdad, in Siria, in Libia. Che saranno state, in quanto occidentali, bombe di “precisione chirurgica” (metafora sanitaria), ma piovevano anche sugli ospedali. Tanto “intelligenti”, le bombe, che continuiamo a piangerne le conseguenze. Certo, non quanto le popolazioni civili interessate.
Ma se c’è metodo nella nostra follia, il primo è quello di credere di essersi svegliati una mattina e avere trovato l’invasore. Il secondo è quello di obbedire al capo dell’italica diplomazia, il ministro per gli Affari esteri Di Maio, che ha paragonato l’invasore a un cane, definendolo “atroce”, ma voleva dire “feroce”. Il terzo è quello di combattere per spezzare le reni alla Russia. Operazione che non è riuscita a Napoleone. Ma è caldeggiata da Letta, segretario del Pd, erede diretto del Pci.
Lui, nipote d’arte, già protagonista dell’hashtag #staiserenoEnrico, legittimo candidato al ruolo di segretario generale della Nato, per un ragionamento politico che scavalca pure l’interventismo di Draghi, è così convinto di “poter mettere in ginocchio la Russia” da dichiararlo. Sì, c’è del metodo in questa follia.
Colpa di Dostoevskij? Siamo nella lista dei paesi ostili
Sorpresa. Siamo nella black list di Putin. Una mattina ci siam svegliati e anche senza trovare l’invasore, almeno non ancora, abbiamo appreso che la Russia ci ha inserito tra i paesi ostili. Ma come mai? Come è potuto succedere?
Sgomento. Nel mentre che “l’Italia è pronta a sostenere un terzo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea alla Russia che dovrebbe ampliare la lista di banche e miliardari russi nel mirino, nel tentativo di spingere Mosca a un cessate il fuoco”. A dirlo è il nostro ministro degli Esteri in missione a New York, sottolineando che la Ue non cederà al “ricatto della Russia” sull’energia. Parla di Unione europea Di Maio, e non nota che il cancelliere tedesco Scholz sull’approvvigionamento energetico dalla Russia ha un’altra idea. Lo considera “essenziale”. Intanto, i nostri giornaloni, quelli finanziati direttamente con i fondi della presidenza del consiglio, contributi più che raddoppiati negli ultimi due anni, non cessano di stupirsi.
In fin dei conti il migliore tra noi, il presidente del consiglio, appunto, ha cominciato con l’affermare solo che “l’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. Che all’insegna dei “valori di libertà e democrazia” in Italia rappresentati al meglio, abbiamo “risposto all’appello del presidente Zelensky, il quale aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall’aggressione russa”. Poi il capo dell’italica diplomazia ha rincarato la dose. E’ andato ardito sul pulpito televisivo e ha paragonato Putin a un cane. Ha specificato: “atroce”, ma forse voleva dire: “feroce”. In fondo cosa abbiamo fatto?
La politica traccia il solco e il popolo lo difende. E’ un fatto di cultura, di identità. Fuori Dostoevskij, sommo scrittore della stagione migliore (quella sì) della letteratura russa. “Non dignum” l’autore di “Demoni” e “L’idiota” – romanzi che già per i titoli risultano di compiuta attualità – di essere studiato all’università Bicocca. A dimostrazione che l’enunciato latino “nomen omen” non sbaglia e che mai ci fu stirpe più razionale nell’uso della lingua degli antichi romani.
Quel genio di Dostoevskij, alieno all’era del comunismo russo e anche del postcomunismo, era uno fuori misura. Uno che mal si adattava pure al potere che vide e visse. Lo zar di tutte le Russie lo condannò a morte. Poi lo salvò dalla esecuzione quando già era pronto sul patibolo e gli commutò la pena capitale in quattro anni di lavori forzati in Siberia.
Già solo per questa esistenza da brivido, in preda ad astratti e concreti furori, Dostoevskij non meritava di essere ostracizzato come un putiniano qualunque. Riotta docet. Ma “à la guerre comme à la guerre” e Dostoevskij, morto nel 1881, è stato rimosso come alcuni artisti viventi costretti all’aut aut da sindaci, sovraintendenti e sovrastanti. “O con la Russia o con l’Occidente”, l’ora delle decisioni irrevocabili è scoccata.
Fino alla campagna contro i cittadini russi in Italia imbastita con violenza verbale di sicura efficacia, già collaudata e sperimentata sui reprobi al vaccino. Poi capita che avvengano episodi di intolleranza. Come, per esempio, quel liceale di Brescia aggredito e picchiato dai compagni perché russo. La stessa ambasciata di Mosca a Roma ha diffuso un messaggio: “Cari compatrioti, in riferimento all’aggravarsi della situazione internazionale e alla campagna di informazione antirussa lanciata sui media, il numero di casi di discriminazione nei confronti di cittadini russi all’estero è notevolmente aumentato. Per la risposta più tempestiva ed efficace a tali incidenti, l’Ambasciata russa in Italia ha messo a disposizione una linea dedicata. Se ricevete minacce o insulti, siete vittime di molestie, aggressioni o violenze fisiche, segnalate immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine italiane nonché a noi”.
Ma dato che è stato Putin ad aggredire l’Ucraina, e questo va detto con chiarezza e in premessa, in fin dei conti noi che abbiamo fatto?
Dalle sanzioni culturali a quelle economiche e finanziarie. Abbiamo disconnesso il sistema bancario russo, isolandolo dal sistema di pagamenti internazionali Swift. Mosca ha risposto che pagherà i creditori dei paesi ostili alla Russia in rubli. Nel frattempo grandi banche come Unicredit e Intesa San Paolo hanno qualche cruccio per i crediti concessi in Russia. Milioni di euro. In gran parte derivanti dalla vocazione tutta italiana al risparmio. Ma che sarà mai?
Nella caccia ai tesori di Mosca presenti sul territorio italiano “si è provveduto a congelare beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi per circa 140 milioni di euro”, ha detto il Ministero dell’Economia. Finora. In attesa di ulteriori sanzioni.
Severi ma giusti di fronte all’aggressione di uno stato sovrano come l’Ucraina. Che non possiamo comparare alle altre recenti aggressioni all’Iraq, alla Libia o alla Siria perché sarebbe un accostamento azzardato. Perfino complottista. E neppure alle bombe su Belgrado nel 1999 che dal cuore dell’Europa aprirono la stagione del “militarismo umanitario”.
Ma “the devil is in the details”, come dicono Oltremanica. Ricade sullo Stato italiano la manutenzione dei beni congelati ai russi. Per esempio residenze di lusso sulle colline toscane come Villa Lazzareschi nelle campagne di Lucca riconducibile all’oligarca Oleg Savchenko. E soprattutto costosissimi mega yacht, con tanto di rispettivi equipaggi. “Belle barche”, si sa, ormeggiate qua e là sulle coste italiane, specialmente in Liguria.
Come dire, “Il danno e la beffa”, narrativa che i contribuenti italiani conoscono al meglio. A menadito. Altro che “Delitto e castigo” di Dostoevskij. Un capitolo è dedicato ai rincari: gas, luce, petrolio. Tutto alle stelle e di buon auspicio per la tanto decantata ripresa. Forse, in fin dei conti ci siamo fatti pure male.
Certo, al momento quisquilie rispetto al sangue delle vittime innocenti, al dolore degli invisibili, alle bombe, al fango delle trincee in Ucraina.
“Nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra” rimarcò rivolto ai governanti e ai popoli Pio XII nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale. “Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo. Lasciando alla ragione il suo impero avranno risparmiato il sangue dei fratelli e alla patria rovine”.
Ecco, “il rispetto dei reciproci diritti”. Come è noto il venerabile servo di Dio, Papa Eugenio Pacelli non venne ascoltato.
Quell’informazione che sta dalla parte degli infedeli
Dalla parte degli infedeli. Giornalisticamente parlando, s’intende. Dalla parte di quelli che provano a smontare pezzetti del gioco delle parti, del mainstream imperante, pagato agli editori con fior di contributi pubblici. O pensate davvero che nel “gran teatro del mundo” la verità coincida con l’apparenza, la realtà con la narrazione della stessa?
Nelle redazioni la prima regola che si impara è quella di attaccare l’asino dove vuole il padrone. Altrimenti, dietro c’è posto. O fuori.
In tempi normali, e soprattutto in alcuni settori considerati non cruciali, spettacoli, cultura, esteri, c’è tolleranza di pensiero e di opinione. Anzi, è “colore”, come si dice in gergo, dà l’idea di voler mostrare all’occhio del mondo una realtà sfaccettata e composita. Come in effetti è.
In tempi straordinari come quelli che ci è dato vivere, “nell’ora più buia”, vietato celebrare perfino la memoria di Dostoevskij, superlativo scrittore della superba letteratura russa dell’Ottocento, autore di “Delitto e castigo”, “I fratelli Karamazov”, “L’idiota”, romanzo quest’ultimo assai citato al momento per via del titolo, solo quello, che rimanda all’attuale, indiscutibile prevalenza della categoria in oggetto.
Che poi, per ironia della sorte, Dostoevskij si percepiva come un epigono di Gogol, ucraino di nascita, autore dei “Racconti di Pietroburgo” e “Le anime morte”, altri capolavori della universale letteratura prodotta sotto gli zar. “Siamo tutti usciti da Il cappotto di Gogol”, amava dire Dostoevskij che citava nelle sue opere brani e personaggi del maestro. Per via di una vicenda collegata a Gogol, accusato dal filosofo Belinskij di essersi “venduto” allo zar, Dostoevskij fu arrestato, condannato a morte, l’esecuzione sospesa quando si trovava già sul patibolo, il castigo trasformato in quattro anni di lavori forzati in Siberia. E già questo fa capire lo sprezzo del ridicolo di cui bisogna essere armati per ostracizzare Dostoevskij.
Con l’aria che tira perfino su letterati patrimonio dell’umanità, immaginate che succede nelle redazioni inamidate dai finanziamenti della politica, che sono raddoppiati negli ultimi due anni sulla base di un’emergenza sanitaria da narrare alla maniera del governo, secondo regole non scritte ma intuibili.
Non siamo ancora al Minculpop ma ci avviciniamo. E se l’informazione prima non stava tanto bene, adesso è agonizzante sul pensiero unico, di certo non sintesi delle diverse visioni del mondo.
Come dire, la notizia è morta “di” covid o “per” il covid? Perché la pandemia è la causale dei contributi a pioggia sulle aziende editoriali. Tutte o quasi. Ma sul “Rapporto del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 2021”, non si specifica se a sostegno dell’emergenza sanitaria oppure per la sua campagna d’informazione.
E’ successo un po’ in tutta Europa. Solo in Italia, da quanto emerge dal rapporto, i finanziamenti pubblici sono passati da 175,6 milioni a 386,6 con un incremento del 120 per cento. A dirla tutta lo Stato spende molto più di quanto dichiara tra “sostegni diretti e indiretti, crediti d’imposta, iva agevolata” e quant’altro.
“Invadunt asinum ubi vult dominus” non significa, però, che l’asino con la cavezza stretta ragioni meglio. Ecco perché siamo stati condannati all’ascolto dell’assordante cicaleccio dei virologi per due anni, 24 ore al giorno, tutti i giorni. Fino alla nuova emergenza, il conflitto Russia-Ucraina. Quando in un baleno i virologi sono stati sostituiti da un nuovo stuolo di esperti, competenti in guerra e pace su scala globale. Con l’asino sempre legato al suo posto. E la cavezza messa in modo tale da indurlo a guardare a senso unico. Alla maniera metaforica degli asini.
La punta dell’iceberg è sempre la Rai. La balena dell’informazione italiana. Exemplum per eccellenza perché ha per editore il governo e il parlamento della Repubblica. Prendiamo il caso di Marc Innaro, onesto corrispondente di lungo corso. Ha cominciato proprio a Mosca e poi, passando per Gerusalemme e il Cairo, è tornato a Mosca. Un’affermazione: “Basta guardare la cartina geografica per capire che, negli ultimi trent’anni, chi si è allargato non è stata la Russia, ma la Nato”, è bastata a compromettere un’irreprensibile trentennale carriera.
Un putiferio. Un vortice di accuse di filo-putinismo al capo dell’ufficio di corrispondenza Rai a Mosca. La direttrice del Tg1 Monica Maggioni, quella che fu “embedded” tra le fila militari americane in Iraq, per sì e per no lo ha cancellato dal video. Con la scusa che da lì, cioè da Mosca, passava l’inviato del Tg1 Alessandro Cassieri con trascorsi da corrispondente in Russia. “Avendo il nostro inviato, è normale che ci colleghiamo con lui”, ha dichiarato Maggioni, prima che la Rai decidesse di ritirare tutti i giornalisti da Mosca.
I deputati del Pd hanno strillato in coro contro “la falsità palese” profferita da Innaro “ancor più per il momento drammatico che l’Ucraina sta vivendo” e sulle “interpretazioni compiacenti verso i crimini di Putin”. Il Partito Democratico? Proprio quello. Quello che a risalire l’albero genealogico è figlio del Pci, un tempo il più grande partito comunista d’Europa legato a doppio filo rosso con l’Urss, Napolitano docet e anche le reazioni ai carrarmati russi in Ungheria nel 1956 e a Praga nel ’68.
Ma la “Madre Russia” di Dostoevskij ha cessato da tempo di essere di sinistra. E il segretario del Pd Letta, un cognome una garanzia, si è talmente infastidito con Innaro da chiedere l’intervento della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, anche per garantire maggiore pluralismo e un ricambio generazionale.
Ricambio che non vale, sarà per cavalleria, per la meno giovane Giovanna Botteri, praticantato in Rai, un curriculum da inviata su tutti i fronti, corrispondente negli Stati Uniti dal 2007 dove ha assistito trionfante all’elezione di Obama e piangente a quella di Trump, quasi una sconfitta personale al di là di qualsiasi possibile previsione per una giornalista d’esperienza come lei.
Dopo Washington, la Cina e, adesso, Parigi. L’esperienza di guerra non le manca. E quindi giorni fa sul Tg3 – a proposito degli attacchi che Kiev subisce dalla Russia e della resistenza del popolo ucraino che costruisce molotov “fai da te” – Botteri si è attardata sul come si potenziano le bombe molotov, dettagli misconosciuti al grande pubblico.
“Un particolare tecnico è che il polistirolo nella molotov serve per rendere più forte l’effetto. Quando le bottiglie incendiarie vengono lanciate, diventa una specie di napalm, ancora più devastante”, Botteri dixit in tv. Nessuno nel teatrino della politica vi ha dato peso. Non più di tanto. Altro che commissione di Vigilanza Rai.
Per la serie televisiva: “Due pesi e due misure”, uno sceneggiato senza fine, ricordiamo il memorabile fuori onda sugli ucraini “camerieri, badanti e amanti” pronunciato da Lucia Annunziata & Antonio Di Bella, impagabile coppia del giornalismo italico. Giudizio che sarebbe già disdicevole e becero se profferito da due pivelli qualsiasi. Figuriamoci dal “sancta sanctorum” del pensiero corretto. In quanto tale, unico. Nessuno ha neppure pensato di spostarli dall’altare.
E da Lucia Annunziata, una lunga militanza extraparlamentare a sinistra del Pci, il pensiero corre a Gianni Riotta che con lei ha condiviso gli anni degli esordi al Manifesto. Anni formidabili, cronache dalle Americhe per un giornale di grande fascino intellettuale. Per loro, allora giovani squattrinati, imperitura fama.
Certo la vita cambia. E adesso a Gianni Riotta giorni fa su Repubblica, il giornale di John Elkann, gli viene di stilare “l’identikit dei putiniani d’Italia”, che si trovano dovunque, destra, sinistra, perfino tra i no green pass. Con annessa lista di proscrizione, che non si sa mai dove può finire e l’uso che se ne può fare.
Tra questi “Putinversteher”, come li chiama Riotta, c’è anche Barbara Spinelli, figlia di Altiero, padre fondatore del federalismo europeo concepito a Ventotene durante il confino nell’era fascista. Una che ha mangiato pane e Europa dalla nascita.
E in questo caos, che neppure Mao ci si raccapezzerebbe, solo loro, i nostri eroi amerikani, atlantisti e interventisti sul fronte orientale, non perdono il bandolo della matassa, certi della propria superiorità ideologica e intellettuale. Gauche caviar, al momento a corto di caviar.
Sono quelli che hanno selezionato la propria personale antologia della Spoon River dei giornalisti assassinati, tacitati per le loro idee, per le loro inchieste, per ciò che rappresentavano.
Un nome dimenticato è quello di Andrea Rocchelli, trent’anni, fotoreporter, assassinato nel 2014 assieme all’amico e collega Andrej Mironov, mentre raccoglievano immagini e notizie sui bombardamenti delle milizie ucraine contro le popolazioni civili del Donbass. Divennero bersaglio dei soldati della 95a Brigata aviotrasportata. Che li inseguirono a colpi di mortaio fino a ucciderli.
Anni di indagini e processi non sono bastati a fare giustizia. Solo grazie al documentario “La disciplina del silenzio” trasmesso lo scorso febbraio da Rainews24 e a poche altre voci eretiche come “Contropiano. Giornale comunista on line” i nomi di Andrea e Andrej non sono caduti nell’oblio. L’ufficiale responsabile del reparto che fece il tiro a segno sui reporter è oggi un deputato del parlamento ucraino.
Andrea Rocchelli nella sua breve vita aveva fondato un collettivo di fotografi indipendenti e lo aveva chiamato poeticamente Cesura. Nel suo cammino ha trovato censura.
Morire per Kiev? Draghi e le citazioni pericolose
Due anni di virologi in tv e sui social in un assordante cicaleccio h 24 ogni giorno tutti i giorni e poi, zac, il conflitto Russia-Ucraina. Emergenza scaccia emergenza. Via i virologi dagli studi televisivi, sostituiti in un attimo da uno stuolo di esperti in geopolitica globale, cremlinologi di nicchia, teorici dell’arte della guerra. Psicologi perfino, ché ce n’è bisogno.
Anche perché il presidente Biden si è appena espresso sul conflitto. Nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato al Congresso, ospite d’onore l’ambasciatrice dell’Ucraina in Usa Oksana Markarova, una festa di giallo e blu negli abiti di molte deputate americane, decise a sfoggiare i colori della bandiera ucraina, Biden ha affermato grave che Putin “può circondare Kiev con i tank, ma non avrà mai i cuori e l’anima del popolo ucraino”.
Il Commander in chief ha anche annunciato la chiusura dello spazio aereo americano ai voli russi, sull’esempio di quanto già fatto da Unione Europea e Canada. Poi, forse nella speranza di risalire nei sondaggi – la sua popolarità è ai minimi storici, ben sotto il 40 per cento – ha ricordato il suo impegno in prima persona per “costruire una coalizione di nazioni che amano la libertà, dall’Europa alle Americhe, dall’Asia all’Africa”.
Citata anche l’Italia. Per cui, tolta la mascherina, è consigliabile indossare l’elmetto. Pronti a combattere sul fronte orientale.
Elmetto che ha già messo, da par suo, il migliore tra noi, il presidente del consiglio che ha scandito in Senato: “L’Italia non intende voltarsi dall’altra parte”. Forte dei “valori di libertà e democrazia”, l’Italia al tempo di Draghi “ha risposto all’appello del presidente Zelensky che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall’aggressione russa”.
Oltre ai ringraziamenti di circostanza e a un omaggio, molto per inciso, a Alcide De Gasperi, padre della Repubblica, in più di mezz’ora di discorso Draghi ha citato soltanto “lo storico Robert Kagan”, per il quale “la giungla della storia è tornata, e le sue liane vogliono avvolgere il giardino di pace in cui eravamo convinti di abitare”. Poetico. Forse troppo per il cuore callido di un banchiere. Come una “voce dal sen fuggita, come se tra le righe l’inconscio venisse a galla, sempre supponendo che Mario Draghi abbia un Es oltre l’Ego.
Chi è, dunque, Robert Kagan? Politologo statunitense, grande sostenitore di Hillary Clinton, Kagan è un “liberal interventionist”, sempre a sostegno di scelte interventiste nella politica estera degli Stati Uniti.
Sua moglie è Victoria Jane Nuland, una lunga carriera ai piani alti del Foreign Office, una che nel 2014 si trovava in Ucraina nel tentativo di dirimere la crisi, per intenderci quella definita “rivoluzione” dall’Occidente e “colpo di stato” dalla Russia. Dopo scontri cruenti, dalla rivolta di Euromaidan a Kiev alla strage di Odessa per mano dei nazionalisti di estrema destra filoccidentali, la crisi portò alla fuga e alla messa in stato di accusa dell’allora presidente Viktor Janukovyč.
Nel febbraio 2014 qualcuno pubblicò una telefonata intorno all’Ucraina tra due alti diplomatici degli Stati Uniti: Victoria Nuland, appunto, allora vicesegretario di stato e l’ambasciatore a Kiev, Geoffrey Pyatt. Il file audio esiste ancora su YouTube, mai smentito dagli Usa che, anzi, accusarono la Russia per l’imbarazzante fuga di notizie. Perché nel corso della conversazione Victoria Nuland pronunciò la frase fatale: “Fuck the EU”, a rimarcare l’intenzione degli Stati Uniti di tralasciare l’Unione Europea nella ricerca di una soluzione alla crisi ucraina. L’intercettazione fece il giro del mondo, ripresa da tutti i giornali.
Tanto più che negli stessi giorni l’ex segretario di stato e premio Nobel per la pace nel 1973, Henry Kissinger si pronuncio più volte, con editoriali e interviste, in modo ben diverso rispetto alla soluzione della crisi sul fronte orientale dell’Europa: “Una saggia politica avrebbe dovuto cercare il modo di favorire l’intesa fra le due parti dell’Ucraina: quella nazionalista e quella russofona. Non il dominio di una fazione sull’altra. Spingere l’Ucraina a far parte della Nato condurrà necessariamente alla guerra”.
Con queste premesse, armiamoci e partite. Perché chi non conosce la storia è condannato a riviverla. E dovrà presto chiedersi se vale la pena morire per Kiev. Come poco più di ottanta anni fa, allo scoppio della seconda guerra mondiale, ci si domandò se valesse la pena morire per Danzica. (buttanissima.it)
L’Occidente muore. E i giornali non stanno tanto bene
“L’Occidente di preciso a che ora tramonta? E se è già tramontato, da quando esattamente?”. Dopo anni di sentir parlare del crepuscolo della civiltà occidentale, uno la domanda se la pone, senza essere la Pizia, oracolo di Delfi nell’antica Grecia.
E magari la vorrebbe anche fare al nostro esperto in tv, in studio h24, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Il quale si destreggia nell’interpretazione della geopolitica globale come fosse Tiresia, per restare nel mondo classico.
Che poi anche sulla data dello scoppio bisognerebbe mettersi d’accordo perché c’è chi ricorda gli scontri cruenti del 2014 a Kiev e dintorni, definiti “rivoluzione ucraina” dal punto di vista filoccidentale, “colpo di stato” secondo i russi. Con in mezzo la tragedia di Odessa, già città martire durante il nazismo e in tante altre occasioni della storia, porto sul Mar Nero con un nome così evocativo che dispiace due volte.
Comunque sia, la guerra è dentro l’Europa, la più vasta operazione militare nel continente dai tempi della Seconda guerra mondiale. “La sanguinosa follia”, come avrebbe detto Oriana Fallaci, è alle porte e l’allerta è massima quando si annuncia l’uso di armi nucleari. Con l’aggravante che l’America che c’era una volta, adesso non c’è più. Lo testimonia purtroppo l’immagine (che è “forma” per eccellenza) del suo presidente, il quale quasi fatica a deambulare e appena pochi mesi fa ha lasciato l’Afghanistan in braghe di tela dopo vent’anni di guerra guerreggiata. Vatti a fidare. Di lui, come della Nato, come dell’Unione Europea che “per la prima volta finanzierà l’acquisto di armi contro l’aggressione di Putin” come ha sentenziato, stavolta non via sms, Ursula von der Leyen. Ovviamente di fidarsi di Putin manco a parlane coi suoi trascorsi nel Kgb.
Armiamoci e partite, come nella migliore tradizione italiana. I primi sono stati i nostri inviati. Tolta la mascherina considerata d’ordinanza negli ultimi due anni, con effetti disastrosi per l’assenza di labiale sulla comprensione del testo da parte dei telespettatori diversamente giovani, i nostri inviati hanno indossato l’equipaggiamento da reporter di guerra altrettanto d’ordinanza: elmetto e giubbotto antiproiettile, possibilmente con la scritta Press sovrapposta, a sottolineare l’indipendenza della libera stampa che dovrebbe documentare atrocità ed eroismi “né con la Russia, né con l’Ucraina”.
E qui si apre un capitolo a parte, uno sguardo irriverente pur nella tragedia della guerra. Perché in quarantotto ore Putin ha fatto sparire il Covid dall’Europa intera. Non se ne parla più. Secondo i canoni del giornalismo ciò di cui non si parla non esiste. Speriamo che funzioni. Soprattutto per i nostri inviati, rigorosamente senza mascherina, in un paese di circa 43 milioni di abitanti, poco vaccinati soprattutto con la terza dose. Gente che in Italia neppure potrebbe salire sull’autobus.
Se non fosse impertinente si potrebbe proporre Putin per il premio Nobel della Medicina come Obama ha avuto il Nobel per la Pace, nonostante abbia aperto più focolai di guerra di qualsiasi altro presidente degli Stati Uniti della storia recente senza chiudere nessuno di quelli ereditati. In alcuni casi ne paghiamo ancora le conseguenze, vedi eventi in Libia, in Siria, ma anche in Somalia, Yemen, Iraq, Pakistan e nella stessa Ucraina, repubblica indipendente dal 1991 dopo la dissoluzione dell’Urss.
Trent’anni complicati. Basti ricordare il caso dell’imprenditrice Julija Tymošenko, considerata una delle donne più potenti del mondo da Forbes, rivista economica statunitense. Divenuta primo ministro dell’Ucraina, alla fine del mandato venne arrestata e trascorse tre anni in carcere.
Oggi il presidente è Volodymyr Zelensky, che incarna il “Paradosso sull’attor comico” di Diderot, un libro assai amato da Sciascia il quale aveva previsto ante diem come l’apparenza avrebbe sovrastato e inglobato la realtà. “E’ la natura che dona le qualità personali: figura, voce, acume e finezza – scrive Diderot – poi l’assiduo lavoro e l’esperienza perfezioneranno il dono della natura”.
Zelensky, il simbolo della resistenza ucraina, in mimetica davanti alla telecamera, fino a quattro anni fa era uno dei comici più famosi del suo paese, protagonista di una di serie televisiva di successo: “Il servo del popolo”, in cui si narra l’ascesa al potere di un oscuro professore di Kiev fino a diventare “il presidente del popolo”. Detto, fatto. Sull’onda del successo di tre stagioni in tv, nasce il partito politico con lo stesso nome dello sceneggiato. Zelensky si candida e ottiene un plebiscito. Eletto con il 73 per cento dei consensi dagli ucraini. Popolo che ha prodotto pagine di letteratura universale come “Le anime morte” di Gogol o “Il maestro e Margherita” di Bulgakov, la danza di Nijinsky, la musica di Horowitz.
Altro che “camerieri, badanti e amanti”, copyright Lucia Annunziata & Antonio Di Bella, impagabile coppia del giornalismo nostrano, mica due pivelli qualsiasi. Hanno vissuto e lavorato tra Italia e estero, sanno come si sta al mondo e come si fabbricano opinioni, chi fustigare e chi premiare. Anche se gli scappa un fuori onda razzista, una banalità becera, “voce dal sen fuggita”, non pagano dazio e non scendono mica dallo scranno. Anche perché nessuno glielo chiede. Sono il “sancta sanctorum” del politicamente corretto, i cantori del pensiero unico.
Se queste sono le fonti meglio lasciare perdere l’analisi geopolitica, le ragioni degli uni e i torti degli altri. Bisognerebbe risalire almeno al Divo Giulio che di fronte alla caduta del muro di Berlino e all’unificazione tedesca ebbe a dire che amava talmente tanto la Germania che ne preferiva due. Un’era geologica fa. Altro acume. Altra arguzia.
Restano i nostri inviati a raccontare gli accadimenti. Con oggettive difficoltà. Capita che per portare a casa un servizio decente, talvolta qualcuno/a ecceda o il cameraman sia distratto e non badi all’inquadratura. Con effetto “straniamento” rispetto alla percezione della realtà, alla verità del momento inquadrato che contraddice la verità del momento narrato. Perché capita di vedere giornalisti/e di tutti i Tg, attrezzati di tutto punto come Oriana Fallaci in Vietnam, che raccontano fatti di guerra mentre tutto attorno la vita scorre normale, un’anziana signora porta la spesa o i bambini giocano per strada o un turista fotografa una cupola d’oro a Kiev.
Il che non significa che non c’è la guerra in Ucraina, intendiamoci, ma solo che loro, i giornalisti, non sono proprio al fronte, luogo che in effetti, anche a volerlo, è difficile da raggiungere. Soprattutto da quando è invalsa, durante la seconda guerra del Golfo, la pratica del “embedded journalism” al seguito delle truppe militari, con la possibilità per i cronisti prescelti di raccontare più da vicino il teatro delle operazioni anche dal punto di vista di chi conduce l’azione.
Per capirci, la più famosa giornalista italiana “embedded” rimane Monica Maggioni, oggi direttrice del Tg1, testata per la quale nel 2003 realizzò cronache dall’Iraq, poi confluite in un libro: “Dentro la guerra. Il conflitto iracheno raccontato da una reporter al seguito dei militari americani”, Tea editore, 2007. Maggioni era l’unica italiana ammessa tra le fila americane e ciò, assieme alla indiscussa bravura e tenacia, le ha portato fortuna.
La guerra, si sa, è anche, forse soprattutto, propaganda. Ai tempi di internet il gioco è più duro. Difficile discernere per chi ci lavora, sempre di corsa contro il tempo, la notizia vera da quella falsa e soprattutto l’immagine vera da quella falsa. Ecco allora il videogioco di guerra, o la parata militare di due anni fa sui cieli di Kiev spacciati per ostilità in diretta, o il blindato d’annata che investe l’utilitaria.
Sembrano inezie, ma nell’informazione ciò che conta è la credibilità. Almeno così ci hanno insegnato in un’altra epoca del giornalismo. Che non era affatto l’età dell’oro. Ma non c’era bisogno di vivere dentro “lo spettacolo integrato” previsto da Guy Debord, il filosofo e cineasta protagonista del Maggio francese. Non c’era bisogno di stare sempre sull’orlo dell’emergenza, per poterla sceneggiare.
L’Occidente è morto, forse. Ma neppure i giornalisti stiamo tanto bene.
CE NE RICORDEREMO DI QUESTO PIANETA 24
E mentre la libertà di stampa, specchio dei tempi e della democrazia, evapora in questo paese più velocemente che in una soluzione chimica, speriamo non Endlosung, il quotidiano italiano che più ha supposto negli anni di incarnare lo spirito della Repubblica omaggia in prima pagina il novello editore-padrone con un titolo invero straordinario: “Il prestito a Fca: formula innovativa, un modello per tutta l’economia” per spiegare il prestito di 6,3 miliardi di euro a Fiat Chrysler Automobiles garantito dallo Stato italiano. Cioè da noi contribuenti
Giova ricordare che Fca è una società estera con sede legale a Amsterdam e domicilio fiscale a Londra.
Il presidente è John Elkann, l'erede dell’unica vera monarchia che abbia conosciuto l’Italia, forse anche prima dell’avvento della Repubblica e anche di La Repubblica.
Fca deve ancora al Fisco italiano la Exit Tax, dopo il trasferimento della società all'estero. Dopo un lungo contenzioso si è passati da 1,3 miliardi richiesti dal Fisco italiano a 700 milioni di euro che Fca paga a rate.
A RA TE.

Coronavirus, "siamo agli arresti domiciliari..."
Ho visto dal balcone una signora anziana con guanti e mascherina che con fatica avanzava carica di spesa. L’hanno fermata. Ha messo giù i sacchi e ha mostrato “il lasciapassare”, come da decreto legge. Tutto a posto perché ha ripreso il suo cammino. Con maggiore, visibile, fatica.
E non ho potuto fare a meno di pensare che secoli di lotte per arrivare a una democrazia costituzionale sono stati spazzati in un fiato. Anzi, DA un fiato crudele e insidioso.
Un intero paese agli arresti domiciliari. Col benestare di tutti, si intende. Anche mio.
Con governanti che speriamo cerchino di fare del proprio meglio per la collettività secondo la loro indole, carattere e formazione. (Ce n’è uno di periferia che mi fa ridere da sola quando si atteggia al “Grande dittatore” di Chaplin, inconsapevole e soddisfatto.)
Pecore nel recinto, siamo. E non ti azzardare a uscire da quel recinto perché “la teoria dei camion dell’esercito che trasportano bare”, “la fuga dal Nord degli imbecilli” e, ancor più giustamente , “il sacrificio dei medici e del personale sanitario”.
Pecore siamo. In un pascolo giorno dopo giorno più stretto. L’emergenza finirà, prima o poi.
Ma noi pecore ci ricorderemo delle verdi praterie che pure abbiamo conosciuto?
Ah, dimenticavo. Montesquieu diceva che una nazione può perdere le sue libertà in un giorno, e non sentirne la mancanza per un secolo.
#stayhome.
Ricordiamoci...
Quando ci saremo lasciati tutto questo alle spalle, e torneranno a difendere gli evasori fiscali trattandoli - tutti - come povere vittime perché buoni elettori, ricordiamoci dei cittadini onesti che le tasse le hanno sempre pagate. Perché è grazie a loro che abbiamo ricevuto le migliori cure del mondo, senza sganciare un centesimo. Evasori inclusi.
Quando torneranno a dirci che la priorità del Paese è fermare qualche barca di disperati, ricordiamoci di questi giorni in cui a essere trattati da appestati siamo stati noi.
Quando torneranno a dirci che la priorità è smantellare lo Stato Sociale perché bisogna lasciare quei soldi nelle tasche dei più ricchi con la flat tax al 15%, ricordiamoci di cosa la Sanità Pubblica ha fatto per tutti noi in questi giorni.
E ricordiamoci dell'opera straordinaria di migliaia di medici, infermieri, oss, tutti, che in Italia sono pagati meno che altrove, sono precari più che altrove, ma che hanno dato tutto, tutto, nonostante tutto.
Quando torneranno a dirci che le ONG sono bande di criminali senza scrupoli e dedite ai loro interessi, ricordiamoci di quando quello stesso partito ha chiesto in Lombardia aiuto alle ONG per affrontare l’emergenza.
Quando torneranno a dirci che gli africani ci portano le malattie e che per questo bisogna ributtarli in mare, ricordiamoci di quando siamo stati respinti noi. E ricordiamoci di quell’italiano che ha portato il coronavirus in Africa. E in Africa è stato ricoverato e curato.
Quando torneranno a dirci che “loro” difendono la Patria e la dignità dell’Italia, ricordiamoci delle interviste che hanno rilasciato in mezza Europa contro il governo italiano, per far credere che non stesse fronteggiando al meglio l’emergenza pur di lucrare qualche voto. Danneggiandoci spaventosamente agli occhi del mondo.
E ricordiamoci di chi era in montagna a mangiare prosciutto e formaggio e chi nelle Istituzioni e negli ospedali a lavorare giorno e notte per la salvezza del paese.
Quando torneranno a dirci che finanziare la Ricerca e l'Istruzione non è importante e che quei soldi è meglio usarli altrove, ricordiamoci di questi giorni. E dei risultati ottenuti in silenzio dai nostri ricercatori precari.
Quando l’emergenza sarà finita e torneremo a quel clima misero e puerile della politica italiana di ogni giorno, proviamo a ricordare i giorni in cui abbiamo capito cosa sia davvero importante. Di quanto sia fragile la vita, anche sociale, e quanto per essa siano importanti cose che diamo per scontate e trattiamo quasi con fastidio.
Per una volta, una volta almeno, proviamo a non dimenticare.
L'ho ricevuto e volentieri lo condivido


 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431