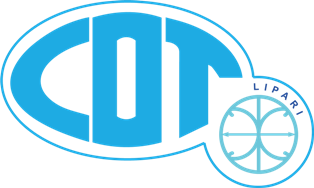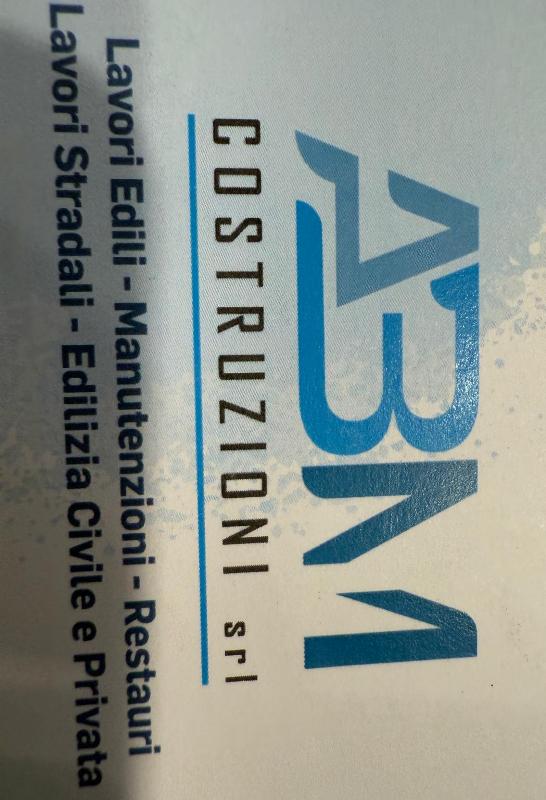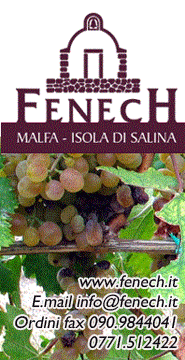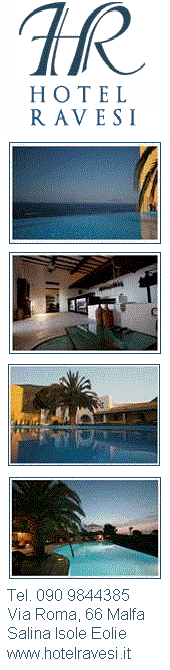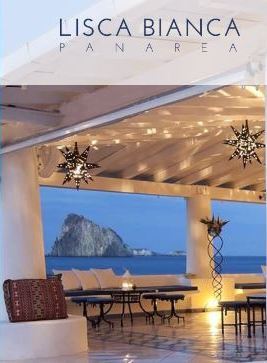di Michele Giacomantonio
di Michele Giacomantonio
Lipari al tempo di Garibaldi e l’uccisione del sindaco Policastro
Parte terza. Esplode la tragedia in via del Fosso
Ma c’era chi non era soddisfatto della piega che stavano prendendo le cose. Che cosa avevano risolto? Valeva la pena aver portato centinaia di persone d’avanti al municipio per ascoltare quello che si sapeva già? Era possibile che a Lipari i signori l’avessero sempre vinta e non dovevano pagare mai? Fra i più loquaci c’era Nicola Cappadona che raccontava come in altre parti della Sicilia la rivoluzione era stata più coraggiosa e ai signori ed ai borghesi avevano messo addosso la paura. Intorno a lui si era formato un gruppetto dei più giovani che lo ascoltava come se fosse un oracolo. Intanto più in la Vanni Mario Cannistrà e Antonio Cappadona avevano formato un crocchio in un vicolo e parlavano fitto fitto.
Dopo un pò le voci si alzarono di tono e fu chiaro che si era cambiato registro. Non era più solo il problema del caro prezzi e del funzionamento del calmiere. Ora si parlava dei borbonici che volevano passarla liscia. Che volevano continuare a comandare ed a profittare come se niente fosse successo. Era loro la colpa se la gente pativa la fame, se le merci erano care, se non si trovava il pane e la carne. Ed ecco il giovane Cappadona gridare forte “Viva l’Italia e viva la Libertà! Abbasso ai borboniani e morte ai regressisti” che aveva sentito ed imparato per le strade di Milazzo. E con lui, a cominciare dai più giovani, il grido fu ripreso e divenne assordante fra la mura di via del Timaparozzo, filtrò fra le persiane delle finestre, raggiunse le case e i vicoli. E poi subito dopo:”Andiamo alle case dei padroni! Prendiamoci quello che ci spetta e che hanno nascosto!”, “Andiamo da don Piddu Maggiore chissà quanto grano e quanti gioielli ha in casa!, “Andiamo da don Giuseppe Policastro che si è rubato i soldi della cassa di San Bartolo!” “Andiamo da….”.
Ancora le grida non si erano calmate che già don Piddu non c’era più dinnanzi alla farmacia e questa era già chiusa e sprangata. Ma non fece a tempo a raggiungere il portone di casa sua che era qualche decina di metri distante che una legnata lo prese sulla fronte e lo stordì. Si riprese subito e guadagnò il portone che era ormai a due passi barricandosi dentro. Ma i protestatari non lasciavano la presa e cominciarono a picchiare sul portone minacciando di gettarlo giù. E così don Piddu si fece le scale di corsa raggiungendo il terrazzo e di là, tetti tetti, raggiunse l’abbaino di una casa di amici e vi si rifuggiò.
“Lasciate stare quello!” gridò una voce mentre l’orologio del Seminario suonava le undici “Se l’è già fatta sotto. Andiamo a casa di Policastro che ha rubato i soldi dei poveri. La ci sono già i Marii e gli altri che stanno dando l’assalto.”. E subito la turba si diresse verso l’abitazione dell’ex sindaco che era a un centinaio di metri.
Quando vide che smettevano di pestare al suo portone e gridando si dirigevano verso la casa di Policastro, don Piddu gridò che era scoppiata la rivoluzione e che appena finito con Policastro sarebbero tornati da lui per ammazzarlo. Nella casa dove s’era riparato c’era anche don Antonino Ziino, il cappellano di San Giuseppe. “Non si preoccupi don Piddu - gli disse -ora la mettiamo in salvo”. E mandò a prendere a casa sua una tonaca ed un cappello da prete , che gli fecero indossare e così lo speziale potè uscire indisturbato facendo perdere le sue tracce e rifugiandosi in campagna da suoi parenti.
Intanto la folla era tutta intorno alla casa di Policastro ma la furia sembrava essersi calmata.
“Don Giuseppe, si affacci al balcone – dicevano da sotto – nessuno vuole farle del male. Vogliamo solo discutere”. Ma proprio sotto il balcone, in prima fila, c’era Vanni Mario e don Giuseppe non si fidava. Intanto temeva che dagli inviti suadenti si passasse ad azioni più risolute e che alla fine sfasciassero il portone entrandogli in casa. “Dove posso nascondermi? “ andava dicendo”Dove posso rifugiarmi?”Ed ad un certo punto gli venne in mente che aveva una cisterna che aveva fatta riparare da poco e che non era stata ancora riempita. E così si fece calare dentro e raccomandò che rimettessero il coperchio e se ne tornassero sopra a parlare con i ribelli e cercare di tenerli buoni dicendo che don Giuseppe stava male e si era messo a letto.
E così mentre don Giuseppe se ne stava acquattato nella cisterna mamma Francesca andò sul balcone e prese a supplicare la gente che cingeva d’assedio l’edificio. Ed insieme a mamma Francesca anche i loro servitori ed i mezzadri che erano venuti in città, facevano di tutto, dall’interno e dall’esterno per fare ragionare gli assedianti, implorandoli di tornare a casa loro.
Guardie municipali ufficiali non ce n’erano perché il nuovo corpo non era stato ancora investito di autorità. Vi erano quelle designate che ad un certo punto intervennero in forma privata cercando di rabbonire la gente.
Ma malgrado tutto la tensione continuava a rimanere alta e ad un certo punto scoppiò il “casus belli”. Un colono di Policastro, Domenico Barbuto di Canneto, stava discutendo con Giuseppe Ventrice e via via i toni divennero sempre più alti. Ad un certo punto dalle parole si passò alle mani ed i Barbuto si avventò sul Ventrice e gli assestò una coltellata allo stomaco.
Per un momento ci fu un silenzio di tomba come se improvvisamente il tempo si fosse fermato. Poi si udì un grido “Assassini!Assassini! ci vogliono ammazzare! Non basta che ci hanno derubato vogliono anche il nostro sangue!”. E scoppiò il finimondo. Qualcuno si chinò sul ferito e lo trasportò sull’alto ciglio della strada cercando di fermargli il sangue che usciva dalla ferita. Ma altri si gettarono sul Barbuto che tentava di scappare, lo agguantarono ed uno con una roncola gli squarciò il fianco. Barbuto cadde a terra in un lago di sangue e nello scompiglio che ne seguì qualcuno riuscì a trascinare in casa il corpo del ferito che dava ancora segni di vita malgrado continuasse a perdere tanto sangue. Il Barbuto e il Ventrice spirarono nello stesso momento, uno nel magazzino della casa di Policastro, l’altro sul ciglio della strada ‘u Fossu che non era ancora suonata la mezza.
E malgrado il bilancio fosse ora di un morto per parte la calma e il buon senso non si facevano strada. Anzi la ressa si fece più serrata e il vociare più forte. Qualcuno gridò: “Vogliamo Policastro vivo o morto!” e poco dopo arrivarono dei giovani due grossi fasci di sterpi secchi che poggiarono al portone cercando un acciarino per dar loro fuoco. Un altro gruppo cercava di scardinare la porta di servizio che dava sulla stradina.
A questo punto i servitori pensarono che era meglio cercare per don Giuseppe una via di fuga attraverso i tetti. E mentre veniva sistemata una scala a pioli a mo’ di ponte con il vicino terrazzo del Municipio, l’ex sindaco veniva issato dalla cisterna e portato sul terrazzino basso della casa. Da lì, attraverso la scala doveva scappare per i tetti.
Mentre si studiava il modo migliore di organizzarsi per questa impresa, mamma Francesca dal balcone, in lacrime, col volto disfatto, protendendo le falde del grembiale nero ricolmo di ori e denaro di grosso taglio, implorava:”Prendetevi tutto! Ecco è quello che abbiamo! Ma lasciate stare mio figlio! Vi prego, lasciate stare mio figlio!”. Nessuno fece un gesto di pietà. Nessuno pareva dare ascolto. E la scena della madre implorante sul balcone e della folla sorda nella strada rimase a lungo nella mente degli eoliani.
In prima fila, sotto il balcone c’era sempre Vanni Mario con il suo clan, ma non c’erano più i fratelli Cappadona. Appena aveva visto la scala a pioli sul terrazzo al giovane era venuta un’idea. Era corso a casa a prendere lo “scopettone” che aveva portato da Milazzo e aveva raggiunto il fratello che lo aspettava all’angolo di un vicoletto da dove potevano vedere il terrazzo della casa senza essere visti. E lì appostati caricano il fucile con polvere da sparo e una manciata di brecciame.
Ad un certo punto videro comparire sul terrazzo don Giuseppe che incerto, avanzando carponi sulla scala si apprestava a passare da un terrazzo all’altro. Quando Policastro fu nel mezzo del cammino, sospeso in aria, Nicola Cappadona prese la mira e sparò. Ciò che la gente ricordò di quel momento fu l’urlo disperato della madre che, mentre il figlio precipitava nella strada, si lanciò per le scale per raggiungerlo. Don Giuseppe non era morto sul colpo, era ancora in terra e rantolava. E su di lui infieriva a parole con pedate Vanni Mario Cannistrà.
“Hai fatto la fine che meritavi, porco!” gli gridava il ribelle di Quattropani. Fu a quel punto che Angelo Megna e Bartolo D’Albora, le due guardie, che per tutto il tempo avevano cercato di sedare gli animi pur non avendo un ruolo ufficiale, si sentirono in dovere di intervenire e bloccarono il Cannistrà insieme a Nicola Cappadona che aveva ancora in mano lo schioppo fumante e lo sguardo allucinato. Antonino Cappadona invece fuggì via e di lui non si seppe più nulla per diverse settimane.
La folla era come di sasso, inebetita. Automaticamente si scansò per fare spazio a mamma Francesca che, il viso bagnato dalle lacrime e i capelli scarmigliati, si getto sul corpo del figlio.
“Giuseppino, Giuseppino mio che ti hanno fatto! Oh figlio, figlio..”. E gli asciugava con lo scialle il volto insanguinato e lo baciava sugli occhi e sulla fronte.
A questo punto, richiamato dallo sparo giunse sulla strada del Fosso lo studente Giuseppe Palamara, anche lui un reduce della battaglia di Milazzo, e per questo autorevole fra i giovani liberali liparesi con una fama di persona assennata e aliena dagli eccessi. Palamara si fece largo fra la folla e vista la scena straziante della madre col figlio moribondo, girò gli occhi verso quelli della prima fila e puntandoli su Vanni Mario e Nicola gridò loro:”Vigliacchi, almeno scopritevi dinanzi al dolore di una madre”. E tutti, Vanni Mario e Nicola per primi, si tolsero la coppola del capo.
Il corpo di don Policastro fu sollevato da terra e portato, agonizzante, in casa e adagiato sul letto grande. Ed alle quattro del pomeriggio il giovane cessava di vivere fra lo strazio della madre ed il pianto dei congiunti.
Spirato il Policastro, le due guardie Angelo Megna e Bartolo D’Albora, si recarono al Municipio per dichiarare i decessi. Negli atti del Comune è scritto che il Policastro morì alle 22, il Ventrice alle 18 ed il Barbuto alle 18,30. Potrebbe essere che orari scritti nei documenti ufficiali siano ancora con l’ora siciliana e non con l’ora italiana. Altra stranezza è che negli atti del municipio è detto che sia il Barbuto che il Policastro erano morti, non nella casa di via del Fosso dove la memoria di chi ha riferito li colloca, ma nella casa del dott. don Filippo De Pasquale che, come abbiamo detto, doveva trovarsi in vico Sant’Antonio dietro la Marina San Giovanni[1]e quindi abbastanza lontano da dove si sarebbero svolti i fatti.
Di questo drammatico episodio l’unico segno che rimane è la lapide sulla tomba posta nella chiesa dei Cappuccini. Essa dice: “Il 2 ottobre 1860, mano assassina, giovandosi dell’anarchia nell’isola, trucidava sotto gli occhi materni Giuseppe Policastro di animo nobile e costumi semplici onesti, la inconsolabile madre Francesca Salpietro a perpetuare la memoria del suo unico figlio ucciso a 37 anni lacrimando pose”. Nel Consiglio comunale che si tenne l’11 ottobre nessuno osò dire una parola di commemorazione o proporre un momento di raccoglimento.
All’indomani dell’eccidio giunse a Lipari un distaccamento di carabinieri reali comandati da un capitano che prese alloggio in via Santo Pietro – oggi via Maurolico - in un appartamento di don Onofrio Paino. Il primo atto che compirono fu quello di prendere in consegna e di inviare alle carceri di Milazzo Nicola Cappadona, Vanni Mario Cannistrà e Giovanni Ventrice imputati di omicidio e di concorso in omicidio[2]. Nicola e Vanni Mario saranno anche condannati[3].
Possiamo concludere che giustizia fu fatta per questo orrendo episodio? Non ne saremmo così sicuri. Certo stando alla ricostruzione i maggiori responsabili sarebbero stati arrestati e condannati. Compreso Antonino Cappadona che aveva fatto perdere le sue tracce e poi fu arrestato a Lipari il 23 novembre[4].
Il problema non è questo. Il problema è di capire se si trattò di un moto spontaneo che andò via via crescendo, episodio che innesca un altro episodio o il delitto di Giuseppe Policastro era premeditato ed aveva non solo degli esecutori ma anche dei mandanti, o meglio, un mandante che è rimasto dietro le quinte. Il problema lo pone lo stesso Iacolino che ha trovato fra le carte della famiglia Bongiorno la minuta di una lettera senza data, senza firma, senza destinatario e per di più rosicchiata dai topi e quindi in alcune parti illeggibile. L’unica cosa certa – afferma Iacolino - è che la calligrafia è quella di don Giovanni Bongiorno e che fu scritta nell’arco degli ultimi due mesi del 1860. Don Giovanni Bongiorno aveva nel 1860 la stessa età di Giuseppe Policastro ed era stato nel 1848 caporale della Guardia nazionale ora, con ogni probabilità era ufficiale postale.
Don Giovanni sul finire del 1860 scrive una lettera ad un personaggio che rimane sconosciuto e riporta quanto gli aveva detto don Rosario Rodriquez un eminente personaggio di Lipari che “in casa sua riceveva tutti” e cioè “essere cosa notoria a tutti che il principale autore dei luttuosi fatti del due ottobre 1860 siete stato voi per soddisfare la vostra sciocca e smodata ambizione e per sfogare pravi sentimenti di vendetta, ma pure vi ha egli perdonato nel suo animo. Questo perdono rimane sopito dalla pietosa memoria del sangue dell’innocente Policastro, il quale grida vendetta dinnanzi Iddio ed agli uomini, e le perenni lagrime di quella infelice madre devono anche laniarvi il cuore e logorarvi il pensiero mentre un’ombra di sentimento in voi rimane !!”.Per quello che si capisce dal resto della lettera, in certi passaggi illeggibile, e che questo ignoto personaggio era stato preso in società da padre di don Rosario, beneficato dallo stesso che lo aveva soccorso nelle più “ dure emergenze” ed ora quindi lo accusa di “indicibile ingratitudine”. Ma Bongiorno rassicura il suo ignoto interlocutore. Don Rosario non ha mai pensato alla vendetta e si è meravigliato quando ha sentito che gli si attribuisce la volontà di vorrebbe portare il caso alla luce. Questo potrebbe essere una preoccupazione dei cognati dello sconosciuto interlocutore ma “egli non ne sa una iot. Anzi mi soggiunse che in ottobre ultimo …parlato di questo affare dai vostri cognati egli rispose evasivamente, nel fermo proposito di non far nulla”[5]. Secondo don Giuseppe Aricò l’arresto dei fratelli Cappadona ha sicuramento creato problemi in certi ambienti liparesi infatti “più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli la contassero bene”[6].
Un ultima considerazione. Sulla correttezza dell’amministrazione Policastro – che “don Salvatore” ed alcuni manifestanti mettevano in discussione - vi è un giudizio della commissione che fu chiamata a fare l’”esame del conto morale e materiale del 1860” che dice: “La Giunta [del 1860] ha agito con tutta legalità ed ha adempiuto tutti gli obblighi che la legge metteva a suo carico. Non mancò mai di solerzia e di operosità nell’immigliamento dell’Amministrazione e miglioramento del paese. Si conviene inoltre che gli sconvolgimenti politici avvenuti in quel tempo non permettevano fare più di quanto fece[7]”.(Archivio storico eoliano.it)
[1] Archivio del Comune di Lipari, Registro ad annum degli atti morte del Comune di Lipari, annotazione n.78, n. 79, n.80.
[2] Nulla si sa della sorte del Ventrice. Quanto agli altri Iacolino riporta informazioni raccolte dai ricordi dei vecchi ma non documentate. Giovanni Mario Cannistrà sarebbe stato condannato ad una decina di anni nel bagno penale di Milazzo. Riuscito ad evadere e a tornare clandestinamente a Lipari, per un paio d’anni tenne in scacco le forze dell’ordine. Soltanto dopo che furono arrestati alcuni suoi congiunti, egli si decise a costituirsi. Nicola Cappadona invece sarebbe stato condannato a circa trent’anni da scontare nel bagno penale di Milazzo. Ne uscì nel 1890. Trasferitosi a S. Marina Salina, dove esercitò il mestiere di sarto, si sposò nel 1903. Morì a ottantatrè anni il 25 gennaio del 1924. Di Antonino Cappadona i carabinieri non trovarono alcuna traccia e su di lui si fantasticò a lungo. Qualcuno avanzò anche il sospetto che fosse stato lui a sparare e non il fratello.
[3] Di parere diverso è Angelo Raffa (E. Melena, op. cit., nota n. 122, pag. 181. “Non si sono rintracciati documenti relativi all’inchiesta e al procedimento penale che avrebbero dovuto aver luogo. Ma se l’inchiesta vi fu, e se gli uccisori vennero individuati, ad essi sicuramente non toccò alcuna condanna. Infatti, con Decreto dittatoriale firmato da Garibaldi a Caserta il 29 ottobre 1860 si dichiarava all’art.1 “abolita l’azione penale a favore degli autori e complici di reati di sangue commessi durante l’insurrezione o in conseguenza dell’insurrezione”: v. Giornale Officiale di Sicilia, Palermo 4 novembre 1860, n. 127 – Parte Officiale. L’Unico onere che incombeva ai processati per delitti di sangue durante l’insurrezione, era la presentazione di apposita domanda al Procuratore generale del re, affinché la Corte dichiarasse estinta l’azione penale per l’applicazione dell’indulto”. Il problema è: i fatti della strada del Fosso potevano rientrare nei delitti di sangue durante l’insurrezione?
[4] Da una lettera di don Giuseppe Aricò a suao figlio Giovanni del 24 novembre 1860 in G.Iacolino, inedito cit., pag. 454 a-d. A proposito di questa vicenda nella lettera si dice “Il figlio di maestro Nicola Capadona Sabbino arrestato fu qui spedito, e l’altro fratello Antonino, che dicesi essere stato colui che vibrò il colpo mortale al miserando Policastro, ieri sera alle 5 arrestato fu tradotto in carcere dai Carabinieri sorpreso ed occultato da quelli potentissimi buttani delle sorelle Cafarella che ne è il Direttore il Canonico Bonica Cartella. Per un tale arresto più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli Capadona la contassero bene”.
[5] Dall’Archivio priv. Del dott. Edoardo Bongiorno, riportata da G. Iacolino, inedito cit. Quaderno VII, pp. 358 a-b.
[6] G. Iacolino, inedito cit., p.354 b, lettera citata.
[7] Archivio Comune di Lipari. Seduta del Consiglio comunale del 25 nov. 1863.
[1] Da una lettera di don Giuseppe Aricò a suao figlio Giovanni del 24 novembre 1860 in G.Iacolino, inedito cit., pag. 454 a-d. A proposito di questa vicenda nella lettera si dice “Il figlio di maestro Nicola Capadona Sabbino arrestato fu qui spedito, e l’altro fratello Antonino, che dicesi essere stato colui che vibrò il colpo mortale al miserando Policastro, ieri sera alle 5 arrestato fu tradotto in carcere dai Carabinieri sorpreso ed occultato da quelli potentissimi buttani delle sorelle Cafarella che ne è il Direttore il Canonico Bonica Cartella. Per un tale arresto più individui sono accuratissimi perché temono che detti fratelli Capadona la contassero bene”.
[1] Dall’Archivio priv. Del dott. Edoardo Bongiorno, riportata da G. Iacolino, inedito cit. Quaderno VII, pp. 358 a-b.
[1] G. Iacolino, inedito cit., p.354 b, lettera citata.
[1] Archivio Comune di Lipari. Seduta del Consiglio comunale del 25 nov. 1863.
Lipari al tempo di Garibaldi e l’uccisione del sindaco Policastro
Parte seconda. L’uccisione di Giuseppe Policastro
La versione di “don Salvatore”
Ma il calmiere sui prezzi non risolse la situazione di disaggio sociale e di forte tensione che c’era nel paese. Già a fine agosto, il 28 per l’esattezza, aveva colpito l’opinione pubblica l’uccisione di don Giovanni Amendola, ex consigliere e drammaturgo, che si era ritirato nella sua casa di Quattropani. Ora il due ottobre, il giorno dopo l’applicazione delle misure annonarie, si hanno ben tre vittime di morte violenta anche se quella che fa più scalpore è l’uccisione di don Giuseppe Policastro ex sindaco che era rientrato da Salina qualche giorno prima.
Perché viene ucciso Policastro e come? Una versione è quella che ne dà Elpis Melena, pseudonimo di Marie Esperance Brandt von Schwartz, giornalista e scrittrice, legata a Garibaldi da una affettuosa amicizia, che visitò le Eolie dal 7 al 13 ottobre del 1860 e fu a Lipari 9 giorni dopo i tragici fatti raccogliendo quindi ,su di essi, un racconto di prima mano.
La causa dello scontro, secondo la scrittrice anglo tedesca, fu l’accusa che si faceva al Policastro di essersi appropriato della “cassa di San Bartolomeo” e cioè di un fondo costituito con i soldi che dovevano essere pagati, nel 1672, al proprietario del vascello di nome Bartolomeo che portò a Lipari miracolosamente un carico di grano e poi partì di notte senza riscuotere il corrispettivo. Una versione tutta particolare dell’episodio narrato dal Campis che non parla né del corrispettivo né di questa “cassa di S.Bartolomeo”[1]. Comunque il narratore, un non meglio precisato don Salvatore liberale e antiborbonico[2], afferma che l’amministrazione di questa “cassa” era stata affidata al Sindaco e doveva servire ai liparesi come sostentamento in caso di rincaro dei prezzi annonari.
“Questo momento era giunto. L’aumentata tassa sull’olio e sul grano spinse il popolo a chiedere l’aiuto della ‘cassa di San Bartolomeo’, ma invano. E poiché negli ultimi vent’anni ogni aiuto è stato sempre negato e l’ultimo sindaco [ il Policastro] (…) affermò persino che nella cassa non vi era più alcun denaro, il popolo fu condotto all’ira e all’esasperazione. Gli abitanti della città e della campagna si armarono e si unirono per assalire la casa del sindaco, per impossessarsi della cassa trattenuta ingiustamente e compiere vendetta contro l’amministratore infedele e disonesto.
Ma questi si era trincerato con trenta seguaci ben armati, e non accontentandosi di dare l’ordine di sparare sulla popolazione, fu anche colui che fece fuoco per primo e più frequentemente. L’esasperazione cresceva ogni istante da tutte e due le parti, finché il conflitto non degenerò in una generale lotta politica, in cui prevalsero gli odi partitici a lungo repressi. Quando infine il sindaco riuscì a stendere al suolo, con un colpo ben mirato, il capo dei liberali[3] – uno dei nostri cittadini più insigni – allora per lui fu finita. Egli tentò di salvarsi saltando da una finestra; ma nello stesso momento fu afferrato dal popolo e letteralmente fatto a pezzi. Sua madre fuggì in campagna, i suoi seguaci si dispersero, e la popolazione, placata da questa terribile, anche se ben meritata vendetta, si preoccupò soltanto di curare i feriti e seppellire i morti”.
Nella casa del Policastro viene trovata “la cassa di San Bartolomeo” con settemila once. “. “ Il sindaco – continua la narrazione di “don Salvatore” – era un uomo di ancora neanche 36 anni ed aveva rivestito già da circa undici anni la carica a lui affidata da Francesco II. La sua dipendenza dalla dinastia borbonica l’aveva reso odioso presso molti uomini illuminati della nostra cittadina. Con lui si è estinta la sua famiglia, cosa che non è certo da considerare una sventura, visto che essa ha portato da secoli soltanto miseria e dolore su quest’isola. Tre volte i suoi antenati hanno commesso tradimento contro Lipari e l’hanno consegnata al saccheggio dei pirati. Mio padre mi raccontava spesso che Policastro, il nonno di questo sindaco assassinato, non ha fatto nulla di meglio, per favorire certi interessi privati, che far pervenire segretamente al nemico assediante le chiavi della fortezza, in cui si era rifugiata la spaventata popolazione, e lasciare, col peggiore tradimento, tutti gli isolani in balia dei pirati”[4].
Fin qui il racconto di “don Salvatore” per la penna di Elpis Melena.. Sgomberiamo subito il campo circa la responsabilità “storica”. Se “don Salvatore” allude al tempo della “ruina” del Barbarossa, non vi era nessun Policastro fra le famiglie “cospicue” di Lipari prima della distruzione[5]. I sospetti allora circa chi avesse venduto la città al Barbarossa si appuntarono, come abbiamo visto, sul Camagna – che non risulta appartenesse alla casata dei Policastro -, ma anche di queste dicerie abbiamo dimostrato l’inconsistenza. I Policastro risultano invece fra le famiglie che esistevano al principio dell’anno 1600[6] e quindi potrebbero essere fra quelle immigrate a Lipari subito dopo la “ruina” e visto il cognome, potrebbe essere di origine calabra.
Altre due punti dell’esposizione ci sembra di dover confutare. Il Policastro era divenuto sindaco il 18 maggio 1859 e dovette rimane in carica sino all’8 luglio 1860[7], non può avere ricoperto quella carica per gli ultimi undici anni perché come abbiamo visto in questo periodo diverse personalità si erano susseguite in questa responsabilità. La seconda osservazione riguarda la cosiddetta “cassa di S.Bartolomeo”. Esisteva questo fondo? E chi ne era depositario? E se esisteva come mai non si era fatto ricorso ad esso in tanti anni? Come mai il vescovo Attanasio aveva chiesto al governo nel 1853 un soccorso economico per la miseria che si era prodotta anche a causa della malattia che aveva colpito la vite? Giuseppe Iacolino osserva che nella seduta consiliare dell’11 maggio 1859 e ancora in altre successive si discusse della pretesa dell’Intendente di Messina che voleva aver restituiti, da parte del Comune di Lipari, la somma di 3.600 ducati che proprio il governo aveva inviato al vescovo “a sollievo dei poveri delle isole Eolie”. Pretesa alla quale Sindaco e consiglio si erano opposti energicamente. Potrebbe essere stato questo episodio, mal interpretato e distorto, alla base della diceria secondo la quale il Policatro si sarebbe appropriato di certo denaro destinato ai poveri. A sentire altre voci – conclude Iacolino – si sarebbe trattato addirittura del denaro della cassa dell’amministrazione di S. Bartolomeo confusa o identificata con la cassa della Mensa vescovile[8].
I fatti del 2 ottobre 1860 nella ricostruzione di Iacolino
Vogliamo sottoporre tutto il racconto di “don Salvatore” ad una verifica alla luce delle ricerche fatte dal prof. Giuseppe Iacolino[9]. E dobbiamo dire che la vicenda si tinge di giallo perché non solo si definisce il contesto ed in qualche modo si precisano gli attori ma addirittura si suggerisce che dietro l’assassinio di Policastro ci possa essere la regia di un personaggio di spicco della Lipari d’allora che sia rimasto nell’ombra. Ma procediamo con ordine.
“ Quando morì il padre don Antonio Policastro, Giuseppino (così è indicato nel testamento del genitore) aveva appena tre anni, e la madre donna Francesca, ventottenne, lasciò la propria abitazione di vico Sant’Antonio ( il signorile edificio che guarda su Marina San Giovanni ) per ritirarsi in un’altra casa Salpietro, parte della quale era abitata dal cognato Bartolo De Pasquale. Codesta casa è quel severo palazzetto, il penultimo a sinistra, che si scorge salendo per l’odierna via Umberto. A quel tempo la via Umberto era detta la strada del Fosso a causa di un modesto slargo, il Fosso appunto, che s’apriva lì accanto, nel bel mezzo di quel fitto reticolato di vicoletti e povere abitazioni che ricadevano nell’area dell’odierna piazza Arciduca d’Austria. Sul retro, il palazzetto dava sul tratto iniziale del vico Milio, oggi chiamato vico Montebello. Del fabbricato donna Francesca venne ad occupare il primo piano.
Educato con ogni amorevole cura, Giuseppe Policastro concluse gli studi laureandosi in giurisprudenza. Poi, oltre che interessarsi dell’amministrazione dei beni e delle vaste tenute ( ma in siffatte cose - e, a quanto si dice, nella pratica dell’usura – dava ottima prova l’abilità di mamma Francesca) egli, “come si conveniva ad un giovane del suo rango, attivamente partecipò al gioco della politica paesana”[10]nel quale ebbe successo divenendo sindaco. Sindaco dei Borboni e quindi in qualche modo tagliato fuori dei nuovi giochi che si andavano aprendo. Ma il nostro era giovane, era dinamico era fattivo e quindi aveva ancora molte carte che si potevano giocare. E poi in quei giorni erano in molti a convertirsi al nuovo corso e quindi il futuro poteva ancora riservagli delle prospettive. E magari un futuro non troppo lontano visto che presto si sarebbe andati alle elezioni per il nuovo sindaco. Quindi Policastro poteva essere un avversario temibile in una eventuale competizione elettorale… Avversario temibile o capro espiatorio di un regime che si era macchiato certo di abusi e aveva lasciato dietro le sue spalle odi e rancori? Rancori magari nemmeno legati a fatti specifici ma coltivati da giovani che avevano assaporato l’aria nuova partecipando anche alle lotte delle ultime settimane nella vicina Milazzo e ritenevano che la rivoluzione dovesse essere portata più a fondo al di là delle istituzioni, nei confronti dei ceti aristocratici e borghesi che avevano comunque fatto parte del vecchio potere. Ritenevano che andando a sparare a Milazzo avevano acquisito un credito che dovesse essere messo all’incasso, superando le disparità sociali che a lungo avevano subito.
Tutto questo certamente era presente quella mattina del martedì 2 ottobre quando, di buon’ora, gli uomini cominciarono a raccogliersi dinnanzi alla porta del Municipio. Prima una ventina, poi una trentina, poi circa cinquanta. A gruppetti e sparpagliati. E c’era chi andava su e giù per la via del Timparozzo, da Sopra la Civita a Marina San Giovanni, a via del Pozzo per incontrarsi con chi arrivava dal Vallone, da Diana, da Marina San Nicolò e con cui si erano dati appuntamenti fin dal pomeriggio precedente quando la manifestazione era stata decisa. Si doveva manifestare contro il caro prezzi, contro una amministrazione che sembrava immobile, che non risolveva il problema. I benestanti ed i galantuomini – i Marchese, gli Scolarici, i Tricoli, i Bongiorno, i Maggiore, i De Mauro, i Florio, i La Rosa, i Peluso, i Morsillo, i Palamara, i Rodriquez, i Favaloro - se ne stavano chiusi nelle loro case che davano sulla via del Timparozzo che ora si chiamava via del Municipio, spiando da dietro le persiane dei balconi la gente che andava crescendo e che era sempre più rumorosa. Appena più in là vi erano i De Pasquale ed i Policastro. Ma rimanevano chiusi nelle loro case della Marina San Giovanni, come in attesa di qualcosa che doveva succedere, anche i Carnevale, gli Aricò, i Rossi, gli Amendola. Mentre don Onofrio Paino era asserragliato nella sua casa in via Santo Petro. Tutti guardavano nelle strade per vedere chi c’era fra i manifestanti. E c’erano i Marii con a capo Vanni Mario Cannistrà, c’erano i Cappadona, Antonino e suo fratello Nicola che da quando era tornato da Milazzo si credeva chissàcchi, c’erano Giovanni e Giuseppe Ventrici. C’erano insomma tutte le teste più calde dell’isola e molti altri ancora, gente che in città non era mai venuta e scendeva ora dalle campagne per protestare.
Erano chiusi balconi con le persiane abbassate, i portoni sprangati, serrate le botteghe, Solo don Piddu Maggiore, lo speziale, che era anche un grosso proprietario di terre alla Vitusa, a valle S. Angelo, nella contrada ‘u voscu, ad un certo punto aprì la farmacia . E poco dopo anche don Antonio Incorvaja decise di andare al suo Caffè pubblico dove d’estate serviva una granita al limone e all’amarena fatta con la neve che d’inverno infossava a Monte Sant’Angelo in buche nel terreno rivestite di erba fresca e ben coperte da frasche e terriccio.
Finalmente alle dieci quando il cicaleccio si era fatto assordante sul portone del municipio apparve il presidente don Giuseppe La Rosa accompagnato dai due giurati don Michele Scafidi e don Antonino Megna. Subito dalla folla si levarono urla di minacce e il clamore aumentò ma dopo un po’ subentrò il silenzio perché la gente voleva sentire quello che veniva detto. Il presidente disse parole, invitando alla calma ed alla responsabilità e subito passo la parola a don Michele Scafidi che ripetè il discorso che aveva fatto in Consiglio. La penuria dei beni alimentari dipende dalla situazione in cui si trova la nazione che per le isole sono accresciute dalla difficoltà di approvvigionarsi in Sicilia. L’Amministrazione può fare ben poco. Ha calmierato i prezzi e controllerà che questi vengano rispettati. Si spera che la situazione migliorerà nei prossimi giorni. Le parole di don Michele ebbero il potere di far abbassare in qualche modo la tensione. La gente si mise a discutere del calmiere interrogandosi se avesse funzionato e se si era in grado di farlo rispettare. Si discuteva a gruppetti, a capannelli e la gente cominciò lentamente a disperdersi in ogni direzione. (continua). (Archivio storico eoliano.it)
[1] Angelo Raffa nella nota n.119 al testo della E.Melena (In Calabria e alle Isole Eolie nell’anno 1860, Soveria Mannelli 1997, pag.180) osserva che l’ esistenza del Peculio Frumentario, a cui riconduce la cosiddetta “cassa di S. Bartolomeo”, è comunque documentata nell’800 da alcuni atti notarili.. Il Peculio Frumentario era un deposito per il grano per i periodi di carestia, distribuito in cambio di una piccola somma di denaro. Dai documenti citati da Raffa si deduce che a Lipari il Peculio aveva un “depositario della cassa”, un “magazeniero delle fromenti” che a Lipari si trovavano nel Borgo, quartiere il Pozzo, e due “deputati”.
[2] A.Raffa nella nota n. 124 ( idem, pag.182) al testo crede di identificare con don Salvatore Amendola, che alla fine del 1861 compare negli atti del Comune come “assessore funzionante da Sindaco”, oppure don Salvatore Favaloro che sarà Sindaco dal 1864 al 1865.
[3] Angelo Raffa nella nota n. 120 (idem, pag.181) osserva che dovrebbe trattarsi di Luigi Ventrice, sarto di 38 anni, perché era l’unico dei tre uccisi che sia morto per strada.
[4] E. Melena, op. cit., pp.115-116.
[5] G.La Rosa, “Pyrologia Topostorigrafica dell’Isole di Lipari”, a cura di Alfredo Adornato, ., vol II, v. “Rollo delle famiglie cospicue de’ Gentiluomini di Lipari, che si trovarono esistenti nella città di Lipari, in tempo della sempre memorabile invasione del barbaresco Ariadeno Barbarossa l’anno di nostra salute 1544” , pp.19-22.
[6] G. La Rosa, op.cit., vol II, pp.30-31. dove si dice che la famiglia Policastro è diramata in diverse casate.
[7] G. Iacolino, La fondazione della Communitas Eoliana agli albori della Rinascenza (1095- 1995), Lipari 1995, pag. 91
[8] G. Iacolino, inedito cit., quaderno VI, pag. 312 a.
[9] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno VII, pp.344 e ss.”Nel tentativo che ci proponiamo di ricostruire la dinamica dei fatti di quel martedì di sangue, noi ci affidiamo ai pochi documenti che avanzano ( in primo luogo i registri anagrafici del Comune di Lipari) e a quelle frammentarie notizie – spesso anche contraddittorie e di scarsa attendibilità – che abbiamo raccolto dalla bocca di concittadini non più giovani i quali ci assicurano di avere appreso a loro volta dai più antichi ascendenti. Nostro compito darà esclusivamente quello di vagliare e di legare le varie informazioni in un ordine il più possibile logico e consequenziale”.
[10] G.Iacolino, inedito cit., Quaderno VI pp. 345- 345 a.
Lipari al tempo di Garibaldi e l’uccisione del sindaco Policastro
Prima Parte. Lipari ed i liparesi di fronte alla spedizione dei Mille
Fra i volontari garibaldini che combatterono a Milazzo vi erano anche alcuni eoliani. Innanzitutto Giovanni Canale, l’animatore della cellula rivoluzionaria di Lipari, che si buscò due ferite e fu promosso maggiore da Garibaldi sul campo e lo stesso Garibaldi lo nominò governatore provvisorio delle isole Eolie mettendo ai suoi ordini un gruppo di garibaldini per sostenerlo nella liberazione di Lipari. Oltre al Canale altri volontari furono Domenico Pirejra classe 1831, Nicola Cappadona che all’epoca dei fatti aveva 19 anni e Giuseppe Palamara che di anni ne aveva 21 ed era studente in chimica all’Università di Messina. Sicuramente il Palamara, ma probabilmente anche gli altri, una volta avvenuta la capitolazione dei borbonici, tornarono a Lipari con il Canali per procedere alla liberazione delle isole ed alla costituzione della nuova amministrazione.
Ma andiamo per ordine e facciamo un passo indietro. Quando nel mese di aprile corre la notizia in ogni parte della Sicilia che Palermo è insorta e poi anche Messina e le altre città, anche a Lipari ci furono tensioni ed in qualche modo manifestazioni di cambiamento anche forti e violente. Anzi il 17 marzo, prima quindi che avvenisse l’occupazione della Gancia, vi era stata una manifestazione di liberali liparesi che avevano esposto nella Marina di San Giovanni ribattezzata Piazza del Commercio, il tricolore, fissandolo al braccio della statua di S.Bartolomeo[1].
Ma a Lipari vi era una situazione particolare. Da una parte vi erano i carcerati della colonia coatta fra cui diversi politici che speravano in un cambiamento che potesse farli tornare liberi e dall’altra una forte guarnigione militare. Ed è forse proprio per la preoccupazione di questo contingente militare che gli atti di insofferenza assunsero una fisionomia non solo violenta ma anche delittuosa attirandosi l’accusa, da parte, dei borghesi e dei benestanti locali, di brigantaggio. E questi briganti, da qualche anno, si erano manifestati nell’area di Quattropani facendosi sempre più arditi e intraprendenti. Si trattava, si diceva, di caprai ignoranti e analfabeti che avevano dato vita ad una sorta di potere illegale facendo taglieggiamenti, grassazioni, minacce e, di tanto in tanto, anche qualche omicidio. Appartenevano quasi tutti alla banda dei Cannistrà, meglio conosciuta come la banda dei Marii. Si trattava di sei o sette famiglie dove ricorreva frequentemente, almeno nella generazione più giovane che si avvicinava ai vent’anni o li aveva da poco superati, il nome di Mario. C’era Mario Cannistrà figlio di Andrea che era del 1834, Mario Cannistrà figlio di Giuseppe nato nel 1841, Mario Cannistrà di Giovanni nato nel 1841, Mario Cannistrà di Bartolo nato nel 1847, Antonino Cannistrà, Mario Vanni Cannistrà e altri. Il capo sembrava essere Mario Vanni che aveva sposato Grazia Rijitano e si distingueva per il suo fisico possente e il suo abbigliamento rustico e stravagante. Infatti andava in giro con un giaccone e cosciali di pelle di pecora che insieme alla barba incolta ed i capelli lunghissimi che fuoriuscivano da un berrettone di lana grezza che calzava costantemente conferivano alla sua figura un che di selvaggio. Eppure contrariamente a quanto si diceva, Mario Vanni non solo sapeva leggere e scrivere, come altri membri del gruppo, ma teneva in casa molti libri dai quali attingeva quelle idee di giustizia e di libertà che professava e per le quali godeva di considerazione e di rispetto fra i contadini de
lla contrada e delle campagne vicine dove era diventato famoso assieme agli altri del suo gruppo[2]. Comunque i Marii non erano i soli nell’isola ad avere fama di essere irrequieti e violenti. Anche in città si mormorava di appartenenti alle casate dei Cappadona[3] e dei Ventrici[4] che avessero la lingua e anche la mano e qualche volta il coltello facile. Fatto sta che il 1858 ed 1860 si erano registrati a Lipari ben sei “morti violente” un fatto certamente tutt’altro che usuale per una comunità solitamente tranquilla.
Era sindaco di Lipari in quel tempo don Giuseppe Policastro[5], un trentaseienne avvocato colto e facoltoso che cercò di barcamenarsi in una situazione sempre più difficile e poi nel 1860, nell’isolamento più completo, senza notizie di quello che avveniva all’esterno, solo voci confuse. Soprattutto dette la caccia ai Marii e probabilmente a Vanni Mario che era latitante.
In quei mesi di forti speranze e preoccupazioni l’attenzione dei liparesi fu attratta dal forte fulmine che alle sette della sera del 19 febbraio 1859 si abbatté sul timpano della Cattedrale facendolo rovinare e provocando diverse crepe nella volta. Subito la gente vide in questo evento un presagio negativo magari anche politico data l’incertezza dei tempi. Comunque il vescovo mons. Ideo[6] non frappose tempo in mezzo e fece arrivare da Napoli, in poco tempo, le pietre per la riparazione grazie anche alla somma inviatagli, in tutta fretta, da Ferdinando II per riparare il frontone[7] e magari…per nascondere il presagio.
Comunque, dal punto di vista ufficiale, tutto procede come al solito in municipio ed al vescovato fino all’aprile del 1960. Nell’ottobre e nel novembre del 1859 si celebrano con rito religioso in Cattedrale le ultime due ricorrenze dei Borboni: l’onomastico di Francesco II e la commemorazione per il sesto mese dalla morte di Federico II. Ed in Comune ancora nelle sedute consiliari del 1960 si discute normalmente dei problemi dei collegamenti marittimi e dei prezzi annonari. Sui collegamenti marittimi il 13 febbraio si avanzò richiesta al governo di fare eseguire al vapore della tratta Lipari- Messina altre due corse passando così a quattro la settimana.[8]
I prezzi annonari creavano molti malumori. Quelli della carne produssero addirittura una serrata da parte dei macellai ed il malumore crebbe fra la popolazione. Nella seduta dell’1 aprile, l’ultima presieduta da Policastro, si discute proprio di questo malcontento che circola nel paese sia per i prezzi sia per la penuria di merci nei negozi e che si indirizza in particolare nei confronti del sindaco tanto che Policastro nella stessa seduta ritiene di doversi “discaricare per la responsabilità … dopo aver fatto noto al Colleggio lo stato di deficienza in cui attualmente trovasi il paese”.
Che la rivoluzione fosse ormai vicino i liparesi lo intuiscono il 10 luglio quando si sparge la voce che il Duca di Calabria, il vapore proveniente da Messina e diretto a Napoli, proprio nei pressi di Lipari era stato catturato da una corvetta della Marina Dittatoriale Siciliana e dirottato a Palermo.
Quando si ha notizia che Garibaldi ha conquistato Palermo buona parte dei sindaci siciliani spariscono o erano fuggiti o, chi non aveva fatto in tempo, era stato soppresso[9]. Il Policastro se ne va a Salina nelle sue terre sia per sfuggire alle proteste annonarie ed al malcontento dei cittadini in genere, sia temendo una vendetta da parte dei Marii. E dal 13 luglio non compare più la sua firma nei registri del Comune. Non potendo fare conto sulla pubblica amministrazione il governo della Sicilia scrive ai vescovi chiedendo la loro collaborazione e quella del clero “acciocché con la predicazione s’insinui negli animi de’cittadini d’abbracciar questa misura [quella della leva dell’esercito] non come una gravezza, ma come un sacro dovere, gloria vera e degna d’un popolo che vuole conservare la sua libertà[10]”.
Quando il 25 luglio Garibaldi, dopo la vittoria di Milazzo, parte per Messina chiama a se il maggiore Giovanni Canale e gli dà disposizioni per l’occupazione di Lipari e delle Eolie. Il contingente militare che era di guardia ai coatti non avrebbe opposto resistenza, se qualche preoccupazione ci poteva essere riguardava la Regia Marina che sorvegliava l’intera area dello Stretto, ma visto che la capitolazione era stata firmata dal colonnello Anzani dello stato maggiore borbonico, anche questa eventualità appariva improbabile. Quindi il Canale prendesse il gruppetto di liparesi che avevano combattuto a Milazzo ed un altro gruppetto della guarnigione locale e andasse a Lipari assumendo le funzioni di governatore provvisorio delle Eolie e lo comunicasse a tutte le autorità.
E così avviene . Tra il 26 ed il 28 il maggiore Giovanni Canale parte per il Lipari con il suo gruppetto, indossando la camicia rossa, un poncho grigio- marrone, un berretto di velluto scuro ricamato. La prima visita sarà per il vescovo Ideo, quindi si recò al municipio sul Timparozzo dove incontrò quelli dei decurioni che non si erano nascosti, i gentiluomini del paese, gli ufficiali borbonici del Castello. Ad essi Canale comunicò la decadenza del Sindaco e del decurionato borbonico, lo scioglimento del corpo delle guardie municipali con il passaggio dell’incarico di pubblica sicurezza alla guardia nazionale e mostrò la sua nomina a Governatore e Presidente del Municipio, firmata da Garibaldi. Dichiarò che riceveva ordini solo dal Governatore della Provincia. Emanò alcune urgenti ordinanze di polizia compreso quella che aboliva la pena del bastone nei confronti dei relegati coatti e infine firmò il primo atto anagrafico, una registrazione di nascita. Era il 29 luglio 1960.
Il Canali annunciò che presto vi sarebbero state le elezioni per il nuovo Consiglio comunale che sarebbe stato presieduto da un Presidente del Consiglio e il Consiglio avrebbe eletto il Magistrato Giuratorio che doveva comprendere il Predente del municipio e due giurati. Il Consiglio comunale sarebbe stato eletto da elettori che sapessero leggere e scrivere e fossero iscritti ai ruoli dei contribuenti con un certo censo: una settantina o poco più[11] . I comizi furono indetti per i primi giorni di agosto. Furono eletti quarantesi consiglieri di cui sette canonici ed un sacerdote, cinque erano i confermati rispetto alla precedente assise, il più anziano e quindi presidente provvisorio era il dott. Antonino Megna.. Fra i consiglieri vi era anche Giovanni Canale.
Il Consiglio si riunisce per la prima volta il 25 agosto per prendere visione di una circolare del Governo del Distretto di Messina sui Consigli civici, ma siccome si tratta dei consigli da eleggere mentre a Lipari questo è giù costituito si procede solo alla nomina del Presidente e del Segretario nelle persone del signor Felice De Gregorio e del signor Giuseppe Mercorella. In un successivo consiglio del 31 agosto si provvide ad alcune sostituzioni e cancellazioni in seno al Consiglio per ricondurlo al numero di quaranta membri, ma non si procedette alla nomina dei componenti del Magistrato Giuratorio che insieme al Presidente del Municipio avrebbero costituito l’esecutivo. Non si parlò affatto del corpo dei vigili urbani come non si parlò dei problemi del Comune. Probabilmente si aspettava che la situazione si chiarisse meglio ed intanto ci si dedicava ai lavori dei campi visto che era arrivata la stagione del raccolto a Lipari come nelle isole minori.
Aveva preso ad operare la guardia nazionale a Lipari e nelle isole[12] mentre Giovanni Canale dovette partire per qualche tempo lasciando il suo incarico ad interim al giurato don Antonino Aricò.
Settembre si apre con le notizie contraddittorie che arrivavano dalla Sicilia e dall’Italia, della coscrizione obbligatoria che era stata imposta dai piemontesi e dello Statuto Albertino che Depretis aveva esteso all’isola, del re Francesco II che si era rinchiuso a Gaeta e di Garibaldi che aveva occupato Napoli, e anche delle camice rosse che erano state sconfitte a Caiazzo. Ma a Lipari si parlava anche dei beni di prima necessità che scarseggiavano, dei prezzi che erano saliti alle stelle e di cui si dava la colpa ai bottegai e agli speculatori, dell’anarchia che ormai sembrava impossessarsi del paese. Così il 23 settembre si riunì il Consiglio sotto la presidenza di don Felice De Gregorio con all’ordine del giorno la nomina delle guardie municipali e la nomina del Magistrato municipale. Presidente a maggioranza di voti fu eletto don Giuseppe La Rosa mentre il dott. Michele Scafidi e il dott. Antonino Megna vengono eletti primo e secondo giurato. Per quanto riguarda la Guardia municipale la scelta era stata fatta cadere , di preferenza, su individui che erano stati assunti nel 1848 e qualche mese dopo dimessi, per cui risultò un corpo di vigili per lo più anziani per la gran parte superiori ai cinquant’anni ed anche, per la gran parte, analfabeti.
Ma il problema che rimaneva grave era quello dei beni alimentari e dei loro prezzi. Che fare? Gli amministratori sapevano che la mancanza di grano, olio e carne dipendeva dallo stato di guerra che ancora affliggeva il territorio del regno per cui l’unica strada, se vera strada si poteva chiamare, era quella del blocco dei prezzi a dettaglio pur con qualche aggiustamento “onde togliere qualunque attentato all’ordine per l’imprudenza dei venditori”. Ed è con questo obiettivo che viene convocato d’urgenza il Consiglio in seduta straordinaria solo una settimana dopo, il 30 settembre che definisce, su proposta del giurato dott. Scafidi i prezzi per tutta una serie di merci: pane, vino, olio, pasta, carne di vacca, di montone e becco, di capra e pecora, e quindi dei pesci dalla cernia, al dentice, alle occhiate, agli scorfani, alle ope, alle morene e mostine, alle aragoste, al tonno sotto sale.(Archivio storico eoliano.it)
[1] Elpis Melena – In Calabria ed alle isole Eolie nell’anno 1860 , Soveria Mannelli 1997, pag. 116.
[2] Mario Cannistrà di Andrea nato a Quiattropani il il 25 aprile 1834 nel 1870 sarà condannato a venticinque anni di lavori forzati per grassazione. Morirà nel bagno penale di Procida il 22 luglio del 1871. Un altro Mario Cannistrà detto anche Mariano di Bartolo, nato il 4 ottobre del 1847 verso il 1867 trovandosi in servizio di leva ucciderà un capitano dell’esercito. Sconterà trent’anni in un carcere romano. Tornato a Lipari verso il 1900 vivrà sin oltre il 1920. Queste notizie sui Marii come altre riguardo a Lipari in questo periodo, dove non diversamente indicato, sono presi da Giuseppe Iacolino, La chiesa cattedrale di Lipari sotto il titolo di S. Bartolomeo, inedito manoscritto . Quaderno VII, pp 312-314 e pag. 348.
[3] Un Nicola Cappadona, diciannovenne, sarà a Milazzo a combattere con i garibaldini. Faceva parte di una famiglia numerosa giacchè la madre, Nicolina Mellina, aveva messo al mondo tredici figli e una decina erano viventi nel 1860. Il padre Nicola, detto Sabina, era calzolaio e guardia municipale. Vivevano in una casupola in una stradina sotto le mura del Castello. Oltre a Nicola fra i più attivi vi era il fratello Antonino più anziano di sei anni.
[4] I Ventrice erano un clan di sei o sette famiglie dislocate in vari quartieri della città ed esercitavano i più svariati mestieri. Qualcuno aveva fatto il militare nell’esercito borbonico, vi erano sarti, calzolai, fabbri e agricoltori. Probabilmente erano originari di Ustica e avevano vissuto per qualche tempo a Palermo.
[5] Giuseppe Carlo Bartolomeo Policastro era nato a Lipari il 12 maggio 1823 dal settantenne don Antonio, dottore in legge e grosso proprietario terriero, e da donna Francesca Salpietro, una fanciulla di venticinque anni ed anche lei erede di grosse fortune patrimoniali. Era cugino di don Filippo De Pasquale che abbiamo conosciuto sindaco di Lipari e partecipante a Palermo all’insurrezione del 1848 e alla conquista di Palermo da parte di Garibaldi. Era imparentato anche con don Onofrio Paino meglio conosciuto come don Nofriu ‘u pirata.
[6] Mons. Ludovico Maria Ideo, domenicano, era nato a Pietraporzia in provincia di Enna il 21 aprile 1811. Era un predicatore eccellente e nel 1852 aveva pubblicato a Palermo il quaresimale predicato nel 1840, Venne nominato vescovo di Lipari il 25 giugno 1858 e prende possesso della diocesi l’8 ottobre. Il problema più grave che il nuovo vescovo si trovò di fronte era quello di una diocesi distribuita fra tante isole così distanti fra loro mentre la sua salute era cagionevole e non gli permetteva di sopportare gli strapazzi del viaggio e dei soggiorni disagiati. Per questo aveva chiesto subito al papa di essere dispensato dalle visite pastorali nelle isole in prima persona e di potere delegare qualcuno per le cresime.(Archivio vescovile, Corrispondenza, carp.E).Sera anche un letterato e poeta. Nel 1880 uscì a Palermo un suo libro dal titolo “Poesie edite ed inedite di Monsignor F.Ludovico Maria Ideo dell’Ordine dei Predicatori Vescovo di Lipari”. Collaborò a diverse riviste fra cui “Vera Buona Novella” di Firenze e “Sicilia Cattolica”.Morì il 3 dicembre 1880.
[7] Dal Manoscritto anonimo di proprietà della famiglia di Luigi Mancuso, p.636.
[8] Probabilmente due corse Lipari-Messina si effettuavano già da qualche anno ed erano inserite nella linea bisettimanale Napoli –Messina una della Compagnia Calabro Sicula ed una della Compagnia delle Due Sicilie. Una volta al mese un vapore faceva il viaggio da Palermo per Lipari. S.Lanza, Guida del viaggiatore in Sicilia, Palermo 1859.
[9] F. Ioli, Roccavaldina, Torino 1972, p.86. Il 19 luglio a Roccavaldina i patrioti avevano ucciso il sindaco Carmelo Bottaro ed un suo messo. Entrambi sgozzati e lasciati in mezzo alla piazza del paese in un lago di sangue.
[10] Lettera del 19 giugno 1860 della “Segreteria di Stato dell’Istruzione Pubblica e del Culto” al Vescovo di Lipari, Archivio Vescovile, Corrispondenza, Carp.C.
[11] La lista degli elettori alle elezioni del 12 maggio 1864 erano 72, quindi supergiù lo stesso numero del 1860.
[12] Sappiamo che a Salina era già operante prima del 10 ottobre da una lettera che il governatore Giovanni Canale scrive a don Giovanni Aricò, capitano della terza compagnia dei Militi Nazionali in Santa Marina e in cui si parla del luogotenente Domenico Giuffré e dei sottotenenti Gaetano Favazza e Giuseppe Lo Schiavo, insieme ai quali l’Aricò deve procedere alla nomina dei “bassi ufficiali” e cioè un sergente foriere, sei sergenti, dodici caporali ed un caporale forire. Forse Giovanni Arico era uno dei volontari che aveva combattuto a Milazzo. Documenti riguardanti Giovanni Aricò sono di proprietà della dott.ssa Giulia Mammana in Amendola.
[1] Sappiamo che a Salina era già operante prima del 10 ottobre da una lettera che il governatore Giovanni Canale scrive a don Giovanni Aricò, capitano della terza compagnia dei Militi Nazionali in Santa Marina e in cui si parla del luogotenente Domenico Giuffré e dei sottotenenti Gaetano Favazza e Giuseppe Lo Schiavo, insieme ai quali l’Aricò deve procedere alla nomina dei “bassi ufficiali” e cioè un sergente foriere, sei sergenti, dodici caporali ed un caporale forire. Forse Giovanni Arico era uno dei volontari che aveva combattuto a Milazzo. Documenti riguardanti Giovanni Aricò sono di proprietà della dott.ssa Giulia Mammana in Amendola.
IL PLAUSO.
di Aldo Natoli
Gentile Direttore, Approfitto del Tuo giornale online per complimentarmi con Michele Giacomantonio per gli interessanti scritti storici, frutto di un'accurata ed intensa ricerca, che ci consentono di conoscere uno spaccato sconosciuto della nostra storia. Pagine che ci sollevano dal "grigiore" giornaliero che attanaglia sempre di più la nostra meravigliosa isola. Grazie Michele !!!
La rivolta di Lipari contro il confino coatto[1]
di Michele Giacomantonio
La paura dei coatti
Finita la prima guerra mondiale non si era dimenticata a Lipari la lunga permanenza della colonia coatta e la preoccupazione di un suo possibile ripristino continuava ad aleggiare nell’isola. Ogni volta che giungeva un’ autorità sconosciuta e si recava a visitare il Castello ecco immediatamente che la cittadinanza entrava in fibrillazione. Così fu nell’agosto del 1926 quando giunse un questore di pubblica sicurezza che appunto salì al Castello e si mise ad esaminare, afferma un testimone dell’epoca[2], i fabbricati esistenti. Subito si diffuse la voce che si volevano portare dei delinquenti e si disse anche un numero: circa duecento. Per la verità – osserva Paino – era da mesi che il Governo si dava gran da fare a riattare le case del Castello, ma nessuno gli aveva posto pensiero.
Quando la voce prese corpo una delegazione di cittadini si recò dal commissario di Pubblica sicurezza Stagno, ma non riuscirono a parlargli. Migliore fortuna ebbero, il giorno dopo un bel gruppo di donne che non si limitò a chiedere di essere ascoltate, ma inscenò una manifestazione gridando “Non vogliamo i coatti”. Questa volta Stagno non poté fingere che non c’era anche perché quelle dichiaravano che non se ne sarebbero andate via finchè non gli avessero parlato.
La provocazione
Così si fece sulla porta e cercò di rasserenarle. Ma non c’era verso. Queste volevano l’impegno che non ci fossero nuovi ospiti al Castello e Stagno questa garanzia non poteva darla. Così ad un certo punto perse la pazienza ed esclamò:
“Ma perché ce l’avete tanto con i coatti? Certo fra voi ci sono anche figlie di coatti”. La frase cadde un macigno in mezzo alla schiera e subito si fece silenzio. “Chi dissi..chi dissi…”, domandavano quelle che si trovavano più in dietro e non avevano capito bene.[3]L’offesa era così pesante che il gruppo si ritirò. E parlottando fra di loro se ne tornarono ai propri impegni. Ma l’eco dell’insulto non si spense. Passò di negozio in negozio, di casa in casa e nel lavorio del passa parola divenne sempre più pesante ed insultante. “Il commissario ha detto è giusto che vengano i coatti perché a Lipari sono tutti coatti e figli di coatti”.
Massoni e preti si mobilitano
La sera arrivò silenziosa e tranquilla come era una sera d’agosto in una Lipari che non conosceva ancora il frastuono delle macchine e degli altoparlanti. Serena per le strade ma vivace nelle case . Nella villa dei De Mauro a Diana vi erano riuniti i massoni iscritti alla due Logge; alla Cattedrale vi era riunito il Capitolo al gran completo con l’Amministratore apostolico mons. Ballo con la motivazione che si doveva parlare dell’imminente festa di San Bartolomeo. L’Amministratore disse poche parole poi rimasero tutti in silenzio e poco dopo arrivò Nunzio Esposito, un uomo che la Chiesa – commenta Paino – se l’era dimenticata da un pezzo, inviato dalle due logge. Ballo gli andò incontro fraternamente, parlottarono fra loro e poi si abbracciarono congedandosi.
Nella casa di Diana - subito dopo - parlò solo il dottor De Mauro, disse poche parole e poi tutti gli ospiti uscirono alla spicciolata ognuno con un compito ben preciso. Il messaggio da portare in tutte le frazioni era semplice. “All’indomani mattina muniti di tutti gli attrezzi che avevano: pale, picconi, randelli ma non armi da fuoco, dovevano scendere a Lipari ed, al suono delle campane, dare l’assalto al Castello”.
Quella mattina del 19 agosto
E così sorse la mattina del 19 agosto[4]. Tutte alla stessa ora le campane delle chiese di Lipari suonarono a distesa e da Santa Lucia, dal Vallone, dalla Marina lunga la gente arrivava a flotte ognuno con alla spalla un attrezzo dei campi, gridando “Non siamo coatti e non vogliamo i coatti”. Una massa enorme circondò il Castello ma il Commissario avendo intuito cosa stava succedendo diede ordine di chiudere l’unica entrata e di piantonare la grande porta di diversi quintali mentre lui si trincerava nell’ospedale che era nel vecchio palazzo vescovile accanto alla Cattedrale. Vi era anche un’altra entrata al Castello, la scalinata che da via Garibaldi porta alla Cattedrale, ma questa era barricata perché il muro che era crollato non era stato ancora riparato. Comunque anche questa via era stata piantonata ed era stata affidata ad un sottufficiale liparese che non capiva cosa stava succedendo.
La gente intanto si era ammassata all’entrata chiusa dal portone e non sapeva che fare. Un giovane di diciassette anni disse che aveva un piano. Gli si fecero intorno alcuni uomini ed alcune donne ed egli spiegò che da quella parte non si poteva fare niente ma bisognava tentare dalla scalinata. Bisognava concentrare lì una parte dei dimostranti e tenerli nascosti per non insospettire le guardie e mentre un gruppetto di donne davano discorso al piantone per distrarlo, lui ed un altro ragazzo, il Belletti, si sarebbero aperti un varco nel vicolo sbarrato ed avrebbero tagliato i fili si ferro che bloccavano l’accesso alla scalinata. Finita l’opera il Belletti lancia un grido alle donne e mentre il piantone si allontana per vedere chi ha gridato, il varco si apre e prima le donne e poi gli uomini irrompono urlando e prendendo di sorpresa i militari che sembrano sbandati e non capiscono che cosa è successo. I dimostranti corrono subito al portone dell’entrata principale, tagliano i cardini, lo divelgono e lo gettano in mare. Cominciò così la distruzione delle case e casupole che si stavano riadattando per i nuovi relegati.
Sette ore per distruggere tutto
“Sette ore – commenta Pino Paino - durò la distruzione del Castello e quando l’ultimo degli insorti si ritirò, sembrò che fosse passato di nuovo il Barbarossa. Solo che questa volta nessuno piangeva come allora, che anzi era ognuno felice di sentirsi nato”.
All’indomani, navigli di guerra, truppe e rinforzi di polizia giunsero da Messina e Milazzo ponendo l’isola in stato di assedio. Furono operati numerosi arresti e De Mauro fu condotto in catene a Messina. Il fratello Giovanni, capitano dei bersaglieri e presidente degli invalidi e mutilati di guerra, fece inviare un telegramma a D’Annunzio che aveva conosciuto nei lunghi anni di guerra del Carso, chiedendogli giustizia per la sua isola “poeticamente bella”. E alcuni giorni dopo il dott. De Mauro tornò a Lipari in libertà, tra le ovazioni della sua gente che continuò a curare come medico, finché non si trasferì a Messina, dove istituì una clinica che portò per lungo tempo il suo nome[5].
Non erano i coatti ma i politici antifascisti destinati al confino
Era vero che il Governo pensava a Lipari come luogo di detenzione. Ma non per i delinquenti comuni come era avvenuto per lo più nel passato. Questa volte si aveva in mente un confino tutto politico sulla base del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che sarà promulgato il 6 novembre 1926[6]. E’ l’articolo 184 che recita: “Possono essere assegnati al confino di polizia, con l’obbligo del lavoro, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1. gli ammoniti; 2. coloro che abbiano commesso, o manifestato il deliberato proposito di commettere, atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici, costituiti nello Stato e menomarne la sicurezza.”
[1] Queste pagine sono tratte da www.archiviostoricoeoliano.it .
[2] Sulla vicenda abbiamo la fotocopia di una memoria stilata da Belletti Antonino il 10 febbraio del 1989 di anni allora 74 e quindi 11 anni all’epoca degli avvenimenti. Inoltre, sempre sulla vicenda, Pino Paino ha pubblicato una memoria in appendice a L.S. d’Austria, Le isole Lipari, vol.VIII, Parte generale.
[3] La versione che abbiamo deciso di seguire è quella di Pino Paino. Il Belletti né dà una differente. L’episodio del commissario con le donne sarebbe avvenuto al Castello il giorno della sommossa e la risposta di Strano avrebbe scatenato la violenza. Dette quelle parole sarebbe stato “preso come un sacco di patate per buttarlo fra gli scogli sotto il Castello ma l’intervento del medico De Mauro gli salvò la vita. A questo punto cominciò la distruzione”.
[4] Nella memoria di Belletti si dice che fu il 27 agosto il giorno della sommossa.
[5] P.Paino, Francesco De Mauro e gli altri nei Vespri di Lipari del ’26, in L. S: d’Austria, Le isole Eolie, vol. VIII, op. cit.
IL PLAUSO.
di Maurizio Mandarano
Gentile Direttore, voglia pubblicare queste poche righe per esprimere il mio sentimento di apprezzamento nei confronti del Dott. M. Giacomantonio, per la sua rubrica dedicata alla storia eoliana; un lavoro svolto da uno storico appassionato che ci aiuta a conoscere tanti particolari legati al passato delle nostre isole. Tra l'altro ho acquistato e letto il suo "Navigando nella storia delle Eolie", e l'ho trovato, oltre che interessante, anche esaustivo nella sua trattazione storica.
Complimenti.
Bartolomeo da Lentini, il vescovo dei Vespri
Bartolomeo da Lentini e le difficoltà ad insediarsi
Abbiamo detto che il 17 aprile del 1255 papa Alessandro comunica al popolo della diocesi di Lipari-Patti di avere consacrato vescovo Bartolomeo da Lentini che era stato nominato già l’anno precedente. Ma anche ora, malgrado Filippo non lo possa più ostacolare, Bartolomeo non riesce a prendere possesso della sua diocesi. Messina come altre città della Sicilia si era ribellata al re e si era costituite in repubblica e lo stradigoto di Messina, Leonardo Aldigieri, avventurandosi in una gestione tutta familistica del suo ruolo, nomina il proprio figlio Matteo che era chierico, amministratore della diocesi di Lipari-Patti. E malgrado il papa spedisca tre lettere[1] per sostenere Bartolomeo – una esaltandone il ruolo concedendogli la facoltà di assolvere chi era colpito dalla scomunica contro Federico; la seconda ai fedeli della diocesi perché lo accolgano come loro vescovo; e la terza agli Aldighieri perché restituiscano la chiesa a Bartolomeo – Matteo lascerà la diocesi solo quando Messina verrà riconquistata dagli svevi, la repubblica si dissolverà e lui verrà arrestato. Ma anche questa volta non sarà Bartolomeo a prenderne possesso ma un funzionario laico del re, Leone di Pardo, in qualità di procuratore della diocesi[2].
E’ ancora il papa ad intervenire a beneficio di Bartolomeo. Alessandro si rivolge all’arcivescovo di Palermo perché recuperi i beni - che “il fu Filippo, che si faceva passare per vescovo di Patti, di fatto trasferì” - e li recuperi per conto del vescovo Bartolomeo che dimora a Roma. Il fatto che il papa invochi l’intervento del vescovo di Palermo e non quello di Messina come sarebbe logico. visto che è il metropolita della diocesi di Lipari-Patti, è perché lo ritiene un migliore interlocutore nei confronti del re Manfredi[3]. Ma Manfredi non vuole riconoscere il vescovo nominato dal papa e così prima agisce tramite il procuratore Leone di Pando e poi nomina vescovo Bonconte di Pendenza nel maggio del 1261.
I traffici di Bonconte
Questo Bonconte doveva essere un personaggio poco affidabile, venale e trafficone. Dopo avere spremuto Patti e Lipari – badando bene di farsi rilasciare degli attestati che quanto davano i locali lo davano di loro spontanea volontà[4] - egli si trasferiva nel Lazio e nella Sabina dove concludeva affari personali e politici non sempre limpidi[5]. E sono questi affari illeciti che spingono Bartolomeo a rivolgersi al papa Urbano IV che era succeduto ad Alessandro. E Urbano il 7 luglio del 1264 denuncia Bonconte al podestà di Rieti accusandolo “con i proventi della suddetta chiesa di Patti compra estesi e vasti poderi e, soggiornandovi pubblicamente a suo piacimento, ma uomo pestifero e manifesto sostenitore dello stesso persecutore ( Manfredi) ha l’ardire di conchiudere ogni giorno in quella città perversi intrighi con alcuni Nostri cittadini e non esita di fare occultamente altre cose che potrebbero portare alla sottomissione della stessa città ( Rieti) e un notevole danno per la Romana Chiesa”[6]. Ancora un paio di anni e poco più e il 26 febbraio del 1266 a Benevento il re Manfredi viene sconfitto dalle armate di Carlo d’Angiò e Bonconte, finalmente, si rassegnò ad abbandonare Patti, scomparendo, per cui finalmente il vescovo Bartolomeo da Lentini poté prendere possesso della sua diocesi.
“Una vicenda del tutto singolare[7]” la definisce Luigi Pellegrini, quella del vescovo Bartolomeo. “Da tale vicenda si evince – osserva- come lo stato di confusione creatori in Italia meridionale dopo l’avvento di Manfredi abbia influito anche sulle possibilità di comunicare tra la curia romana ed i suoi inviati nel Regno ed abbia indotto elementi di scompiglio anche nella nomina dei vescovi”[8].
Alla morte di Federico i suoi eredi non riescono a stabilire un modus vivendi con la Santa Sede che ad essi preferisce i Comuni ed il regno di Francia e sarà proprio il fratello del re di Francia, il conte d’Angiò, che nel 1266, scende in Italia meridionale e, sconfitto Manfredi, figlio illegittimo di Federico, nei pressi di Benevento, si impossessa del regno. In Sicilia il dominio angioino durerà però poco perchè il lunedì di Pasqua 1282, una provocazione abbastanza banale provoca contro gli Angioini la sommossa nota come “Vespri Siciliani”. Umiliati dall’occupazione dei nuovi conquistatori e dal duro fiscalismo angioino, i siciliani massacrano migliaia di francesi.
Il governo dell’isola viene affidato al genero di Manfredi, Pietro III d’Aragona che era uno degli istigatori della rivolta con il sostegno dell’imperatore bizantino Michele Paleologo.
Bartolmeo promuove i Vespri
Conviene soffermarsi sui Vespri perché vi giocò un ruolo di rilievo proprio il nostro Bartolomeo da Lentini. Bartolomeo riuscì a prendere possesso della sua diocesi, abbiamo detto, solo nel 1265 dopo dieci anni di esilio trascorsi nei conventi del Lazio e presso la Curia pontificia. All’inizio del 1266 quando Carlo d’Angiò batteva Manfredi a Benevento , Bartolomeo era già all’opera rivendicando le terre della sua chiesa e cercando di rimediare ai guasti di oltre dieci anni di abbandono. E quest’opera di regolarizzazione della diocesi continuò - malgrado fosse un vescovo per lo più assente che viveva la maggior parte del suo tempo nel Lazio - ristabilendo buoni rapporti con Carlo d’Angiò ed approfittandone perché concedesse la riattivazione dei porti di Patti e di Lipari e Vulcano a favore del commercio locale. Tornò a vivere nella diocesi nel 1276 ma si trovò di fronte a molte resistenze degli abitanti che si sentivano vessati sotto l’aspetto economico da tasse e balzelli del regno e cercavano di compensare non pagando quanto dovuto al vescovo.
Vivendo nella sua diocesi e fra la gente Bartolomeo si convince delle loro buone ragioni e si immedesima nelle loro condizioni di vita facendosi portavoce delle loro angustie contro le malefatte delle signorie. Allo stesso tempo va prendendo le distanze dal re che viveva lontano dalla Sicilia e soprattutto a Roma ed Orvieto presso la corte pontificia specie da quando, nel febbraio del 1281, era salito al trono pontificio il francese Martino IV.
E fu così che nella primavera del 1281, Bartolomeo con il confratello Bongiovanni Marino, accettano la missione di farsi ambasciatori delle istanze dei siciliani. Si recano ad Orvieto per rappresentare al papa le lamentele ed alla corte papale i due inviati trovano anche il re Carlo d’Angiò che vuole assistere alla loro esposizione.
Bartolomeo non è per nulla intimorito da questa presenza, forse inattesa, ma comincia la sua perorazione richiamandosi al vangelo di Matteo ed all’invocazione che la donna cananea rivolge a Gesù: ” Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio”. Quindi aggiunse “Se le lunghissime guerre, se la rivoluzione dei popoli, se gli umori vari e diversi del regnare oppressero la Sicilia nei tempi passati, nessuna di queste calamità è paragonabile a quella che viviamo oggi, perché questi furono momenti felici paragonati con le miserie di oggi. La Sicilia fu memorabile per le molte ricchezze e la sua potenza, per l’antichità e nobiltà delle origini, per la gloria delle cose fatte. Oggi invece è tanto umile e abietta che essa stessa ne prova vergogna, ha sopportato per molto tempo le acerbe crudeltà fino a quando non si è oltrepassato il segno dell’onore, per cui vedendosi privata di quello, a voi Re Carlo si richiama e anche a voi Martino , pontefice massimo. La Sicilia, ultima nel gregge cristiano, si raccomanda a voi per essere protetta dalle rapaci Arpie e dalle acute e velenose zanne dei fieri lupi”[9]. E dopo questo “incipit” Bartolomeo proseguì con energia e coraggio esponendo le ingiustizie, le rapine, le libidini, le tirannie, che in Sicilia si praticavano da parte dei ministri del re e dai nobili e funzionari francesi[10].
Il risultato di tanto impegno fu che i due ambasciatori furono arrestati e buttati in prigione. Bartolomeo riuscì a fuggire pagando i carcerieri mentre il suo confratello, meno fortunato, vi perì . Scampato dal carcere Bartolomeo si tenne lontano dalla sua diocesi fino a quando scoppiarono i Vespri e i francesi furono cacciati dalla Sicilia. Allora il vescovo tornò a Patti ma senza frequentare Lipari che era rimasta angioina. Morì nell’estate del 1282 o nel primo semestre del 1283.
[1] G:Iacolino, Le Isole Eolie…, libro II, op.cit., pp.284-286.
[2] G.Iacolino, idem, pag. 287.
[3] Idem, pag. 288-9.
[4] Per Lipari vi è un atto notarile del 3 settembre 1261 che manifesta questa “liberalità” dei liparesi con atto pubblico“perché in qualcuno non sorga dubbio circa la forma e la natura di questo donativo e offerta”, in G. Iacolino, op.cit., pag 293-4.
[5] Idem, pag. 295.
[6] Idem, pag. 297.
[7] L.Pellegrini, “Che sono queste novità?”. Le religiones novae in Italia meridionale (secoli XIII e XIV), Napoli 2005, pag.99.
[8] Idem, pag. 99.
[9] G. Iacolino, Le Isole Eolie, vol II, op.cit. pag. 312-313; F. Mugnos, I ragguagli Historici del Vespro Siciliano, Palermo, 1645, pp50-51;
[10] P. Campis, op.cit. , pagg 233.
---Le consuetudini : norme locali. Il libro delle Corrie.
Fin dal tempo dell'Abate Ambrogio erano venute definendosi nel territorio delle "consuetudini"[1] che riguardavano la civile convivenza ed in particolare la disciplina dei pascoli, la regolamentazione dei diritti di famiglia, la divisione dei beni le esecuzioni testamentarie, il rapporto locativo, ecc. Nei primi decenni del XIV secolo queste norme locali vennero redatte in iscritto in lingua latina, raccolte e sistematizzate in un unico testo che purtroppo non ci è pervenuto nella forma originaria ma solo in una trascrizione del XVIII secolo contenuto nel Libro delle Corrie col titolo "Consuetudines scripte huius civitatis Lipare"[2]. Riteniamo che questa prima stesura debba risalire ai primi decenni del trecento perché portano la data del 1312 le Consuetudini di Patti. Ma a differenza di quest'ultime che furono ratificate dal re, le consuetudini di Lipari lo furono da parte del vescovo anche se, non conoscendo la data della loro ratifica, non conosciamo nemmeno il nome del vescovo.
Per renderci conto del tenore di queste norme pubblichiamo alcuni stralci del documento. A proposito degli affittuari o coloni morosi: "Il locatore di case o di altri immobili propri, se l'affittuario o il colono non paga il canone al locatore della casa o dell'immobile, il locatore stesso può, di sua iniziativa, entrare e appropriarsi di un pegno corrispettivo a quanto gli è dovuto".
A proposito della vendita diretta : "Qualsivoglia persona...può ogni anno, uccidere e vendere al macello tre bestie del suo allevamento liberamente e senza tasse, e può vendere, per ogni rotolo, ad un denaro in più di quanto vende un macellaio".
Particolarmente rigorosi si era rispetto ai danni provocati dai propri animali – buoi, pecore, capre, maiali, asini – alle vigne, alle messi, agli ortaggi di terzi per incuria. Per ogni tipo di coltura è specificata una ammenda. Una eccezione era prevista per gli animali lattanti sorpresi con la madre, in terreni di terzi che non erano sottoposti a nessuna penalità. Per le bestie da ovile, pecore e capre in particolare, si procedeva a multarli per centinai di capi.
Il toponimo "sotto il palo"
Se i responsabili dei greggi non erano individuati, il baiulo ordinava che le bestie fossero condotte nei pressi della città e raccolte in un apposito recinto. Questa zona si trovava dove oggi vi è piazza Mazzini, lungo il margine orientale e per questo la spianata della Civita veniva chiamata "carcere animalium" o più comunemente "palium" che significava largo, spiazzo, radura da cui il toponimo "sotto il palo" che è giunto fino ai nostri giorni.
Se invece non si trattava di greggi ma di pochi capi come accadeva per i maiali la norma era diversa:"Se un uomo o una donna alleva porci di 'mannara'... e questi porci vengono sorpresi in orti o vigne senza pali né recinzione, ai padroni delle vigne e degli orti – dopo aver prima diffidato i padroni dei porci a tenerli a bada perché non arrechino danno ai vigneti e agli orti – è data facoltà di chiedere al baiulo l'autorizzazione di potere liberamente abbattere questi porci; i porci stessi, così uccisi, resteranno di proprietà del possessore e padrone delle vigne e degli orti a titolo di risarcimento del danno subito; al baiulo però spetta – in ragione di ogni capo ucciso – un quarto e la testa".
[1] Questo paragrafo è stato redatto sulla base di quanto a questo proposito ha scritto Giuseppe Iacolino in Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla rifondazione della communitas eoliana alla battaglia di Lipari del 1339, (Lipari, 2001 pp. 212-215) e La fondazione della Communitas eoliana agli albori della Rinascenza (1095- 1995), (Lipari, 1995. pag. 61-63).
[2] G.Iacolino, Le isole Eolie..., op.cit., pag. 213-216. "Il libro delle corrìe" si trova presso la biblioteca del Museo Archeologico regionale Bernabò Brea di Lipari, come correttamente è riportato in G.A.M. Arena, Bibliografia Generale delle Isole Eolie, Società Messinese di storia patria, Messina, 1985, pag. 210.. Ma a differenza di quanto riporta l'Arena che parla di 582 pagine, la copia che abbiamo visionata è composta di 250 fogli e quindi da 500 pagine. Esso – sempre secondo Arena – sarebbe il registro della Corte Capitaniale di Lipari in cui si trovano copiati numerosi atti che furono di fondamentale importanza per l'economia e la vita sociale delle Isole Eolie. Ed appunto fra questi atti, al foglio 212 sono copiate le Consuetudines scripte huius visitati Liparae. Per il resto il libro contiene lettere ed ordinanze che vanno dal 1574 al 1785. Sempre al Museo, afferma C.M. Rugolo (Il recupero della memoria. I codici dei Capitoli e Privilegi Lipari, in Bulletino dell'Istituto Storico italiano per il Medioevo, n. 105, 2003, pp 404-426), che sembra non sapere niente del Libro delle corrìe perché non ne parla, esisterebbero invece tre codici manoscritti: il primo, indicato con la lettera B, di 83 carte, in pessimo stato di conservazione. Esso contiene i privilegi concessi alla città di Lipari fino alla prima metà del XVI secolo e ricalca fedelmente il contenuto del Libro verde o dei privilegi che si trova nella Biblioteca comunale di Lipari ( contrassegnato dalla Rugolo con la lettera A). Entrambi i due libri avrebbero come origine la Camera di Sommarìa di Napoli. Avrebbero invece come origine la Regia Cancelleria di Palermo altri due codici, contrassegnati dalla Rugolo con le lettere C e D, che si trovano anch'essi presso la biblioteca del Museo Archeologico. Il codice C composto da 18 carte ha una copertina in cartone con il titolo Libro de' privilegi, gratie, franchezze, etc. riconduce immediatamente ad un esemplare del 1613 che a sua volta rimanda ad un archetipo perduto del 1519. Il codice D composto di 84 carte evidenzia il proprio carattere di uso quotidiano, una copia di rapida consultazione. Il Libro dei privilegi o libro verde che si trova nella biblioteca comunale di Lipari è composto di 60 carte ed è certamente la copia redatta dalla Camera della Sommarìa di Napoli a metà del 500. All'inizio del libro oltre lo stemma asburgico vi è lo stemma di Lipari. Infine vale la pena segnalare che presso la Biblioteca comunale di Lipari vi è anche un altro manoscritto chiamato Libro rosso citato da Arena ma non citato dalla Rugolo. Questo libro rosso, secondo Arena, contiene gli atti dell'Università di Lipari dal XVI al XVIII secolo e sarebbe composto da 388 fogli. Iacolino a margine di una fotocopia selettiva di questo libro definita, raccolta antologica, dice che contiene decreti vicereali e "banni" del Comune dal 1620 al 1720 circa, non perfettamente ordinati, né tutti al completo. Le pagine che Iacolino indica sarebbero 373.(Archivio storico eoliano.it)
Tags:
Il libro delle Corrie
Il libro dei Privilegi
Sotto il Palo
---La creazione della municipalità a Lipari
Lo strutturarsi della municipalità in Sicilia
Nel periodo che va dal XIII al XV secolo, il fuoco della nostra storia delle Eolie non sta più nelle vicende della diocesi quanto nello strutturarsi della municipalità nell'ambito di un processo che investe tutta l'Europa, a partire dal secolo XI, e che ha il suo dinamismo nell'urbanesimo e nell'emergere di nuovi ceti sociali in particolare nelle realtà urbane. Continuerà la signoria feudale dei vescovi nell'ambito del regno che vedrà succedere agli svevi prima gli angioini e poi gli aragonesi, ma andrà maturando ed emergendo, all'interno di questo potere, una autonomia richiesta dalla società civile.
"Il Comune – osserva Mario Ascheri[1] - non fu voluto né dall'impero né dalle sue autorità locali legittime – vescovi, conti, marchesi - ; non ebbe un ordinamento calato dall'alto, ma fu una creazione nuova, autonoma venuta su dal basso tra mille difficoltà, passo dopo passo, anche in modo inizialmente provvisorio, a tempo, e che peraltro non potè che legittimarsi da sé, come avviene per ogni fatto rivoluzionario".
Da noi, a differenza di quanto avvenne ad esempio in Lombardia, non si trattò di autodeterminazione politica sull'onda di un conflitto, più o meno cruento, con i poteri costituiti come l'Impero, ma piuttosto del manifestarsi di una autonomia che portò – sostanzialmente in accordo col vescovo ed il re quando non addirittura da questi promosso - ad un autogoverno dei problemi cittadini in relazione ad attività che integrano quelle previste dall'ordinamento, rimediando alle sue carenze.
Vero è, come abbiamo visto nel capitolo precedente, che nel 1199 il vescovo Stefano deve piegarsi alle proteste dei possessori dei terreni in enfiteusi di Salina ed Alicudi che richiedevano la concessione libera e gratuita di questi. Ma, per quello che sappiamo, siamo in presenza qui di un conflitto circoscritto ed eccezionale che proprio per questo viene registrato dal Campis. Un conflitto che, per'altro, ben presto rientra col pentimento di chi l'aveva promosso.
Ben più interessante è il documento che ci parla del giudizio, sempre del vescovo Stefano, tenuto a Lipari nel marzo del 1190 contro dei razziatori di falconi che conferma la presenza nell'isola di uno stradigoto e di un certo numero di incaricati di avanzare richieste di natura amministrativa alla corte di giustizia del vescovo e verosimilmente anche alla corte del re quando il contenzioso investe lo stesso prelato, come emerge da un altro documento del settembre del 1191 riguardante gli abitanti di Patti a proposito dei terreni di Librizzi. Da questi documenti si palesa che già sul finire del XII secolo si ha nell'ambito del vescovato di Lipari- Patti, la "presenza di un ceto di piccoli proprietari e operatori locali impegnati attivamente nell'esercizio di diritti elettivi e nella conquista di spazi autonomi di governo"[2] .
Difficile è però parlare, a proposito di questi, di organismi municipali in qualche modo distinti dagli uffici del Vescovo.
Federico II e i "giurati"
Per tutta la durata della dinastia normanna e nei primi decenni della dominazione sveva (sino al 1230) non ebbero, infatti, i comuni siciliani organismi che fossero abilitati a deliberare in piena autonomia nell'interesse della collettività. Bisogna giungere all'avvento dell'imperatore Federico II (1198 – 1250) - primo re di Sicilia di questo nome – perchè si riscontri il termine "giurato". Fu il titolo che si cominciò a dare a taluni boni homines de melioribus terrae, i quali scelti dal re stesso e dopo aver giurato sui Vangeli fedeltà alla corona, assumevano precise minute incombenze da espletare nell'ambito delle singole terre e città: di polizia monetaria, di repressione delle frodi mercantili, di vigilanza sulla corretta applicazioni delle consuetudini. Di giurati a Lipari si parla in documenti del 1222 e del 1231[3].
Federico nel 1231 – dopo aver ristabilito la pace col papa ed avere ricondotto sotto la sua autorità i baroni ed i saraceni - emana le Costituzioni di Melfi, chiamate anche Liber Augustalis[4]. Come per Federico anche su queste Costituzioni abbiamo giudizi contraddittori. Per qualcuno siamo di fronte a leggi del primo stato moderno d'Europa[5], per altri invece di fronte ad "una combinazione ben dosata di fonti romane, canoniche e feudali", ma sostanzialmente prive di originalità[6]. E' certo comunque che si tratta del primo grande codice del Medioevo che introduce nella legislazione, pur fra contraddizioni ed una forte tendenza centralistica, elementi di modernità. Infatti, Federico superando la concezione feudale germanica, ritorna alla tradizione romana affermando l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; elimina il potere dei baroni, del clero e delle città, e tutte le funzioni giuridiche ed amministrative vengono esercitate dal re per mezzo di una organizzazione burocratica centrale, posta alle sue dipendenze; i magistrati sono stipendiati dallo Stato ed eletti per un solo anno, salvo riconferma; per garantire gli introiti necessari alla vita del regno crea un saldo sistema finanziario, basato sulle imposte dirette, con organi incaricati della riscossione; organizza inoltre un esercito regolare di saraceni, per non dipendere dai baroni e dai comuni che spesso si sottraevano agli obblighi di fornire la milizia.
Gli organi centrali sono il Sovrano, i grandi ufficiali della Corona, la Magna Curia ed il Parlamento. Al vertice sta il re, il solo che possa fare le leggi, dal momento che il suo potere gli deriva direttamente da Dio. Al suo fianco stanno i grandi ufficiali della Corona, i moderni ministri con funzioni ed attribuzioni ben definite. I ministri non sono scelti tra i nobili feudali, come avveniva in passato, ma tra la gente di cultura, come notai e giuristi. La Magna Curia, rappresenta la Suprema Corte di Giustizia, con funzioni ispettive e di controllo su tutti i funzionari. Il Parlamento, infine, era un'assemblea generale alla quale potevano partecipare, i feudatari, i rappresentanti delle Università, ed i Comuni demaniali, per essere messi a conoscenza delle leggi promulgate dal sovrano e non per discuterle od approvarle. Potevano però fare presente eventuali necessità.
Ai Parlamenti generali o Curie, fanno riscontro le assemblee provinciali, presiedute da un giustiziere.
I comuni aspiravano evidentemente ad avere una certa autonomia, come le città dell'Italia settentrionale; ma Federico non poteva certo concedere alle città siciliane l'autonomia che vantavano i comuni del nord che andava combattendo. Pur tuttavia non poteva ignorare le istanze di autonomia che si andavano diffondendo col rischio che se ne facesse portatore, in contrapposizione a lui, il papa che rivendicava la signoria sul regno di Sicilia, così volle che nei più importanti centri abitati del regno si desse vita ad un sistema amministrativo municipale stabile e confortato dai crismi del diritto pubblico caratterizzato da tre giudici e sei notai. I notai, come i baiuli ( funzionari regi a cui spettava di deliberare circa le lamentele contro i feudatari; una figura introdotta nella Francia del nord sul finire del XII secolo) erano allora considerate non come attività autonome a sé stanti ma componenti del corpo municipale. I notai fungevano da consulenti legali accanto ai giudici e così anche i baiuli se preparati culturalmente.
Il formarsi delle istituzioni municipali a Lipari
Fino a qualche anno fa non era possibile sostenere che a Lipari fosse stato attivato, secondo le disposizioni di Federico, un corpo municipale. E' solo nel 2002 che il prof. Iacolino[7] viene in possesso, nella sua integrità sebbene si tratti di un trascritto, di un documento – un atto notarile – del 22 maggio del 1246 in cui nell'intestazione può leggersi: "Noi Bartolo de Bruno, Amico de Aldimerio, Benedetto de Maracita, giudici di Lipari,....". Sempre questo documento ci dice che a Lipari c'è anche il baiulo di cui si fa il nome, Andrea Saurano, ed il notaio che però è morto e viene sostituito, nella redazione del verbale, da un notaio messinese. La presenza di questi funzionari non intaccavano il potere del vescovo giacchè venivano da esso nominati come risulta da un documento contenuto nell'Archivio Capitolare di Patti riguardante il vescovo Bartolomeo di Lentini dove è detto espressamente che egli "creò e istituì il baiulo, i giudici, gli avvocati, gli accattapanos, e gli altri ufficiali della città di Patti" e che questi ufficiali prestarono al vescovo giuramento di fedeltà. E se questo avveniva per Patti doveva, ugualmente, avvenire per Lipari.Il documento aggiunge che questa prerogativa di creare ed istituire gli ufficiali di città era stata anche dei predecessori di Bartolomeo.[8]
La figura del baiulo, che sovraintende alle funzioni giudiziarie, non intacca, ripetiamo, le prerogative del vescovo e della sua curia ai quali rimangono, come vedremo, un'ampia competenza.. Inoltre spettavano al vescovo la maggior parte delle cause dette di "misto foro" di cui parleremo più avanti..
Probabilmente, ritiene Iacolino, risale ai primi decenni del XIII secolo la creazione dello stemma civico cittadino[9] che riproduce il castello con le tre torrette allora esistenti e l'immagine di S. Bartolomeo sulla porta del Castello.
Più, tardi, presumibilmente nella prima metà del XIV secolo a Lipari compaiono anche i giurati, accostati o subordinati ai giudici. Si trattava di una figura che aveva istituito Federico nel 1222, ancor prima delle Costituzioni di Melfi, con una ordinanza per le città di una certa importanza. Si trattava di scegliere due o più boni homines da affiancare ai giudici per controllare la qualità e i prezzi di generi alimentari in vendita, di indagare sulle frodi monetarie, di verificare la "legalità" dei prodotti farmaceutici e sciroppi. Siccome queste persone giuravano prima di affrontare il loro incarico vennero chiamati giurati. Di fatto i giurati godevano di pari dignità dei giudici infatti alcune lettere redatte da Federico d'Aragona e dai suoi funzionari fra il 1355 e il 1356 sono indirizzate ai giurati ed ai giudici della Città di Lipari.
Nel corso del XIV secolo i compiti dei giurati furono trasferiti ai catapani, chiamati a svolgere pressa a poco la funzione che hanno oggi i vigili urbani, mentre furono i giudici a chiamarsi giurati ed infatti solo ai giurati di Lipari si rivolge una lettera della Curia reale del 6 maggio 1392.[10]
La competenza del vescovo nella nomina di questi funzionari dovette durare forse fino alla fine del XVI secolo. Abbiamo un riscontro storico del 1618 che ci informa che la loro elezione era passata all'assemblea popolare e cioè ai nobili e ai possidenti, mentre al vescovo era riservata soltanto la scelta del candidato del baiulato.[11].
E' importante capire quando si ha il passaggio dell'amministrazione cittadina, almeno per alcune importanti funzioni, dalle mani degli officiali regii a quelli di organi elettivi[12], perché a questo processo è legato un importante salto di qualità nella universitas ed il delinearsi di un ceto medio che diventa classe dirigente. Inoltre questo processo a Lipari risulta più complicato perché fra il re e l'universitas c'è il ruolo e la figura del vescovo che assomma in sé alcuni compiti del re ed essendo figura prossima alla comunità ritarda in qualche modo anche il processo di crescita autonoma della universitas.
"Consuetudini, privilegi, fiscalità locale, istituzioni elettive divenivano il nucleo di identità cittadine che esercitavano un controllo sul territorio, contendendolo all'aristocrazia fondiaria , e si esprimevano essenzialmente intorno a un ceto dirigente composito ma che si presentava collettivamente come espressione della città. L'apparato istituzionale della città rappresentava il luogo in cui questo certo eminente si cristallizza e si aggrega"[13].Questo apparato varia di luogo a luogo e da luogo a luogo variano le competenze ed i poteri delle specifiche figure[14]. Comunque in genere la nuova élite cittadina espressione della universitas è formata dal baiulo ( a Lipari abbiamo visto che il baiulo è nominato dal vescovo fino al XVII secolo) , da un gruppo di giudici e da giurati elettivi, da funzionari subalterni , nominati permanentemente o ad hoc per lo svolgimento di compiti specifici: sindaci (ambasciatori), notai degli atti della curia baiulare, tesorieri e razionali creati per diversi compiti che andavano dalle costruzioni delle mura all'annona. In questa élite in senso lato rientrano pure gli appaltatori delle gabelle cittadine, i veri arbitri della fiscalità e del debito pubblico della città[15].
Col tempo una certa dialettica si crea fra i dirigenti espressioni della universitas e quelli espressione dell'autorità regia ed in particola con il capitano regio. Il capitano regio, titolare della giustizia criminale, era depositario di un potere di enorme rilievo, e per questo i dirigenti locali tendono a limitarlo chiedendo al sovrano o un controllo maggiore sul suo operato o di circoscrivere la sua autorità. Più tardi si chiederà che la carica vada ad uno del luogo[16].Nelle realtà, come Lipari, in cui il baiulo non era elettivo esso non assumeva il ruolo di coordinamento della curia civile, ed il ruolo preminente nella rappresentanza della comunità veniva assunto dai giurati quando con Federico III nel 1312 viene affermata la loro designazione per elezione.
Il complesso rapporto fra poteri: vescovo, amministratori locali, autorità regia.
Si è detto che il rapporto fra i poteri a Lipari risulta più complicato ed in qualche modo anomalo per la particolare autorità del vescovo che "gioca un importante ruolo di mediazione istituzionale con evidenti riflessi nella gestione del governo locale"[17]. Questo si rivela in particolare sul piano giudiziario.
Come abbiamo visto ai giurati spettava – soprattutto quando sono divenuti organi elettivi – la rappresentanza ufficiale della città, l'amministrazione locale degli uffici e del patrimonio, nonché l'esercizio della giurisdizione civile attraverso una corte presieduta dal baiulo con l'assistenza di un giudice assessore. La corte capitaniale, presieduta dal capitano d'armi o governatore, anch'esso provvisto di un giudice togato, esercitava la giurisdizione penale: un fiscale svolgeva le funzioni di pubblico accusatore nei procedimenti ex officio, notai e maestri d'atti curavano la redazione formale dei processi, i serventi avevano funzioni esecutive e di notifica degli atti giudiziari. Infine vi era la curia vescovile che in qualche modo incideva sulle due corti laiche. Nell'ambito della giurisdizione civile, essa era titolare per antico privilegio del diritto d'appello sulle cause decise dalla corte baiulare e, per suo tramite, le cause potevano in ultima istanza essere trasmesse al Sacro Regio Consiglio presso la corte. Riguardo alla giurisdizione criminale la giustizia ecclesiastica si interessava degli ecclesiastici in senso lato comprendendo familiari e servi; tutte le cause in cui veniva coinvolto in qualche modo un appartenente al foro ecclesiastico ed infine, come abbiamo detto,le cause mixti fori[18] cioè reati che riguardavano sia il codice civile sia quello ecclesiastico come il concubinato, la bigamia, l'adulterio, lo stupro, l'incesto, il lenocinio, le pratiche superstiziose, la bestemmia e persino gli approcci amorosi e lo stesso bacio che finiva coll'assumere la figura di promessa di matrimonio. Proprio queste cause di "misto foro" finiranno – quando con gli spagnoli verrà creata la figura del capitan d'armi e di giustizia – col dar luogo a diversi conflitti di competenza fra questa nuova figura e la curia vescovile[19]..
Sin dalle sue origini e per oltre cinque secoli, il corpo dirigente municipale occupò, in locazione, un paio di vani terranei del vecchio Palazzo Vescovile attiguo alla Cattedrale. La sede si chiamò tocco, dal termine greco thòkos significante il seggio o lo stare a sedere in consiglio. Si andò avanti così per secoli, "in una condizione intermedia di compromesso, di scontro e di confusione - commenta Iacolino[20] - in cui non si saprà veramente entro quali spazi di libertà e di movimento dell'organismo comunale fosse consentito di agire". Fu solo ai primi del settecento che il Comune ebbe una sua sede autonoma. Probabilmente i locali in dotazione al comune non dovevano essere molto ampi e a Lipari il consiglio pubblico, talvolta, si teneva nella spianata della Marina di San Giovanni, come accadde nel 1484, quando si dovette nominare un console per Lipari nella città di Siracusa, o nella piana della Civita o anche nella Cattedrale che allora aveva una sola navata e le dimensioni, rispetto ad oggi, erano più ridotte. E' dal verbale di questa seduta si evince che il titolo di giudice era passato a designare tre nuove figure del governo municipale: i tre assistenti del baiulo nelle funzioni di giudici togati. Risulta altresì che uno dei tre giurati e due dei tre giudici dichiarano di non sapere scrivere.
Alle sedute partecipava di diritto il baiulo e quando si dovevano discutere problemi gravi si chiamavano una decina di cittadini ,"uomini veterani" e "mercanti cittadini" – che in qualche modo prefiguravano il futuro consiglio comunale. (Archivio storico eoliano.it)
[1] M. Ascheri, Istituzioni medioevali, Bologna 1994, pag. 209.
[2] L. Catalioto, op. cit., pag. 133.
[3] G. Iacolino, Le isole Eolie..., op.cit. pag. 205-206; G. Iacolino, La fondazione della Communitas eoliana..., op.cit. pagg. 53-55; G. Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla battaglia di Lipari del 1339 alla vigilia della "ruina" del 1544, Lipari 2007, pagg. 5-11.
[4] M.Fumagalli Beonio Brocchieri, Federico II. Ragione e fortuna, Bari, 2004.
[5] E.Kantorovicz, Federico II imperatore, Milano 2000.
[6] D. Abulafia, Federico II. Un imperatore medioevale, Torino, 1990, pag. 167.
[7] G.Iacolino, Le isole Eolie nel risveglio delle memorie sopite. Dalla battaglia di Lipari del 1339 alla vigilia della "ruina" del 1544, Lipari, 2007, pagg. 5-58.
[8] G. Iacolino, op.cit., pag. 14-15. G.C. Sciacca, Patti e l'amministrazione del Comune di Patti nel Medio Evo, Palermo 1907, pp.226-7.
[9] Idem, pag. 13.
[10] Idem, pag. 50.
[11] Idem, pag. 50-51; G. La Rosa, Pijrologia Topostorigrafica delle Isole Eolie, a cura di A. Adornato, Lipari 1997, Vol.II, pag. 25 e ss.
[12] F. Calasso, La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del regno all'epoca degli statuti, Roma, 1929 (ristampa anastatica Roma 1971), pp.175 e ss.; L. Catalioto, Il medievo: economia, politica e società., in F.Mazza, Messina. Storia.cultura,economia, Soveria Mannelli, 2007, pag. 81-82.
[13] P. Corrao, Città ed élites urbane nella Sicilia del tre-quattrocento, in Revista d'Historia Medioeval, n. 9, pp 176-7.
[14] F. Titone, Istituzioni e società urbane in Sicilia, 1392-1409, Storia e società, n.105, 2004, pp469 e ss.
[15] P.Corrao, op.cit., pag. 177.
[16] F. Titone, op.cit., pag. 470.
[17] F. Vergazza, Società e giustizia nelle isole Eolie ( secc.XVI-XVIII). I processi penali della Curia Vescovile di Lipari, Soveria Mannelli, 1994, pag. 11.
[18] Idem, pp 11-12.
[19] G. Iacolino, op. cit., pag. 51.
[20] G.Iacolino, Le isole Eolie, II, op.cit., pag. 343 .
Tags:
Federico II
I giurati
Le costituzioni di Melfi
I giudici e il baiulo di Lipari
I vescovi di Lipari al tempo di Federico
I vescovi Anselmo e Giacomo Amalfitano
Il fatto che alla morte di Stefano si tardò ad eleggere il nuovo vescovo potrebbe essere dovuto alle incertezze legate al diritto di nomina conteso e discusso fra il re (o chi per lui giacchè Federico aveva ancora dodici anni) ed il Papa. Proprio nel 1206, fra marzo e dicembre, Innocenzo III fu sollecitato dal suo notaio pontificio Filippo a destinare in una sede della Calabria (Mileto o Sant’Eufemia) o della Sicilia ( la diocesi di Lipari-Patti) l’abate di San Lorenzo di Aversa, dotato di buone doti diplomatiche, per sostenere, nel regno di Federico, la politica papale; sempre in quell’anno, nel nome di Federico, si staccava dalla diocesi la Chiesa di S. Lucia del Mela col suo territorio a favore di un cappellano di corte.
Comunque a cavallo fra il 1206 ed il 1207 i capitoli conventuali di Lipari e Patti rompono gli indugi ed eleggono abate e vescovo Anselmo, monaco benedettino che probabilmente proveniva da un convento di Catania. Dell’operato di Anselmo si conoscono poche cose fra cui un viaggio ad Augusta, in Germania, nell’aprile del 1215 in compagnia dell’Arcivescovo Berardo di Palermo probabilmente per incontrare Federico che, in quel tempo, vi soggiornava e probabilmente, sempre con Berardo, lo stesso anno partecipò al Concilio Laterano IV dove incontrarono San Domenico[1]. Invece, realisticamente, senza fondamento sono le voci che vogliono il vescovo Anselmo amico, oltre che ammiratore, di S. Antonio da Padova in quanto Anselmo morì fra il maggio del 1216 ed il giugno del 1219 mentre S. Antonio non venne in Italia prima del 1221[2].
Ad Anselmo dovette succedere Giacomo Amalfitano meglio conosciuto come Giacomo di Capua. Divenne vescovo di Lipari-Patti fra il 1219 ed il 1221 e conservò il titolo fino al 1227 quando Onorio III lo nominò vescovo di Capua. Fu il primo vescovo della Diocesi non benedettino e probabilmente aveva precedentemente ricoperto l’incarico di notaio reale. Durante il suo episcopato Giacomo visitò Lipari forse un paio di volte e non molto più tempo dedicò a Patti visto che gli incarichi politici che Federico gli affidava lo portavano spesso in giro per il mondo lasciando la diocesi in mano ai due capitoli. Ma i suoi meriti diplomatici furono riconosciuti anche da papa Onorio che volle ascoltarlo per cercare di venire a capo del contenzioso con Federico che non transigeva sul fatto che solo a lui spettasse la scelta dei vescovi nell’ambito del suo Regno. Durante il vescovato di Giacomo si ha la fondazione a Patti del primo convento francescano che la tradizione vuole essere avvenuta fra il 1222-1223 e la attribuisce a S. Antonio da Padova[3].
A Giacomo Amalfitano seguono due presuli eletti e non consacrati probabilmente perché la loro nomina fu voluta dall’imperatore senza accordo col papa. Si tratta di Pagano, forse monaco benedettino, che governò dopo il marzo del 1227 fino a 1232 quando probabilmente morì e di Gregorio Mustaccio. Di Pagano si ricorda solo che curò con molto impegno l’integrità del patrimonio e il rispetto dei privilegi della sua chiesa tanto che nel 1229 è a Sora, nei pressi di Frosinone, dove Federico era impegnato in scontri con le truppe di papa Gregorio, e proprio lì ottiene dal re un diploma che confermava ,appunto, beni e privilegi. Gregorio Mustaccio era quel cappellano di corte a favore del quale e nel nome di Federico, nel 1206, era stato scorporata, dalla diocesi di Lipari-Patti, la Chiesa di S. Lucia. Ora Federico, alla morte di Pagano, lo nomina vescovo ma il papa si rifiuta di confermarlo e gli contrappone il suddiacono della curia romana e notaio Pandolfo, nato a Rieti, che si era impegnato in molte missioni a favore del papa ed allo stesso tempo però era anche stimato dall’imperatore. Il risultato fu che Federico accettò Pandolfo ma scorporò nuovamente S.Lucia dalla diocesi, riaffidandola a Mustaccio. Così Mustaccio sarà vescovo “eletto” di Lipari-Patti solo per il 1232-1233[4].
Pandolfo e Filippo
Pandolfo governerà la diocesi dal 1234 o 1235 fino al 22 marzo del 1246 come risulta dall’atto notarile relativo allo “spoglio”dei beni e dei crediti da lui lasciati e che venivano requisiti a favore della Camera Imperiale, e di cui parleremo fra poco. Governerà in un periodo turbolento in cui si riacutizza lo scontro fra l’imperatore ed il papa ed in cui eserciterà tutta la sua abilità diplomatica per rimanere al tempo stesso fedelissimo sia al papa che al re. Del suo impegno sul territorio possiamo arguire da quanto è detto nel verbale notarile e cioè che l’ammontare delle decime percepite dalle isole doveva essere elevato, che le isole erano quasi tutte abitate o meglio frequentate da contadini e cacciatori, che probabilmente – proprio per questo - il vescovo adottò, forse lui per la prima volta, il sistema dell’appalto per la riscossione dei tributi ricorrendo a gabellieri.[5]
A Pandolfo successe fra il 1246 e il 1247 il vescovo Filippo che governò fino a maggio del 1255, quando la morte lo colse qualche settimana dopo che il papa Alessandro IV, che non l’aveva mai riconosciuto, aveva nominato il suo sostituto. Ad attirare su Filippo i fulmini della Santa Sede, di Innocenzo IV prima e di Alessandro IV dopo, fu l’eccessivo attaccamento di questi alla causa sveva e dell’impero – non dimentichiamo che il vescovo Filippo sarà nella delegazione dell’imperatore che trattò col papa e sarà ancora lui che celebrerà le esequie di Federico nella cattedrale di Patti - ma è certamente infondata l’accusa che, dopo morto, gli rivolse il pontefice di avere dilapidato molti beni della sua chiesa. Anzi – dai pochi documenti che sono giunti a noi relativi al suo vescovato – risulta un suo impegno costante nella difesa del patrimonio e una scrupolosa diligenza nel curare gli interessi della giustizia e dell’amministrazione. Comunque il conflitto fra Filippo e la Santa Sede portò il papa Innocenzo ad emettere il 5 gennaio del 1254 una bolla rivolta al capitolo di Patti dove, ignorando completamente la nomina di Filippo, parla di prolungata vacanza della Diocesi e notifica la nomina del domenicano Bartolomeo da Lentini, che viveva nel convento di Anagni ed era un professore. Si trattava di una nomina che non poteva avere esecuzione pratica ma serviva a segnalare che la Santa Sede non aveva dimenticato i suoi diritti sulla Sicilia. D’altronde che questo fosse il senso della bolla lo dimostrava il fatto che il 6 ottobre dello stesso anno, papa Innocenzo affida proprio a Filippo, insieme al vescovo Gregorio di Siracusa, l’incarico di intervenire in una difficile situazione diocesana. Ma sul finire sempre del 1254 a Messina e nel messinese investendo anche il territorio di Patti, esplode la ribellione contro il dispotismo e l’ambiguità della politica del conte Pietro Ruffo che porta alla creazione di una repubblica autonoma che vede in Filippo un deciso fautore. La cosa non piacque alla Santa Sede che nel gennaio del 1255 riprese in considerazione la consacrazione di Bartolomeo da Lentini che ormai da un anno era stato designato vescovo di Lipari-Patti, dall’altra chiede a Filippo di presentarsi a Roma il 21 marzo per esporre le sue ragioni. Filippo non rispettò l’appuntamento – probabilmente giudicandolo inutile - e papa Alessandro ruppe ogni indugio: il 17 aprile comunicò al popolo della diocesi di avere consacrato il nuovo vescovo in sostituzione di Filippo definito “pseudo-vescovo”. Filippo non aveva nessuna volontà di arrendersi ma penserà la sua morte a risolvere questa intricata situazione.
[1] G.. Iacolino, Le Isole Eolie…, vol. II, op.cit. pgg. 200-204.
[2] Idem, pag. 203.
[3] Idem, pag.227 e ss.
[4] Idem, pag. 237 e ss.
[5] Idem, pag. 243 e ss.
L'ossidiana

Mappa del Mediterraneo con le fonti dell'ossidiana (da Williams Thorpe 1995)
“I primi insediamenti umani stabili nelle isole Eolie hanno avuto luogo negli ultimi secoli del V millennio a.C. in una fase iniziale di quello che può considerarsi il neolitico medio e sono stati determinati dallo sfruttamento dell’ossidiana, il vetro nero vulcanico” TP[1]PT .La cava probabilmente era quella dalla colata del Pomiciazzo- Gabellotto che risale a 10 mila anni fa e quindi all’VIII millennio a.C. Secondo questa ipotesi quindi gli uomini sarebbero giunti alle Eolie oltre 30 mila anni dopo che l’homo sapiens ebbe fatta la sua comparsa, 20 mila dopo che si era dislocato lungo le coste del Mediterraneo, e dieci mila dopo che era giunto in Sicilia.

Un masso di ossidiana.
“L’ossidiana, rientra nella categoria dei vetri vulcanici, ed è – scrive l'archeologa Luigia SalinoTP[2]PT - tra i materiali più usati durante l’antichità sia per fabbricare lame taglienti sia per realizzare alcuni oggetti d’arte, inoltre per le sue qualità estetiche (lucentezza, durezza), è stata apprezzata oltre che per realizzare, spesso come sostituta della selce, attrezzi (coltelli, punte di freccia, raschiatoi, lame e rasoi), anche elementi decorativi come pendenti, statue, specchi e – come è noto - coltelli da sacrificio. Nelle fonti antiche è anche attestato l’uso dell’ossidiana, per pozioni magiche o ricette mediche e viene affermato il suo effetto benefico per la vista e per il viso. Inoltre sono state rinvenute ad Hacilar molte figurine femminili con gli occhi incrostati d’ossidiana. Essa permetteva di vedere oltre la morte, ed, infatti, si definisce spesso l’ossidiana come la “Pupilla degli Dei”, in quanto era supposta, in particolare nel mondo egizio, fare da tramite tra l’uomo e l’altro mondo. C’è chi vi riconosceva proprietà divinatorie e si costruivano sfere d’ossidiana attraverso le quali i veggenti potevano predire il futuro.

Un bel blocco di ossidiana pura
L’ossidiana è in genere di colore nero o grigio, ma si trovano anche ossidiane con venature verdi o rosse, come nel caso di quelle provenienti Nemrut Dag (Turchia)a seconda del contenuto di ferro. In Italia i giacimenti d’ossidiana si trovano sulle isole di Lipari, Palmarola, Sardegna e Pantelleria. Grazie alle recenti metodologie d’indagine è possibile ricostruire le vie commerciali dell’ossidiana che iniziano con una traversata via mare e proseguono con una catena di scambi via terra confermando un'ampia distribuzione territoriale, che ne ha fatto materia prima di scambio di notevole importanza nella Preistoria. I percorsi commerciali coprivano lunghe distanze: infatti, si trovano testimonianze d’ossidiana che dalle Eolie raggiungeva le coste francesi o dalla Sardegna giungeva in Italia settentrionale, mentre il giacimento dell’isola di Pantelleria è l’unico che esportava l’ossidiana verso l’Africa settentrionale, dove i rari ritrovamenti sono localizzati soprattutto in Tunisia e nell’isola di Malta.Da una serie di studi risulta che l’arcipelago eoliano ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del commercio dell’ossidiana. Il centro protagonista spetta sicuramente all’isola di Lipari che alimentava il Sud e il Centro dell’Italia (Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo); mentre la Sardegna (M.te Arci) esportava verso la Corsica, l’isola d’Elba, la Toscana, la Lombardia, la Liguria e probabilmente la Provenza (Dauphinè e Linguadoca).(Archivio storico eoliano.it)

Ossidiana lavorata
L’ossidiana delle isole Pontine (Palmarola), invece, è stata ritrovata in Liguria e nelle isole Tremiti nell’Adriatico. Il periodo durante il quale il traffico dell’ossidiana risulta più attivo è testimoniato dal 3000 a.C. fino alla fine del IV-III millennio“.


 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431