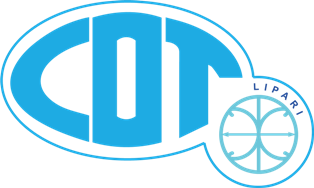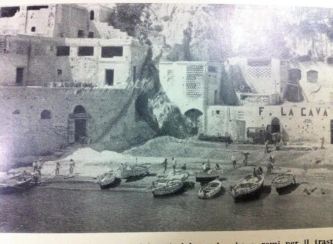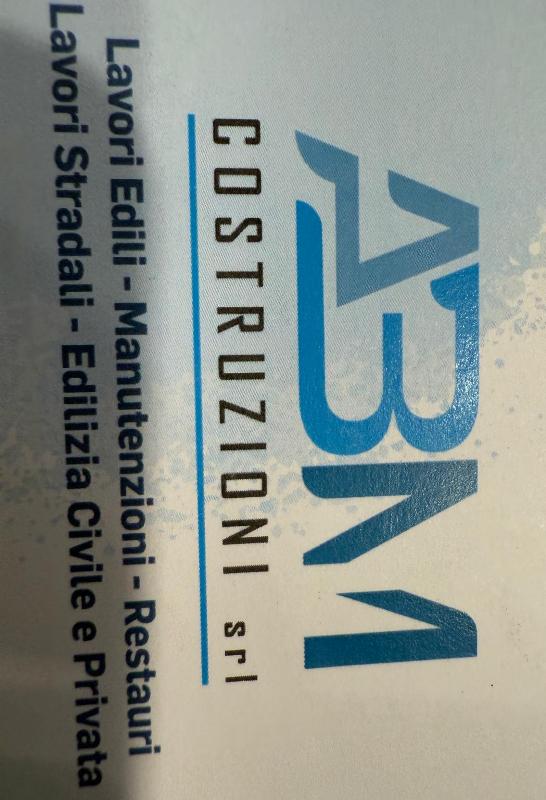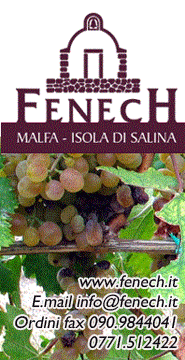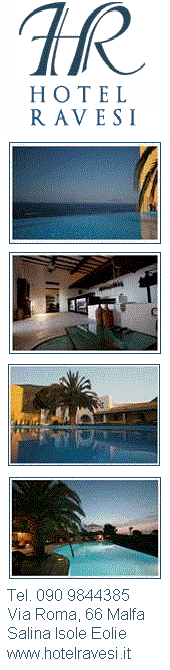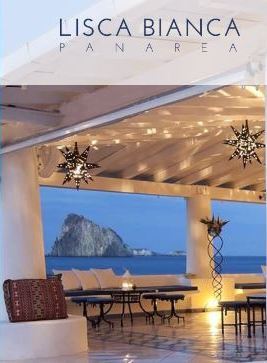Sono davvero lieto di presentare un articolo diverso dalle usuali tematiche di Narrare di Storia. Oggi mescoliamo infatti storia e attualità. Forse pochi lo sanno ma l’isola di Lipari, la maggiore dell’arcipelago delle Eolie, ha avuto una lunga storia industriale basata sull’estrazione di una risorsa semplice quanto preziosa: la pietra pomice, grazie al vulcanismo dell’isola, è presente in qualità purissima.
Carlo Cavazzuti ci racconterà quindi una storia industriale ed economica che però, ultimamente, sembra finita in modo inglorioso oltre che pericoloso per l’ambiente e i residenti.
Buona lettura!
La pomice di Lipari, storia di un’industria forse finita
Chi ha messo piede sulle Sette Sorelle e in particolar modo sulla maggiore di quelle, Lipari, non avrà mancato di notare l’assidua presenza sulle spiagge, e come compagne di nuoto quando vi è un poco d’onda, piccole e grandi rocce di pomice che formano una bianca linea sulla spiaggia o galleggiano mollemente sui flutti.
Presto spiegata la loro presenza andando anche solo a fare un salto tra la località di Caporosso e quella di Porticello di Lipari, dove Monte Pilato, per secoli scavato per estrarne pomice, ora sbianca il paesaggio con i segni della cava.
La pomice ha da sempre caratterizzato l’isola, ma da alcuni anni la pietra è lasciata a sé stessa. La storia della cavazione di pomice nelle isole Eolie, e in particolare sulla maggiore di Lipari, risale al neolitico quando le isole già esportavano, se nel neolitico si può parlare di esportazione vera e propria, ossidiana e pomice sulle più piccole sorelle e sull’isola maggiore.
Un’industria antica
L’estrazione e il commercio di questa pietra vulcanica vengono per la prima volta annotate in maniera formale il 18 maggio 1276 quando re Carlo d’Angiò autorizza il vescovo di Lipari (sin dal tempo della dominazione normanna signore delle Eolie) a esportare e commerciare oltre allo zolfo e all’allume anche la pomice.
Le stime di cavazione di quei primi anni di commercio si aggirano a circa 100-200 tonnellate all’anno. La pomice di Lipari si spande in Europa senza freni, sia per la cosmesi che per l’edilizia tanto che venne utilizzata per la costruzione della cupola emisferica della Cappella di Santa Maria del Fiore, a Firenze (alcuni, senza prove certe, sostengono che fosse già così famosa da essere utilizzata per la costruzione della cupola del Pantheon di Roma nel 120 d.C.).
Il borgo liparoto di Canneto, al tempo del 1200 chiamato Baia della Calandra, essendo poco distante dalla zona estrattiva principale si sviluppa fortemente sotto la spinta dei cavatori e trasportatori che assieme ai pescatori vivevano già in loco, tanto che nel 1596 viene fondata dal vescovo Juan Pedro González de Mendoza una piccola chiesetta dedicata a San Cristoforo (diventata poi basilica romana minore nei secoli successivi) noto al tempo come il protettore dei portatori e facchini. La chiesetta, fulcro della vita della borgata, inizialmente era anche utilizzata come riparo dagli attacchi dei pirati barbareschi che trovavano un buon punto di sbarco in quella zona per depredare proprio la risorsa mineraria tanto apprezzata anche all’estero.
La risorsa naturale estratta a Lipari era così fortemente richiesta e così conosciuta che nei secoli successivi al medioevo anche scienziati internazionali si interessarono della faccenda. Déodat de Dolomieu (colui che ha dato il nome alla Dolomia, la pietra più comune sulle Dolomiti che prendono il nome proprio da questa roccia) nel 1781 afferma che Lipari è “l’immenso magazzino che fornisce la pomice a tutta l’Europa” e sette anni dopo il modenese Lazzaro Spallanzani afferma che a Lipari “vengono bastimenti italiani, francesi e d’altre nazioni per caricare questa merce”.
PER LA VISIONE DI TUTTO IL SERVIZIO SPECIALE CLICCARE NEL LINK LEGGI TUTTO
L’epoca moderna
Inizialmente, sin dal 1200 per arrivare al 1800, i singoli cavatori, o in gruppi familiari, si organizzavano autonomamente vendendo l’estratto ai capitani dei velieri che approdavano sull’isola, ma era un’attività che non riusciva a coprire l’immensa richiesta che proveniva dall’Italia e dall’estero e quindi con la rivoluzione industriale l’estrazione diventa via via sempre più dedicata agli imprenditori e alle loro società.
Si deve aspettare il 29 aprile del 1835 per poter parlare di un dazio sulle estrazioni di pomice: secondo i dati ammontava a 10 Grani siciliani per ogni quintale di pietra pomice scavata. Le entrate previste sarebbero ammontate a 100 onze l’anno corrispondenti a circa 600 tonnellate di prodotto e dovevano servire per far fronte all’illuminazione notturna dell’isola. Di concessioni ai privati già si discute qualche anno prima dei dazi, ma non si arriva mai a nulla in quanto ci sono serie difficoltà nell’apprendere quali appezzamenti terrieri fossero demaniali, o patrimoniali e quali dati dal vescovo in enfiteusi ai propri sudditi che consideravano i terreni pomiciferi come beni comuni dove ognuno prendeva quello che poteva per sostenersi o integrare i propri guadagni da altre fonti.
Solo nel 1885 arriva una regolamentazione legale sulle proprietà, stipendi ai minatori, dazi di cavazione e dazi di esportazione sancendo l’inizio di un’era di industrializzazione della pomice.
Il precursore in questo campo è il francese Firmine Bacot della ‘Leonard Bacot’, specialista in pomici, polveri e grani a Parigi. Bacot il 2 settembre 1865 sposa a Pirrera Angelina Restuccia (liparota) ed il 24 maggio 1867 rivolge una petizione al Sindaco per chiedere una porzione di demani comunali in contrada Rocche Pirrera e la esenzione del dazio sulla polvere di pietra pomice che viene manufatta ed esportata all’estero.
La richiesta è negata per i danni economici che porterebbe all’isola intera.
Nel 1880 si iniziano a vedere le prime società che stabiliscono base sull’isola, prima per acquistare il prodotto, poi impiantando i primi mulini a Canneto, Acquacalda, e Porticello per la macinazione a diverse pezzature, infine acquistando terreni pomiciferi da singoli privati.

I primi industriali degni di questo nome sono Gabriele Barthe, Felice Neble e francesi Chamencin e compagni (anche la Banca Siciliana di Messina si inserì per un tratto nella questione) che lotteranno per un bando del Comune per quattro anni. A vincere il bando fu poi Gabriele Barthe dopo una lunghissima diatriba giuridica in merito al contratto stesso.
Già sei mesi dopo l’assegnazione il Barthe lamenta l’impossibilità di proseguire la sua attività in quanto il terreno assegnato non risulta a pieno del demanio.
Nel 1898 il contratto affidato dal bando si risolve per via giudiziaria per l’inadempienza del Comune senza che alcun lavoro di estrazione fosse stato praticato.

Il monopolio sulla pomice
Sarà solo nel 1887 che si vedrà un contratto regolare sull’estrazione della pomice di Lipari assegnato alla Società Eolia, neofondata allo scopo.
Il nuovo contratto concede in locazione monopolistica, per due anni con possibilità di rinnovi biennali fino al termine massimo del 1905, con un canone annuo di lire 92 mila e cauzione di lire 85 mila, tutti i terreni demaniali produttivi di pietra pomice che il municipio possiede e di cui è in godimento che vengono elencati con nome delle contrade in cui si trovano “Col diritto di scavare nelle cave esistenti ed in altre che vorrà aprire senza limitazione alcuna. Il Comune ed i residenti possono fare uso della qualità detta alessandrina, del lapillo e della stacquatura, che si trova sulle spiagge, ed anche dei bastardoni purché questo materiale venga adoperato esclusivamente nei fabbricati del territorio comunale.”
Il monopolio lascia però i lavoratori privi di un contratto collettivo di lavoro pagando loro una retribuzione estremamente bassa e sbilanciata per gli orari e le condizioni lavorative difficili e pericolose.
Fu anche per questo motivo che fin dall’inizio molti di essi rifiutano di munirsi del permesso di lavoro, obbligatorio dal contratto monopolista, continuando a scavare per conto proprio e vendendo la pietra a commercianti e mediatori vari che esistevano nonostante il monopolio a Eolia.
Oltre ai lavoratori, l’altra categoria che veniva colpita dal contratto monopolistico erano i commercianti e i mediatori di pomice, nonché i bottai privati che costruivano casse e botti per il trasporto che dovevano ridurre il loro giro d’affari perché l’Eolia trattava direttamente con gli importatori nazionali ed esteri estromettendoli dal mercato sempre più fiorente grazie ai primi macchinari di scavo.
Nonostante i problemi con il disappunto dei lavoratori e il mercato nero della pomice di frodo i primi due anni di attività dell’Eolia, dal 1888 al 1890, furono positivi e le sue azioni inizialmente quotate a 250 lire ciascuna passarono a 450 e si vendettero non solo in Italia, ma fino alla borsa di New York. Nel 1892 l’Eolia chiude: debiti insoluti, problemi con le risoluzioni giuridiche in merito ai terreni demaniali, non ultimo la cittadinanza contro al monopolio, porteranno all’affido dei terreni pomiciferi ai lavoratori (pagati comunque solo 2 lire al quintale come sotto contratto con l’Eolia) sottoposti al controllo di un caposquadra e nove vigili.
Saranno diverse le richieste per concessioni monopolistiche negli ultimi anni del 1800 e anche nei primi del 1900.
Una in particolare salta agli occhi, quella di Theodor Haan di Dresda che apre sull’isola una fabbrica per il pezzamento della pomice tramite mulini utilizzando aree di estrazione private che avevano legalmente rilevato. La sua richiesta di monopolio venne respinta come tutte le precedenti, ma grazie ai terreni della sua società poté comunque continuare a lavorare sull’isola sin tanto che i rapporti con il regno austro-ungarico non si deteriorarono troppo con l’approssimarsi della Grande Guerra. La ditta di Haan chiuse i battenti sull’isola nell’aprile del 1915, ma riuscì a mantenersi come distributore unico per la Germania sino agli anni ’70.
Contesa “medievale”
Tra il 1911 e il 1921 il Comune si impegnò in una contesa giudiziaria decisamente ardua e senza tempo con il vescovo di Lipari Monsignor Angelo Paino, il quale rivendicava la proprietà dei terreni pomiciferi addirittura sulla base di un diploma datato 1088 e concesso dal Conte Ruggero il Normanno all′Abate Ambrogio, con il quale si decretava il Monastero di San Bartolomeo (trasformatosi ad oggi cattedrale dell’isola) proprietario di tutti i territori delle isole Eolie. Il Comune difese con successo le sue spettanze producendo un diploma databile 1134 che dimostrava esse fossero state donate alla Chiesa solamente le terre nullius, implicitamente, e non anche le proprietà private e gli usi civici delle terre comuni e non ultimo il sottosuolo delle stesse.
Tra le due guerre l’attività estrattiva fu altalenante e subì un gran freno come tutte le attività industriali non necessarie allo sforzo bellico, ma continuò garantendo sostegno all’isola e ai suoi abitanti nonostante la concorrenza di due isolani che si interessarono alla pomice delle isole greche. Impresa comunque mai andata in porto a causa del secondo conflitto mondiale.
Le condizioni sanitarie
Assieme alla modernità e alle nuove macchine arrivò anche la medicina e non pochi furono i casi riconosciuti di silicosi in tutta Lipari. Non che prima gli operai e i minatori non ne morissero, ma ora, con le nuove analisi mediche si sapeva di cos’era la colpa di quella tosse straziante che colpisce quasi tutti gli operai che vivono il lavoro in condizioni inumane.
Nel 1961, oltre quarant’anni dopo il giornalista Francesco Rosso descrivendo la situazione delle cave scrive:
L’intero versante settentrionale dell’isola di Lipari è una immensa cava di pomice, parte a cielo aperto e parte solcata da centinaia di anguste gallerie. Vi lavorano un migliaio di operai. Nelle giornate ventose, una compatta nuvola bianca di polvere insidiosa avvolge il fianco del monte. Gli operai devono lasciare il lavoro: una giornata senza salario nel ristretto bilancio di un anno di fatica mal ripagato. Nei mesi estivi, quando il sole saetta implacabile, lavorare lassù è pauroso. La roccia libera un calore intollerabile, la polvere cocente soffoca, la sete tortura e i meno forti cedono. Un capogiro, uno sforzo maldestro per muovere sulla liscia parete le gambe impiombate di stanchezza, e la voragine si spalanca sotto gli ignari, che – storditi dall’insolazione – hanno già perduto conoscenza ancor prima di iniziare il volo di trecento metri verso l’abisso d’ombra…
Gastone Vueiller riporta altre considerazioni:
Provvisto di un cestino, di un piccone e di una lampada l’operaio esce di casa alle quattro del mattino e arriva, dopo un’ora e mezzo di cammino, all’antico cratere. Là comincia per lui l’ascesa molto faticosa sul pendio. Alla fine raggiunge il capo di grotta, che comanda una squadra che conta dieci o quindici lavoratori. Insieme scendono tre o quattrocento metri sotto terra attraverso un sentiero inclinato. Ma prima di arrivare a quella profondità dove oggi si trova la pomice, gli operai hanno dovuto scavare per quindici o venti giorni senza profitto il fianco della montagna per aprirsi un varco attraverso la sabbia bianca, fino alle viscere del suolo. Il metodo di scavo non è cambiato da un secolo. I lavori di sostegno sono sconosciuti, ci si fida di un terreno franoso, che ogni anno causa delle vittime.
Un comandante di una delle navi che agli inizi del 1900 caricano le botti di pomice scrive così:
La vita di quei poveracci è spaventosa. Nel nord avete le miniere di carbone: la vita è dura per i lavoratori, è vero, ma almeno alcune società forniscono loro dei mezzi per lo sfruttamento della miniera e il trasporto del materiale. Ci sono compagnie che li assicurano e in caso di incidenti si dà una pensione alle vedove, ai vecchi. L’operaio della pomice non ha niente; lavora quattordici o quindici ore al giorno guadagnando un franco o un franco e venticinque centesimi, non di più. Vive nel paese del vino e non conosce che acqua, a tavola non conosce la carne e campa soltanto di legumi e pane cotto un mese prima. Eppure non si è mai messo in sciopero. Dopo la sua faticosa giornata, scende al villaggio con 50 o 60 chili di pomice sulle spalle, attraverso i sentieri pericolosi che ha percorso al mattino. Arriva dal sensale e deposita il suo fardello ricevendo un acconto. Quando la pomice si è seccata viene pesata e l’operaio riscuote il prezzo convenuto. È lì che lo aspetta il sensale, o piuttosto il suo aguzzino, che stabilisce il peso a proprio piacimento. Il povero disgraziato non può protestare, perché ha ricevuto un anticipo ed ha bisogno di quell’individuo il giorno dopo…
Vittorio Bertarelli, fondatore del Touring Club Italia scrive così nel 1909:
Profonde, caldissime all’interno… coltivate con metodi vecchi, industrialmente non lodevoli ed igienicamente perniciosi… Dura vi è l’opera di estrazione, che si fa col piccone; durissimo il trasporto all’esterno, entro sacchi e recipienti di stuoie e di vimini, al quale sono adibiti anche ragazzi giovanissimi, evidentemente senza alcun rispetto della legge sul lavoro dei fanciulli. Producono abbastanza per tutta Europa ed anzi per esportarne oltre mare. Dei vapori sono sempre sotto carico a Canneto e ad Acquacalda dove in grandi molini, di cui vari appartengono ad una ditta tedesca, si opera una cernita di materiale ed in parte la sua macinazione in mezzo ad un pulviscolo folto, persistente che si diffonde a distanza come una nebbia intorno agli stabilimenti ed è visibile a più chilometri…
Nel 1957 si arrivò anche a un’interpellanza parlamentare, ma non si riuscì più di tanto a mitigare la malattia che colpiva quasi ogni lavoratore né a mutare più di tanto le loro pessime condizioni lavorative.
Pumex: le ultime vicissitudini di un’industria antica
Negli anni ’50 del nostro secolo la parcellizzazione delle cave aveva fatto nascere oltre una quarantina di scavi mettendo in crisi il settore per l’eccessiva concorrenza tra le stesse. Ormai oltre una ventina di ditte, da quelle individuali ai gruppi di grandi industriali picconano la pomice.
Nel 1958 vide la luce la Pumex che nel giro di pochi anni riuscì a inglobare e acquistare la quasi totalità dei lotti pomiciferi lasciando attive tre sole concorrenti: la ditta di Francesco La Cava a Ponticello, Italpomice di Acquacalda e la Cooperativa S. Cristoforo di Canneto che si occupava unicamente del settore produttivo e proseguì la sua attività fino alla seconda metà degli anni ′80.
A metà degli anni ’80 a suon di acquisizioni il monopolio della Pumex sulla pomice di Lipari era tale se non giuridicamente, di fatto. Oggi, laggiù a Porticello, accanto ad un ottimo ristorantino a conduzione famigliare, giace abbondonata alle intemperie la più grande produttrice di pomice del Mondo tutto: la Pumex.
Chiusa nel 2007, si dice senza ragione per volere dell’UNESCO che fece le Eolie patrimonio dell’umanità (in realtà fu il primo ente a richiedere una riconversione), altre voci non tanto azzeccate dicono che l’azienda era ben in attivo e venne fatta chiudere per rispettare fantomatici accordi internazionali sulla vendita della pomice. All’atto pratico si sa che la ditta fece richiesta di un rinnovo e di una nuova concessione mineraria che non gli vennero assegnate e di seguito questioni finanziarie la portarono al fallimento e al conseguente sequestro per sanare un buco di oltre trenta milioni di euro.
Come ci si sia arrivati è altra storia, troppi interessi e troppa politica per queste poche righe già prolisse. Gli ex dipendenti avrebbero dovuto entrare a far parte di un progetto di riqualificazione misto pubblico-privato che avrebbe visto la zona rianimarsi ristrutturando gli stabili in buono stato in modo da renderli fruibili, già sotto progetto della Pumex stessa e consegnato direttamente all’UNESCO.
Il piano, oltre alla cessione dei beni e il pagamento dei creditori, prevedeva anche la ripresa dell’attività produttiva attraverso la commercializzazione del prodotto in esubero e già stoccato, ma nulla è stato fatto.
La riqualificazione avrebbe dovuto creare un pool di centri di interesse cittadino, turistico e naturalistico che avrebbe permesso alle Eolie di uscire dal circolo lavorativo della stagionalità che affligge le sette isole con un’economia altalenante tra inverno ed estate.
L’amministrazione comunale che avrebbe dovuto trattare con l’ente UNESCO e con i mini-steri nazionali per portare a termine un progetto che avrebbe collocato lavorativamente ben più che i dipendenti della sola Pumex non se ne occupò a dovere, tanto da non invitare nemmeno i rappresentati della ditta quando gli inviati dell’UNESCO andarono a fare un sopralluogo.
Alcuni dicono anche che il progetto nacque solo allo scopo di procrastinare sine die la liquidazione dei beni per andare a frustrare la ragione dei creditori. Quale sia la motivazione per non aver perseguito un così utile progetto rimane ancora un piccolo mistero isolano.
Trentatré lavoratori rimasero bloccati per anni, e forse alcuni lo sono ancora, con un inquadramento comunale per lavori socialmente utili e retribuiti con fondi regionali sempre in ritardo, non arrivati, o arrivati e mai distribuiti che portarono a scioperi ad oltranza in diverse occasioni.
A anni di distanza quei dipendenti sono ancora allo stato di precari e la zona che avrebbe dovuto essere riconvertita entro dieci anni, e posta in sicurezza ben prima, resta alle intemperie a sgretolarsi sotto il suo stesso peso, scaricando in mare quintali di pietre e polvere di scarto ricoprendo letteralmente un ecosistema marino che più volte è stato valutato per entrare a far parte di una zona marina protetta.
La situazione attuale
A oggi la zona è preda di vandali, coppiette in cerca di un posto tranquillo dove appartarsi, graffittari e purtroppo un piccolo giro losco di spaccio.
La cava abbandonata a sé stessa, senza più una copertura di terriccio e rocce dure è a forte rischio di frana che nel caso dovesse avvenire crollerebbe sulla strada sottostante bloccando buona parte della circolazione dell’isola, dicono i geologi.
Gli anni di scavo e poi l’abbandono sotto la spinta della parca pioggia siciliana hanno fatto sì che la desse vita a un piccolo canyon profondo ormai una cinquantina di metri nel punto più basso.
Chi avesse voglia e velleità da esploratore può semplicemente accostare la macchina sulla strada che da Canneto porta ad Acquacalda, scavalcare il guardrail e senza troppo sforzo iniziare il suo percorso nel Gran Canyon liparoto. Lo stesso li porterà in salita assottigliandosi via via verso la cima del monte, sino all’ultimo punto di cava dove lo attenderanno placide gli stabili della Pumex.
Il problema forse più pressante per la cittadinanza è che le strutture che dovrebbero essere ben chiuse dai sigilli del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono del tutto accessibili a chiunque senza un minimo sforzo e oltremodo pericolanti.
Nelle sale abbandonate a tutt’oggi si possono vedere i laboratori chimici con i falconi dei reagenti, molti dei quali ancora pieni e altri rosi dal tempo colanti il loro chimico contenuto, in bella mostra sugli scaffali accanto ai caschetti da minatore degli operai lasciati assieme alle note di carico, appunti, penne e documenti vari.
Scansie piene di faldoni di documenti crollano nelle stanze vuote con i resti dei festini dei giovani che si ritrovano in quelle stanze. Macchinari da migliaia e migliaia di euro abbandonati sui tavoli e le scrivanie, preda della polvere di pomice che ovunque sbianca le superfici e impregna l’aria rendendola densa in bocca. Le ruspe giacciono inerti nel parcheggio diventando ricettacolo di piccoli animali e arbusti.
Il molo di carico navale che si insinua nel mare di Porticello, anch’esso ufficialmente sigillato, è in parte crollato, ma la parte collegata all’isola vede periodici inquilini pescatori che lanciano le loro lenze aggiustando le passerelle erose dal sale marino con assi di legno e ponti improvvisati.
Chi non è del posto non sa che di quei ponti di carico ce n’erano parecchi che in parte stati smontati infine sono crollati erosi dal mare. Hanno lasciato però pali di ferro ben conficcati nella spiaggia ciottolosa da cui spuntano acuminati spuntoni arrugginiti, e altri sommersi a pelo d’acqua, tali per cui la spiaggia non possa essere usata con tranquillità né dai pescatori per lasciare le loro piccole barche, né dai bagnanti per un tuffo rinfrescante estivo tanto che la spiaggia stessa è sottoposta a sequestro nell’attesa di una bonifica di cui si dovrebbe occupare la sovrintendenza del comune di Lipari.
Sequestro che però è tale solo sulle ordinanze perché ogni estate la spiaggia si riempie di bagnanti più o meno consapevoli.
Lì accanto, a poche bracciate a nuoto, nella stagione balneare c’è uno dei ritrovi più frequentati dell’isola: di giorno dalle famiglie sulla spiaggia e a notte da gruppetti di ragazzi che spesse volte si ritrovano per un falò in barba alla guardia costiera. Tutto ciò sempre ben attenti a non inciampare in un grosso blocco ferroso o sperando di non tagliarsi con le lame arrugginite che a volte spuntano dai sassi della spiaggia e che già hanno portato diverse persone a fare un salto al presidio di pronto soccorso ospedaliero, altro e forse più pressante e complesso problema delle sette isole.
Aggirandosi per gli stabili sono ben visibili i segni del tempo che ha portato al crollo di diverse parti degli stessi seppellendo sotto le macerie grandi macchine da lavoro che forse avrebbero potuto essere vendute per sanare i debiti dell’azienda assieme a più modesti apparati da laboratorio, arredi e macchine escavatrici.
I grandi magazzini di stoccaggio ancora parzialmente pieni di sacchi di diverso pezzaggio lasciano immaginare un’attività che a detta di tutti sull’isola è sempre stata se non florida, per lo meno redditizia.
I mulini con i filtri in stoffa, i cicloni di separazione delle polveri e i nastri trasportatori tacciono poco lontani da stanze che già come sono ora potrebbero essere trasportate in un museo della pietra pomice: vecchi macchinari in legno, ancora utilizzati alla chiusura della ditta, si sono salvati dall’azione dei vandali e restano dove son stati lasciati solamente ricoperti da un velo di polvere bianca.

Uscendo verso la zona di estrazione si ci accorge come l’acqua abbia proseguito il lavoro dei picconi e delle ruspe dilavando la tenera pomice dal monte. Stanze semisepolte da detriti tanto fini che con l’andare degli anni si sono cementati creando un pavimento secondario all’altezza della maniglia di una porta.
Per arrivare alla grande torre di estrazione spesso le scarpe affondano in una sabbia finissima di pomice da cui spuntano radi ciuffi d’erba tra i primi solchi scavati dall’acqua e che tra secoli emuleranno il più grande canyon di poco distante.
Al termine dei nastri trasportatori esterni c’è ancora un piccolo monticello di materiale esattamente come se la macchina si fosse spenta qualche istante prima; altri più lunghi che passano sopra la strada pendono sulla carreggiata. Aggirandosi tra quei tetti crollati e macchine inchiodate ogni tanto si sente qualche voce giovane in lontananza e viene naturale chiedersi se siano le voci degli spettri di chi in tanti anni di lavoro in miniera anche dopo la morte ne rimane legato, o solo un gruppo di ragazzini che chiacchierano fumandosi uno spinello.
Quello però che lascia del tutto colpiti nel percorrere i corridoi vuoti in cui gli spogliatoi hanno ancora gli armadietti pieni degli oggetti degli operai, le bacheche riportano attaccate con le puntine le foto e le cartoline inviate dai dipendenti ai colleghi, gli uffici che sono stati lasciati intonsi con penne poggiate su fogli metà scritti, macchine cariche e pronte all’uso e sacchi e sacchi di materiale pronto alla vendita, è uno strano senso di sospensione. Come se il tempo si fosse fermato al suono dell’ultimo rintocco dell’ultima ora lavorativa lasciando ogni cosa come se si dovesse riprendere le proprie mansioni il mattino seguente, al normale orario di presa di servizio.
Però il tempo passa, la pomice e il ferro si sfaldano sotto la pioggia e scivolano in mare, l’acciaio delle grandi strutture arrugginisce e si contorce sotto il suo stesso peso, i muri crollano sulla strada fitta di macchine e nelle stanze da lavoro, i debitori attendono i loro soldi e i giovani incoscienti gozzovigliano intanto che Lipari aspetta di veder cancellata non tanto la cicatrice sul Monte Pilato, che ormai resterà per sempre a monito di un’attività che per quasi un millennio ha sostenuto l’isola, quanto risolto il mistero per cui una risorsa dell’isola sia diventata ora un grosso rischio per la stessa.

Fonte narraredistoria.com/



 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431