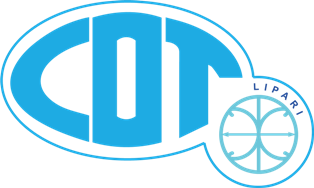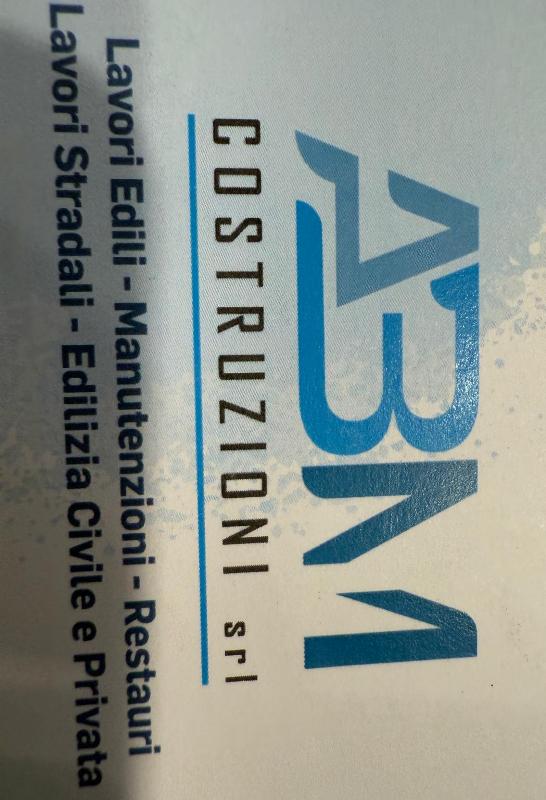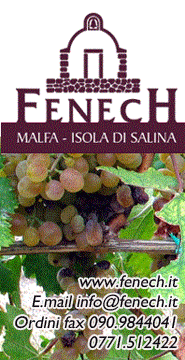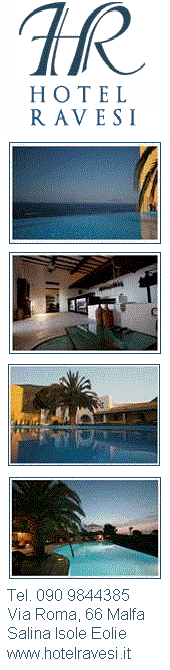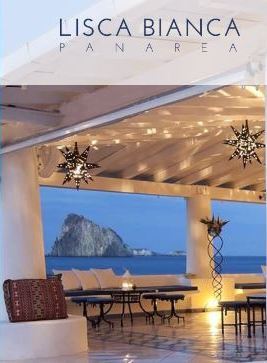di Alessio Pracanica
Questo 2020 sembra voler piallare ogni anomalia del mondo, fino a ridurlo a una biglia di levigata disuguaglianza.
L'altro giorno si è portato via l'ultimo semidio di quel culto pagano chiamato calcio.
Amico di Fidel e compagno di bisboccia dei camorristi. Difensore degli ultimi e candido esibizionista di lussi trash. Uomo di rara generosità ed evasore seriale. Calciatore immarcabile e atleta di innata pigrizia.
In grado di vincere un mondiale quasi da solo. Che in quell'Argentina del 1986, l'unico a balbettare lo stesso verbo tecnico era un tale Jorge Burruchaga.
Ora Dio ha riavuto la sua mano.
IL PROF ALESSIO PRACANICA E' STATO ANCHE BATTEZZATO IL "MOGOL DELLE EOLIE"

Italia rossa, gialla e arancione
Dopo l’ultimo Dpcm gli italiani non sono più tutti uguali, senza distinzione di sesso, età, religione e altre quisquilie, ma differenziati in base al colore.
Avremo, cioè, i rossi, gli arancioni e i gialli.
Steccati cromatici dividono gli abitanti di Belpelo da quelli di Belpasso, seguendo scrupolosamente i confini regionali.
Il Belpaese rinnegato un secolo di tradizione calcistica, getta alle ortiche l’ormai sorpassato trapattonismo e si schiera a zona, aprendosi finalmente alla luce, alla modernità, al progresso.
Visto dall’altra faccia della Luna, sembrerebbe provvedimento in cronico ritardo sui tempi, pezza a colore di un esecutivo senza i mezzi economici, e gli spiccioli politici, per imporre misure in linea con il resto d’Europa.
L’economia detta le regole e che la salute pubblica s’arrangi.
Ma, fatto nuovo per la repubblica peninsulare e insulare, a quanto pare le misure scatteranno in automatico, sulla base di 21 rigorosi parametri, senza le solite contrattazioni al ribasso, dalla Corte Costituzionale al consiglio di quartiere.
Riducendo gli amministratori locali a meri esecutori degli ukase centrali.
Rinunciando così, stante l’altissima qualità di qualcuno dei suddetti amministratori, a un notevole contributo in fatti, pensieri e omissioni.
Nonché al pittoresco apporto, in cultura e folklore, che solo certe disinvolte autonomie locali riescono a cagionare alla cosa pubblica.
E che la partita si giochi soprattutto in questo campo, lo testimonia il grido di dolore di un intellettuale del calibro di Matteo Salvini, quando denuncia a chiare lettere il timore di morte culturale del sistema paese.
Riferendosi, con molta probabilità, ai rischi di interruzione per la filiera produttiva della polenta taragna o dei campanacci per vacche frisone.
L’estro di Zaia
Per fortuna, pensionato Piero Angela e con Rai Storia a rischio chiusura, ad acculturare le masse ci pensa Luca Zaia da Conegliano Veneto.
L’ormai mitico Presidente del Veneto non è nuovo a esternazioni di ampio respiro. Come quando, nella scorsa primavera, rinsaldò indissolubilmente i legami affettivi con il generoso popolo cinese, affermando che li abbiamo visti tutti, i cinesi, mangiare topi vivi.
Parole da statista maturo, in cui nessuno potrebbe ravvisare un conflitto di interessi, essendo appunto Zaia di Conegliano (provincia di Treviso) e non di Vincenza.
Tempo pochi mesi e sarà sempre lui a sciorinare, con notevole modestia, la sua competenza in campo virologico: Non sono un super esperto, ma la materia la conosco. Ho fatto due anni di Veterinaria.
Due anni due, mica cotiche.
Quanto al Nobel, per il momento soprassediamo. Sognare è lecito, avverarsi è cortesia.
Mammiferi a zona
Non pago di siffatti successi, il grande Zaia ha recentemente partorito una nuova gigantesca idea. Utilizzare i veterinari per i tamponi.
Epocale trovata che, per essere apprezzata in tutta la sua rivoluzionaria grandezza, necessita delle parole testuali espresse in conferenza stampa, senza la mediazione di inutili commenti.
Convocheremo i rappresentanti dei 2450 veterinari, per fare i tamponi. L’uomo è un mammifero, tutti i mammiferi hanno 7 vertebre cervicali, tutti i mammiferi sono catalogati in questa categoria perché allattano il nascituro, che siano dei volatili o dei pesci, anzi dei mammiferi. Il delfino è un mammifero, per dire, no? Il pipistrello è un mammifero. E a livello di mammiferi, i veterinari sono degli esperti. Noi siamo un animale, un mammifero. Non c’è nulla di trascendentale pensare di poter fare un percorso anche assieme ai veterinari, che qualora fossero disponibili, noi siamo disposti ad affrontarlo. I veterinari sanno benissimo com’è fatto un corpo umano, perché conoscono benissimo l’anatomia. Fanno due esami di ana…, di autonomia, di anatomia. Anatomia 1 e anatomia 2, conoscono la fisiologia…
Certo, l’esposizione non è propriamente fluida, con qualche farfugliamento e intoppo. Vi sono dei lapsus calami, autonomia invece di anatomia, tutto sommato giustificabili in un leghista con pedigree e la ben nota sintassi itinerante, che per il simpaticissimo Zaia è ormai un marchio di fabbrica.
Ma elevandosi al di sopra di queste umane miserie, bisogna riconoscere una visione di ampio respiro, che oltre a svolgere funzione didascalica, introduce nuovi e mirabolanti concetti scientifici.
Apprendiamo infatti, con vivo stupore e commossa gratitudine, che delfini e pipistrelli sono anch’essi mammiferi, parte affatto disprezzabile della nostra grande famiglia.
Sembra poca cosa, ma nelle lunghe serate di lockdown consente figuroni a Trivial.
Mammiferi variabili
Apprendiamo anche, nelle more della zaiaiesca inventiva, che i suddetti mammiferi non si limitano ad allattare i cuccioli, ma anticipano l’atto ancor prima del parto (nascituro: agg. e sost. m. Che sta per nascere. Vocabolario Treccani) tanto è l’amore materno.
Ulteriore, mirabolante scoperta, tutti i mammiferi hanno 7 (sette) vertebre cervicali. Si vede che nel frattempo, opportuno decreto della Regione Veneto ha modificato la struttura scheletrica di bradipi e trichechi.
In quanto, risulterebbe da fonte attendibile che questi buffi animali abbiano un numero di vertebre (cervicali) variabile tra 5 e 9, a seconda dell’ordine e della famiglia (intesa come classificazione biologica e non, of course, come nucleo di congiunti).
Ma non avendo frequentato i primi due anni di veterinaria, requisito minimo per qualsivoglia competenza scientifica, non possiamo, né vogliamo esprimere certezze in campi a noi ignoti. In specie al cospetto di un gigante dell’anatomia comparata come Luca Zaia.
Resta solo da stigmatizzare la crassa riottosità di questa pur minoritaria componente del regno animale (mammiferi, vabbè, ma fino a un certo punto) nell’uniformarsi alla legittima volontà di un rappresentante democraticamente eletto.
Un lockdown in allegria
L’unico rimprovero che sentiamo di poter muovere, con serenità, al Presidente del Veneto è semmai, di non aver osato abbastanza.
Perché, già che ci siamo, non estendere la tamponesca mobilitazione anche a macellai, beccai, norcini, pastori, butteri, mandriani, tassidermisti et similia?
Fior di professionisti che magari ignorano l’esatto numero di vertebre cervicali del dugongo, ma se opportunamente addestrati, sapranno certo infilare un tampone nel naso o nella cavità orofaringea.
Come d’altronde, e senza bisogno di addestramento, tutti gli infermieri e i tecnici di laboratorio italiani, ma vuoi mettere la gioia di essere tamponati (orrido termine ormai invalso nell’uso) da un veterinario fatto e finito?
Considerazioni di ordine umanitario, oltre che di dignità democratica, ci impediscono di invocare che, per il folto popolo leghista, l’assistenza veterinaria venga estesa a ogni ambito sanitario, includendo anche diagnosi e terapia.
Ma se domani tale eventualità venisse caldeggiata da uno dei loro più prestigiosi leader, qual è Luca Zaia, riteniamo che andrebbe quanto meno vagliata senza particolari pregiudizi.
Venendo a noi comuni mortali, nutriamo la certezza che un nuovo ed eventuale lockdown trascorrerebbe in allegria.
Allietato da una categoria giammai latitante nelle italiche vicende, pur tristi e perigliose che siano.
I comici.(kulturjam.it)
“Siamo il paese più antico del ventesimo secolo”.
(Geltrude Stein)
Chiunque vinca, sarà il presidente più anziano della storia americana.
Ammesso che laggiù, in quelle lande sterminate tra l’Atlantico e il Pacifico, si possa parlare di storia.
Non secondo i nostri standard, sia chiaro. A parte le facce scolpite sul monte Rushmore, il lontano passato americano possiede ben poca storia. Diciamo che il più delle volte ha una narrazione.
Non c’è, nelle biblioteche d’oltreoceano, un Tacito, uno Svetonio, un De Tocqueville. E nemmeno un Omero.
L’epica americana viene cantata, postuma, dai film di John Ford e dai fumettosi romanzi di Louis L’Amour.
Questi ultimi, non a caso, lettura preferita di Eisenhower, nei convulsi anni della guerra in Europa.
Mondo selvaggio e idealizzato, ma sempre all’americana, quindi secondo canoni non necessariamente positivi, per le abitudini europee. Prima si spara e poi si fanno le domande. L’impiccagione e subito dopo, il regolare processo.
Inoltrandosi in deserti e praterie, armati solo di bibbia e Winchester, con dentro le bisacce il giusto mix di fede e disperazione.
Un mito gonfiato, esagerato, millantato fino alla sbruffoneria, ma tutto sommato accettabile, finché si rimane sul terreno della fantasia, dell’invenzione artistica.
Il guaio è quando viene preso sul serio, quantomeno come ideale e fonte di ispirazione, da una parte consistente dell’elettorato.
Abbandonandosi a un facile paragone, è come se noi prendessimo per vera l’invulnerabilità di Achille o la deificazione di Romolo.
Verrebbe da ridere, ma interpretare gli States secondo i parametri europei è sempre un grave errore, per altro abbastanza comune.
Quella già citata storia che abbiamo alle spalle, le tante stratificazioni che ci compongono, spesso in modalità inconsapevole, ci fanno guardare il passato con affettuoso paternalismo, ritenendolo era di simpatica ingenuità.
Perché il nostro passato è, appunto, passato da un pezzo. Lo contempliamo issandoci su rovine di millenni.
Quello americano è molto più recente di quanto si pensi.
Basta guardare una carta geografica degli Stati Uniti.
Andando dal nord-est verso ovest, i confini dei vari stati diventano sempre più regolari, squadrati, quasi fossero appezzamenti di terreno messi all’incanto.
Territori che solo dopo aver raggiunto le diecimila anime, ricevevano la grazia di un governatore e di una rappresentanza al Congresso. Dove la legge era comunque molto più presente di quanto ci racconti un John Wayne. Altrimenti, a forza di duelli e assalti alle diligenze, si sarebbero estinti da un pezzo.
Eppure non c’è scolaro americano, che guardando quei confini non si senta, anche in minima parte, erede del mito della Frontiera, per altro l’unico disponibile.
Prova ne sia l’ingombrante presenza, nell’albo d’oro delle presidenziali, di uno come Ronald Reagan. Forse l’uomo in cui, negli ultimi cinquant’anni, gli americani si sono maggiormente incarnati.
Che su un canale esponeva lo stato dell’Unione e sull’altro caracollava contro i sudisti. A colori attaccava l’Impero del Male e in bianco e nero svuotava il tamburo della Colt contro gli ululanti pellerossa.
Sorta di simpatico sbruffoncello, forte propugnatore di un pensiero debole, che si può condensare nella perniciosa dottrina della Deregulation, tana libera per ogni pescecane a stelle e strisce.
Il quale, per uno di quei casuali crocevia della storia, poté intitolarsi la patente di vincitore della Guerra Fredda. Titolo forse leggermente superiore ai suoi meriti.
Altro aspetto, apparentemente insignificante, ma simbolico, i colori degli schieramenti politici.
Nel Vecchio Mondo, oberato dai retaggi classici, il rosso è colore della rivoluzione, drappo da sventolare davanti al toro, financo colore dei cattivi. Visto che nelle esercitazioni Nato la fazione red ha sempre il ruolo di aggressor (leggasi russi/sovietici/cinesi) e quella blue di pacifico difensore del patrio suolo.
Nel Nuovo Mondo il blu, classico e aristocratico, è la tinta dei democratici, partito di quasi sinistra, tradizionalmente vicino alle minoranze e all’elettorato povero. Mentre il rosso è simbolo dei repubblicani, che pure sarebbero i campioni del capitalismo e del Leave it to the market.
Non per questo è un mondo capovolto, ha solo modelli diversi di riferimento.
Un mondo in cui, a tutt’oggi (scriviamo alle 11.00 a.m. del 4 novembre) non si sa ancora chi sia il nuovo presidente. In virtù di un sistema elettorale che sarebbe riduttivo definire inutilmente arzigogolato.
Eppure, in un paese ideale, nessuno che abbia consigliato ai propri elettori iniezioni di candeggina per difendersi dal Covid, potrebbe sperare di prendere un voto che uno.
Negli Stati Uniti reali invece, Trump è lì che lotta spalla a spalla e minaccia, in caso di sconfitta, la prosecuzione della lotta con altri mezzi.
Esecrarlo, in virtù del profluvio di castronerie e verità prefabbricate che è uso esternare, non basta.
Per spiegare, almeno in parte, il fenomeno, si deve evitare l’errore di restringere gli States a città come New York o Los Angeles, realtà cosmopolite che fanno storia a sé, appartenendo più al pianeta che alla società americana.
Si guardi piuttosto alle migliaia di paesini sparsi per il Midwest, con magari solo un drugstore e una pompa di benzina, il cui elettorato, bianco e impoverito, guarda a Trump come al messia.
Perché a dispetto del metodo comunicativo, cazzate ma con grinta, è l’unico da cui si sentano davvero considerati.
Rispecchiandosi nei suoi difetti, più che negli eventuali, e finora sconosciuti, pregi. Ritenendo aurea la sua palese mediocrità, per la semplice ragione che è anche la loro. E sconfessando lui, sconfesserebbero tutto ciò in cui sono cresciuti.
Non dopo che Hollywood, per molti unica fonte di apprendimento, ha mostrato loro che qualunque sia la minaccia, alieni, cataclismi, asteroidi in rotta di collisione, a salvare il mondo ci pensa sempre l’americano medio.
Il buon vecchio Tom, Bill o Jack, che dopo aver distrutto l’astronave madre, torna tranquillamente a dipingere lo steccato.
Infine, but not least, perché Donald incarna i tratti più scivolosamente egoistici di quella fetta di società americana.
I suoi ripetuti inviti a spendere e spandere, promettendo un rapido ritorno ai bei tempi andati. Le sue ben note preferenze per il junky food, che suona quasi eretico in un’epoca di continue conversioni al vegano.
Mangiare e spendere come se non ci fosse un domani, negando il Covid, il surriscaldamento globale e ogni altro scrupolo che possa frapporsi tra un suprematista bianco e la sua succosa, sfrigolante bistecca.
D’altronde, ricordava Andy Warhol, comprare è molto più americano di pensare.
Whatever happens, nome e colore del vincitore sono meno importanti di quanto si pensi. Cambierà solo il colore della famelica folla di burocrati, in trepidante attesa al di là del Potomac.
L’uomo più potente del mondo, l’Overlord del Sacro Impero d’Occidente, è limitato da una serie infinita di contropoteri, di lacci e lacciuoli, lobby e interessi, che i padri fondatori sparsero sui tappeti della Casa Bianca, nel timore che il Grande Capo diventasse troppo grande, sconfinando nella dittatura.
Right now, il presidente degli Stati Uniti è piuttosto un simbolo, culturale e antropologico, del tasso di ottimismo, o di paura, che attraversa la società nel suo complesso.
Venisse eletta una mediocre riserva della democrazia, come Biden, vorrebbe dire che la politica statunitense considera i quattro anni precedenti un incidente di percorso e che la maggioranza della società è pronta a fare i conti con il presente.
Vincesse Trump, con i suoi modi da toro nella cristalleria, significherebbe una cronicizzazione, in senso sclerotico, del Mito sulla realtà, con tutto quel che ne consegue. Incluso il rifiuto di accettare l’allargamento del mondo e l’arretramento dal ruolo di unico arbitro del destino comune.
Il che, a dispetto del più grande arsenale nucleare del pianeta, non è affatto poco.(antimafiaduemila.com)
La nuova lezione del prof Roberto Lipari



 393.97.18.272 - 393.97.18.431
393.97.18.272 - 393.97.18.431